|
|
|
|
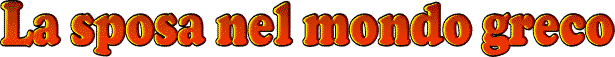
(secc.
VII-IV)
Nei secoli dal VII al
IV a.C., nel mondo greco, con le precisazioni che faremo, la donna, o
almeno la sposa legittima, cioè quella data, dopo l’"eggùe" dal suo "kùrios"
insieme con la dote, al marito, veniva considerata un "dono grazioso". Lo
statuto della sposa e delle ricchezze che l’accompagnavano era molto
diverso ad Atene, città dell’apertura e del cambiamento, rispetto a
Sparta, città della chiusura e dell’immobilismo, proprio perché le due
città avevano una diversa concezione della comunità cittadina e della sua
composizione.
A quel tempo vi erano
"città calde" e "città fredde", secondo una classificazione del
Levi-Strauss.
Le
"città fredde", come Sparta, avevano deciso di conservare l’organizzazione
in case e di limitare l’appartenenza alla comunità cittadina ai soli
possessori di terreni.
Le "città calde",
come Atene, posero fine alla struttura per case e rifiutarono di limitare
l’appartenenza alla comunità cittadina ai possessori di terre.
Nelle città fredde la
sposa era padrona della sua persona e del suo corredo matrimoniale, mentre
nelle città calde la sposa, legata ad una dote in denaro, era sottoposta
all’autorità maritale.
Potremmo dire,
insomma, che la donna fu vittima dell’invenzione della democrazia.
Nell’Iliade e
nell’Odissea vengono descritte molto bene le società strutturate in "case
separate".
L’"oikos", la casa,
era un elemento simbolico che rappresentava: la casa stessa, il suo
contenuto, il proprio pezzo di terra ed il bestiame.
La casa omerica è
dunque un oggetto simbolico anche se essa è soprattutto l’abitazione.
Essa è
importantissima per la persona e per determinarne la condizione sociale:
per avere un nome bisognava essere riconosciuti dal padre, appartenere ad
un gruppo di residenti liberi di una casa.
Nelle società
omeriche i non liberi non avevano una casa, un nome, un padre.
Se la casa era
importante per determinare un gruppo residenziale, la terra permetteva la
costruzione della gerarchia dei gruppi residenziali.
Il possesso di un
lotto di terreno permetteva l’integrazione con la comunità: casa e terra
erano, quindi, ricchezze particolari che determinavano lo status
giuridico-sociale e lo statuto.
La casa era fondata
sul matrimonio legittimo e si perpetuava attraverso matrimoni legittimi:
la donna che metteva al mondo figli legittimi, a differenza delle altre
donne, aveva, nel bene e nel male, un‘esistenza sociale riconosciuta.
La donna sposa, per
la logica delle cose della società di allora, faceva parte delle
ricchezze, poiché era colei che provvedeva alla riproduzione.
Nelle società
omeriche l‘intero gruppo residenziale si fondava sul matrimonio legittimo
e si perpetuava imponendolo.
Statuti e beni erano
trasmessi per via ereditaria e solo i legittimi eredi ne potevano
usufruire; infatti, solo ai figli legittimi era destinata l‘eredità, agli
illegittimi era riservata solo la quota del bastardo e non godevano di
nessuno statuto.
Vi erano, quindi,
delle regole rigidissime per quanto riguardava la sessualità a scopo
riproduttivo, mentre non vi erano vincoli per la sessualità edonistica: le
grandi case omeriche erano piene di concubine e di prigioniere.
Tutte le regole
imposte tendevano a scoraggiare la poligamia, forse perché si temeva un
ingrandimento delle grandi case o un‘esplosione demografica.
Tre concetti
fondamentali aiutano a capire la società delle case:
le case non si
intersecavano: i figli maschi rimanevano in esse, le figlie femmine
andavano in mogli in altre case;
le case si
perpetuavano: se una casa aveva solo figli maschi, essa si perpetuava
accogliendo delle nuore; se, invece, aveva solo figlie femmine, essa si
perpetuava accogliendo generi;
le case si
segmentavano: alla morte del padre, quando i figli si dividevano l‘eredità
e si insediavano separatamente nella casa; oppure quando un padre prendeva
un genero.
Le case omeriche,
quindi, sembravano praticare due tipi di matrimonio: quello "da genero" e
quello "da nuora", che sono tipici della società omerica.
Tali due tipi di
matrimonio implicano entrambi: il "dono grazioso" di una sposa, legata a
delle ricchezze e l‘incorporazione del coniuge "mobile" nella
consanguineità della casa che lo riceve.
Il concetto di sposa
e di matrimonio si è poi evoluto, nel mondo greco, dalla configurazione
dell‘epoca omerica a quella del periodo classico.
In proposito vi sono
due ipotesi più accreditate ed entrambe legate, per metodiche opposte –
cogliendo una le affinità e l’ altra le differenze – alla formazione ed
evoluzione delle varie "pòleis", le città-Stato, del periodo in esame.
La prima ipotesi
individua una relazione fra l’apparire delle città e la scomparsa della
regalità e la ristrutturazione dei gruppi sociali.
Le "case separate"
omeriche cedono il posto alle "case che si collegano fra loro": cambia,
cioè, l’organizzazione sociale.
Nelle società
strutturate in "case che si collegano fra loro" è la sovrapposizione delle
case che salda il gruppo sociale trasformandolo in un insieme
indivisibile.
La città comincia ad
esistere con l’instaurarsi della parentela fra cognati.
Questo processo di
ristrutturazione delle case scaturisce da una riorganizzazione del sistema
della riproduzione legittima:
la sposa viene data
dalla sua casa a quella del marito affinché egli possa assicurare la sua
continuità;
la dote o "deriva
patrimoniale" segue la sposa che rimane per tutta la vita titolare delle
ricchezze donate dalla sua famiglia. Lo sposo è solo un usufruttuario,
essendo, in realtà i beni dotali destinati ai figli generati dai due sposi
e tali beni, provenienti dalla casa della madre, sono il segno concreto
della loro appartenenza alla casa della madre. Non si tratta più di una
filiazione complementare, bensì di una doppia filiazione;
il collegamento fra
le case rende superflue le procedure dei matrimoni della nuora e del
genero e l’integrazione del coniuge mobile nella casa che lo accoglie. Gli
sposi cessano di essere consanguinei per diventare affini.
In tutte le "pòleis",
oramai, due sono gli schemi matrimoniali seguiti: il matrimonio della
figlia che ha un fratello e il matrimonio della figlia che non ha un
fratello.
La seconda ipotesi
tiene conto delle differenze che il "dono grazioso" della sposa presenta
tra le due città tipo di Atene e Gortina (cui sono assimilabili Chio, Teo,
ma, soprattutto, Sparta).
Essa propone di
stabilire una correlazione tra la scelta del sistema matrimoniale e quella
del sistema politico.
La riconversione
delle società a "case separate" in società a "case che si collegano" non
vuole rimettere in discussione i principi cardine dell’organizzazione
delle società omeriche:
la gerarchia del
gruppo residenziale è fondata sul possesso di ricchezze che danno uno
statuto, quali la casa (segno concreto della libertà) e l’ appezzamento di
terra (segno concreto dell’integrazione nella comunità \ collettività
ormai "pòlis");
la riproduzione
legittima assicura tanto la trasmissione ereditaria quanto la successione.
Quelle città che,
come Gortina e Sparta, hanno scelto di conservare questi principi
organizzatori hanno scelto di legare le loro figlie alle particelle della
terra della comunità.
Queste città,
pertanto, sono state portate a pensare il loro dispositivo matrimoniale a
partire dal matrimonio da genero delle società a "case separate" e a fare
della donna un membro della comunità, padrona della sua persona e dei suoi
beni.
Le case cittadine,
che rappresentano solo una parte dell’insieme dei residenti, si collegano
e trasmettono il loro bene comune (la terra della città) ai loro figli
legittimi, senza distinzione di sesso.
Altre città, come
Atene, hanno scelto, in un certo momento storico, di rifiutare la
gerarchia della società organizzata per case; le case cittadine, che
rappresentano la totalità dei residenti, si collegano trasmettendo ai loro
figli legittimi, senza distinzione di sesso le ricchezze che esse
contengono. In tal modo la città si può aprire anche a coloro che non
posseggono terra civica.
Quello che comunque
emerge e che colpisce la nostra sensibilità affinata ai problemi femminili
(in una società dove la pari opportunità fra i sessi è oramai conquista
riconosciuta), è la considerazione che presso la "pòlis" per eccellenza
democratica e culturalmente avanzata, quale Atene, la donna sposa vive una
vita segregata e vegetativa.
In verità Atene era
una "pòlis" creata da uomini per uomini, che escludeva le mogli non solo
dall‘attività politica, ma anche da quella sociale, religiosa e culturale.
Il mondo, regno e
prigione, della sposa ateniese era la casa, anzi la "gunaikonìtis" e tutti
gli avvenimenti esterni ad essa riguardavano l’uomo e solo l’uomo.
Viceversa presso
Sparta, Gortina, Chio, Teo, Lesbo, città di cui abbiamo testimonianze
storiche, il discorso si atteggia alquanto diversamente.
Le donne in generale,
ma anche le spose, godevano di una maggiore libertà, non vincolate alle
precipue funzioni di procreazione e di amministrazione della casa, libere
di frequentare palestre, scuole, danze, cori, teatri, vita culturale,
religiosa, sportiva, anche pubblica, pur con l‘esclusione di tutti i
diritti politici e di governo.
Il perché di questa
differenza, abbiamo visto, sta forse nelle diverse scelte effettuate nel
contesto della trasmissione del patrimonio e dell’adozione delle forme di
sviluppo economiche attuate dalla "pòlis".
Come già detto,
presso Sparta e Gortina la cittadinanza veniva trasmessa insieme alla
terra: cittadino era chi possedesse della terra nell’ambito dell’agro
della polis.
Tra l’altro tali
scelte hanno comportato come conseguenza coatta, sovente, l’endogamia
proprio per evitare la dispersione del patrimonio immobiliare della "pòlis"
e la disgregazione del tessuto sociale originario della città stessa.
Così la donna che,
sia pure in misura meno garantita rispetto ai maschi della famiglia,
poteva anch’essa ereditare la terra, vedeva automaticamente riconosciuto
il suo status di cittadino con la connessa maggior tutela della sua
condizione anche da sposata: ricordiamo ancora una volta che le era
conservata la proprietà del bene dotale, mentre il marito ne era solo
usufruttuario.
Presso Atene, invece,
l’evoluzione del matrimonio monogamico non solo non favorì la donna,
quanto, invece, aumentò l’emarginazione femminile.
La condizione della
donna ateniese divenne assolutamente subordinata al padre prima, al marito
poi, al figlio o ad altro parente, in caso di vedovanza.
Ciò parallelamente
alla nascita di una città–stato dalla struttura di tipo maschilista, un
vero "club di uomini" da cui erano escluse, oltre agli schiavi, agli
stranieri, ovviamente le donne.
Abbiamo visto,
riconducendo il discorso sul piano della disamina delle scelte che hanno
determinato una tale organizzazione societaria, che in Atene prevalsero un
sistema ereditario femminile ed un sistema dotale legati al denaro ed ai
beni mobili.
La donna non
ereditava terre che, fra l’altro, non davano più "tout-court" il diritto
alla cittadinanza, ma passava essa stessa, come un qualunque oggetto, vero
"oikourèma", dalla potestà del padre a quella dello sposo.
Tale sistema si
adattava bene di sicuro ad una città come Atene dall’economia vivace e
dinamica, dai molteplici contatti, dai commerci veloci e legati a capitali
facilmente reperibili, da spostare in vari settori.
Furono le riforme
matrimoniali e politiche di Solone a segnare storicamente il transito
dalla società "a case separate" all’Atene "pòlis" più evoluta.
Aristotele ha
ritenuto che tali riforme furono determinate dall’esigenza di ripianare i
contrasti fra ricca minoranza nobile, proprietaria terriera potente e
dominante e massa di poveri che non avevano terra propria.
Atene è assurta a
prototipo e paradigma del mondo classico anche in virtù del fatto che di
tale popolo e di tale periodo abbiamo un maggior numero di testimonianze
rilevanti oltre che per quantità anche per qualità.
Grazie a tali
contributi il carattere della donna greca è stato formato e modulato sullo
schema della donna ateniese dell’età classica.
E va detto che il
matrimonio monogamico non favorì la donna: padrone era l’uomo.
La donna non
sceglieva mai ed arrivava al matrimonio quasi sempre senza aver visto il
suo futuro marito.
L’uomo si sposava per
un unico scopo: la procreazione di figli legittimi.
Il matrimonio d’amore
non esisteva, anzi il matrimonio era un vero e proprio contratto in cui
tutti gli obblighi erano a carico di una sola parte.
Infatti il marito
poteva ripudiare la moglie e tenersi i figli, con la sola formalità di una
dichiarazione in presenza di testimoni ed al solo patto di restituire la
dote o pagarne gli interessi.
Al contrario
l’istanza di divorzio presentata dalla moglie veniva raramente accolta;
era sempre necessaria una decisione del giudice, motivata da sevizie gravi
o da notoria infedeltà.
A tale ultimo
proposito va detto, comunque, che l’ infedeltà del marito veniva
comunemente ammessa dal costume, potendo egli avere concubine e
cortigiane.
Si attribuisce a
Demostene l’affermazione: "…abbiamo cortigiane per il nostro piacere,
concubine per essere ben curati e mogli perché ci diano figli legittimi e
siano guardiane fedeli del focolare".
Va altresì ricordato
che il contratto di matrimonio fa appartenere la donna alla comunità
cittadina ponendola sotto la tutela di un altro cittadino, e colui che la
dà garantisce che ella sia nata da un padre e da una madre appartenenti
entrambi alla comunità cittadina, secondo le clausole del decreto di
Pericle: "…per essere oggetto di un contratto di matrimonio una donna deve
essere cittadina di nascita. Colui che la dà deve essere un cittadino … (
omissis )".
Le condizioni del
contratto, dunque, garantivano che la donna data in sposa fosse di nascita
cittadina, pur se non attestanti la legittimità di essa.
Quanto alla "deriva
patrimoniale", ossia alla dote, va detto che il suo significato non è di
univoca interpretazione.
Ad una prima
superficiale analisi, la dote è il segno concreto dell’ascendenza materna
e della doppia filiazione: vero "punctum dolens" dei matrimoni, se nell’
età omerica era l’ assillo del giovane che voleva sposare una fanciulla –
ricordiamo che solo in casi eccezionali la sposa era ceduta senza
pretendere dote da parte del richiedente (esempio di Agamennone ed Achille
nell‘Iliade) – in età classica era la croce dei genitori che volevano
trovare uno sposo per la figlia.
La dote naturalmente
era amministrata dal marito, il quale, però, doveva restituirla in caso di
divorzio; in tale ipotesi, e soprattutto quando essa era cospicua, la dote
costituiva un‘arma di difesa della donna e un deterrente per improvvisi e
pericolosi colpi di testa del marito.
Ad un’analisi più
raffinata la dote si dimostra anche un mezzo materiale, uno strumento per
integrare nella città le figlie che sono state, dalla loro nascita, messe
ai margini della famiglia.
Il giorno del
contratto la dote, costituita da colui che separa dal proprio capitale
tale deriva, viene conferita alla sposa e comprende essenzialmente beni
nascosti (cioè denaro ed investimenti che producono interessi, quali
ipoteche sui mobili in affitto, immobili in affitto, …).
In Atene c’è la
cosiddetta "diverging devolution", ma, mentre il ramo femminile è messo in
circolazione col denaro, i figli maschi conservano tutti i beni apparenti,
cioè beni di produzione, casa di abitazione, terra e schiavi.
Si preferivano unioni
entro il "ghènos" familiare in modo che la dote della figlia non finisse
in altre famiglie, cosicché non erano infrequenti matrimoni fra zio e
nipote.
Per la donna greca,
in particolare per quella ateniese, il matrimonio era un atto di
obbedienza alla volontà paterna, un fatto naturale ed ovvio, una legge
fisica determinata dalla tradizione, sancita dalle leggi, riconosciuta
necessaria da tutti per la vita e lo sviluppo della "pòlis" e del
cittadino.
Per quanto riguarda
l’età in cui le fanciulle greche prendevano marito, sembra che cadesse fra
i sedici e i quindici anni, mentre per i giovani era poco frequente e
ritenuto anche inopportuno un matrimonio prima dei trent’anni.
La ragazza che andava
in sposa consacrava ad Artemide, alla vigilia delle nozze, la sua bambola.
Platone e Aristotele
consigliavano, per le fanciulle, un‘età più matura, cercando di
correggere, nelle loro legislazioni ideali, quella che per i due filosofi
era una criticabile norma pratica: spesso una ragazza si trovava sposata
ad un uomo molto più vecchio di lei.
D’altra parte è pur
vero che il matrimonio per la fanciulla greca ed ateniese in particolare
era il solo mezzo per realizzarsi, avere una propria vita di donna, di
madre, di padrona di casa.
La condizione di
nubile, nel mondo greco in esame, significava il fallimento e
l’annullamento completo della donna che non aveva più fine né senso e
diventava un essere inutile nel panorama della "pòlis".
Paventando ciò,
Licurgo a Sparta aveva stabilito pene per i celibi ed Atene incoraggiava
il matrimonio come dovere morale di ogni buon cittadino.
I genitori di una
figlia in avanti con gli anni, quando temevano che ella "ànandros polià
partheneùetai (rimanesse vergine canuta )" ricorrevano come "extrema
ratio" alla mediatrice perché trovasse ad accasare la povera fanciulla e
allontanasse il pericolo di dover mantenere una zitella in famiglia.
Vero è che nessuna
legge obbligava un padre o un fratello a sposare una figlia o una sorella
posta sotto la propria autorità: ma l’ opinione pubblica considerava
espressione di incapacità e criticava ferocemente quei congiunti che non
dotavano la donna e non le procuravano un matrimonio.
Quando col matrimonio
la sposa entrava nella casa del marito, l’ attendevano innanzi tutto i due
doveri sopra citati: la procreazione dei figli, la direzione e
l’amministra-zione della casa.
"Méter", " madre", e
"oikodéspoina", " padrona di casa", sono i suoi appellativi.
L’uomo greco non
chiedeva alla moglie di essere la compagna della propria vita, né
pretendeva da lei comprensione, interessamento, grazia, amore, i tesori
del suo cuore e le doti della sua intelligenza; la moglie in fondo non era
che la persona di cui l’ uomo aveva bisogno per assolvere il suo dovere
sociale e biologico di riprodurre la specie e perpetuare la famiglia per
il "ghénos" e la "pòlis" e di cui poteva fidarsi nell‘affidarle l’
incarico di "tirare avanti la casa" il meglio possibile.
Con queste esigenze è
naturale che diffidasse della donna colta, dai pensieri troppo alti per
una femmina; preferiva una fanciulla alla buona, poco istruita, che avesse
visto, udito e cercato di sapere il meno possibile, ma che fosse fornita
di "sophrosùne", che possiamo tradurre approssimativamente con "saggezza"
o con "buon senso", ma che, in effetti, indica il complesso delle doti
necessarie per essere una buona moglie, quindi la continenza, il pudore,
la fedeltà, l’osservanza dei propri doveri di madre e padrona di casa.
Fra moglie e marito
c’era, quindi, una netta divisione di incarichi, di compiti, di mentalità
e di prassi che non potevano trovare, se non eccezionalmente, un punto di
mutuo scambio, di proficua interferenza in cui si sommassero e si
completassero gli sforzi dei due coniugi, i quali rimanevano, per così
dire, su due binari paralleli che ognuno di loro percorreva, il più delle
volte con l’indifferenza inevitabile di coloro che vivono in due mondi
diversi, che non possono comunicare.
Di qui
l‘incomprensione dell‘uomo greco nei confronti della donna, la quale
diventava facilmente oggetto degli strali avvelenati e crudeli, di
facezie, maliziose e paradossali, di accuse rabbiose da parte di poeti e
scrittori, i quali, pur nella loro esagerazione letteraria, erano tuttavia
portavoce di quella comune incomprensione; perciò il cosiddetto
misoginismo greco delle fonti letterarie non fu soltanto un atteggiamento
folkloristico o individuale, ma un motivo che si collegava a forme reali
di vita e di pensiero.
Nella "gunaikonìtis"
la sposa greca, o meglio, la sposa ateniese, metteva alla luce i suoi
bambini, li nutriva, li allevava, giocava con loro quando non aveva la
possibilità di pagarsi una balia o una nutrice.
Dal gineceo essa
doveva amministrare e dirigere la casa nelle cento piccole cose tra cui ad
esempio le maggiori erano la vigilanza sugli schiavi, il cibo, gli
interminabili lavori domestici.
E’ facile, quindi,
immaginare che la sposa rimanesse imbarazzata nelle prime settimane e
forse anche nei primi mesi di matrimonio, specie se molto giovane.
Nella casa paterna di
solito aveva imparato a tessere, a filare, a ricamare, aveva ricevuto
esortazioni dalla madre, la quale aveva cercato di prospettarle i piccoli
gravosi problemi inerenti la direzione di una casa, ma essa probabilmente
non era preparata alla vera e propria gestione di una casa.
La donna di casa
svegliava gli schiavi al mattino presto e assegnava loro i vari compiti.
Alcuni dovevano
svolgere i loro lavori fuori, altri, invece, rimanevano in casa; ma era
necessario che trovassero già pronte le suppellettili e gli arnesi
necessari in modo che non si perdesse tempo e che tutto procedesse con
rapidità e ordine.
La padrona di casa
era direttamente responsabile delle provviste alimentari che doveva
amministrare attentamente, distribuendo la giusta quantità necessaria alla
preparazione del pranzo giornaliero, evitando sciupii e sperperi inutili;
ciò che mancava in casa, lo mandava a comprare nell’"agorà" da un’ancella,
molto spesso vecchia e fidata, oppure se ne occupava direttamente il
marito.
Generalmente le case
più agiate avevano una buona scorta di vino, olio, grano, che spesso
veniva macinato nella casa stessa, così da avere una certa quantità di
farina sempre pronte, e che pertanto doveva essere conservata nei luoghi
più asciutti della dimora, mentre per il vino erano indicati i locali più
freschi; e tutto questo rientrava nei compiti dell’"oikodéspoina".
Naturalmente, quando
l’amministrazione lasciava a desiderare, il marito poteva chiudere la
dispensa a chiave, amministrando tutto di persona, o per mezzo di uno
schiavo fidato.
Per quel che riguarda
la cucina, la padrona di casa agiata non era solita armeggiare con
fornelli e pentole: l’incarico era devoluto ad una serva capace ed esperta
nella preparazione delle vivande.
La sposa meno ricca
invece provvedeva direttamente all’allestimento dei cibi che dovevano
essere quasi tutti preparati, come le focacce di farina, che poi essa
doveva cucinare al forno o in altro modo, come legumi, piselli,
lenticchie, spesso triturati e variamente manipolati prima di essere
cotti, come le verdure e l’immancabile pesce.
La padrona di casa,
inoltre, doveva occuparsi e preoccuparsi della biancheria tutta della casa
e dei vestiti propri e dei familiari. Doveva, inoltre, pensare al bucato –
di solito fatto in casa dalle serve, ma anche in lavanderie pubbliche -,
alla stiratura della biancheria e delle vesti, alla loro sistemazione, ben
ripiegate, in apposite casse, allestite dalla stessa padrona di casa con
sostanze vegetali profumate e dal potere antiparassitario.
Se qualcuno in casa
si ammalava, a doversi prendere cura di lui era proprio la padrona di casa
che fungeva, allora, anche da medico e da infermiera non solo per il
consorte ed i figli, ma anche per gli altri occupanti della casa, schiavi
compresi.
Quando qualcuno
moriva era compito della donna prestare le ultime cure alla salma.
Inoltre, come
appartenente al "ghénos" del marito, aveva l’obbligo di prendere parte a
tutte le cerimonie religiose della famiglia.
Oltre a tutte queste
incombenze, l’attività più impegnativa e distintiva della moglie,
"padrona" della casa greca, era la lavorazione della lana, la tessitura e
il ricamo, arti che apprendeva già nella casa paterna sotto la guida della
madre.
Aprendo qui una
parentesi va detto che, dopo aver dato al marito i figli desiderati, la
madre poteva allevare i maschi fino ai sette anni e le figlie fino al
matrimonio, ma mentre a Sparta sappiamo che le fanciulle frequentavano
almeno le palestre, che a Teo e a Chio andavano anche a scuola come i
maschi, ad Atene invece non potevano assolutamente uscire dall’ambito
domestico: niente palestra, né scuola.
L’unica educazione
era impartita dalla donna: era la madre che insegnava alle ragazze a
leggere, a danzare, ma, soprattutto, a lavorare la lana, a tessere e a
ricamare, con le nozioni ricevute a sua volta nella casa paterna,
perpetuando così situazioni, gesti, abitudini, senza possibilità di
mutamenti e di varietà.
E’ notorio che la
donna ateniese non aveva una grande cultura e spesso sono citati esempi di
spose noiose e colleriche (vedi Santippe); non "noiose", ma diremmo oggi -
invece - depresse e stressate per la vita chiusa, ritirata, monotona,
ripetitiva, gravosa di compiti minuziosi, umili ed alienanti.
Una volta sposata la
donna di casa greca, se la casa del marito era grande e ricca, poteva
trovarsi a dirigere un piccolo laboratorio in cui veniva lavorata la
materia greggia (lana o lino) e trasformata in tessuto per vesti,
biancheria, tappeti, coperte, etc., di uso domestico.
La tessitura era
un’arte antichissima praticata dalle donne greche fin dalla più antica
età.
Ricordiamo che Omero
creò la figura di Penelope, che tesseva di giorno e disfaceva l’ordito di
notte, traendo ispirazione dal culto delle virtù domestiche e dell’amore
della sposa, fedele al marito lontano.
Per concludere una
curiosità: la donna greca non aveva niente da invidiare alle donne di oggi
per la cura della persona: faceva il bagno in casa, si tingeva i capelli,
si profumava con profumi costosi ed esotici, si truccava con cura, si
adornava di orecchini, collane, braccialetti, si vestiva con attenzione,
quasi sempre però al chiuso della sua prigione dorata, e neanche tanto:
del "gunaikonìtis".
A conclusione di
questa breve disamina si può sicuramente convenire che nella Grecia
omerica e nell’ Atene classica non esisteva uguaglianza fra uomini e donne
e, men che meno, fra mariti e spose legittime.
La condizione della
sposa, dunque, così discriminata per effetto soprattutto dell’adozione
degli indirizzi matrimoniali illustrati, era pessima, grama, priva di
qualsiasi gratifica estranea a moduli e modelli maschilisti, soprattutto
se rapportata a quella dei precedenti periodi minoico e miceneo ed e
quella dell’antica Sparta.
Se si eccettua la
scelta monogamica più che poligamica, essa è molto vicina a quella di
molte realtà orientali, mediorientali e terzomondiste dei giorni d’oggi.
______________________________________________________

La mitologia greca e
quella romana sono davvero affascinanti e popolate di dei.
Gli dei greci sono
più divertenti perché più umani, più coinvolti in sentimenti ed umane
vicende.
Infatti, malgrado la
loro immortalità unita ad un insieme di poteri straordinari, quali la
forza, la velocità, l'invisibilità, la capacità di volare, uomini e dei
sembrano vivere un regime di parità in fatto di sentimenti o stati d'animo
come la voluttà, la passione, il desiderio, la vanità, l'invidia, la
gelosia, l'ambizione, la possessività, la collera, la pietà, la paura, il
desiderio, la felicità, la vendetta, l’amore e l’odio, ecc..
Sebbene ciascuna
delle due specie segua il proprio destino, il genere di vita dei mortali
fa riferimento a quello degli dei, così prossimi, così simili da essere
immaginati come "esseri che hanno la stessa forma della stirpe umana".
Il mondo degli dei
greci è molto affollato (solo le divinità olimpiche sono dodici): ZEUS,
ERA, POSEIDONE (dio del mare), DEMETRA, APOLLO, ARTEMIDE, AFRODITE, ARES,
ERMES (dio dell’astuzia e del commercio), ATENA, EFESTO ed ESTIA;
immortali abitanti dell'Olimpo, nutriti di ambrosia, di nettare, di fumo,
non hanno sangue, ma ben altri umori impregnano la loro carne sotto la
bella pelle; non muoiono, ma ciò non impedisce loro di temere la morte;
sono "akedees", cioè esenti da preoccupazioni, e tuttavia si curano di
molti affari impegnandosi senza sosta a fianco degli uomini.
Questo quadro
piuttosto chiaro e simpatico della vita degli dei greci, mostra una natura
più umana che divina; ma la meraviglia che può scaturire interessandosi di
questi immortali, aumenta nel confrontare il comportamento di alcune dee
greche che manifestano in modo preponderante alcuni sentimenti prettamente
femminili.
Ma andiamo con
ordine: dunque, Crono (tempo), figlio di Urano e Gea (terra), evirò il
padre e divenne Signore del mondo.
Sposò Rea ed ebbe
molti figli che divorava appena nati per paura di essere detronizzato,
come gli era stato predetto.
Ma Rea riuscì a
nascondere uno dei figli, ZEUS, che, non appena fu abbastanza grande,
costrinse il padre a restituire i fratelli ingoiati e poi lo precipitò nel
Tartaro.
Zeus sposò poi la
sorella ERA e diventò Signore dell'Universo stabilendo la sua dimora sul
monte Olimpo.
ERA fu protettrice dei matrimoni, del parto e della monogamia.
Generò EFESTO (dio
del fuoco), ARES (Dio della guerra), ILIZIA ed EBE (dea della giovinezza e
coppiera degli dei prima di GANIMEDE).
Perennemente in lite
con Zeus per i suoi tradimenti, Era occupava il suo tempo perseguitando le
amanti, i figli illegittimi del marito e nemici vari: ERACLE (Ercole
latino), figlio di Zeus e di ALCMENA; IO, tramutata dal Dio in giovenca
per sottrarla alle ire di lei; SEMELE, spinta dalla Dea a chiedere a Zeus
di mostrarsi nel suo vero aspetto che, comparendole tra tuoni e fulmini,
la uccise; i Troiani, per vendicarsi di Paride che aveva scelto AFRODITE
come la più bella delle dee.
Insomma, Era è
rappresentata come una donna che "sa il fatto suo", come una donna
innamorata di suo marito e che fa di tutto per piacere alla persona che
ama e che amerà per sempre perché non desidera altro che il suo amore.
Infatti, trascurata
da Zeus, marito e fratello impegnato negli affari degli uomini, recita una
scena di provocazione sessuale da cui traspare un animo squisitamente
femminile.
Dapprima si accinge
ad una accurata toilette nutrendo e profumando artificialmente la secca,
disidradata e arida pelle; poi si orna di gioielli, bei vestiti e di tutto
ciò che serve ad ingentilire il suo corpo che, più che divino, appare
ormai come il corpo di una bella ed elegante donna.
Ma l'operazione non
finisce qua; infatti Era, non ancora soddisfatta perché, pur apparendo
bella ed abbigliata, mancava del potere di suscitare il desiderio
sessuale, decide di impadronirsi del nastro di Afrodite (specialista nelle
arti della camera da letto), in cui si trova concentrato tutto quel che
serve a sedurre e, grazie all'aiuto della Dea dell'Amore, riesce a domare
suo marito, il quale resta addirittura stupito dal forte desiderio che ha
di fare l'amore con sua moglie; un desiderio perfino più forte di quello
provato a suo tempo per IO, DANAE, EUROPA, SEMELE, ALCMENA, DEMETRA e per
la stessa ERA quando lo aveva sedotto.
Dunque, il fatto che Zeus si meravigli di desiderare
così tanto sua moglie, dimostra come l'amore degli dei fosse tanto
effimero ed intermittente quanto quello dei mortali, perché, anche per gli
dei, dopo il matrimonio, il rapporto amoroso spesso cessa di essere
passionale come la prima volta, divenendo una sorta di abitudine, ed Era e
Zeus, rappresentano appunto gli stereotipi della donna fedele ed
innamorata e dell'uomo traditore e rubacuori.
Ma il desiderio
amoroso non ha catturato solo Era o il solo Zeus, ma anche AFRODITE,
figlia di Zeus e Dione (oppure generata dalla spuma del mare nel quale
erano caduti gli organi genitali di Urano, evirato da Crono), la quale era
la dea della Bellezza e dell'Amore; fu sposa di Efesto ed amante di Ares
con il quale generò Eros (dio dell'Amore), Antero, Deimo e Fobo; di Adone
e di Anchise con il quale generò Enea.
Protesse i Troiani
durante la guerra di Troia, e poi Enea, perché Paride l'aveva scelta come
la più bella fra le dee.
Infatti, Afrodite
infliggeva ai viventi le pene dell’amore per riderne e si vantava di
domare gli dei dell’Olimpo; Zeus, non sopportando questo suo vanto, la
trasformò da seduttrice in sedotta, facendola restare abbagliata dal corpo
del giovane Anchise fino al punto di innamorarsene, relegandola, quindi,
in una posizione uguale a quella dei mortali di fronte al desiderio.
E poi ancora DEMETRA,
figlia del titano Crono e di Rea, quindi sorella di Zeus ed Era, era la
dea della fecondità della terra.
Ebbe una figlia da
Zeus, Kore (Persefone) che fu rapita da Ade (dio dell’Oltretomba e anche
lui figlio di Crono e Rea) e portata nell’oltretomba.
Demetra era così
disperata che trascurò la terra che divenne arida ed incolta.
Proserpina fu infine
liberata dall’intervento di Zeus, ma Ade, prima di lasciarla andare, le
fece mangiare i chicchi di una melagrana che l’avrebbero costretta a
tornare da lui per quattro mesi all’anno.
In primavera, quando
Proserpina era con lei, Demetra era così felice che faceva crescere fiori
e frutti, ma quando Proserpina tornava nell’oltretomba, in autunno, il
dolore che Demetra provava faceva morire le piante ed apriva le porte
dell’inverno.
ERIS, figlia della
notte, era la Dea della discordia, rappresentata come un genio alato.
I suoi figli erano
rappresentati come la personificazione di concetti: Pon (Fatica), Lethe
(Dimenticanza), Limos (Fame), Algos (Dolore) e Horkos (Giuramento) e, non
ultima, ATE, avuta con Zeus, era la dea delle imprese e degli errori; essa
fu bandita dall’Olimpo perché aveva ingannato Zeus e fu la causa dell’odio
tra Agamenone e Achei durante la guerra di Troia gettando la mela d’oro
con la scritta "alla più bella" tra i convitati alle nozze di Teti e Peleo.
La mela che Paride,
figlio di Priamo e re di Troia, donò ad Afrodite ricevendone in cambio
l’amore di Elena.
Infine, a conferma
della identificazione immaginaria e non che i mortali hanno degli dei in
relazione agli elementi ed alle situazioni, nonché vizi e virtù che
circondano la sfera delle emozioni e della umana e quindi mortale
comprensione, possiamo citare ancora:
ATENA, nata dalla
testa di Zeus, era la dea della guerra che portava alla vittoria (di qua
l’appellativo Nike=vittoria), della saggezza, dell’intelligenza, della
giustizia, delle arti e dei mestieri.
Protettrice
dell’agricoltura e del commercio e di ogni aspetto del vivere civile,
divenne divinità cittadina per eccellenza soprattutto di Atene e
dell’Attica.
ARTEMIDE, figlia di
Zeus e Latona, sorella di Apollo (dio della salute, dell’ordine, del
vaticinio, della musica e della poesia), era la dea della caccia e della
natura selvaggia. Era rappresentata armata di arco e freccia.
Vergine, era anche
protettrice delle giovinette.
ECATE (Luna), era la dea delle strade, dei crocicchi
e dei fantasmi notturni, sovrintendeva agli incantesimi e proteggeva
streghe e maghi.
Dunque, nell’immaginario collettivo gli dei
rappresentavano le convinzioni; la natura; i sentimenti; il piacere ed il
dolore; la vita e la morte; e, pertanto, erano simboleggiati a immagine e
somiglianza dell’uomo stesso, non soltanto fisicamente, ma anche, e forse
soprattutto, come un concentrato di pensieri, azioni e reazioni, istinto e
meditazione, vizio e virtù, squisitamente e magnificamente umani.
______________________________________________________
La forza delle dee
Le credenze
dell’antica Grecia portavano spesso a pensare che entità superiori
intervenissero nel corso della vita degli uomini.
Le divinità che
abitavano l’Olimpo, infatti, manipolavano le azioni umane per il
raggiungimento dei loro fini.
In particolare le
dee, animate dal desiderio di primeggiare e di essere venerate dagli
uomini, non esitavano a punire coloro che intendevano sfidare la loro
autorità, ma sapevano anche essere benevole con chi si dimostrava
rispettoso nei loro confronti.
Anche Posidone, dio
che possiede la Terra, si scontra con potenti dee, ed è sempre sconfitto
da queste donne.
Ad esempio, quando la
città di Atene si riunì per scegliere la divinità poliade tra Atena e
Posidone, poiché in Attica le donne, per volontà di Cecrope, sedevano in
assemblea con gli uomini e avevano i loro stessi diritti politici,
consacrarono la vittoria ad Atena, in quanto la parte femminile disponeva
di un voto in più.
La sfida tra Atena e
Posidone per i diritti sull’Attica riprende sotto il regno di Eritteo.
La città di Eleusi,
capeggiata da Eumolpo, figlio di Posidone, sotto consiglio di quest’ultimo
muove guerra ad Atene, difesa da Eritteo.
Gli ateniesi decidono
di consultare l’oracolo di Delfi per sapere come assicurarsi la vittoria,
e così comprendono che è necessario il sacrificio di una delle figlie di
Eritteo.
Questi torna dalla
moglie Prassitea, sicuro che la donna si ribellerà alla terribile
ingiunzione dell’oracolo, ma sottovaluta la forza dell’amore di una madre
che per il bene della città sa versare il sangue della sua stessa carne.
Forte del sacrificio
offerto agli dei, Eritteo uccide Eumolpo, causando la disfatta di Eleusi.
Posidone, adirato per
la morte del figlio, uccide Eritteo, facendolo precipitare in una crepa da
lui stesso causata nella rocca dell’Acropoli.
Atena nomina allora
Prassitea, unica sopravvissuta della sua famiglia, sacerdotessa del suo
culto poliate: ella è l’esecutrice della volontà della dea.
Il vero eroe di
questa tragedia è la stessa Prassitea, è un’esecutrice della giustizia, è
lei che prende le decisioni nel momento in cui bisogna agire, è
completamente opposta ad Eritteo, il quale è interamente travolto dal
destino.
Atena, nata dalla
testa di Zeus, è una donna che non si connota esclusivamente per la sua
bellezza o per il suo ruolo di generatrice, ma per virtù quali la saggezza
e la forza, che delineano una nuova figura femminile.
Dea della saggezza e
della guerra, rivolta ad instaurare i valori della giustizia, improntò
sempre le sue azioni, anche le più audaci, ad un senso di cauta
riflessione; tuttavia, quando si vedeva offesa nelle sue virtù, conosceva
bruschi impeti d’ira.
La dea eccelleva
nelle opere squisitamente femminili.
Molto infatti si
vantava della propria abilità nel filare la lana, nel tessere e nel
ricamare stoffe, al punto da ritenere che nessuno potesse eguagliarla.
C’era però in Lidia
una fanciulla di nome Aracne che, espertissima del ricamo, andava dicendo
in giro che avrebbe sfidato la stessa Pallade.
La dea furiosa, sotto
le spoglie di una rugosa vecchietta, si recò dalla fanciulla e tentò di
dissuaderla dal suo provocatorio atteggiamento.
Ma in nessun modo
Aracne, fiduciosa nei suoi mezzi, depose la sua arroganza; allora la dea
le si rivelò e le propose una gara.
Pallade ricamò sulla
tela lo splendore dell’Olimpo e la divina maestà degli dei, la fanciulla
invece rappresentò nel suo ricamo le avventure amorose di Zeus.
La bellezza del
lavoro di Aracne era pari a quello della dea, che non poté non ammirarlo,
ma non riuscì nello stesso tempo a sottrarsi ad un impeto di collera, per
cui, adirata per tanta insolenza, distrusse la tela ed i fusi della
fanciulla e trasformò questa in ragno, condannandola con ciò a tessere per
sempre una tela dai fili sottilissimi, la cui trama a malapena si scorge.
Racconta Ovidio
nelle Metamorfosi: " ... Atena …]
poscia partendo la spruzza con sughi di magiche erbette: subito il crine
toccato dal medicamento funesto cadde e col crine le caddero il naso e gli
orecchi: divenne piccolo il capo e per tutte le membra si rimpicciolisce:
l'esili dita s'attaccano, invece dei piedi, nei fianchi: ventre è quel
tanto che resta, da cui vien traendo gli stami e, trasformata in un ragno,
contesse la tela di un tempo"
.
Un’altra dea che non
esitava ad affermare la propria autorità è Hera.
In quanto sposa di
Zeus, divenne di diritto la regina di tutti gli dei, signora dell’Olimpo,
madre di tutti i mortali.
Espressione
della moglie modello, la divina signora era casta e fedele, ma nello
stesso tempo gelosa e ostinata.
"…dei venti favorevoli, per tornare a vedere
moglie e figli, dopo dieci anni, i Greci che invasero questa terra. Quanto
a me, devo cedere innanzi a Hera argiva e ad Atena, che di tutto fecero
pur di sconfiggere i frigi, e abbandonare la regale Ilio e i miei altari."
(Euripide, Troadi, vv. 15-25)
Ritenendo a buon
diritto di essere la più potente e la più maestosa fra le dee,
rifiutandosi di essere screditata dagli ingegni e dalle infedeltà di Zeus,
spesso scendeva sulla terra per punire le Ninfe che avevano suscitato
l’interesse di Zeus.
Così accadde nei
confronti di Io, come pure di un’altra ninfa, Eco.
Costei suscitò la
gelosia della dea che non esitò a mostrare la sua potenza punendola: la
condannò a ripetere in eterno le ultime parole che udiva.
In un’altra occasione
scatenò la sua tremenda ira contro Endimione, un bellissimo pastore figlio
di Zeus e di Calice, che aveva offeso la sua divina maestà: la dea lo
abbandonò ad un sonno eterno in una grotta del monte Latino.
Come capitava alle altre dee, anche Afrodite era
spietata nel colpire coloro che le rifiutavano ossequio; come accadde ad
Ippolito.
"… quanti
abitano entro il Ponto e i limiti di Atlante e vedono la luce del sole,
quelli che rispettano il mio potere io (li) proteggo, mentre quelli che
sono superbi verso di noi io (li) rovino"
(Euripide,
Ippolito, vv.3-6)
A Trezene, nella casa
di Pitteo, viveva il giovane Ippolito, figlio di prime nozze di Teseo.
Questi trascorreva le
sue giornate cacciando, dedito al solo culto della casta Artemide,
coltivando nel cuore una sorta di ostilità nei confronti dell’amore e
delle donne. Afrodite si sentì offesa da quest’atteggiamento e decise di
punirlo: la dea instillò una potente passione d’amore nell’animo di Fedra,
la giovane sposa di Teseo e matrigna di Ippolito.
La regina, non
potendo soddisfare la passione che la divorava, si ammalò.
Solo alla nutrice, in
un attimo di debolezza confessò la sua disgrazia.
La donna allora,
cercando di aiutarla, diede avvio a molte sciagure.
Avvicinò infatti
Ippolito e lo mise al corrente di ciò che la sua signora sentiva per lui.
Veemente fu la
reazione dell’aspro e acerbo giovane, che per Fedra, e per tutte le donne,
seppe trovare solo parole di profondo disprezzo.
Furioso, Ippolito
abbandonò la reggia.
Troppo grande fu per
Fedra l’oltraggio, si suicidò, non prima però di aver lasciato uno scritto
in cui accusava Ippolito di averle usato violenza.
Mentre avvenivano
questi fatti, Teseo tornava dopo una lunga assenza. Dinanzi alla
schiacciante prova di questo scritto non prestò fede alle dichiarazioni di
innocenza del figlio ma lo maledisse e lo esiliò con un bando da Trezene.
Subito la maledizione
si avverò: Ippolito venne travolto dai cavalli del suo cocchio, atterriti
dall’apparizione di un mostro che Posidone aveva fatto sorgere dal mare.
Il giovane straziato
venne portato dinanzi al padre, e prima che morisse la stessa dea Artemide
venne a proclamare la sua innocenza. Ippolito spirò sereno e finalmente la
vanità di Afrodite fu soddisfatta.
Afrodite, dea della
bellezza e dell’amore, nata dalla spuma del mare, approdò sul guscio di
una conchiglia sull’isola di Cipro, in cui si diffuse molto il suo culto.
Venerata in
particolar modo per la sua bellezza, è tuttavia molto astuta, proprio
contando sulla sua qualità caratterizzante riesce a piegare gli uomini al
proprio volere.
All’apparire di
Afrodite, nel cuore degli esseri umani si scatenavano tumultuosi e fervidi
impeti d’amore, che non si smorzavano nemmeno dinanzi ai rischi e ai
pericoli: il troiano Paride si invaghì di Elena e non la riconsegnò agli
Achei se non dopo che la sua patria fu distrutta; Didone, regina di
Cartagine, vistasi abbandonata da Enea, presa da una follia amorosa si
suicidò.
Al contrario di
Afrodite, Artemide chiese al padre Zeus di concederle una vita libera da
ogni passione, lontana da ogni legame sentimentale.
L’unico amore che
doveva esserle riservato, desiderio profondo ed irrinunciabile, era quello
verso la natura, che si esprimeva nelle lunghe scorribande notturne,
dedicate alla caccia, nelle selve silenziose, ma ricche di vita, celata
allo sguardo altrui.
Uniche sue compagne
inseparabili le Ninfe che, come lei, erano votate ad una vita casta, di
semplici costumi, vergini bellissime armate di arco e saette, così come la
stessa Artemide, che queste armi recava sempre con sé, prezioso dono
dell’arte dei Ciclopi.
Zeus permise che la
fanciulla, dea dolce e tenera, ma volitiva, sicura di sé e di animo
indipendente, conducesse la sua vita secondo i propri desideri.
Artemide sapeva però
al tempo stesso punire le ninfe in modo inflessibile, se si sottraevano
alle regole da lei stessa imposte.
In particolare era
attenta al fatto che nessuna di esse venisse meno al giuramento di
castità, o che comunque indulgesse ad un atteggiamento frivolo.
Si racconta infatti
della Ninfa Callisto che non seppe opporsi al fascino di Zeus.
Accondiscese la
fanciulla ai desideri del re degli dei, da cui ebbe il figlio Arcas.
Artemide, con la
compiacenza di Hera, trasformò la ninfa in orsa, poi si diede ad una
caccia mortale, la scovò e la uccise.
Zeus, impietositosi,
l’assunse in cielo sotto forma di costellazione, con il nome appunto di
Orsa.
Il poeta latino
Ovidio, raccogliendo antiche tradizioni, espone in versi la spietata
vendetta che Artemide trasse nei confronti di una fanciulla, la bellissima
Chione.
Costei osò menare
vanto dinanzi ad Artemide di essere più bella di lei e di annoverare tra i
suoi pretendenti addirittura Hermes e Febo.
La dea, scossa da un
moto di sdegno, volle punire in modo esemplare la sfacciata fanciulla.
Le vibrò contro un
dardo che le trapassò la lingua e la gola, lasciandola morire in un
confuso gorgoglio di sangue che a fiotti ella vomitava dalla tremenda
ferita.
Identica
determinazione mostrò Artemide nei confronti di Atteone.
Questo giovane, prode
guerriero e cacciatore, mentre errava tra i boschi, malauguratamente si
imbatté nella dea nel momento in cui questa stava nuda per immergersi in
una fonte.
Osò guardarla. Si
soffusero di rossore le guance della vergine, e per pudore e per sdegno.
Artemide non perdonò
l’incauto. Lo trasformò prima in cervo e poi gli aizzò contro i suoi cani,
che fecero scempio delle carni di lui.
E la dea assisteva
muta, immobile, sorda agli strazianti bramiti dell’animale, che moriva
orrendamente dilaniato.
"[
Artemide attinse l'acqua che aveva ai piedi e la gettò in faccia all'uomo,
inzuppandogli i capelli con quel diluvio di vendetta, e a predire
l'imminente sventura, aggiunse: «Ed ora racconta d'avermi vista senza
veli, se sei in grado di farlo!». Senza altre minacce, sul suo capo
gocciolante impose corna di cervo adulto, gli allungò il collo, gli
appuntì in cima le orecchie, gli mutò le mani in piedi, le braccia in
lunghe zampe, e gli ammantò il corpo di un vello a chiazze. Gli infuse in
più la timidezza. Via fuggì l'eroe, figlio di Autònoe, e mentre fuggiva si
stupì d'essere così veloce. Quando poi vide in uno specchio d'acqua il
proprio aspetto con le corna, «Povero me!» stava per dire: nemmeno un fil
di voce gli uscì. Emise un gemito: quella fu la sua voce, e lacrime gli
scorsero su quel volto non suo; solo lo spirito di un tempo gli rimase […]
lo avvistarono i cani. Melampo e Icnòbate, quel gran segugio, per primi
con un latrato diedero il segnale (Icnòbate di ceppo cretese, Melampo di
razza spartana). Poi di corsa, più veloci di un turbine, si avventarono
gli altri … quei cani da ogni parte l'attorniano e, affondando le zanne
nel corpo, sbranano il loro padrone sotto il simulacro di un cervo: e si
dice che l'ira della bellicosa Diana non fu sazia, finché per le
innumerevoli ferite non finì la sua vita."
(Ovidio, Metamorfosi)
Un altro esempio di
vendetta di Artemide ci è dato dalla vicenda di Niobe, figlia di Tantalo,
che, fiera dei suoi figli, si insuperbì a tal punto da affermare che la
sua prole era degna di ammirazione più dei figli di Letò: Artemide e Febo.
Letò affidò ai suoi
figli il piacere della vendetta. Niobe annichilita dal dolore, stette in
lacrime tra i cadaveri dei suoi figli, lasciati insepolti per nove giorni,
perché gli dei avevano pietrificato i Tebani per non consentire loro di
dare ai morti gli onori funebri.
Alla fine Zeus ne
ebbe pietà. Consentì che i corpi fossero seppelliti e trasformò la donna
in rupe, sul monte Sipilo: ancora oggi, al soffio del vento, quella roccia
geme e stilla lacrime.
Altrettanto decisa
troviamo la dea quando si trattò di punire le empietà di coloro che
avevano trascurato il suo culto, come capitò nei confronti di Oeneo, re di
Calidone.
Sulle terre di questo
re, che aveva omesso di offrirle primizie, la dea scatenò la ferocia di un
grosso cinghiale e tale flagello durò fino a quando il coraggio dell’eroe
Meleagro non ebbe ragione della fiera.
Di Admeto, invece,
che pure si era macchiato della stessa colpa, la dea si vendicò
terrorizzandolo: gli fece trovare accanto nel letto un groviglio di serpi
striscianti.
Durante l’ansiosa
ricerca della figlia, anche Demetra ebbe l’occasione di punire
l’irriverenza di alcuni e di premiare la devozione di altri.
Il re degli Inferi
Ades voleva prendere in moglie Core, figlia di Demetra.
Zeus allora gli
consigliò di rapirla, poiché la fanciulla difficilmente avrebbe
acconsentito alle nozze con la prospettiva di trascorrere il resto dei
suoi giorni nel regno dei morti.
Così Ades, mentre la
fanciulla era intenta a raccogliere fiori, improvvisamente uscì da una
fenditura nel terreno e la condusse con la forza con sé.
Demetra, non vedendo
tornare la figlia, si pose disperata alla sua ricerca. Per nove giorni la
dea, senza mai concedersi alcun ristoro, andò errando sulla terra, finché
il suo pianto non commosse il re degli dei, che le rivelò l’accaduto.
Cercò di
tranquillizzarla, giustificando tutto quanto era avvenuto con la
straordinaria forza d’amore che aveva travolto Ades.
La terribile notizia
esacerbò maggiormente l’afflizione di Demetra. Irritata contro Zeus che
aveva disposto di sua figlia senza nemmeno interpellarla, non volle
tornare più sull’Olimpo e abbandonò il suo solito aspetto di dea,
assumendo le sembianze di una vecchia decrepita, si coprì di cenci e
riprese a percorrere villaggi e campagne, senza meta, come una mendicante
vagabonda, sperando di consumare il suo dolore a furia di stenti e
privazioni.
Giunta ad Eleusi,
esausta, fu accolta dal re Celeo e per manifestare la sua riconoscenza
predilesse il figlio di costui Trittolemo al quale insegnò tutti i segreti
dell’aratura e della semina.
E’ a lui infatti che
si attribuisce la diffusione nel mondo dell’agricoltura e della civiltà
che ad essa è connessa. Trittolemo divenne il primo sacerdote di Demetra,
in onore alla quale istituì ad Eleusi sacri riti e solenni feste.
Demetra, una volta
istituito il suo culto, lasciò Eleusi per riprendere il proprio
vagabondaggio.
Ma il suo cuore non
era mutato, e il suo pensiero era sempre fisso alla sua Core, al modo di
riaverla con sé, alla vendetta che voleva prendere contro Zeus.
Il mezzo per ottenere
queste due cose tanto agognate era tuttavia nelle sue mani, e Demetra lo
mise in opera: siccome ella era la dea dell’agricoltura, con un solo gesto
della sua mano divina rese infruttuosa la terra, per un anno intero non si
raccolse più né un filo d’erba né alcun prodotto della Terra.
La razza degli uomini
era destinata a morire di fame e a scomparire dalla faccia del mondo.
"…con mano spietata spezzò gli aratri che rivoltano
le zolle, furibonda condannò a morte uomini e buoi insieme, e impose ai
seminati di tradire le speranze in essi riposte avvelenando le sementi. La
fertilità di quella regione, decantata in tutto il mondo, è smentita e
distrutta: le messi muoiono già in germoglio, guastandosi per troppo sole
o troppa pioggia; stelle e venti le rovinano, con avidità gli uccelli ne
beccano nei solchi i semi; loglio, rovi e inestirpabile gramigna soffocano
il suo frumento." (Ovidio, Metamorfosi)
Zeus se ne preoccupò
e mandò Iris, la messaggera divina, a placare la sua ira; ma Demetra non
si placò e restò sorda alle suppliche insistenti che Iris le rivolse a
nome del re degli dei. Fu Zeus che dovette scendere a patti.
Fu inviato l’astuto
Hermes ad Ades per ottenere che Core tornasse a rivedere la luce del sole.
Il malinconico dio dell’Averno accondiscese, purché poi sua moglie potesse
tornare a lui.
Si decise allora che
Core per sei mesi avrebbe dimorato nel regno dei morti, assumendo il nome
di Persefone, e per altri sei mesi, invece, sarebbe stata accanto alla
madre col nome di Core.
E’ evidente che il
ritorno di Persefone alla luce rappresenta il gioioso risveglio della
natura a primavera.
Dalle varie vicende
qui narrate emerge un nuovo tipo di donna: una donna del tutto moderna che
entra nell’ambito delle competenze dell’uomo e in alcuni casi gli si
sostituisce egregiamente; basti pensare ad Atena guerriera o ad Hera che
sfida Zeus concependo una figlia senza il suo intervento quando lo scoprì
incinto alla testa di Atena.
Queste donne sono
anche capaci di intervenire nei disegni divini: consapevoli del proprio
potere, rifiutano di accettare passivamente ogni decisione presa dal re
degli dei.
Vi sono poi tre
donne, le Moire, figlie di Zeus e Temi, dee del Fato: Cloto, Lachesi,
Atropo. Persino il signore dell’Olimpo, che pure le ha generate, non può
sfuggire al loro volere.
Sia nei confronti
delle altre divinità, sia nei confronti degli uomini le dee sono capaci di
provare odio, amore, rabbia, sentimenti di vendetta; tutte le passioni che
infiammano i loro animi risultano essere mortali, più che divine: molte di
loro erano quasi del tutto umane, eccetto che per nascita.
L’insediamento di
Zeus come dio padre al di sopra di tutti gli altri dei rappresenta sì la
vittoria del principio della famiglia patriarcale, però questo principio
viene intaccato dalla potenza delle divinità femminili, un’eredità della
società matriarcale che precedette l’avvento del matrimonio.
______________________________________________________


Introduzione
Per parlare dei ruoli
femminili nella tragedia, occorre fare una premessa sulla condizione delle
donne nell’età classica.
Tutti sono d’accordo
sul fatto che la condizione della donna nell’Atene classica era
d’inferiorità legale e politica, mentre riguardo alla sua posizione
sociale esistono diverse opinioni.
Alcuni studiosi
ritengono che le donne fossero disprezzate e tenute in uno stato di
segregazione di tipo orientale, altri affermano che fossero rispettate e
avessero una libertà simile a quella goduta dalla maggior parte delle
donne attraverso i secoli, almeno fino all’avvento del movimento
femminista.
Altri studiosi sono
invece dell’avviso che le donne vivessero segregate ma che fossero lo
stesso stimate dagli uomini, tanto è vero che a loro era affidato il
governo della casa.
La divergenza
d’opinioni è dovuta alla natura delle testimonianze consultate.
Studiosi quali Gomme
e quanti si sono posti sulla sua scia, basandosi prevalentemente sulle
testimonianze della tragedia classica e ritenendo che le eroine fossero
modellate direttamente sulle Ateniesi del V secolo a.C., concludono che le
donne erano rispettate e non vivevano segregate.
Lacey, che rifiuta
esplicitamente le testimonianze della tragedia poiché non rappresenta
gente comune in una famiglia normale, ed Ehrenberg, che riconosce valore
testimoniale solo ad Euripide, mentre considera Eschilo e Sofocle meno
vicini alla realtà, dipingono un quadro più infelice della condizione
della donna.
Le donne di Eschilo.
Il comportamento
degli uomini e delle donne è esplorato in molte tragedie, pur non
essendone sempre il tema principale.
Da sempre il
comportamento femminile è contraddistinto da docilità e modestia. Ismene
nell’Antigone, Tecmessa nell’Aiace, Deianira nelle
Vergini trachinie, e le coreute nella tragedia rappresentano le donne
normali.
Le eroine che si
allontano da questo stereotipo talvolta sono definite "mascoline", una
definizione che di certo non può essere considerata un complimento per una
donna.
Le eroine, come gli
eroi, non sono persone normali.
Mentre la maggior
parte delle donne si sottomette docilmente, alcune eroine come
Clitemnestra, Antigone, ed Ecuba, per raggiungere i propri fini,
acquistano tratti del sesso dominante. Tale fenomeno è stato definito
dallo psicanalista Adler "protesta mascolina".
L’Orestea si
annuncia fin dal principio sotto il segno di un’ambigua confusione dei
sessi. La prima connotazione di Clitemnestra è, infatti, quella della
virilità.
"Così comanda il
cuore nell’attesa di una donna di virili propositi" afferma
inizialmente la sentinella (10,1).
La donna non
femminile, che usurpa le funzioni del maschio, domina tutto l’Agamennone:
Clitemnestra governa la città in assenza d’Agamennone, e la governa non
diversamente da un uomo, con la forza e l’intelligenza.
Il coro n’è dominato
e ammirato quando Clitemnestra spiega come ha predisposto lo stratagemma
del fuoco. Eppure, anche se il suo intendimento è quello di un uomo saggio
(351), la sua condizione femminile è più volte esplicitamente ricordata in
quasi tutte le invocazioni del coro (317,351, etc.).
Due tratti vanno però
notati particolarmente. Il primo è il suo rapporto con Egisto. Costui ha
piuttosto una figura di paredro che d’amante, si potrebbe dire di
concubino della regina, conquistato non conquistatore.
La passività d’Egisto
è ripetutamente sottolineata con il tratto che più di ogni altro lo
accomuna ad una donna: il non aver partecipato ad alcuna impresa eroica,
l’esser rimasto in casa.
Domestico (oikouros)
è la marca distintiva di Egisto (1225, 1626) e anche leone imbelle (leon
analkis) e donna (gyne).
Dunque la relazione
tra Clitemnestra ed Egisto appare capovolta rispetto ai canoni normali.
Il secondo tratto
distintivo di Clitemnestra: Clitemnestra resta l’unico personaggio
intrepido nella generale atmosfera di paura, presente già nel discorso
proemiale della sentinella e ripresa poi nelle premonizioni del coro per
proseguire negli interventi del soldato, di Agamennone e di Cassandra, Il
timore è estraneo ai suoi discorsi.
Soltanto alle fine,
dopo l’assassinio, ella accenna alla paura ma per dirsene immune:
"Voi mi tentate
come donna insensata, ma io parlo con cuore intrepido (atrestoi
kardiai) a chi lo sa" (1401-2); e poco dopo afferma: "l’attesa
della paura (phobou elpis) non entrerà nella mia casa
finché nel mio focolare accenderà il fuoco Egisto, benevolo a me come in
passato. Egli è non piccolo scudo al mio coraggio".
L’uomo ucciso da una
donna ed ucciso con il ferro, doppia trasgressione: è il punto supremo di
una klimax di estraniazione di Clitemnestra dal proprio sesso, di
usurpazione delle prerogative del maschio.
Tanto più
significativo dunque il rientro di Clitemnestra nella femminilità, che si
avvia nelle ultime scene dell’Agamennone (riconoscimento del ruolo
maschile di Egisto) e che prosegue nelle Coefore.
Tutta l’azione della
seconda tragedia è mossa da una paura notturna di Clitemnestra, da un
sogno terrificante, che la induce a far sacrificare sulla tomba di
Agamennone.
La paura è entrata
nel palazzo, la donna senza timori è atterrita; alla luce del focolare
sono succedute le tenebre della notte.
L’ultima occorrenza
di phobos nell’Agamennone (1434) e la prima nelle Coefore
(35) scandiscono questo capovolgimento.
La reintegrazione di
Clitemnestra nel suo ruolo femminile trova sanzione suprema nel momento
del suo assassinio: " Abbi dunque rispetto di questo seno" (897),
esclama Clitemnestra, indicando ad Oreste il proprio petto.
Vedere in
Clitemnestra l’androgino o nell’Orestea l’incubo del matriarcato
non appare esauriente. Clitemnestra non è solo la donna-uomo, è anche la
donna-demone.
"Affermi che
questo è un’opera mia. Non dire che io sono la moglie di Agamennone. Sotto
l’immagine della donna di questo morto è l’antico aspro demone vendicatore
(alastor) di Atreo che ha fatto pagare il tremendo banchetto,
sacrificando quest’uomo a quei bambini" (1497-1503).
Nelle Coefore
Clitemnestra ed Egisto sono indicati come mostri: "Hai agito bene -
è il coro che cerca di confortare Oreste dopo il matricidio - non
aggiogare la tua bocca ad una voce maligna, non maledirti, dopo che hai
liberato tutta la città argiva, mozzando la testa ai due serpenti (duoin
drakontoin)" (1049).
E’ tuttavia
un’inutile consolazione: Oreste è ormai preda dell’orrenda visione delle
Erinni "dagli oscuri chitoni, con le chiome intrecciate di fitti
serpenti (pyknois drakousin)" (1049).
La continuità
Clitemnestra-Erinni appare esplicitamente rappresentata all’inizio delle
Eumenidi. Qui l’incubo di Oreste acquista consistenza spettacolare:
il coro delle Erinni si manifesta in tutto il suo orrore, e a incalzarle
nel loro accanimento infernale è lo spettro di Clitemnestra.La
demonizzazione della donna appare qui scenicamente compiuta.
Le donne di Sofocle
L’Antigone
inizia con i lamenti delle figlie di Edipo per le leggi emanate dal
tiranno Creonte. Il loro fratello Polinice è morto, ma Creonte ha proibito
di seppellirne il cadavere per punirlo del tradimento della terra natia.
Mentre Antigone preme
perché il fratello venga seppellito, la sorella Ismene tenta di
dissuaderla affermando: "Noi nascemmo donne, e ciò significa che non
siamo destinate ad opporci agli uomini" (61-62). Essa si serve spesso
del verbo phyo, intendendo che per natura le donne
non possono competere con gli uomini.
Creonte rivela una
particolare ostilità per il sesso opposto. I suoi pregiudizi sono
patriarcali. Egli non riesce a comprendere l’amore di suo figlio Emone per
Antigone e considera una moglie "un campo da arare" (569).
Antigone però per due
volte tenta di dare sepoltura al fratello finché non viene sorpresa dalle
guardie mentre seppellisce Polinice contro gli ordini della città e così
viene chiusa in una grotta sotterranea per ordine di Creonte.
Nel suo penultimo
discorso Antigone spiega di essere disposta a morire per un fratello, ma
non per un marito o un figlio.
Un certo numero di
studiosi ha giudicato spurio il discorso, ritenendo anormale anteporre il
fratello al figlio, eppure nel contesto dell’Atene classica la scelta di
Antigone è ragionevole. Le madri non avrebbero potuto essere legate ai
loro figli come è oggi la madre ideale. L’elevata mortalità dei bambini
piccoli avrebbe scoraggiato la formazione di solidi legami tra madre e
figlio. Inoltre l’autorità patriarcale affermava che il figlio apparteneva
al padre. Egli lo teneva in caso di scioglimento del matrimonio, mentre la
donna tornava sotto la tutela del padre o, se questo era morto, del
fratello. Quindi il legame fratello-sorella era molto forte.
La preferenza per il
fratello è anche caratteristica della donna mascolina, il cui rifiuto del
ruolo tradizionale di moglie e di madre può essere la conseguenza del
fatto che forze esterne le inibiscono manifestazioni di tenerezza o di
istinto materno.
Alla fine Antigone
ritorna a un ruolo femminile tradizionale. Rimpiange di dover morire
vergine, nubile e senza figli (917-18), e si suicida dopo essere stata
sepolta viva da Creonte. Nella mitologia classica il suicidio rappresenta
un modo di morire femminile e un po’ codardo.
L’incapacità di
Creonte di comprendere l’ineluttabilità del dualismo tra maschi e femmine
conduce alla morte di Antigone e al suo annientamento. La moglie di
Creonte muore maledicendolo.
Inoltre, in una
società in cui ci si attende che i figli maschi mostrino obbedienza
filiale, Emone antepone Antigone al padre, trafiggendosi sul cadavere di
lei.
Antigone
e molte altre tragedie mostrano le conseguenze della sopravvalutazione
delle qualità dette maschili (dominio, conquista, eccessiva attività
mentale) a spese di quegli aspetti della vita detti femminili (istinto,
amore, vincoli familiari), che distruggono uomini come Creonte.
L’ideale era
l’armonia tra valori maschili e femminili, subordinando i secondi ai
primi.
Le donne di Euripide
Ecuba è la
protagonista di due tragedie d’Euripide: Ecuba e
Troiane.
Vi ritornano alcune
connotazioni proprie della tradizione: la vecchiaia, la maternità ferita,
le sventure che, dopo una vita fortunata, si succedono fino a quella
suprema della schiavitù.
Fulcro drammatico di
entrambe le tragedie, il personaggio presenta dall’una all’altra una
differenza fondamentale: nell’Ecuba agisce, nelle Troiane si
lamenta.
Sempre però è
peculiare la tensione, la contraddittorietà tra mater dolorosa, la
vecchia che piange i propri morti, e l’abilissima argomentatrice
dialettica: si ricordino nell’Ecuba il discorso sui rapporti tra
divinità e legge, nelle Troiane l’agguerrita discussione con Elena.
Alla critica, questa
vecchia in lutto, ripiegata sul proprio dolore, che improvvisamente si
trasforma in accorta parlatrice, è sempre apparsa come una figura poco
coerente e di conseguenza drammaticamente poco riuscita.
Clitemnestra ed Ecuba:
due esempi di trasgressione. Apertamente terrificante il personaggio di
Clitemnestra, molto inquietante, anche se in parte coinvolto nel
compatimento, quello di Ecuba.
La trasgressione
femminile conosce però altri modi, in cui l’iniziativa della donna non si
pone affatto sotto il segno della vendetta cruenta, ma al contrario di un
destino di vittima.
La flotta greca è
ferma in Aulide per la mancanza di condizioni favorevoli alla navigazione;
è necessario, spiega l’indovino Calcante, che il condottiero di tutti, il
grande Agamennone, sacrifichi la propria figlia per propiziarsi gli dei.
La drammatizzazione di questo mito costituisce l’Ifigenia in Aulide
euripidea.
Agamennone chiama in
Aulide Ifigenia per darla in moglie, così egli fa credere, ad Achille.
L’inganno viene scoperto. Clitemnestra tenta di impedire l’uccisione della
figlia, quindi il colpo di scena: Ifigenia si offre volontariamente al
sacrificio per il buon esito della spedizione.
Analoga offerta era
stata quella di Macaria (Eraclidi) e di Polissena (Ecuba): "A me la
grande Grecia tutta or guarda, da me dipende il viaggio della flotta e la
distruzione dei Frigi e che non più in avvenire i barbari possano rapire
dalla felice Grecia le donne, dopo aver pagato il disastro di Elena rapita
da Paride. Tutto questo con la mia morte realizzerò, e mia sarà gloria
beata per aver liberato la Grecia" (Iph. A. 1378-84).
Un’immagine di sé,
della propria libertà come bene supremo, della propria gloria eterna nel
cadere per la patria. Tutte queste motivazioni, pur diverse tra loro, sono
riconducibili ad una concezione della morte tipicamente maschile. Vi è una
sorta di usurpazione di ruolo nel difendere la patria e nel procurarsi la
gloria, che la tradizione gnomica considera compiti dell’uomo.
Medea rappresenta una
delle più grandi figure dell’arte di Euripide e della poesia di tutti i
tempi.Creatura di passioni e di istinti, che si direbbero disumani se lei
non fosse così potentemente e intimamente donna la cui ragione serve solo
a renderla consapevolmente feroce, senza porre un freno all’animo
indomito.
Già prima, innamorata
di Giasone, non ha esitato a uccidere, per lui, il padre ed il fratello.
Gli stessi figli gli sono cari non perché li abbia partoriti, ma perché
sono pegno dell’amore di lui.
Ora questa natura
selvaggia è minacciata in qualcosa di più importante dell’amore, la sua
stessa vita. Ciò che la sconvolge non è la gelosia, sebbene furiosa, ma è
l’istinto di conservazione: non si uccide o uccide Giasone, ma elimina ciò
che è di ostacolo tra loro.
E arriva all’ultimo e
più atroce delitto, quando i figli sono resi da lei inconsapevoli
strumenti di vendetta.
Tuttavia Medea
giganteggia nella poesia con la dedizione assoluta e totale verso l’uomo
che l’ha resa donna, con la lotta disperata contro tutto e tutti e più
ancora contro se stessa, con gli impulsi indomabili e la debolezza di una
donna abbandonata.
Di fronte a lei,
Giasone non è che un pover’uomo, orgoglioso della sua mascolinità: il
poeta è riuscito a lasciare tale figura nella mediocrità della sua scialba
persona.
Anche nella scena
finale, nella quale il poeta sembra quasi volergli far guadagnare la
simpatia degli spettatori mostrandolo oppresso e distrutto da tanta
sventura, anche allora Giasone non riesce a destare pietà e rimane anzi
piuttosto ridicolo, con le sue vane imprecazioni contro Medea che si leva
alta nel cielo, superba di spietata ferocia, e che, pur carica di orrori e
di delitti, rimane una creatura splendidamente viva di verità e poesia.
Fedra, con l’atroce
Medea e la mite Alcesti, costituisce la grande triade delle creazioni
femminili di Euripide.
Che ella sia lo
strumento della vendetta di Afrodite contro Ippolito, che la dea stessa le
abbia ispirato l’incestuoso e impossibile amore, è proprio ciò che la
rende più nobile nell’impari lotta contro la dea; una lotta nella quale
ella tuttavia salva l’onore.
Ciò che costituisce
la poesia della figura di Fedra e la sua vera novità, è la grandezza di
questo suo amore vietato, che invano ella vuole negare a se stessa prima
che agli altri e di cui soffre tutta l’ineluttabile potenza ed amara
dolcezza.
Ma, pur vittima di
Afrodite, saprà tener fede al suo dovere, saprà rispettare il talamo
nuziale: non farà come altre donne che, che dedite ad amori colpevoli,
osano fingere e ingannare i mariti.
La lotta della
ragione contro la passione, la rivolta dell’anima contro l’oppressione
della morale convenzionale, il diritto della donna al suo amore, amore per
il quale morrà non potendo viverne, fanno di Fedra una figura eterna.
Quanto Fedra è
poeticamente vera e viva, Ippolito è soltanto una costruzione
intellettualistica e raziocinatrice. Entrambi però hanno in comune
l’intima coerenza, la dedizione totale al rispettivo opposto destino: ma
mentre Fedra è vittima di una potenza troppo forte, Ippolito è consapevole
volontà.
Conclusione
I personaggi
femminili della tragedia greca sono personaggi "autenticamente"
drammatici, molto più che quelli maschili: la loro grandezza è nel fatto
che i drammi da esse vissuti sono i drammi che da sempre esse vivono.
Le passioni, i
dolori, le attese e le speranze di queste creature ci ricordano quelle che
oggi come ieri le donne vivono in ogni latitudine.
Questo è il segno
della grandezza artistica dei tre tragici greci.
______________________________________________________
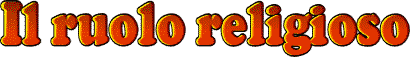
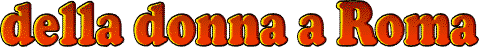
Nel vasto panorama
della religione romana la donna svolgeva sempre un ruolo secondario,
addirittura occupava una posizione marginale, essendo esclusa da culti
religiosi e frequentando talvolta santuari suburbani.
Le funzioni
sacerdotali pubbliche spettavano esclusivamente agli uomini, sacerdoti o
magistrati, che tenevano le liturgie pubbliche e custodivano i doveri
religiosi dello Stato e il potere do formulare ed interpretare il diritto
sacro.
Sacerdoti e
magistrati avevano l’incarico di enunciare la volontà divina e di
esaminare e porre rimedio ai problemi religiosi. Inoltre i grandi
sacerdoti erano eletti nei comizi.
Alle stesse cerimonie
religiose le donne non prendevano parte come a quella dedicata alla dea
Dia il cui potere e la cui funzione erano rappresentate da uomini ossia
dal flamine e da confraternite; così avveniva anche per le liturgie in
onore di Cerere, Flora e di altre divinità romane.
Anche all’interno dei
culti domestici il ruolo di primo piano era svolto dagli uomini che
celebravano i sacrifici per l’intera famiglia. Anche i grandi ruoli
domestici erano dominati dagli uomini: nelle feste dei morti, sia in
febbraio che in maggio e nei funerali, gli uomini pronunciavano gli elogi,
celebravano i sacrifici e guidavano i cortei.
Esistevano cerimonie
cui era vietato che le donne partecipassero, così come i prigionieri e gli
stranieri: Paolo Diacono, epitomatore del dizionario di Festo, racconta
che il littore le allontanasse gridando.
Alle donne, come
riporta Plutarco, era imposto anche il divieto di macerare i cereali e di
preparare le carni, divieto che risaliva al ratto delle Sabine ed al patto
stipulato in seguito tra Roma e i Sabini.
Tale divieto
riguardava i momenti principali dei due più importanti settori alimentari,
cioè la molitura dei cereali e lo scarico delle carni. La proibizione, che
le donne non potessero svolgere delle attività di macelleria, coincideva
con la loro esclusione dallo svolgere sacrifici; specificamente il divieto
della molitura dei cereali impediva alle donne l’utilizzo di un
ingrediente necessario al sacrificio (la farina di farro designata con il
termine di "farina rituale").
Infine le donne non
potevano bere vino puro; infatti venivano allontanate dal sacrificio
proprio perché il vino simboleggiava l’offerta sacrificale per eccellenza
e poneva gli uomini in contrasto con gli dei.
La donna dell’antica
Roma appare, quindi, in quanto tale, incapace di celebrare i culti
religiosi che diventavano pertanto a tutti gli effetti compiti degli
uomini.
Ma in realtà
l’esclusione delle donne non risultava assoluta, come del resto
testimoniano le parole di Plutarco secondo cui la molitura dei cereali e
la preparazione delle carni erano impedite alle donne solo se svolte per
il proprio marito. Si tratta di un divieto che, nell’intento di liberare
le spose romane dai compiti materiali (eccetto la tessitura), valeva
esclusivamente nell’ambito familiare, privato e non di certo pubblico.
Esistevano di fatto
delle eccezioni nell’antica religione: la prima, rappresentata dalle
Vestali, ossia dalle sacerdotesse pubbliche che costituivano appunto
un’eccezione nel mondo sacerdotale romano, proprio in quanto questo erano
quasi interamente composto da uomini.
Le sei vergini
vestali avevano l’incarico di mantenere, sotto l’autorità della grande
vergine Vestale, il focolare pubblico nel santuario di Vesta. Le Vestali
iniziavano il loro servizio prima della pubertà e lo svolgevano per trenta
anni, di cui dieci dedicati all’apprendimento, dieci al servizio vero e
proprio e dieci all’insegnamento. Vivevano in una casa adiacente al
santuario ed erano sottomesse all’obbligo della verginità che, per un voto
di astinenza sessuale totale, coincideva con la pudicizia della matrona
romana, fedele ad un solo uomo ed austera nel contegno. Esse dovevano
rappresentare la natura della Dea di cui celebravano il culto; quindi
dovevano essere esempio della sua purezza.
Le Vestali divenivano
tali nel corso di una cerimonia, simile ai riti del matrimonio romano, in
cui il Pontefice Massimo le sceglieva ricevendole dalle mani del padre. La
Vestale durante tutto il servizio portava la cuffia rossa e la pettinatura
a sei trecce della matrona romana ed era, inoltre, sottoposta al Pontefice
Massimo (che esercitava su di lei lo stesso potere di un "pater familias")
il quale poteva punire duramente le sacerdotesse qualora fossero state
colpevoli dello spegnimento della fiamma del fuoco di Vesta o fossero
venute meno al voto di castità (epotevano essere anche seppellite vive).
Sotto molti punti di
vista le Vestali somigliavano agli uomini in quanto si occupavano della
tostatura, frantumazione e molitura delle spighe di farro da cui
preparavano "la mola salsa", una farina rituale che veniva sparsa sugli
animali condotti al sacrificio e su ogni altra offerta fatta agli dei (da
questo, il termine "immolare" = "in molare: cospargere di mola). Le
Vestali prendevano parte, come gli uomini, a tutti i grandi sacrifici e,
come testimoniano diverse fonti, anche alle offerte di vittime animali,
tanto è vero che esse possedevano un coltello sacrificale, la "secespita",
e detenevano quindi a tutti gli effetti i poteri di fare sacrifici.
Tuttavia le Vestali
non erano né matrone né fanciulle, erano di fatto tutte e due insieme ed
erano anche in un certo senso uomini per tutta una serie di privilegi di
cui godevano: potevano testimoniare in tribunale, avere un littore,
sfuggire alla tutela di un padre o di un marito, disporre liberamente dei
propri beni.
Lo statuto sessuale
delle Vestali era piuttosto ambiguo e questo era forse il motivo per cui
esse potevano godere di privilegi destinati agli uomini.
Oltre alle Vestali
avevano la possibilità di compiere sacrifici… la sposa del flamine di
Giove e quella del re dei riti sacri, rispettivamente la Flaminica di
Giove (Flaminica Dialis) e la Regina Sacrorum. Mentre il flamine
sacrificava a Giove ogni mese il giorno delle idi (13 o 15), la flaminica
offriva al dio tutti i giorni di mercato un ariete. La Regina Sacrorum,
invece, offriva nelle calende (1° giorno di ogni mese) una scrofa o un
agnello a Giunone.
Nonostante ciò né la
Flaminica Diale, né la Regina dei riti sacri potevano essere considerate
come vere e proprie eccezioni alla regola, in quanto i loro poteri
derivavano, forse, ancora una volta, del loro statuto.
Infatti i Flamini e
il Rex Sacrorum, a differenza degli altri sacerdoti, le cui funzioni non
dipendevano da categorie sessuali o domestiche, erano sacerdoti proprio in
quanto domini, cioè uomini con una vita familiare completa, ossia
necessariamente con una moglie. La coppia flaminale formava un’unità
indivisibile e il suo servizio era maggiore proprio in quanto servizio di
una coppia e non di un individuo (il flamine infatti lasciava il suo
compito alla morte della moglie).
La stessa cosa
avveniva per la Regina e il Rex Sacrorum, a testimonianza del fatto che i
poteri sacrificali di tali sacerdotesse derivavano dai legami con i
mariti.
Ancora altri
sacerdozi femminili erano quelli delle Vergini Salie, complemento
femminile dei Salii, che svolgevano processioni guerriere all’apertura e
alla chiusura di un periodo di guerra.
Delle Vergini Salie
si sa poco o nulla: in particolare che offrivano un sacrificio nella Regia
e portavano l’"apex" (cuffia a punta) e il mantello militare dei Salii.
LE LITURGIE MATRONALI
Gli esempi più numerosi di condotta sacerdotale
"autonoma" e di sacrifici compiuti da donne provengono da culti celebrati
dalle matrone di cui se ne riportano taluni.
None Caprotine e
Matronalia
Nel corso di alcune
feste tradizionali, le matrone offrivano "sacrifici non cruenti".
Infatti alle None
Caprotine, in cui celebravano la fecondità femminile (7 luglio), le donne
libere e le serve sacrificavano a Giunone del latte di fico; invece ai
Matronalia (1 marzo) le matrone offrivano fiori a Giunone per
l’anniversario del suo tempio sull’Esquilino. Nello stesso giorno,
inoltre, i mariti pregavano per la loro salute e regalavano loro denari e
doni per le piccole spese che esse adoperavano soprattutto per organizzare
il banchetto per gli schiavi maschi della loro famiglia (le spiegazioni
antiche di questa festa riguardano soprattutto la nascita di Romolo e la
fecondità delle donne).
I Matralia
Ai Matralia (11
giugno) le matrone di buona famiglia si recavano al tempio di Mater Matuta,
sul Foro Boario, in cui prima introducevano eccezionalmente una schiava,
la quale in seguito cacciavano violentemente, e poi prendevano in braccio
e coccolavano i figli delle loro sorelle raccomandandoli alla dea. Si
tratterebbe, dunque, della rappresentazione del mito di Aurora,
interpretato dalle matrone, che caccia le tenebre notturne, interpretate
da una schiava, e che porta nel mondo liberato dalle tenebre il sole. In
ogni caso, da questi esempi, possiamo dedurre che la presenza delle donne
era necessaria per la celebrazione dei grandi rituali pubblici, in quanto
trattavano della fecondità.
Festa di Venere
Verticordia e di Fortuna Virile
Celebrata il 1
aprile, comprendeva come rito principale un bagno che le donne facevano
prendere alla statua di Venere Verticordia, che si pensava volgesse i loro
cuori verso la castità e verso il compimento dei loro doveri matrimoniali;
poi la statua veniva di nuovo adornata con i suoi gioielli e fiori. In
seguito anche le donne si bagnavano nelle terme con mirto e durante questo
bagno esse rivolgevano suppliche e glorificavano con un’offerta di incenso
Fortuna Virile, consumando un beveraggio composto di latte, miele e
papavero. Insomma con il suo fascino Venere Verticordia rendeva possibili
le unioni sessuali ed in ciò favoriva gli effetti positivi che la donna
provocava nell’uomo.
La festa del primo
giorno del mese di Venere consisteva in un’invocazione di Venere
Verticordia e di Fortuna Virile da parte delle donne di "ogni rango" e di
ogni condizione, che chiedevano alle dee unioni coniugali o sessuali
coronate da successo.
Fortuna Muliebris
Il 6 luglio le
matrone si recavano al quarto miglio della via Latina per sacrificare a
Fortuna Muliebris. Secondo la leggenda, la sacerdotessa di questo culto
era una matrona maritata in prime nozze.
La storia, che gli
antichi raccontano circa questo culto, pone la fondazione del santuario di
Fortuna Muliebris nel contesto della guerra contro Coriolano: di fronte
all’impotenza degli uomini, le donne guidate dalla madre e dalla moglie di
Coriolano, si recarono in processione nel suo campo e riuscirono a fargli
togliere l’assedio. Per commemorare questo evento, le autorità romane
decisero di accordare alle donne un privilegio che desiderassero: esse
chiesero che un santuario di Fortuna Muliebris venisse costruito sul luogo
che era stato il teatro del loro successo e che ogni anno avessero il
diritto di celebrarvi un sacrificio. In tale contesto l’aspetto più
significativo è rappresentato dal fatto che le matrone agivano come uomini
nella guerra come nel culto effettuando sacrifici.
Pudicitia
Nel culto di
Pudicitia (castità matronale), le matrone si comportavano come un gruppo
che poteva prendere decisioni, concedere e sottrarre diritti. Secondo la
tradizione una patrizia, che aveva sposato un plebeo, fu esclusa dal culto
di Pudicitia perché era decaduta. In segno di protesta l’esclusa fondò un
nuovo culto destinato a "Pudicitia plebeia", riservato alle donne della
plebe, in cui il regolamento del culto accordava alle matrone fedeli allo
sposo il diritto di sacrificare. Tuttavia, come gli altri riti in cui
venivano coinvolte matrone, questi sacrifici erano celebrati a porte
chiuse senza la presenza maschile.
|
|
|


![]()
![]()