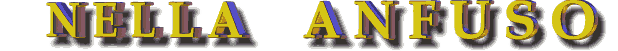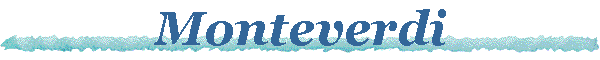Parole dure, ma corrispondenti
al vero, da parte di chi aveva dedicato gran parte della sua vita
e della sua attività al grande Cremonese. In effetti, l’orgia lucrativa
del 1967 segna l’inizio di quella moda “early music” che, a parte
isolatissimi casi, ha contribuito essenzialmente alla messa alla
berlina di un patrimonio vocale e musicale plurisecolare. Una operazione
di cui Malipiero, scomparso nel 1973, ha ben visto l’inizio e ne
ha intuito tutto l’aspetto negativo. Chissà cosa direbbe oggi il
povero Gian Francesco dopo le scorpacciate propinate da alcuni furbastri,
in veste di “direttori barocchi” (ruolo non molto propriamente filologico…)
che sfornano edizioni su edizioni, tutte eguali e tutte non solo
false, ma brutte.
Bisogna dire che Monteverdi è talmente grande che supera tutti gli
imbrattamenti e le deturpazioni possibili.
Eppure la storia della riappropriazione del genio monteverdiano,
a cui accennerò appena poiché sarà argomento di approfondimento
del Prof. Renzo Cresti, qualcosa avrebbe dovuto insegnare. Nel
“Libro Segreto” del 1935 D’Annunzio ricorda:
“La sera del dì tredici d’agosto, dieci
giorni dopo l’arringa improvvisa agli “uomini milanesi”, io giungevo
da Asolo al Vittoriale degli Italiani: ed ero subito introdotto
nell’Officina di Gabriele D’Annunzio, in grazia di Gian Francesco
Malipiero a lui diletto sopra tutti i trovatori di nuove musiche.
Gli recavo, eseguita per lui solo, manoscritta per lui solo, la
prima riduzione del terzo Libro de’ Madrigali di Claudio Monteverde
– quattro viole e un violoncello.
La stupenda edizione di Tutte le Opere del divino Claudio – onore
perpetuo del giovine maestro veneziano – non era ancor venuta in
luce. ma io recavo la primizia in offerta al poeta che
solo, contro tanta ignoranza e tanto oblio, fin dall’agosto 1900
nel suo libri “Il fuoco” aveva scritto: “Bisogna glorificare il
più grande degli innovatori, che la passione e la morte consacrarono
veneziano, colui che ha il sepolcro nella chiesa dei Frari, degno
d’un pellegrinaggio; il divino Claudio Monteverde: anima eroica
di pura essenza italiana”.
Non v’è spirito bennato che possa dimenticare le pagine di quel
libro sul Lamento d’Arianna stampato da Bartolomeo Magni a Venezia
nel 1623. Gabriele D’Annunzio possedeva la stampa del Gardano,
l’unico esemplare rimasto oltre quello custodito nella Biblioteca
di Gent”.
Malipiero, da parte sua,
ricorda ne “Il filo d’Arianna” edito a Torino nel 1966 l’amore
del poeta per il Cremonese: “ Per fargli sentire i madrigali
di Monteverdi, non disponendo delle voci, li feci trascrivere per
cinque istrumenti ad arco (…). Gli dedicai, dal terzo tomo
[1927] in poi, l’edizione di tutte le opere di Claudio Monteverdi;
le gradì veramente, con gioia quasi infantile”. Ricordiamo che
l’opera omnia monteverdiana del Malipiero porta la doppia indicazione:
Asolo - Nel Vittoriale degli Italiani.
Come ricordato dallo stesso D’Annunzio, già nel 1900 egli aveva
osannato il genio del Monteverdi ed è significativo che sia un poeta,
cioè colui che per l’essenza stessa della sua arte “lavora” con
le caratteristiche fonico-semantiche della parola, a comprendere
la grandezza dell’invocazione “Lasciatemi morire” dell’Arianna.
E non è assolutamente un caso che sia Arianna, la Arianna che ha
costituito il punto più alto delle speculazioni estetiche del divino
Claudio, la preferita del poeta abruzzese.
Aveva scritto infatti Monteverdi in una sua lettera del 22 ottobre
1633: “quando fui per scrivere il pianto del Arianna, non trovando
libro che mi aprisse la via naturale alla imitatione ne meno che
mi illuminasse che dovessi essere imitatore, altri che Platone per
via di un suo lume rinchiuso così che appena potevo di lontano con
la mia debil vista quel poco che mi mostrasse; ho provato dicco
la gran fatica che sia bisogno fare in far quel poco ch’io feci
d’immitatione (…)”.
Sono parole di immensa
portata per la retta comprensione dell’arte monteverdiana, parole
non isolate nell’epistolario del Monteverdi, come dimostra
un altro passo della lettera del 2 febbraio 1634, passo che chiarisce
il credo filosofico ed estetico del divino Claudio: “(…) rivoltai
gli miei studi per altra via appagandoli sopra a fondamenti de migliori
filosofi scrutatori de la natura, et perché secondo ch’io leggo,
veggo che s’incontrano gli affetti con le dette ragioni et con la
sodisfatione de la natura (…) et provo realmente che non ha che
fare queste presenti regole, con le dette sodisfationi, per tal
fondamento ho posto quel nome di seconda pratica, (…) perché la
mia intenzione è di mostrare con il mezzo della nostra pratica quanto
ho potuto trarre da la mente de’ quei filosofi a servitio de la
bona arte, et non a principii de la prima pratica, armonica solamente”.
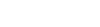

Sono parole straordinarie ed illuminanti sulla vera essenza dell’arte
monteverdiana, ma che gli studiosi hanno ignorato, e continuano
ad ignorare, per motivi imperscrutabili: ignoranza? disinteresse?
impreparazione storica e filosofica?
Rimane il fatto che non solo l’epistolario, ma tutti gli scritti
monteverdiani pervenutici hanno dovuto “aspettare” Annibale Gianuario
per una adeguata disamina, precisa e profonda. Ma di tutto questo
parlerà in questo Convegno il Prof. Bruno Pinchard.
Desidero solo notare che la cultura italiana è priva, ancora,
della coscienza, e “conoscenza”, dell’importanza veramente viva
ed operante del platonismo fiorentino nei secoli XV e XVI, a cominciare
dall’età laurenziana. Ciò spiega la disinvolta noncuranza nei confronti
di molta produzione artistica di vario genere di quegli splendidi
anni della cultura fiorentina, da quella poetica a quella pittorica;
con la conseguente impossibilità di conoscere veramente, e gustare,
un patrimonio fondamentale della nostra storia, a cominciare dal
Canzoniere del Magnifico Lorenzo, dalla Primavera botticelliana
e dal significato misterico - orfico delle Grazie. In tale attuale
stato di cose figuriamoci l’atteggiamento della musicologia ufficiale
nei confronti di musicisti che si permettono di “citare” (ed in
effetti viene considerato semplicemente come un vezzo “di citazione”)
Platone!
L’insipienza e l’ignoranza della cultura massificata contribuiscono
sicuramente alla misconoscenza del vero essere della autentica “alta”
cultura. Certo che è più facile seguire pedissequamente catalogazioni
superficiali di comodo e ridicole. Ad esempio, poiché Monteverdi
è stato catalogato come padre dell’ “opera”, si è pensato bene,
per il piacere di organizzatori, impresari e teatri d’opera, di
appioppare, ad imitazione wagneriana, una “trilogia”
anche al Monteverdi, credendo così di “elevarlo” (sic) e di
far tornare i conti con la Storia e con l’Arte. Il che sarebbe veramente
comico se non fosse invece tragico nella sua comicità.
In effetti l’aspetto tragico in tutto ciò è che una data visione
estetica dell’arte musicale, il cui linguaggio è squisitamente “uditivo”,
si ripercuote sull’aspetto esecutivo che è, in ultima analisi, il
solo elemento che quindi permette all’opera d’arte di “essere”.
Leonardo affermava nel capitolo 25 “Come la musica si dee chiamare
sorella e minore della pittura” del suo “Trattato della Pittura”:
“La musica non è da essere chiamata altro che sorella della
pittura, conciossiachè essa è subbietto dell’udito, secondo senso
all’occhio, e compone armonia con la congiunzione delle sue parti
proporzionali operate nel medesimo tempo, costrette a nascere e
morire in uno o più tempi armonici (…). La pittura eccelle e signoreggia
la musica perché essa non muore immediate dopo la sua creazione,come
fa la sventurata musica, anzi, resta in essere, e ti si dimostra
in vita quel che in fatto è una sola superficie” (edizione della
Unione Cooperativa Editrice, Roma 1890).
Il XX secolo non ha reso
un buon servizio a Claudio Monteverdi. Nella prima parte del Novecento
musicisti e/o musicologi si sono sbizzarriti nelle revisioni (operazioni
lucrose, non dimentichiamo) “operistiche” dell’Orfeo, del Ritorno
di Ulisse in Patria, e tutto il resto possibile ed immaginabile.
Nella seconda metà del secolo, con il particolare sviluppo dell’industria
discografica e dei mezzi di riproduzione audiovisiva, si è consumato
lo scempio totale, cioè quello esecutivo. Al limite si può dire
che le esecuzioni meno obbrobriose siano quelle degli anni ’50 in
cui Monteverdi viene reso con uno spirito cameristico stilisticamente
settecentesco.
I guai per il nostro Claudio, e non solo per lui, sono iniziati
con l’avvento della “filologia” intesa non come scienza e quindi
come vera conoscenza storica, ma semplicemente come “ideologia”.
Alcuni dogmi, il corista a 415 herz, la terminologia “barocca” come
etichetta per musiche di epoche diverse, di musicisti diversi e
distanti e di paesi diversi, la presenza onnipresente del
falsettista condita in tutte le salse, la voce “fissa” e “piccola”
e tante altre falsità storiche, sono stati imposti in ogni dove
e in ogni occasione fino a creare una moda e quindi un gusto ed
un mercato globali.
Il fatto è che dietro il bel nome della “filologia” (la prima
ad essere mistificata) si sono nascosti incompetenti e dilettanti,
strumentisti incapaci e cantanti senza voce e, come si dice, “senz’arte
né parte” ma, in compenso, affaristi “a tutto campo”. Anche in questo
il Novecento si rivela essere un secolo distruttivo al massimo grado.
Da quanto detto due sono i campi di azione per un recupero autentico
del patrimonio musicale: l’aspetto estetico che sottintende qualsiasi
creazione artistica, soprattutto quella di alcuni secoli particolarmente
felici come il periodo di cui ci interessiamo, e l’aspetto realizzatore
dell’idea musicale. La specificità del linguaggio musicale, a cui
ho accennato sopra, permette di capire l’importanza dell’aspetto
pratico poiché qualsiasi conoscenza teorica (estetica) sarà inutile
senza un mezzo di espressione adeguato per esprimere l’idea stessa.
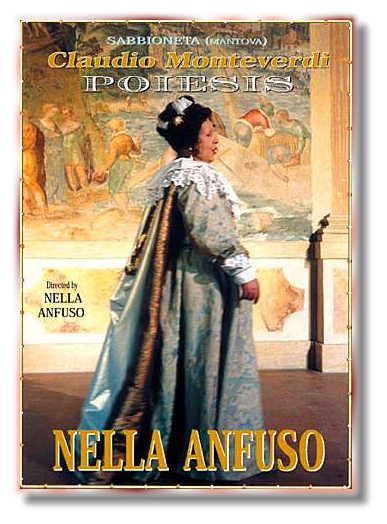
In una relazione ad uno
dei nostri primi Convegni ad Artimino (primissimi anni ’70) Annibale
Gianuario aveva presentato una analisi fonetica della declamazione
iniziale del Lamento d’Arianna. Suffragato dall’analisi elettroacustica
dell’Istituto Galileo Ferraris di Torino, la declamazione del primo
verso di Arianna, il tanto amato “Lasciatemi morire” da parte del
D’Annunzio, risultava di una eccezionale verità fonico-semantica.
Alcune diverse intonazioni parlate del suddetto verso, compresa
la declamazione recto-tono (cioè su una medesima nota) sono risultate
identiche a quella notizzata dal Monteverdi.
[
Ascolto del brano monteverdiano].
Faccio notare l’esclamazione
iniziale su “scia” indicata da una nota puntata con intervallo
discendente come ben descrive Caccini nella Prefazione a “Le Nuove
Musiche”del 1601. Ricordo anche che non è un caso che le prime rappresentazioni
avvenute a Mantova abbiano avuto come protagonisti cantanti fiorentini
e di formazione cacciniana (Settimia Caccini, Francesco Rasi - primo
interprete dell’Orfeo monteverdiano - ed altri). Per comprendere
meglio la sottile (ad un orecchio non particolarmente raffinato)
differenza fra declamato puro e declamato-legato ascolteremo “Mirate”
di Piero Benedetti (1617) ed il Canto delle tre Grazie tratto dalla
Flora (1628) di Marco Da Gagliano.
[
Ascolto 1 ]
[
Ascolto 2 ]
Per
quel che riguarda l’aspetto strumentale che, per quanto concerne
Monteverdi ed il suo tempo, è prettamente secondario, possiamo dire
che un discreto lavoro è stato fatto nella ricostruzione degli strumenti
dell’epoca, soprattutto di quelli a tastiera, a pizzico ed, in parte,
di quelli a fiato. Per gli strumenti ad arco il discorso diventa
serio sia per il fattore “ricostruzione” che per quello “esecutivo”.
Ciò è dovuto alle caratteristiche tipiche di tali strumenti che
hanno come fondamento una particolare qualità del suono. Costruire
una copia di un Amati o di Stradivari significa fare “qualcosa”
di valore? Il fatto che dei moltissimi artigiani liutai dei secoli
passati siano rimasti solo alcuni (pochissimi) nomi significa pure
qualcosa. Ed in effetti tutte le copie di strumenti non hanno
nemmeno lontanamente il suono (mi riferisco alla qualità del suono)
degli strumenti originali, anche rimaneggiati, dei medesimi autori.
Per una corretta interpretazione della “filologia” è da tener presente
che la qualità del suono dipende, in alcune famiglie di strumenti
più, in altre meno, anche dallo strumentista.
Sul piano esecutivo due semplici considerazioni: in primis è da
ricordare il fatto che, nell’epoca di cui ci occupiamo, qualsiasi
strumento era al servizio della voce e del Canto; in secondo luogo,
che qualsiasi strumento, soprattutto a fiato e ad arco, doveva
imitare, sfruttando al massimo le proprie particolari possibilità
tecniche, lo strumento vocale in tutte le sue caratteristiche sonore.
È evidente quindi a tutti la “pochezza” di quanto strumentalmente
viene praticato oggi, nel repertorio pre-ottocentesco, un po’ in
ogni dove, proprio perché manca il modello vocale di riferimento.
La
supremazia plurisecolare della musica vocale aveva avuto come
conseguenza lo sviluppo straordinario dell’Arte canora, uno sviluppo
che raggiunge la sua perfezione nel periodo che va dal XV secolo
ai primi decenni dell’Ottocento. Delle caratteristiche dello strumento
vocale dei nostri “Antichi” ho già scritto e parlato ampiamente
in vari momenti, anche nel Convegno di Artimino dello scorso anno,
quindi non ripeterò quanto già detto e scritto. Posso solo qui ricordare
come il Canto italiano dei secoli XV-XVIII, e quindi anche monteverdiano,
niente abbia a che fare con quanto viene realizzato oggi sotto tutte
le latitudini sia nelle sale da concerto, sia nei teatri che nei
vari “luoghi” discografici.
Mi piace solo ricordare un passo di una lettera di Monteverdi del
24 Luglio 1627 ad Alessandro Striggio in cui viene ricordato il
principio fondamentale che costituisce il segreto della scuola italiana:
la fusione perfetta dei due registri, segreto che determina le caratteristiche
che hanno reso la scuola vocale italiana unica nel panorama storico
internazionale: “(…) è ben vero che canta sicuro, ma canta però
alquanto melancolico e la gorgia, non la spicca così bene, perché
manca nel agiungere la più parte delle volte la vocale del petto
e quella della gozza, perché se manca quella della gozza a quella
del petto la gorgia divien cruda et dura et offensiva, se manca
quella del petto a quella della gola, la gorgia divien come onta
et quasi continua nella vocale, ma quando ambigui operano, si fa
la gorgia et soave et spiccata, et è la più naturale”.
Mi sembra oltremodo opportuno fare una precisazione: tutti i musicisti
del passato conoscevano il buon meccanismo del Canto poiché la musica
per eccellenza era quella vocale e poiché l’apprendimento dell’arte
musicale avveniva vocalmente (il solfeggio parlato era ancora di
là da venire…). In conclusione ogni musicista in quanto tale conosceva
la buona emissione che si tramandava ininterrottamente da maestro
ad allievo. È ciò che ha contribuito all’efflorescenza tutta italiana
dell’Arte vocale.
Sulla base del su citato testo di Monteverdi, e di tutti gli altri
musicisti coevi che documentano la realtà canora dei secoli passati
a noi cari, è possibile trarre delle conclusioni indiscutibili sulle
esecuzioni così dette monteverdiane del nostro tempo (e non solo,
naturalmente, penso allo scempio, siamo proprio in fase di imbarbarimento,
della futura opera omnia discografica vivaldiana da parte della
francese etichetta Naive). Dov’è oggi un Orfeo che sia in possesso
della “gorgia et soave et spiccata” per una esecuzione adeguata
di “Possente spirito”? Non solo, dov’è oggi una Messaggera, una
Ninfa, una Penelope, una Euridice, una Arianna in grado di “declamare”
la poiesis monteverdiana, declamazione che è possibile solo se si
è in possesso della “gorgia et soave et spiccata” (risultato della
perfetta fusione dei due registri)? Dov’è oggi un cantante in grado
di eseguire una “esclamazione” (di cui parla Caccini), essenziale
per l’espressione, non solo solisticamente, monteverdiana, ma di
tutto il repertorio polifonico del Monteverdi e dei suoi contemporanei?
Bisogna ammetterlo: c’è il vuoto assoluto. È per questo che ancora
non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare e quindi di conoscere
e gustare il mondo musicale monteverdiano. Monteverdi è, nella nostra
epoca, un nome- feticcio che serve a farsi belli deturpandone l’arte
in tutti i modi possibili ed immaginabili, anche i più sfacciatamente
vergognosi esteticamente ed eticamente (penso all’edizione in corso,
tutta “mascolina”, dovuta all’italica fantasia, -tanto per fare
qualcosa di diverso - dei vari libri di madrigali).
Così, agli inizi del III Millennio abbiamo un Monteverdi con cantanti
senza voce e naturalmente digiuni di un minimo di tecnica (senza
parlare della vocalità all’antica che non esiste…), con gruppi polifonici
in cui è onnipresente la presenza del solito falsettista,
ciò che fa tanto “early music”. Infatti chi sa oggi che la
chiave di contralto indicava il tenore acuto? Non certo gli “speciali
imprenditori” che si autodefiniscono “direttori”! Non parliamo poi
di stili: ad esempio, chi conosce gli “accenti” di cui parla Monteverdi
per l’esecuzione madrigalistica? E potrei continuare all’infinito….
Il Monteverdi del III Millennio è un illustre sconosciuto, un nome-feticcio
che serve solo per far denaro e carrieruccia. Sì, il divino Claudio
non solo è sconosciuto, è completamente deturpato. Ma soprattutto
è vittima indifesa di un’epoca malsana, visto che non può chiedere
giustizia delle ingiurie a cui è sottoposto. Eppure ha scritto chiaramente
le sue volontà: basterebbe un po’ di onestà, merce rara, oggi. Di
questo stato di cose non sono solo responsabili gli esecutori e
gli interessati vari che girano loro intorno. I maggiori responsabili
sono coloro che hanno il compito di parlarne e scriverne, nella
maggior parte non all’altezza del loro compito. Basterebbe prepararsi
professionalmente con un po’ di vero studio ed essere così, come
scriveva il divin Claudio, al “servitio de la bona arte”.