
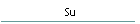
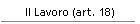

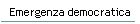
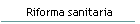

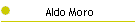

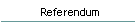






|
|
Aldo Moro
L’EREDITÀ DI ALDO MORO TRA MEMORIA STORICA E VERITÀ PUBBLICA NELLA
TRANSIZIONE DALLA PRIMA ALLA SECONDA REPUBBLICA
Andrea Ambrogetti
Una riflessione circa la lezione politica dello
statista ucciso venticinque anni fa dalle Brigate Rosse
e sul patrimonio ideale, morale e intellettuale da egli prematuramente
depositato nelle mani degli italiani appare oggi tanto importante quanto
opportuna, se non altro perché il paese si trova ancora impantanato nella
transizione dalla prima alla seconda Repubblica. Si tratta di una
transizione – è bene ricordarlo – cui molti guardano al di là dei suoi
termini meramente istituzionali, anche se non tutti concepiscono l’idea che
ciò dovrebbe significare non fermarsi alle scelte istituzionali (dal minimo
della legge elettorale al massimo del tipo di stato e della forma di
governo) ma anche aggredire il problema della concezione e della pratica
della democrazia, in altre parole della sovranità popolare. Si tratta di
una transizione – peraltro – che Moro fece in tempo non solo ad intravedere,
ma anche ad affrontare con una ampiezza di prospettiva che poi deve essere
in buona parte mancata, se due stravolgimenti epocali (il crollo del muro di
Berlino e Tangentopoli), quattro Commissioni bicamerali e la scomposizione e
ricomposizione di quasi tutte le forze politiche italiane non sono bastati
per arrivare dall’altra parte del guado.
Ci si può allora domandare se Aldo Moro – questo indubbio protagonista dei
primi trenta anni di vita della nostra Repubblica – abbia ancora qualche
cosa da dire di rilevante circa le prospettive della transizione italiana,
qualcosa che possa risultare utile alla cultura politica italiana durante
questo passaggio e su quanto dovremmo trovare al termine di esso: la seconda
Repubblica. In altri termini, è possibile delineare e mettere in risalto
alcuni aspetti di una eredità del leader democristiano da richiamare in
questa fase?
Per tentare di rispondere a questa domanda è metodologicamente necessario
prendere avvio con il richiamare i tratti peculiari del contesto
politico-culturale degli ultimi venti anni e dal mettere in evidenza alcuni
termini preliminari circa la delicata questione della attualità e della
inattualità di Aldo Moro.
Rimozione collettiva e eredità perduta: un
«delitto d’abbandono» senza colpevoli?
Per introdursi nel tema del contesto, vale a dire l’Italia degli anni
ottanta e novanta, basterà rileggere questa frase di Carlo Bo, il
grande critico letterario, senatore a vita, rettore dell’Università di
Urbino, il quale il 9 maggio 1979, oltre venti anni fa, scriveva:
«La tragedia di Moro avrebbe dovuto essere un momento della nostra
coscienza comune, oggi sappiamo che non lo è stato, anzi abbiamo il sospetto
che si sia fatto l’impossibile perché non lo diventasse».
Cosa vuol dire questa frase, con la quale Carlo Bo comincia un articolo
significativamente intitolato «Delitto d’abbandono», e cosa ci dice a
proposito della necessità metodologica di identificare il contesto?
Identificare le caratteristiche del contesto è sempre necessario, in
qualsiasi processo di riflessione e di comunicazione, se si vuole
salvaguardarne il buon esito, dal momento che uno stesso concetto, una
stessa idea, possono variare di significato al variare del contesto.
A questo proposito vanno allora sottolineati due elementi di difficoltà, si
potrebbe dire due ostacoli cognitivi, i quali dimostrano come sia avvenuto
quanto tristemente e genialmente fu intuito all’impronta da Carlo Bo: una
analisi della figura di Moro si presenta oggi di difficile intrapresa perché
i soggetti protagonisti del mondo politico e culturale italiano non hanno
impedito che nel corso degli anni si delineasse una situazione
caratterizzata da due elementi critici:
a) la rimozione della figura di Moro dall’immaginario nazionale,
figura ridotta ad irriconoscibile volto di marmo sul brutto e – soprattutto
– illeggibile monumento di via Caetani, ai piedi del quale gli italiani si
sono rassegnati a vedere in televisione, una volta all’anno, piccole folle
di delegazioni di uomini politici;
b) il fatto che le circostanze, le modalità e le finalità relative alla
morte dello statista non sono ancora state chiarite, vale a dire – come
ha scritto Giovanni Moro – il fatto che sugli eventi collegati al sequestro
e all’assassinio di Aldo Moro non è stata ancora raggiunta una verità
soddisfacente, condivisa dai diversi protagonisti dell’epoca ed esauriente
per chi a quelle vicende guarda con gli occhi di oggi.
A proposito del primo ostacolo Carlo Bo sembra dirci che la rimozione non
è avvenuta per caso o per inerzia, ma per una volontà remissiva, che egli
qualifica giustamente come «delittuosa», tesa cioè ad abbandonare
all’oblio uno dei pochi statisti lungimiranti che l’Italia ha avuto nella
seconda parte del secolo scorso. Uno statista che lavorava sul versante
della risoluzione dei problemi strutturali relativi all’impianto e al
funzionamento della democrazia nel suo paese in un’ottica di largo respiro e
di lungo termine – come noi oggi possiamo constatare a contrario se
guardiamo alla mancanza degli effetti benefici che il proseguimento del suo
tipo di politica avrebbe comportato.
Che la rimozione sia avvenuta lo dicono poi numerosi elementi, i quali si
potrebbero considerare altrettanti indicatori socio-culturali di rimozione
morotea:
– il fatto che quasi nessuna famiglia politico-culturale del paese ha
avviato una seria, laica ed approfondita riflessione sulla figura e
sull’operato dello statista pugliese, nessuno – magari più semplicemente
o anche solo strumentalmente – ne ha «sposato la memoria», nessuno ne ha
fatto – magari banalmente – un «monumento» da inserire nella galleria delle
proprie glorie, tanto meno il suo partito di allora, tanto meno – tranne
poche e significative eccezioni degli ultimissimi anni – il suo ambiente
di origine, cioè il mondo cattolico, nel quale Aldo Moro aveva non poco
militato (chi si ricorda, in questi venti anni, un vescovo che abbia
promosso una riflessione di un certo spessore su di un uomo politico che gli
stessi vescovi nel ‘46 spinsero quasi a forza nelle liste democristiane per
la Costituente?);
– le intramontabili vulgate giornalistiche sul Moro temporeggiatore,
incomprensibile, fumoso, poco concreto, poco coraggioso di cui si legge sui
grandi organi di informazione con una certa regolare frequenza e di cui si
potrebbero citare non poche, curiose smentite, di sapore anche attuale (di
quando, ad esempio, nell’ottobre del ‘73, da ministro degli Affari Esteri,
rifiutò agli americani, in occasione della guerra del Kippur,
l’utilizzazione delle basi militari ubicate in Italia, negando che potesse
trattarsi di una crisi Nato);
– la fortuna mass-mediologica e pubblicistica che ha baciato terroristi,
carnefici, postini e vivandiere con le loro migliaia di ore di apparizioni
televisive e con le loro migliaia di pagine di libri, ore e pagine che
sembrano in gran parte dedicate a ripetitive sedute psicoanalitiche di
autoassoluzione – peraltro con scarso pudore – piuttosto che allo sviscerare
e al portare alla coscienza nazionale un reale contributo di verità sul
ruolo da essi giocato nell’impedire l’evoluzione della democrazia italiana
verso equilibri nuovi e più avanzati e non verso l’immobilismo che sono
stati gli anni ottanta e la rottura forzata dei vecchi equilibri, a quel
punto inevitabile e, in parte, rovinosa, che sono stati gli anni novanta.
A questa situazione si collega anche una relativa sfortuna storiografica di
cui lo statista è rimasto vittima e che solo negli ultimissimi anni sembra
vivere un’inversione di tendenza, anche grazie ad una nuova e intensa
stagione di storiografia italiana contemporanea, all’interno della quale gli
interrogativi di ricerca sul ruolo di Moro nella storia repubblicana paiono
moltiplicarsi
Certo,
su Aldo Moro, sono usciti tanti libri e sono stati fatti, non molti, ma
pochi convegni, alcuni dei quali ben riusciti. Ma, all’Italia che volta
secolo, l’impressione di una lontananza, sembrerebbe quasi di una – almeno
per il momento – irrecuperabilità dell’uomo Moro e del leader politico Moro,
delle sue idee e dei risultati delle sue azioni di governo, sembra restare
ancora oggi.
Sembra restare nonostante l’impegno dei nuovi gruppi dirigenti del paese –
quelli successivi alla vittoria dell’Ulivo nel ‘96 – che, tramite i
presidenti delle due Camere, nel maggio del 1998, hanno riportato Moro
nell’aula di Montecitorio e hanno chiamato a ragionare su di lui i leaders
politici di questi anni.
Sembra
restare nonostante la provocazione lanciata nella stessa occasione
dall’allora presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, sulle
«intelligenze criminose che scelsero, mirarono e centrarono il bersaglio in
quel momento politico essenziale», a suo dubbio rimaste forse non
comprese nei processi celebrati fino ad oggi.
Per quanto riguarda il secondo ostacolo cognitivo, esso appare non meno
importante perché (come ha fatto presente Giovanni Moro negli ultimi anni in
più occasioni) fino a quando non saranno state raggiunte soddisfacenti
condizioni di verità circa le circostanze, le modalità e le finalità della
morte e circa i comportamenti tenuti dai vari attori in gioco durante il
lungo sequestro sembra difficile poter dire qualcosa di definitivo anche
sull’opera dello statista pugliese nei venti-trenta anni precedenti
all’attacco al cuore dello stato e, dunque, avviare e condurre a primi
punti di approdo la stessa ricerca storiografica su Aldo Moro.
A nessuno possono sfuggire, infatti, le forti connessioni tra l’azione
politica dello statista e le circostanze della sua morte: chiarire le prime
e chiarire le seconde è ormai divenuto quasi un solo sforzo conoscitivo. Lo
sanno bene gli storici, i quali non possono fare altro che lasciare almeno
in parte in sospeso le loro ricostruzioni dell’azione politica del leader
democristiano e lo sanno bene gli uomini delle istituzioni incaricati di
fare un po’ più di luce sul sequestro e l’assassinio, i quali non possono
fare altro che andare all’indietro a cercare nell’attività dello statista
elementi utili anche alla comprensione della sua tragica fine.
Nel limbo in cui è rimasto sospeso Aldo Moro, tuttavia, non si trova in
solitudine. Egli è solo il più alto ed emblematico caso di un problema più
generale, problema non politico, non istituzionale, non economico, ma
culturale, che attanaglia la nostra Repubblica ad oltre cinquanta anni dalla
sua fondazione: quello del nesso tra memoria storica e verità pubblica.
Un problema originato dalla persistenza di buchi neri nella nostra storia
recente di cui, appunto, la controversa scomparsa di Moro è solo l’esempio
più significativo, in buona compagnia con le stragi, i tentativi di colpi di
stato, le zone oscure in cui politica e mafia si sono sovrapposte, gli
intrecci perversi tra politica e affari dei quali è difficile credere che si
sia saputo tutto in cinque minuti. Fino a quando non sarà raggiunta una
sufficiente verità pubblica su queste come su altre pagine poco chiare della
recente storia italiana non sarà neanche disponibile una sufficiente memoria
storica, sufficiente per rinsaldare l’identità nazionale e per rafforzare la
tenuta democratica delle istituzioni.
Condizioni e spunti per una possibile eredità
morotea
Nonostante tutte le avversità costituite da questo tipo di contesto
resta il dubbio che una qualche possibile eredità morotea esista e che possa
ancora essere spesa nel tempo presente e in quello futuro. Questo a patto
che non si trascuri che – inevitabilmente – la sua vicenda intellettuale e
politica è, almeno in parte, inattuale e che su di essa non si può ancora
parlare in termini compiuti perché, come già detto, il debito di verità nei
suoi confronti non è stato ancora pienamente saldato. Si tratta di quel
debito di verità del paese nei confronti di Aldo Moro che è stato evocato da
Pietro Scoppola parlando nell’aula della Camera dei Deputati, in occasione
del ventennale della morte: «Vi è un debito di verità verso Moro che è
anche un debito di verità verso la storia del paese».
Per quanto riguarda l’inattualità su di essa non c’è molto da dire perché
deriva, sia dalla crescente distanza temporale, sia da un radicale
cambiamento delle principali caratteristiche della situazione politica: ad
esempio, è venuta meno la grande contrapposizione mondiale in due blocchi, i
soggetti politici si sono rimescolati e non ce n’è più uno che rappresenta i
cattolici, la transizione infinita ha portato ad una situazione tale per cui
oggi non si può comunque prescindere dallo «sblocco» delle riforme
costituzionali e istituzionali perché si possa avviare una nuova fase della
storia repubblicana.
Per quanto riguarda il versante dell’attualità, è necessario porsi il
problema di disporre di un metodo, con il quale eventualmente individuare
quanto ci può essere di attuale in una vita, in un’opera e in un pensiero
inevitabilmente legati alla loro epoca. Due potrebbero essere allora gli
aspetti di una prima proposta per questo tipo di metodo:
a) verificare la pertinenza per il tempo presente di ciò che
continuiamo a condividere con il tempo in cui Moro ha vissuto e b)
verificare l’effettiva appropriatezza per i nostri anni di quanto egli ha
esplicitamente indicato come importante per il futuro che sarebbe venuto
dopo di lui, cioè quanto da lui era stato appena intravisto, ma sottolineato
come rilevante per la sua incidenza a lungo termine.
A proposito di ciò che continuiamo e continueremo a condividere con l’epoca
in cui Moro ha vissuto, un possibile spunto può riguardare quello della
democrazia: questo tipo di «regime» politico a cui ci si può forse essere
abituati, almeno in Europa, ma che a livello planetario costituisce una
sfida tutta aperta. A proposito di quanto era stato indicato come valido per
il futuro, un possibile spunto può riguardare quei nuovi attori politici ai
quali Moro si riferisce quando parla, a seconda delle espressioni, di
cittadini o di società civile, e dei quali aveva preconizzato una
importanza crescente.
La democrazia: da un tipo di regime a un tipo di
società
Terminata la lunga oppressione della dittatura fascista, dai banchi della
Costituente, fino alla tormentata fase degli anni settanta, Moro prende
sempre molto sul serio il fatto che viviamo in tempi di democrazia e si
interroga sulla sua natura con costante attenzione. Si tratta peraltro
di un aspetto tanto trascurato quanto interessante del suo pensiero, che
dovrebbe a mio parere interpellarci in questi anni in cui spesso vediamo
quali sono le tragiche differenze tra una nazione democratica e una in cui
la democrazia è assente, in costruzione, incerta o in pericolo.
Moro ritorna, in più occasioni, sulla democrazia, considerandola sotto
molteplici aspetti:
– come sistema istituzionale, in cui gli attori politici si muovono,
partecipando al «gioco democratico», il quale «senza poter risolvere di per
sé tutti i problemi, offre con una sua naturale pieghevolezza ed intrinseca
fecondità strumenti di dialogo ed occasioni per assumere responsabilità
quali il momento storico richiede»;
– come ambiente di valori condivisi, in cui gli attori politici si
riconoscono (si legga, per tutti, il famoso intervento all’Assemblea
Costituente, del marzo ‘46, sulla democrazia intesa come una casa comune
costruita su di un minimo comune denominatore – il valore della dignità
della persona umana – valido per gli uomini di tutte le diverse ideologie)9;
– come finalità costante (e obiettivo pratico) verso cui sempre tende
la politica e lo stato in un’opera che in realtà non ha un termine
precostituito, dovendo lo stato e la politica farsi in eterno carico dello
stesso rafforzamento e ampliamento della democrazia dentro, ci dice lo
statista, un incessante circolo virtuoso i cui benefici sono esaltati e
moltiplicati mano a mano che un numero maggiore di individui e popoli gode
della libertà, e assume quindi una sempre più attiva e consapevole presenza
nelle realtà sociali in cui si trova a vivere;
– come, infine, vedendo questo ultimo passaggio, un nuovo tipo di
società, che si afferma quando il continuo sviluppo della vita e delle
istituzioni democratiche e delle loro conseguenze sulle donne e gli uomini
induce, in connessione con altri fattori contemporanei, altrettanto se non
più rilevanti, primo fra tutti il processo di modernizzazione, ad una «maturazione
democratica delle masse», qualcosa in fondo di abbastanza vicino
all’idea di mutazione antropologica, se si accetta che essa possa avere una
accezione non necessariamente tutta negativa.
Alla luce di questo interesse così ricco e sfaccettato per la democrazia, se
si guarda bene anche all’insistenza con la quale Moro ritorna sul tema
dell’«estensione dell’area della dignità degli uomini e dei popoli»,
e sul significato epocale che gli assegna, vale forse la pena di azzardare
la tesi secondo la quale lo statista pugliese è stato tra i primi ad
abbandonare le concezioni in cui i problemi dello stato, del ruolo della
politica e dei partiti erano sostanzialmente inquadrate in una visione di
parte (per cui la democrazia è – in realtà – un modo per arrivare al
socialismo, o per preservare l’identità cristiana del paese, o per garantire
le libertà formali), oppure erano ancorate ad un processo storico ritenuto –
in realtà – centrale rispetto al cammino democratico (la continua
ridefinizione del welfare state o la dipendenza internazionale, ad esempio).
In Moro lo stato, la politica, i partiti sono finalmente valorizzati come
fattori ed effetti di una nuova società – quella democratica – in cui si
dispiega, appunto, la «dignità umana e dei popoli».
È il tema, altrettanto caro allo statista, del «fare la rivoluzione nella
democrazia», con il che già si chiarisce come questa situazione non sia meno
priva di problemi e sfide. Lo sottolinea lo stesso statista, ad esempio
nella funesta occasione del colpo di stato in Cile.
«Qual è infatti il senso dello sviluppo storico, del quale siamo in
qualche misura protagonisti, se non il portare nell’alveo della democrazia
la rivendicazione sociale del nostro tempo, di rendere attuabile mediante il
consenso e con la forza della legge e delle istituzioni la richiesta di
giustizia e di partecipazione? Nostro compito in questa epoca è trovare
nella democrazia un’alternativa alla rivoluzione e far sì che la democrazia
non sia un alibi per la stagnazione sociale».
Mi sembra allora che l’opera di Aldo Moro per allargare, consolidare e
portare a compimento la democrazia italiana sia rivelatrice di un tipo di
leader politico di tipo nuovo e di una concezione della democrazia
originale rispetto a quelle prevalenti nella sua epoca. Un leader politico
di tipo nuovo (e forse ancora attuale) perché la sua azione di uomo di
partito, di governo, del parlamento non discende da una ideologia, ma
scaturisce da una attiva interpretazione del reale e del suo divenire, che
va guidato verso nuove sintesi e nuovi equilibri, nei quali il rapporto tra
istituzioni pubbliche e cittadini si modifica a favore di questi ultimi,
soprattutto da quando se ne è scoperta la nuova soggettività sociale e
l’irriducibile protagonismo politico. Una concezione della democrazia
originale perché svincolata (o almeno proiettata verso un affrancamento)
dalle ideologie e dalle appartenenze separate.
A proposito della democrazia, infine, non è da trascurare il fatto che Moro
si sia dovuto mobilitare anche per la difesa tout-court del sistema
democratico in Italia, contro gli attacchi occulti alla sua legittimità.
Il titolare della sovranità e la sua soggettività politica
In coerente continuità con la sua idea – più volte manifestata negli anni
quaranta e cinquanta – di uno stato democratico da cui nessun cittadino
dovesse essere escluso, a partire dagli anni sessanta Moro (forse il
primo in Italia?) accede lucidamente alla consapevolezza che nelle società
industriali dell’occidente non è possibile governare le complesse
trasformazioni in atto in tutti i settori della vita sociale senza
l’inserimento a pieno titolo dei cittadini nel sistema degli attori politici.
Vi è, negli ultimi suoi discorsi, qualche chiaro accenno a questo stato di
cose, che per il leader democristiano acquista un tale spessore da superare
in prospettiva perfino la terribile crisi degli anni settanta. Così si
esprime nel marzo del 1976:
«l’urgenza di trovare una soluzione al problema della vasta e talora
disordinata domanda di partecipazione che investe tutte le società
industriali e minaccia di travolgerle, se le forze politiche non sapranno
trovare appropriati assetti istituzionali nei quali, in maniera nuova ed
originale, questa esigenza abbia risposta piena e soddisfacente».
«So che, pur con distorsioni ed errori, per i quali si paga talvolta un
alto prezzo, avanza nella nostra epoca una nuova umanità, più ricca di
valori, più consapevole dei propri diritti, più impegnata nella vita sociale.
So che la vita civile ha una sua consistenza, proprie intuizioni, proprie
proposte, proprie esigenze. … Insomma, malgrado la crisi, sotto la crisi, è
un nuovo mondo che si affaccia e al quale è doveroso e insieme saggio dare
spazio. Tra il realismo della preoccupazione e l’idealismo delle forze e
dei diritti emergenti, non c’è contraddizione. Sono le due facce di una
stessa realtà, nella quale la ricchezza del nuovo e dell’umano che avanza
non deve essere soffocata, ma composta in un assetto costruttivo. Noi non
siamo chiamati a fare la guardia alle istituzioni, a preservare un ordine
semplicemente rassicurante. Siamo chiamati invece a raccogliere, con
sensibilità popolare, con consapevolezza democratica, tutte le invenzioni
dell’uomo nuovo a questo livello dello sviluppo democratico».
Si tratta di un’intuizione sostanzialmente confermata, non solo dall’ampio
sviluppo che hanno avuto, a partire dagli anni ottanta, prima i movimenti
politici di seconda generazione (ad esempio quelli ecologisti), poi le
organizzazioni della cittadinanza attiva (ad esempio Legambiente), ma anche
dalla vastissima letteratura sociologica e politica sulla governance che, a
partire dagli anni novanta, ha invaso i siti internet di tutto il mondo.
Si dovrebbe allora meditare sulle modalità attraverso le quali recuperare
la ricca tematizzazione dello statista circa una società civile che –
con la seconda metà di questo secolo, in seguito alle ultime tappe del
processo di modernizzazione – incarna ed esprime da sé un inedito
protagonismo politico, in una buona parte non incanalabile e non
rappresentabile tramite gli istituti tradizionali (partiti, sindacati). A
proposito del «cittadino protagonista» così si esprimeva Moro nel
1974:
Un partito che voglia guidare, non può non capire, non può non seguire,
non può non farsi carico di tutto quello che è alle sorgenti della sua
funzione politica, la realtà concreta degli interessi, dei valori, dei
pensieri, degli ideali nella quale si muove il cittadino, come protagonista
della vita politica. Questa è l’autentica base, sulla quale l’istituzione
deve collocarsi, il potere dev’essere esercitato, l’unità deve essere
realizzata.
La società – afferma lo statista sempre più spesso dalla seconda metà degli
anni sessanta in poi – ha maturato una propria autonoma soggettività
politica e una propria capacità di esprimersi, al di là appunto dei canali
tradizionali della rappresentanza politica, mettendone in discussione
ogni pretesa monopolistica. Dal novembre del ’68 in poi Moro ritorna in
ogni suo intervento pubblico su queste dinamiche e parla di: «un
impetuoso emergere di una umanità nuova che propone gravi problemi ad un
partito», «una acuita sensibilità sociale (che) eccita la sensibilità
dei partiti», «un fermento sociale (che) mette in crisi la funzione
rappresentative dei partiti». Dinamiche che nel loro complesso avvengono
nell’ambito di un processo di liberazione al quale è connessa una inedita
soggettività politica delle aree di base della società. Un processo di
liberazione – faceva presente profeticamente Moro – che è in grado di «spazzare
via e trascinare con sé» molte certezze della politica e dei suoi
protagonisti, compresa la diversità comunista, volendo forse richiamare
l’attenzione sul fatto che in crisi c’era il sistema della rappresentanza
partitica in generale e non solo un certo partito. A proposito del fatto che
in gioco ci fosse la necessità di riequilibrare i poteri, è significativo
che Moro nel 1976 arrivi a dire «È diminuito il potere dello stato»:
erano sorti altri poteri che andavano inseriti nel contesto democratico per
garantire una ordinata prosecuzione del progresso civile.
Questa pionieristica visione del cittadino «sovrano» appare importante
proprio oggi, nel momento in cui è in discussione lo statuto del cittadino
comune, il quale si sta solo ora faticosamente liberando dallo stigma che lo
vede come un soggetto omologato dai mass media e dagli imperativi
consumistici, o come un elemento di disturbo al tranquillo funzionamento
delle istituzioni. Un cittadino che oggi esercita un ruolo autonomo di
tutela dei suoi diritti e di verifica della qualità dei servizi e dei beni
pubblici e che rivendica piena parità con quelli che una volta si chiamavano
i «governanti» e che dagli artefici delle modifiche istituzionali, in una
progettata democrazia della stabilità e dell’alternanza, è candidato a
svolgere il ruolo di «arbitro».
È peraltro proprio tale consapevolezza della sovranità pratica del cittadino
contemporaneo il punto di partenza dell’elaborazione morotea sulla «terza
fase» della vita politica italiana, sulla quale il minimo che allora si
possa ipotizzare è che essa avrebbe dovuto vedere nuovi rapporti tra
stato e società, e non solo nuove regole e nuove alternative di governo.
La soggettività politica della società, dunque, potremmo aggiungere noi
oggi, non solo non è da considerare come un elemento critico per la vita
della democrazia (perché apparentemente ne aumenta l’entropia e
l’ingovernabilità), ma come un suo punto di forza, non potendo più
esserci – in questo mondo sempre più complesso e sempre più globale – un
governo della realtà e dei processi di sviluppo affidato ad un unico attore,
quello statuale. È proprio questo ciò che viene riconosciuto da più parti in
ambito internazionale, in special modo da quella corrente che sta
proponendo appunto l’approccio della governance, un’espressione traducibile
all’incirca con «sistema di governo allargato» (allargato alla società
civile, al settore privato, ecc.). Un approccio che, invece, trova
ancora purtroppo difficoltà a farsi strada in Italia, un paese dove le
amministrazioni locali non hanno ormai più difficoltà a convocare le
associazioni ambientaliste dopo una frana o una alluvione, mentre ne hanno
ancora moltissime a convocarle prima, con lo scopo, ad esempio, di mettere a
punto un sistema permanente di monitoraggio e di prevenzione «misto»
stato-cittadini.
Democrazia incompiuta, riforme istituzionali e
seconda Repubblica
Tornando alla transizione italiana, ci si può a questo punto
domandare se essa si potrà dichiarare conclusa quando sarà stato approvato
dal Parlamento, prima, e – forse – dal popolo, poi, un nuovo testo della
seconda parte della Costituzione, oppure quando il premier sarà indicato
direttamente dall’elettorato, oppure, invece, secondo una linea forse più
consona ad un approccio moroteo, quando si saranno consolidati nel paese i
nuovi soggetti politici della democrazia e, in particolare, della democrazia
dell’alternanza.
In una disamina della transizione alla seconda Repubblica un riferimento a
Moro è dovuto (messa da parte la precisazione relativa al fatto che,
ovviamente, l’Ulivo non è stata una esperienza politica simile o analoga
alla solidarietà nazionale ma un’esperienza che essa ha casomai reso poi
possibile) anche perché egli è stato forse l’ultimo leader politico
italiano che ha tentato di affrontare in profondità lo storico nodo della
«democrazia difficile» in Italia. Pur sapendo bene quanto essa fosse
«difficile» perché priva della possibilità di una alternanza
fisiologica tra opposti schieramenti, soprattutto a causa dei limiti imposti
dagli schieramenti internazionali, Moro ha tuttavia operato sul versante non
solo dell’arena ristretta del gioco politico o di quello delle modifiche
istituzionali, ma anche su quello più ampio del consolidamento della
democrazia nel tessuto sociale del paese, del suo progressivo allargamento a
tutte le famiglie politiche sinceramente democratiche, anche attraverso la
legittimazione di quelle forze che il mondo contrapposto di allora impediva
di considerare affidabili.
Si tratta allora di chiedersi se vi sono o meno legami tra l’ultima azione
politica dello statista pugliese negli anni settanta e la transizione
italiana, all’apparenza senza fine. In altre parole, ci si può domandare:
la transizione italiana è infinita, tra l’altro, a causa dei limiti negativi
della politica di solidarietà nazionale (cioè il consociativismo) o, al
contrario, essa è infinita anche per la ragione che quella politica è stata
interrotta?
Giuseppe Cotturri ha esaminato questi legami mettendo in evidenza la
necessità di tematizzare l’oggetto della transizione e di verificare se la
terza fase morotea fosse o meno una proposta di transizione, anche se non
esplicita, verso una ulteriore tappa della democrazia repubblicana. A suo
parere, negli ultimi due decenni, si sono effettivamente confrontate in
Italia due ipotesi diverse circa l’oggetto della transizione, una
relativa alla riforma politica e una relativa alle riforme istituzionali,
che è poi prevalsa dalla seconda metà dagli anni ottanta in poi. Secondo
Cotturri, inoltre, per Moro la terza fase avrebbe dovuto comportare anche
una transizione politica profonda, rimasta però solo abbozzata e non più
coltivata adeguatamente da altri leaders. Potrebbe essere questo un
ulteriore spunto per tornare oggi ad interrogarsi sulla natura della
transizione che tutti auspicano, senza farla automaticamente coincidere con
le sole modifiche costituzionali e istituzionali.
Con la solidarietà nazionale, intanto, come è stato bene messo in
evidenza da Franco De Felice, «in Italia il muro è caduto dieci anni
prima che in Europa». Secondo De Felice, infatti, anche grazie alle
politiche condotte da Moro negli anni settanta si registra nel nostro paese
«un mutamento sostanziale nella ridefinizione dei rapporti fra le forze
politiche italiane rispetto al precedente trentennio», tanto che si «può
dire, allora, che in quegli anni si chiuda il dopoguerra italiano e si apra
una nuova fase».
E si potrebbe aggiungere che, non solo il leader democristiano aveva
idealmente scavalcato la cortina di ferro con la sua politica nei confronti
del PCI, ma anche che aveva preso atto e correttamente interpretato i
mutamenti sociali che stavano portando alla crisi e al superamento delle
ideologie e delle appartenenze separate. Ne emerge un leader politico
capace di mettersi in sintonia con i cambiamenti di lungo periodo e di
prefigurare situazioni ancora lontane. Lo si vede, ad esempio, da come Moro
legge i successi elettorali del Partito comunista della metà degli anni
settanta, sottolineando «la caduta della barriera morale e politica»
e non tanto il rischio di una prossima consegna dell’Italia al comunismo
(ad esempio nel Consiglio nazionale democristiano del luglio ’75).
«Soprattutto il voto giovanile ha concorso fortemente a far cadere quella
pregiudiziale, in forza della quale si considera il Partito comunista un
partito ‘diverso’. I giovani elettori innanzitutto, ma poi anche altri,
ideologicamente non comunisti, hanno trascurato o escluso la diversità del
Partito comunista ed hanno votato per il suo programma sfumato, senza che
giocassero in nessun modo nel loro giudizio le esperienze storiche del
comunismo internazionale. È caduta così per molti quella barriera morale
e politica, che pur nello svolgersi della dialettica democratica, per alcuni
decenni era stata innalzata».
Certo, contro le potenzialità della politica di consolidamento della
democrazia praticata dal leader pugliese, rimaneva insormontabile
l’ostacolo del muro di Berlino, degli effetti pratici del quale Moro era
perfettamente consapevole, anche se già immaginava un futuro diverso.
A questo proposito, nel Congresso della Democrazia cristiana del 1976, si
esprimeva in questi termini.
«E possono essere trascurati i fattori internazionali? È naturale e
giusto rivendicare l’autonomia del nostro paese, il cui assetto interno non
può che dipendere dalla volontà del popolo italiano. Resta però vero che
vi sono conseguenze sul piano internazionale, rischi almeno d’isolamento, i
quali non sono solo importanti per se stessi, per il pregiudizio che
arrecano agli interessi nazionali, ma anche per i riflessi che possono avere
sui delicati equilibri sui quali ancor oggi riposa la pace nel mondo.
Quali che siano le decisioni che il paese, nella sua sovranità, sarà per
prendere, è doveroso mettere in guardia l’opinione pubblica di fronte ai
rischi che permangono e sono gravi, anche se non provocano quell’ondata
emotiva che ha caratterizzato una lunga fase della politica italiana e in
generale di quella europea occidentale. Trova così giustificazione la
posizione negativa di fronte alle forme proposte di associazione dei
comunisti alle responsabilità del potere, il coinvolgimento della Democrazia
cristiana in una comune esperienza di governo con il Partito comunista».
Per quanto riguarda il tema di un futuro diverso, nel discorso ai
gruppi parlamentari democristiani del febbraio 1978, Moro non si sente di
escluderlo.
«Se mi chiedesse se la situazione di oggi si riprodurrà domani, in elezioni
ravvicinate, la mia risposta, che può essere sbagliata ma è sincera, è: sì!
Se voi mi dite: fra qualche anno cosa potrà accadere, fra qualche tempo cosa
potrà accadere? Non parlo di logoramento di partiti, linguaggio che penso
non sia opportuno, ma parlo dell’andamento delle cose, del movimento delle
opinioni, della dislocazione delle forze politiche. Se mi dite: fra qualche
tempo cosa accadrà? Io rispondo: può esservi qualcosa di nuovo».
D’altronde già cinque anni prima non si era sentito di escludere grandi
cambiamenti futuri, proprio scontrandosi con la democrazia italiana
«bloccata».
«Ho detto prima che l’impossibilità di un’alternativa, sia di avvicinamento,
sia di avvicendamento, contrassegna la nostra come una democrazia
difficile. Ed ho rilevato che qui risiede il fondamento della tensione
propria del nostro sistema politico. Non noi, con la nostra volontà, ma la
storia stessa, l’evoluzione delle cose ed i movimenti reali dello spirito
umano, potranno forse, in tempi imprevedibili, modificare questa
situazione».
In fondo, se guarda con attenzione all’Italia degli anni novanta, una volta
caduto materialmente il muro di Berlino, è accaduto, almeno in parte,
qualcosa di simile proprio a quanto Moro ipotizzava, mentre delle riforme
istituzionali si parla dall’inizio degli anni ottanta e ancora è stato fatto
poco in concreto, nonostante che sulla loro necessità esista un consenso
generalizzato.
Se l’Italia è ancora una democrazia incompiuta, se è ancora impegnata in una
complessa transizione, si dovrebbe allora riconoscere che tale
transizione non è tanto costituita da quella aperta da Tangentopoli e dal
rapido mutare della geografia partitica ma, soprattutto, da quella iniziata
alla fine degli anni settanta, quando si sarebbe dovuta affrontare, prima
che diventasse patologica, la crisi fisiologica dei partiti dopo trenta anni
di storia democratica e si sarebbe dovuto acquisire, si potrebbe dire
quasi incorporare, al sistema democratico il contributo della società civile
e della cittadinanza, insomma da quando è rimasto in sospeso il problema
posto dal nocciolo duraturo della terza fase: una profonda riforma
non solo dello stato ma anche dei rapporti stato-cittadini.
In questo senso, è vero allora che la morte di Moro, nel 1978, rappresenta
uno spartiacque nella storia della Repubblica, nel senso che da quel momento
quest’opera di ulteriore sviluppo della democrazia italiana resta senza
guida, la degenerazione partitocratica prende il sopravvento, si cede il
campo alla stagione moderata degli anni ottanta e il
coinvolgimento/legittimazione nel governo del paese della parte politica
diversa da quella che aveva governato ininterrottamente dal dopoguerra deve
attendere molti anni.
Ecco perché, tra l’altro, nonostante la sua rimozione e la carenza di
verità sulla sua morte non si spegne nel paese l’interesse verso Aldo Moro,
ecco perché il suo fantasma continua a passeggiare fuori e dentro il palazzo
e il suo spirito aleggia su questa infinita transizione italiana.
Infine, per quanto riguarda la nascita e il consolidamento dei nuovi
soggetti politici dell’alternanza in che cosa dovrebbe consistere? Vuol dire
forse – come suggerisce Pietro Scoppola nella Prefazione ad un libro
dedicato proprio ad Aldo Moro – porre l’accento sui dati di cultura
politica che condizionano la costruzione di una democrazia dell’alternanza,
cioè porre l’accento su una nuova mentalità democratica. Ecco cosa
scrive Scoppola a questo proposito.
«L’esperienza stessa degli ultimi anni sta a dimostrare – mi sembra – che
la costruzione di un tale tipo di democrazia non è una operazione che possa
compiersi solo sulla base di mutamenti istituzionali, quali sono anzitutto i
sistemi elettorali, ma esige non solo la costruzione, da noi incompiuta, dei
soggetti politici dell’alternanza, bensì anche di una maturazione di
mentalità, un modo nuovo di sentire la democrazia stessa, un lungo percorso
insomma, nel quale la cultura politica ha un ruolo certamente decisivo».
Si tratta di un’indicazione tipicamente morotea, una delle tante possibili
tra quelle recuperabili da uno statista e da un pensatore che la cultura
italiana dovrebbe riscoprire e studiare a fondo per trarne utili categorie
interpretative, delle quali ancora non sospettiamo la ricchezza e la
modernità.
Pietro Scoppola, Prefazione, in Fabio Vander, Aldo Moro. La cultura politica
cattolica e la crisi della democrazia italiana, Marietti, Genova, 1999.
Home | Il Lavoro (art. 18) | Amministrative 02 | Emergenza democratica | Riforma sanitaria | Cristiani e Politica | Aldo Moro | Legalità | Referendum | Amministrative 03 | La riforma Moratti | Riflessioni | Europa e radici cristiane | Prodi | WTO 2003
Ultimo aggiornamento:
14-01-04
|



