
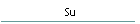


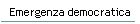
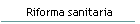

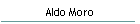

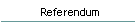




|
|
Legalità tra etica, diritto e politica
di Francesco Saverio Borrelli
Ci sarebbe forse possibile vivere, se fosse corrotta
quella parte di noi che viene turbata dall'ingiustizia, mentre dalle cose
giuste riceve giovamento? E giusto o ingiusto che si cerchi di evadere
pagando e ringraziando coloro che ci aiuteranno a farlo? Se ci sembra
giusto, proviamoci; altrimenti, se ci apparirà chiaro che di un'azione
ingiusta si tratta, non preoccupiamoci di dover morire o di subire qualsiasi
altra pena, restiamo con tranquillità al nostro posto e diamoci pensiero,
piuttosto, di non commettere ingiustizia. E se commettere ingiustizia è, per
chi lo fa, cosa né buona né bella, noi non dobbiamo nemmeno ricambiare le
ingiustizie, qualsiasi cosa gli altri facciano a noi. A condividere queste
opinioni sono e sempre saranno in pochi, e fra chi la pensa così e chi no,
non è possibile comunità d'intenti. Ma può sopravvivere, e non essere
sovvertita, una città in cui si fa quanto è possibile per distruggere le
leggi, una città in cui le sentenze non hanno efficacia, e possono essere
invalidate e annullate da privati cittadini?».
Nel celeberrimo dialogo di Piatone, il Critone, da cui sono estratti i passi
appena citati, Socrate respinge l'insistente proposta del discepolo Critone,
che vorrebbe farlo fuggire dalla prigione e da Atene con l'aiuto di amici
fedeli e generosi che hanno raccolto il denaro necessario per corrompere il
carceriere. In quelle proposizioni, in quegli interrogativi, e in generale
negli scenari dialettici dell'intero dialogo — la cui rilettura, in tempi di
pensiero debole, ma soprattutto di morale debole, non si raccomanderà mai
abbastanza — è possibile cogliere il riferimento, diretto o indiretto, a
tutti gli aspetti del tema enunciato nel titolo: la legalità intesa come
osservanza delle leggi della città; l'etica, come norma dell'agire
individuale posta dalla ragione e dalla coscienza; la giustizia, come
riverbero dell'etica ma anche come applicazione della legge da parte dei
giudici; la politica, intesa come governo della città in base a un patto —
folgorante anticipazione illuministica — che i cittadini non possono
disconoscere a proprio piacimento senza minare il fondamento stesso della
loro vita associata. Mi accingo a proporre un modesto contributo di
riflessione sulle tematiche alte della giustizia, in un momento
caratterizzato da polemiche non sempre disinteressate, da disinformazione,
da disorientamento dell'opinione pubblica, e chiarezza vorrebbe che
anzitutto si tentassero definizioni almeno provvisorie di ciascuno dei
termini enunciati. Sennonché ci accorgeremo ben presto come essi facciano
parte di una sorta di struttura a geometria variabile, non tanto per la
multifunzione lessicale di alcuni, quanto per la diversità delle prospettive
culturali, storicamente e/o ideologicamente condizionate, da cui possono
trarre luce, e per i nessi di rimando reciproco dall'uno all'altro.
1. Il senso della legalità
Di legalità si parla in senso oggettivo, per indicare
il principio di organizzazione dei moderni ordinamenti giuridici, basato su
un corpo precostituito di norme generali e astratte destinate a vincolare
più o meno strettamente le stesse istituzioni, oltre che i cittadini e i
rapporti tra loro. In accezione più specifica, nel diritto penale il
principio di legalità, accolto nell'art. 25 della Costituzione italiana e
negli artt. 1 e 2 del Codice penale, vieta che qualcuno possa esser punito
per un fatto che non sia previsto come punibile in virtù di norma
anteriormente entrata in vigore (irretroattività della legge penale). Suo
corollario è il principio di tassatività, che impone la formulazione delle
fattispecie legali, o figure di reato, mediante descrizioni analizzabili con
un numero finito di operazioni mentali, e che, correlativamente, inibisce la
creazione di nuove fattispecie criminose da parte della giurisprudenza.
Sempre sul piano dell'oggettività, la connotazione positiva o negativa di
legalità sta a indicare, come predicato, la relazione di compatibilità o
contrasto di determinati atti o fatti o persine iniziative istituzionali con
i modelli normativi vigenti ai vari livelli dell'ordinamento.
Se ci poniamo dal lato dei soggetti dell'ordinamento, la legalità indica il
momento anche psicologico del sottostare spontaneamente alla legge: una
sottomissione che può scaturire da abitudine contratta passivamente, da
disciplina di servizio, da inclinazione al quieto vivere, da timore delle
sanzioni giuridiche o sociali, da autocompiacimento nel contemplarsi come
cittadino esemplare, da adesione cosciente al dettato normativo per calcolo
di convenienza individuale, da credenza nella legalità come valore
imprescindibile in una collettività organizzata, da condivisione sul piano
morale della regola di comportamento dettata dal legislatore, da convinzione
— infine — eticamente radicata circa il' dovere di rispettare i precetti
provenienti dall'autorità costituita.
Dal punto di vista del valore, non v'è dubbio che il rispetto della legalità
sia fattore, indice e conseguenza ad un tempo del coefficiente di coesione
nelle formazioni sociali. La morale di sostegno dell'ordinamento, di ogni
ordinamento, ne rappresenta un collante indispensabile alla sopravvivenza,
perché, se è vero che esistono istituzioni preposte al controllo della
legalità e all'attuazione anche coattiva della legge, la possibilità di
coercizione incontra dei limiti, nel senso che decresce in misura
proporzionale, forse più che proporzionale, all'incremento statistico di
diffusione delle violazioni, fino a scendere in prossimità del livello zero
quando lo scostamento dalle norme sia generalizzato. In altri termini, ogni
punto percentuale d'incremento nella diffusione della devianza dovrebbe
fronteggiarsi in ipotesi con un aumento proporzionale, o più che
proporzionale, delle risorse destinate al ripristino della legalità. Ma è
evidente che proprio il tasso di diffusione dell'illegalità costituisce un
limite nella reperibi-lità delle risorse umane — e culturali — da destinare
alla lotta contro la devianza. Per dirla brutalmente: in una collettività di
banditi sarà pressoché impossibile trovare poliziotti e magistrati che
affidabilmente gestiscano la legalità ufficiale, piuttosto che la
controlegalità banditesca.
La legalità è dunque un valore al quale il cittadino deve essere educato
perché il suo rispetto è fattore di conservazione dell'ordine sociale,
baluardo delle libertà democratiche, difesa contro l'arbitrarietà, scudo
dell'eguaglianza di tutti, ricchi e poveri, forti e deboli, nei confronti
dei poteri reali, o, com'è stato detto, «potere dei senza potere»; è
garanzia della prevedibilità dei comportamenti nostri e altrui, dunque
elemento di sicurezza e affidabilità reciproca nelle relazioni
intersoggettive; e, nelle democrazie aperte al rinnovamento, anche fattore
di emersione delle obsolescenze, delle irrazionalità, delle contraddizioni o
inadeguatezze dell'assetto esistente e dunque stimolo indiretto al progresso
istituzionale, normativo, economico. Ma la legalità è un valore, per così
dire, climatico al quale lo stesso comportamento delle istituzioni e dei
pubblici uffici deve ispirarsi nella quotidianità. Francesco Bacone (t
1626), nel saggio Della Grandezza (Of Great Place], individuò i quattro
difetti dell'autorità come «lentezza, villania, debolezza, corruzione». Sono
passati quasi quattro secoli, e in tutti i Paesi occidentali, negli ultimi
anni anche da noi, leggi e provvedimenti amministrativi si sono succeduti
per portare nelle prassi delle pubbliche amministrazioni una maggior
trasparenza e un atteggiamento di più attenta considerazione degli interessi
del cittadino. Si pensi alle leggi sulla semplificazione delle procedure
amministrative, sul diritto di accesso, sulla tutela della riservatezza, sui
diritti fondamentali del contribuente. Molti passi avanti, dunque, ma solo
un inguaribile ottimista potrebbe dire che, di quei difetti, il nostro Paese
si sia emendato.
2. Rapporto tra diritto ed etica: giusnaturalismo o
giuspositivismo?
Se la legalità, come rispetto dell'ordine esistente, è
un valore, si può accettare senza incertezze e senza residui una sorta di
equazione tra legalità e giustizia, o addirittura, su un terreno più
avanzato, tra legalità ed etica? Qui il discorso si complica. Da un punto di
vista piattamente operativo e realistico, giustizia significa né più né meno
che attuazione del diritto vigente, spontanea, ovvero ottenuta attraverso i
meccanismi dichiarativi e coercitivi della giurisdizione: ma il diritto
vigente e la sua applicazione puntuale conseguono sempre risultati
rispondenti al senso profondo di giustizia che ciascuno di noi porta in sé
come proiezione di un ideale interiore di dignità umana, di equilibrata
distribuzione dei beni materiali e spirituali della vita, di saggia e
razionale composizione dei conflitti, di tutela efficace delle persone e
delle cose? E se così non è, possiamo contestare la validità del diritto
vigente e rifiutare di conformarci ad esso?
Sul problema del rapporto tra legalità e giustizia astratta, tra nomos
(legge) e dike (giustizia), le posizioni teoriche sono fondamentalmente due:
1) il giusnaturalismo, che movendo dal presupposto dell'esistenza di norme
razionali, universalmente valide, anteriori a ogni norma giuridica positiva,
condiziona l'obbligatorietà e quindi l'intrinseca validità della legge alla
sua conformità a tali norme, sicché in altri termini la legge è tale solo se
eticamente giusta (Verbindungsthese, nella terminologia tedesca, cioè tesi
del collegamento diritto/morale); 2) il gius-positivismo, che contestando
che la giustizia sia un reperto di natura, ossia un criterio desumibile
dalla mera osservazione dell'umanità e del mondo, sostiene che legge e
morale si pongono su piani distinti (Trennungsthese, tesi della sepa-ratezza),
e che il diritto è tale ed è vincolante a prescindere dalla sua eticità.
La contrapposizione tra i due orientamenti non è puramente teorica e può
avere rilevanti ricadute pragmatiche. Mi riferisco alle questioni dibattute
sia al processo di Norimberga sia, successivamente, davanti ai tribunali
ordinari della Repubblica Federale Tedesca, per stabilire se appartenenti
alla Wehrma-cht fossero giuridicamente tenuti, o meno, a obbedire agli
ordini dei superiori contrastanti con i diritti umani. Mi riferisco, più in
generale, alla teorizzazione del diritto di resistenza, come opposizione
contro le lesioni o le minacce ai diritti fondamentali arrecate con atti,
con provvedimenti, con leggi formalmente in vigore: e alludo non tanto alla
resistenza predicata nel medioevo da ecclesiastici come Manegoldo di
Lautenbach (t 1119) o Giovanni di Salisbury (t 1180), che si dirigeva contro
il sovrano, quanto a quella singolare formulazione del diritto di resistenza
che si rinviene nell'ari. 35 della Costituzione francese del giugno 1793
(«di fronte alle ingiustizie e all'oppressione l'insurrezione è per il
popolo, e per ogni parte del popolo, il più sacrosanto dei diritti e il più
inderogabile dei doveri»), che si ritrova in alcune Costituzioni di Laender
tedeschi, ma anche a certi atteggiamenti di disobbedienza civile o di
ostruzionismo che qua e là emergono nella vita contemporanea come
manifestazioni di obiezione di coscienza. Accenno di passaggio all'opinione
di chi ha intravisto nella menzione dei «diritti inviolabili dell'uomo»,
contenuta nell'ari. 2 della nostra Costituzione, un embrionale
riconoscimento del diritto di resistenza. Sono decisamente scettico, forse
perché condizionato dal mio passalo di operatore della legge, circa la
possibilità logica di configurare la resistenza contro l'ordine co-stituito
come diritto soggettivo riconoscibile da norme giuridiche, giacché l'ordine
costituito rappresenta un sistema chiuso che può prevedere, e normalmente
prevede, meccanismi di correzione dall'interno, ma non può, per la
contraddizione che non lo consente, conferire patente di legittimità alla
ribellione attuata da un proprio appartenente che voglia dargli scacco
matto.
Ma, al di là della constatazione che ogni ordinamento, democratico o
autocratico che sia, si autoqualifica «giusto», ritengo che concettualmente
non sia corretto condizionare il riconoscimento di validità, sul piano
giuridico, del diritto positivo al parametro della conformità a un modello
pretesamente naturale di giustizia o di elicila anziché al realistico
parametro dell'effettività. La natura, ahimè, nel mondo dei viventi non ci
mostra modelli di giustizia o di eticità, ma solo di forza, e quelli che noi
adottiamo come espressivi di valore sono proiezioni, talvolta nobilissime,
della nostra cultura, dunque modelli storicamente e ideologicamente
condizionati, dunque relativi a punti di vista più o meno condivisi, mai
categorici e definitivi. So bene che questo discorso solleva serie obiezioni
da parte di chi aderisce alla filosofia del diritto naturale. Ma, laicamente,
non posso ignorare il disordine sociale che si creerebbe lasciando penetrare
nell'ordinamento criteri assiologici ad esso estranei o con esso
contrastanti, come convinzioni religiose sulla cui valenza uno Stato,
appunto, laico non può esprimere disponibilità differenziate, o filosofiche,
costumanze di clan o di etnia, finalismi politici di vario genere, privilegi
di casta o di consacrazione popolare, criteri pragmatici di particolari
subculture, magari tradizioni gentilizie, e così via, soprattutto in
presenza di realtà geopolitiche di convivenza multiet-nica e multiculturale,
entro le quali legittimare l'esenzione dal rispetto di questa o quella norma
giuridica creerebbe un contesto di confusione e incertezza.
L'ordinamento giuridico ha dunque carattere eminentemente autoreferenziale,
nel senso che esso, e soltanto esso, può dettare i criteri per riconoscere
giuridicità ai rapporti interpersonali, ai diritti, ai doveri. Ma
attenzione: questo non significa che la concezione legalistica del
positivismo giuridico e la credenza nel primato della legge debbano tradursi
eticamente sempre e comunque in un atteggiamento di passiva rassegnazione
alla gabbia di ferro della parola del legislatore. Non credo, ho detto, alla
resistenza come diritto soggettivo riconosciuto dall'ordinamento (perché
allora dovrebbe esistere anche il diritto soggettivo di opporsi alla
resistenza e l'enunciato sarebbe intrinsecamente contraddittorio, per
l'affermazione simultanea di due diritti uguali e contrari, come abbiamo
visto); ma credo che esista talvolta — non sembri paradossale — un dovere
morale nascente da un'esigenza categorica che può dar luogo alla resi-stenza
contro l'autorità come fallo di rottura, come allo di ribellione o
addirittura di rivoluzione, che nel tempo si legittimerà retroattivamente,
se e quando avrà aperto una falla nel sistema o magari l'avrà travolto
instaurando un nuovo ordine settoriale o generale. Si tratta ovviamente di
ipotesi-limite, di situazioni nelle quali non per spunti episodici e
occasionali, ma per profondo, insanabile, essenziale contrasto tra
l'ordinamento e la coscienza morale non vi sia e non possa più esservi
compatibilità tra ciò che la legge pretende e ciò che la voce perentoria del
foro interiore reclama come giusto; situazioni nelle quali non l'opinione
del singolo o del gruppo, non la predicazione di un'ideologia o di un
programma politico, bensì la somma dei valori forti, riassuntivi delle
acquisizioni secolari e millenarie faticosamente assicurate dal procedere
della civilizzazione, renda assolutamente intollerabile e non altrimenti
rimediabile il conflitto tra l'ordine esistente e la dignità della persona
umana.
Non è difficile trovare nella storia del «secolo breve» da poco conclusosi
esempi concreti di tale situazione. La resistenza antifascista, sebbene
nell'ultima fase supportata, quanto a legalità, dalla presenza del Regno del
Sud, è certamente stata di questo tipo, come ribellione contro un regime
che, soppiantando il vecchio Stato liberale proprio nel momento in cui la
pressione dal basso avrebbe potuto farlo evolvere verso forme più
modernamente democratiche, gradualmente aveva conculcato tutte le libertà
del passato, aveva costretto il Paese e le istituzioni in schemi
centralistici e autoritari, aveva tentato e in parte realizzato
l'assoggettamento della giustizia, si era lanciato nell'avventura etiopica
per mera vanità colonialista, aveva inseguito le follie di Hitler prima con
le leggi razziali e poi con l'intervento nella seconda guerra mondiale. Un
insieme di circostanze che, incidendo negativamente con un'inversione di
tendenza storica nel patrimonio ideale di libertà e giustizia che le
rivoluzioni americana e francese avevano consacrato e la civiltà occidentale
aveva saldamente acquisito, ben giustificavano sul piano morale il rifiuto
d'obbedienza e la ribellione contro l'esistente non riformabile per altra
via. Ripeto: non riformabile per altra via, come si verifica nei regimi
autocratici, in cui la concentrazione del potere blocca il circuito
interattivo tra istituzione e sudditi.
Riassumendo: il rispetto della legge vigente costituisce un valore sociale
che deve essere affermato, coltivato e diffuso come esigenza morale; dal
punto di vista dell'ordinamento la giustizia e le sue applicazioni
s'identificano con la conformità alla legge; la non coincidenza tra la
giustizia legale (dike) e il senso della giustizia (dikaiosyne) che ogni
persona reca in sé come sintesi etico-culturale del dover essere ideale, per
quanto diffusa ne sia la percezione, non toglie validità e vigore alla
singola norma né esime dall'obbligo giuridico e morale di rispettarla; solo
in situazioni-limite di radicale, intollerabile e insanabile contrasto tra
il sistema vigente e le più profonde e radicate convinzioni morali, la
coscienza — non il diritto — potrà consentire e dettare comportamenti di
di-sobbedienza, di resistenza, di rivolta come strumenti fattuali di rottura
in vista della creazione di un nuovo ordine. Mi rendo perfettamente conto
della sensazione di grettezza che può provocare un'impostazione per cui alle
categorie della legalità e della giustizia venga tendenzialmente impedita
ogni connessione con parametri esterni al diritto storicamente posto,
sebbene nel parlar comune — e non soltanto in quello — sia il primo sia,
soprattutto, il secondo concetto vengano spesso invocati, e talvolta
connotati con espliciti riferimenti verbali, in un senso che trascende il
piano legalistico. Tuttavia, da un punto di vista logico e, perché no,
pedagogico, sono del parere che l'apparente restrizione dia maggior
chiarezza alla vista, giacché permette di rendersi meglio conto che istanze
etiche, istanze di equità distributiva e attributiva, valori spirituali e
culturali trovano una loro collocazione e una loro operatività a monte del
diritto positivo, nella fase genetica di questo, oltre che nei suoi
interstizi e negli spazi vuoti.
3. Il giudice tra legge, giustizia ideale e politica
Ed ecco che il discorso è naturalmente giunto
all'approdo della politica, vista nel suo aspetto di attività di produzione
normativa. Una produzione che non è destinata solo a regolare le relazioni
intersoggettive tra i cittadini e tra i cittadini e le istituzioni, ma,
anzitutto, le funzioni, l'organizzazione, le competenze, le modalità di
svolgimento per quanto riguarda la stessa attività delle istituzioni a
cominciare dalla legislazione. La politica, nei Paesi che ispirano il
proprio assetto a modelli di democrazia più o meno avanzata, fa capo a
gestori con poteri di rappresentanza — o solo di temporanea fiducia, secondo
i pensatori illuministi — conferiti dal popolo, negli Stati autocratici a
dittatori che di tali poteri si autoinvestono attribuendosi il compito, per
grazia del destino, d'interpretare i bisogni della collettività. Nell'uno e
nell'altro caso si da luogo alla formulazione di princìpi e
all'articolazione di regole che dovrebbero costituire proiezione
formalizzata dell'autentica volontà, dello spirito e dell'identità del
popolo, e dunque anche e soprattutto degli ideali di giustizia e delle
istanze etiche corrispondenti alla cultura e al costume della collettività.
Ma poi, a valle e nell'ambito di tale formulazione, la politica presiede nei
vari livelli istituzionali alla quotidiana amministrazione degli interessi
della collettività, individuando i fini concreti da perseguire e scegliendo
i mezzi più opportuni per la loro realizzazione. Sia nel primo sia nel
secondo di tali momenti l'autorità politica, quand'anche la si possa
considerare machiavellicamente svincolata da un rapporto immediato con il
valore assoluto dell'eticità, non può eludere il rapporto con la legalità,
quindi con la giustizia positivamente intesa, quindi
con quelle istanze di eticità che nella legislazione abbiano trovato
accoglimento. Tale è il modello del moderno Stato di diritto, in cui i
vertici sovrani sono essi stessi soggetti alla legge: prospettiva che ancora
nel 1620, in quell'Inghilterra che, pure, aveva conosciuto più di quattro
secoli prima la Magna Charta Liberta-tum, scandalizzava il re Giacomo I. Al
giurista Edward Coke, infatti, che gli ricordava come i giudici dovessero
obbedire non al volere del sovrano, ma alle leggi del Paese, Giacomo I, che
aveva dalla sua il sostegno di Thomas Hobbes, rispondeva irato: «I shall be
under thè law? which is treason to affirm» («Dovrei dunque sottostare alla
legge? È un atto di lesa maestà affermarlo»).
Ma la legalità non vincola soltanto i vertici esecutivi: anche i Parlamenti,
finché essi stessi non le modifichino secondo procedure prestabilite, sono
tenuti a rispettare le leggi vigenti, e ciò vale in particolare per le
Costituzioni rigide e le leggi costituzionali che fissano con prospettive di
ampio periodo i princìpi supremi e le regole fondamentali dello Stato. Tra i
princìpi sommi si annovera quello dell'indipendenza della magistratura,
corollario della separazione dei poteri teorizzata da Montesquieu e poiché
alla magistratura nel suo complesso — comprensiva da noi, sperabilmente per
lungo tempo ancora, di giudici e pubblici ministeri — spetta il compito di
tutelare la legalità, riaffermando la volontà della legge violata o incerta,
e di infliggere le eventuali sanzioni, ecco che viene alla ribalta il
problema dei rapporti, delle consonanze o dissonanze, delle frizioni, dei
possibili conflitti tra potere politico e potere giudiziario e più in
generale delle relazioni tra la politica e l'amministrazione della
giustizia.
Con qualche malinconia, e senza temere d'incorrere in vilipendio della
nazione, possiamo francamente riconoscere che nel nostro Paese la cultura
della legalità non ha radici né profonde né estese, probabilmente in
conseguenza di secolari vicende storiche, e che è piuttosto diffusa una
sorta di disaffezione verso le regole, se scomode, e verso il potere
costituito, se non è possibile servirsene. La presenza di sottosistemi
reticolari di appartenenza, con forme di fiducia localizzata nel loro ambito
(la famiglia, il parentado, il clan, il gruppo, la fazione), tende a fare
aggio sulla fedeltà allo Stato, sul rispetto dell'ordinamento, sulla
coscienza del dovere verso la società; il fine cui si mira, nobile o
egoistico che sia, è addotto a giustificazione dei mezzi adoperati; donde la
propensione al clientelismo, che talvolta è l'anticamera dell'illegalità, la
disponibilità alla compravendita dell'invendibile ovvero corruzione attiva e
passiva; di qui anche la scaturigine dell'economia violenta secondo il
paradigma dell'impresa mafiosa.
In uno scenario così caratterizzato sarebbe stato ben difficile che le
istituzioni rimanessero del tutto incontaminate da inclinazioni non
esattamente ortodosse. Vi è stata la stagione di «tangentopoli», con il suo
intreccio inestricabile di politica e affarismo, con il suo sistema occulto
— ma non tanto — di drenaggio di ricchezza a favore di partiti, correnti
politiche e personaggi corrotti. Vi è poi stato il tentativo, con «mani
pulite», di ripristinare la legalità nella politica e nell'amministrazione.
Le cronache recenti inducono al più nero pessimismo circa l'utilità di quel
tentativo, che sembra circoscritta alla mera dimostrazione che, se si vuole,
qualcosa si può fare contro la corruzione. Appunto: se lo si vuole. Ma da
tempo è in atto il riflusso, sotto forma di reazione punitiva da parte della
classe politica verso la magistratura, e di sfiduciata stanchezza e
raésegnazione nell'opinione pubblica, pervasa da quell'indifferenza di fondo
verso tutto ciò che non tocca gli interessi personali, da quella sorta di
relativismo morale, che secondo alcuni studiosi sarebbero tipici dell'io
cosiddetto postmoderno o postindustriale. Non mi dilungo in questo inciso
sulla realtà nazionale né su alcuni aspetti di essa, anche a livello
elevato, che mostrano segni di squallore senza l'eguale nei Paesi di
democrazia liberale. L'ho aperto per esemplificare un momento particolare
del rapporto in casa nostra tra politica e giustizia, a proposito del
controllo di legalità che la magistratura non può non esercitare in presenza
di notizie di reato, o comunque se debitamente sollecitata, sulle attività
dei pubblici amministratori come in qualsiasi altro campo; un controllo che
i politici insofferenti tendono a respingere, in qualche modo facendosi
scudo del consenso dei loro elettori come di una sorta di assoluzione
popolare, e accusando la magistratura di perseguire a sua volta obiettivi di
lotta politica secondo il falso sillogismo: «si vuole incriminare Tizio,
Tizio appartiene al partito X, dunque si vuoi recare danno al suo partito»;
oppure: «non è stato incriminato Caio, Caio appartiene al partito Y, dunque
si è voluto favorire quel partito». Poco importa, poi, di fronte a
un'opinione pubblica il cui livello di attenzione e di competenza non può
pretendersi particolarmente elevato, che nel primo caso magari ci siano le
prove provate della disonestà, e nel secondo invece le prove manchino o
addirittura non ci sia nemmeno la «notizia di reato».
D'altra parte il tema del rapporto tra politica e giustizia, più esattamente
tra politica e giurisdizione, non s'identifica con il problema locale e
forse transeunte dei politici inquisiti dalla magistratura, ma ha un respiro
ben più ampio e di più elevato interesse storico e concettuale. Non senza
fondamento i politici percepiscono con qualche allarme una tendenza della
giurisdizione a portarsi a ridosso, talvolta pericolosamente a ridosso,
della loro area operativa. La tendenza è nelle cose e non può essere
banalizzata come prava velleità di supplenza o, peggio, di usurpazione di
potere da parte di singoli magistrati eversori, a prescindere dal rilievo
che per almeno nove decimi l'attività della magistratura è di supplenza, in
quanto per definizione deve rimediare a strappi, buchi, smagliature,
tensioni, opacità nella trama vivente del tessuto sociale.
Può riuscire utile a questo punto ricordare l'ascendente storico meno remoto
del fenomeno. Sebbene comunemente la separazione dei poteri venga fatta
risalire al pensiero illuministico, e io stesso poco fa abbia richiamato
Montesquieu, a cui bisognerebbero aggiungersi Locke, Rousseau, Constant e la
concezione del «regno della legge» passata intatta dalla Rivoluzione
francese alla Restaurazione, in realtà l'attuale posizione del potere
giudiziario in Italia, più che ai modelli francese e inglese, va ricollegata
al modello americano conseguente alla Costituzione varata nel 1787 dalla
Convenzione di Filadelfia. In Francia, infatti, la rigida legalizzazione del
potere giudiziario, la visione del giudice come «bocca della legge», come
severo applicatore della legge, la diffidenza per ogni operazione di
interpretazione addirittura il suo divieto (filoso-ficamente insensato, ma
tant'è), la centralità del governo e dunque del potere esecutivo (Napoleone:
«II Governo è al centro della società come il sole, tutte le altre
istituzioni devono percorrere la loro orbita attorno a lui, senza mai
allontanarsene»), hanno mantenuto la magistratura in una condizione di
sostanziale sottoposizione all'Esecutivo, che non è venuta meno neppure con
la Costituzione gollista del 1958. In Gran Bretagna la situazione è diversa,
ma solo nel senso che il baricentro del sistema è il Parlamento, che
controlla sia il potere giudiziario sia quello esecutivo, senza alcuna
possibilità per il giudice di mettere in discussione il contenuto della
statute law (legge scritta), neanche se contraria alla common law (legge non
scritta di diritto consuetudinario). Negli Stati Uniti, invece, la
giurisprudenza della Corte Suprema Federale, presieduta dal Chiefjustice
John Marshall, fin dai primi dell'800 affermò la possibilità di unajudicial
review (controllo di costituzionalità) davanti alla Corte, avente per
oggetto leggi emanate dal Parlamento; la possibilità, cioè, di sollecitare
dal giudice un sindacato sulla legge ordinaria, cui consegue il dovere della
Corte di negare validità a questa — dopo averla interpretata — se contraria
alla Costituzione. Scrittori dell'epoca ponevano in evidenza la necessità di
proteggere e garantire un potere intrinsecamente debole come il giudiziario,
che poteva contare solo sull'autorità del proprio giudizio, se realmente si
voleva thè rule of law, cioè la supremazia del diritto, contro il rischio
immanente e costante di sopraffazione o di condizionamento politico.
Il modello americano, nel secondo dopoguerra del XX secolo, è stato recepito
negli ordinamenti di vari Stati europei, tra cui la Repubblica Italiana, con
la creazione di Costituzioni rigide che, incorporando, è stato detto, la
dimensione secolarizzata della moralità, o la « positivizzazione del diritto
naturale», formano uno strato normativo soprastante alla legislazione
ordinaria, con il quale il giudice è chiamato a confrontarsi direttamente,
sia traendone criteri di giudizio d'immediata applicazione, sia rimettendo
alle Corti costituzionali questioni di legittimità di leggi ordinarie. Già
questa possibilità di dialogo diretto tra il giudice e la Costituzione
passa, per così dire, sopra la testa del legislatore ordinario, alla ricerca
di un risultato di giustizia che la legge non garantirebbe. Ma anche altri
fattori di mutazione concorrono ad abbassare gli steccati tradizionali tra
la giurisdizione e il terreno delle decisioni politiche, ad arricchire sia
l'attesa di giustizia sia il significato della legalità, a svelare più
chiaramente la nota di creatività che non può non celarsi — checché ne
pensassero gli illuministi e con buona pace dei politici gelosi —
nell'operazione mentale della ricerca e dell'interpretazione del diritto da
applicare al caso singolo. È noto che secondo un insegnamento di tradizione
scolastica, ma alquanto semplicistico per non dire asfittico, l'applicazione
della legge da parte del giudice riprodurrebbe lo schema del sillogismo
categorico illustrato da Aristotele negli Analitici Primi della sua Logica:
premessa maggiore la norma («chi cagiona la morte di un uomo mediante
veneficio è punito con l'ergastolo»), premessa minore il fatto («Tizio ha
avvelenato e ucciso Caio»), conclusione l'applicazione della norma al fatto
(«dunque a Tizio deve infliggersi la pena dell'ergastolo»). Ma nella realtà
le cose sono molto più complicate per ragioni logico-linguistiche prima
ancora che fenomenologiche, né quell'insegnamento gode più di alcun credito
salvo forse presso qualche personaggio politico di modesta levatura
culturale che se ne serve per ammonire i magistrati a compitare la legge
senza interpretarla.
La Costituzione italiana, al pari di altre Costituzioni, contiene un insieme
di princìpi fondamentali in tema di libertà, di eguaglianza, d'istruzione,
di lavoro, di sanità, di famiglia, di ambiente e così via, che, com'è
proprio dei
«princìpi» (per contrapposto alle norme contenenti semplici «regole»), hanno
il carattere di segnali obbligati della direzione verso cui la vita della
collettività deve orientarsi. Hanno il carattere di valori in espansione a
sfondo prospettico illimitato, aperti a un'interpretazione progressiva, a
un'attuazione dinamica che tende a trasformare aspettative e speranze in
diritti riconosciuti dall'ordinamento, ed è inevitabile che riflettendosi
nella giurisdizione essi abbiano l'effetto di far esplodere l'angusto schema
della sentenza come sillogismo meccanicamente applicativo della regola. Da
ultimo dobbiamo tener presente che negli Stati moderni alle codificazioni
tradizionali si è aggiunta una proliferazione amplissima, spesso
frammentaria, mutevole, ingarbugliata, perfino contraddittoria, di leggi
speciali in correlazione con la complessità crescente e palpitante della
vita economica, dei bisogni dei cittadini, dei rapporti transnazionali, per
non parlare delle direttive promananti dalle organizzazioni soprannazionali.
Di fronte al quadro così complicatosi dei riferimenti normativi, e talvolta
anche al fenomeno di formulazioni deliberatamente compromissorie adottate
dai Parlamenti, che scaricano sul momento applicativo la responsabilità di
scelte neces-sarie per adeguare la decisione alla giustizia del caso
concreto, il ruolo del giudice si è elevato di necessità a un livello sempre
più intimamente integrativo dell'indirizzo politico — nel senso più largo,
più alto, più a-partitico della parola — impresso alla vita e allo sviluppo
della società. Di tale complessità della funzione giurisdizionale e dei
rischi a cui è perciò esposta deve prendere coscienza anzitutto il giudice,
da un lato per uscire dal mitico isolamento della «torre d'avorio» e aprire
gli occhi sulla realtà circostante, dall'altro per imparare sia a filtrare e
padroneggiare criticamente gli stimoli che la pressione osmotica
dell'ambiente gli trasmette, sia a trascendere autocriticamente gli stessi
ingredienti della propria personale cultura.
In uno scenario cosiffatto, pur nel pelago dei dubbi e delle cautele che
devono costituire il sale e il freno della riflessione filosofica, credo si
possa aderire al punto di vista di quegli studiosi che, nella contesa
storica tra giusnaturalismo e giuspositivismo, scorgono l'affacciarsi di una
terza ipotesi: l'ipotesi secondo cui la riaffermazione del primato della
legge si tempera con l'affermazione di un dovere d'interpretazione del
diritto che sia sensibile alle istanze di giustizia ideale appartenenti alla
morale sociale storicizzata, che trovano il loro luogo tipico, ma forse non
esclusivo, di emersione nelle moderne Carte costituzionali. Legalità,
politica, giustizia, etica, senza che le rispettive matrici concettuali
abbiano a confondersi l'una con l'altra, possono forse in questa prospettiva
equilibrarsi in una dialettica di distinti che le sottragga a ogni
cristallizzazione lasciando aperta la strada verso il futuro: verso un
futuro senza punti di arrivo, ma nutrito della speranza nelle sorti
progressive della società umana. Un futuro illuminato dal lampeggiare del
vivido frammento di divinità che ogni uomo custodisce dentro di sé.
-Francesco Saverio Borrelli-
Il testo riproduce
sostanzialmente la prolusione con cui l'A. ha inaugurato, il 30 ottobre
2002, il nuovo anno accademico dell'Istituto di formazione politica «Pedro
Arrupe» (Palermo). - Titoletti e neretti sono a cura della Redazione.
Home | Il Lavoro (art18) | Amministrative 02 | Emergenza democratica | Riforma sanitaria | Cristiani e Politica | Aldo Moro | Legalità | Referendum | Amministrative 03 | La riforma Moratti | Riflessioni | Europa e radici cristiane
|

