Queste note di meteorologia sono particolarizzate per il
territorio alpino italiano.
Le considerazioni qui esposte possono venir meno in
condizioni territoriali e orografiche diverse.
Esse rappresentano comunque una metodologia di analisi e previsione
locale del tempo applicabile in ogni luogo.
Le condizioni climatiche condizionano l'attivita` esterna (campi, battute,
ricerca di ingressi, scavi) e, anche se indirettamente, qualla interna
(regime idrico, circolazione d'aria, rientro dopo una uscita).
Pertanto una interpretazione delle condizioni atmosferiche e` importante
per pianificare l'attivita`: selezionare gli obiettivi, scegliere
l'equipaggiamento, ...
Per fare una analisi e previsione locale del tempo e` importante
avere un quadro generale a grande scala in cui inquadrare le
osservazioni locali.
Questo quadro e` fornito dalle fonti di informazioni ufficiali:
bollettini meteorologici e nivometeorologici (radio e tv),
giornali quotidiani,
siti web dedicati alle condizioni e previsioni meteorologiche.
L'informazione meteorologica dei bollettini e` spesso
approssimativa lacunosa, povera di dettaglio, e viene aggiornata
ad intervalli lunghi.
Questi bollettini sono inoltre "sparsi", senza diffusione regolare,
standardizzata e organica.
Molti quotidiani riportano la carta del tempo al suolo, ma questa
rappresenta solo una visione parziale e istantanea dello stato del
tempo.
Certi siti internet hanno varie carte meteorologiche (copertura,
venti, precipitazioni, temperatura, pressione) e immagini da
satellite. Inoltre per le diverse carte sono disponibili dati
a diverse ore, permettendo cosi` di fare una stima della evoluzione
dinamiche delle condizioni.
Queste fonti di informazione permettono comunque solo una
analisi a grande scala, cioe` danno un quadro di riferimento
per una previsione locale del tempo.
Inoltre durante i campi in zone remote e` necessario affidarsi
alle sole proprie osservazioni per fare una previsione delle condizioni
atmosferiche locali.
Su grande scala si hanno zone di bassa pressione e zone di alta pressione.
Le depressioni tendono ad apportare aria umida e calda sulle zone alpine,
determinando cattivo tempo.
Intorno alle depressioni il movimento dell'aria avviene in senso
antiorario e ascendente.
Salendo l'aria si raffredda e tende a condensare l'umidita` formando le
nuvole.
Quando ai centri di bassa pressione sono associati fronti si hanno
fenomeni piu` evidenti, con nuvolosita` estesa, precipitazioni persistenti
e continue associate al fronte caldo, e nubi cumuliformi con temporali
e rovesci associati al fronte freddo.
Il fronte caldo e` piu` lento ed esteso (1000 km).
Ha nubi alte (cirri) che tendono ad invadere
tutto il cielo diventando sempre piu` fitte. Il fronte freddo e` piu`
veloce e copre una area piu` ridotta (circa 100 km).
Le zone di alta pressione sono "anticicloniche": l'aria scende verso il
basso e scaldandosi perde umidita` (relativa),
diventa secca, e dissolve le nuvole.
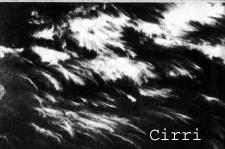 La previsione locale del tempo viene effettuata con osservazioni
dirette (venti, nuvole, aspetto del cielo) e con misurazioni
(pressione atmosferica, temperatura, umidita`)
ripetute ad intervalli regolari.
La previsione locale del tempo viene effettuata con osservazioni
dirette (venti, nuvole, aspetto del cielo) e con misurazioni
(pressione atmosferica, temperatura, umidita`)
ripetute ad intervalli regolari.
La temperatura puo` essere misurata con un termometro, comunque la
sensibilita` umana e` sufficiente a percepire variazioni di mezzo
grado.
Per l'umidita` ci possiamo affidare alle nostre sensazioni, oppure
ad un igrometro.
[FIXME I BAROMETRI SONO DOTATI DI UN IGROMETRO A CRINE ? ]
Le misurazioni delle pressione possono essere fatte con un
altimetro.
Se questo e` mantenuto in un punto fisso, una indicazione di aumento di
quota indica una diminuzione della pressione.
Viceversa una indicazione di diminuzione di quota indica un
innalzamento della pressione.
Una variazione di 10 metri corrisponde a circa un millibar.
Se l'altimetro non resta nello stesso punto ma viene spostato,
occorre riferire i valori letti sullo strumento a dei punti
di quota nota, in modo da ottenere l'andamento della variazione
di pressione atmosferica.
Per esempio se durante una salita l'altimetro indica un dislivello
maggiore di quello riportato sulla
carta topografica,
la pressione e` diminuita.
Se invece l'altimetro indica un dislivello minore, la pressione e`
aumentata.
|
 Variazioni significative sono dell'ordine di 100-150 m in 12 ore.
Variazioni di poche decine di metri sono dovute al ciclo termico diurno.
In estate, durante le belle giornate la quota aumenta nel primo pomeriggio
e diminuisce alla mattina a causa del diverso riscaldamento dell'aria
che ne varia la temperatura e quindi la densita`.
A una maggior temperatura corrisponde una minor densita` (per la legge
dei gas: P/d = R T, la pressione diviso la densita`
e` proporzionale alla temperatura), e quindi una minor pressione
atmosferica (che e` data dal peso della colonna d'aria sovrastante);
questo viene rilevato dall'altimetro come un aumento di quota.
Variazioni significative sono dell'ordine di 100-150 m in 12 ore.
Variazioni di poche decine di metri sono dovute al ciclo termico diurno.
In estate, durante le belle giornate la quota aumenta nel primo pomeriggio
e diminuisce alla mattina a causa del diverso riscaldamento dell'aria
che ne varia la temperatura e quindi la densita`.
A una maggior temperatura corrisponde una minor densita` (per la legge
dei gas: P/d = R T, la pressione diviso la densita`
e` proporzionale alla temperatura), e quindi una minor pressione
atmosferica (che e` data dal peso della colonna d'aria sovrastante);
questo viene rilevato dall'altimetro come un aumento di quota.
|
 In estate si hanno variazioni rapide che generano spesso condizioni
temporalesche.
In inverno le variazioni sono piu` lente e meglio monitorabili
nel tempo.
In estate si hanno variazioni rapide che generano spesso condizioni
temporalesche.
In inverno le variazioni sono piu` lente e meglio monitorabili
nel tempo.
La direzione dei venti (stimata osservando il movimento delle nuvole)
e` indice delle condizioni del tempo.
Se sono disposti da SW, S, SE, apportano aria umida e
relativamente calda che, sui rilievi, si solleva, raffredda e
condensa, generando perturbazionii estese.
Venti da NW, N, NE portano aria fredda (che puo` dar luogo a
temporali estivi quando si solleva contro i rilievi) e solitamente
meno umida: in genere si ha brutto tempo a nord dei monti (dove
l'aria si solleva e condensa l'umidita`) e
bel tempo a sud (dove l'aria scende, piu` secca e calda).
|
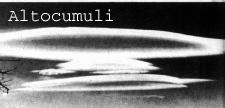 La direzione dei venti viene valutata osservando il movimento delle
nuvole allo zenit (cioe` sopra la testa); il movimento delle nuvole
nei pressi delle cime delle montagne e delle dorsali risente della
orografia.
La variazione della direzione dei venti e` indice di cambiamento del
tempo.
Se le condizioni migliorano i venti tendono a ruotare verso NW, N.
Se peggiorano verso SE, S.
La direzione dei venti viene valutata osservando il movimento delle
nuvole allo zenit (cioe` sopra la testa); il movimento delle nuvole
nei pressi delle cime delle montagne e delle dorsali risente della
orografia.
La variazione della direzione dei venti e` indice di cambiamento del
tempo.
Se le condizioni migliorano i venti tendono a ruotare verso NW, N.
Se peggiorano verso SE, S.
|
 La
brezza e` un leggero vento dovuto alla differenze di temperatura
causata dalla insolazione durante il ciclo diurno.
Di notte la brezza scende dai monti verso le valli (da terra verso il
mare), di giorno va nella direzione opposta.
Quindi il regime di brezza e` tipico di condizioni di bel tempo.
La cessazione di un regime di brezza e` indice di peggioramento delle
condizioni.
La
brezza e` un leggero vento dovuto alla differenze di temperatura
causata dalla insolazione durante il ciclo diurno.
Di notte la brezza scende dai monti verso le valli (da terra verso il
mare), di giorno va nella direzione opposta.
Quindi il regime di brezza e` tipico di condizioni di bel tempo.
La cessazione di un regime di brezza e` indice di peggioramento delle
condizioni.
Infine la tipologia delle nuvole, e la loro evoluzione nell'arco
della giornata sono indicatori delle condizioni atmosferiche.
In inverno cielo terso in montagna e foschie mattutine in pianura
e nelle valli sono indice di bel tempo.
In estate, in condizioni di bel tempo si puo` avere formazione di
cumuli pomeridiani in dissoluzione durante la notte.
Nubi alte e formate da ghiaccio (cirri) sono indicatori di perturbazioni:
il loro apparire all'orizzonte (a SW, S) indica l'arrivo di un fronte caldo;
il loro dissolversi indica l'allontanamento della perturbazione.
Altocumuli indicano l'arrivo di un fronte freddo;
dopo un periodo di cattivo tempo indicano una transizione verso il bello.
In estate, cumuli pomeridiani, sempre piu` estesi e con tendenza ad
organizzarsi verticalmente sono
indice dell'avvicinarsi di un temporale.
Quando sulla parte superiore dei cumuli si formano protuberanze a forma
di piccole torri il temporale e` proprio imminente.
|
La tabella sottostante riassume queste considerazioni.
| |
Stabile bello |
In peggioramento |
In miglioramento |
Tempo brutto |
Venti
Direzione e
intensita`. |
In quota venti
da N, NW, NE deboli,
verso la pianura
ed in estate brezze |
In basso le brezze
sono rimpizzate da
venti da SE, E;
in quota venti da SW. |
Sopra i 1500 m, i
venti ruotano da sud
verso W, NW, N.
In basso venti da W, NW. |
Oltre 1500 m da S, SW.
In basso da S, SE, E. |
Altimetro
Indicazione
di altezza. |
In inverno varia poco.
In estate aumenta 10-30 m
durante la notte, e diminuisce
nel pomeriggio (20-50 m). |
In inverno aumento
costante (max 100-150 m
in 24 h).
In estate aumento rapido
(max 100 m in 6-10 h). |
In inverno diminuzione
costante (100-150 m in 24 h).
In estate diminuzione rapida
(specie dopo un temporale)
in 3-4 h. |
Valori piu` alti rispetto
all'altezza dei punti quotati. |
| Temperatura |
Bassa d'inverno.
Alta d'estate.
|
In aumento d'inverno.
In diminuzione d'estate. |
In diminuzione d'inverno
In aumento d'estate. |
In aumento in inverno
In diminuzione in estate. |
| Umidita` |
Bassa |
Aumenta l'umidita'. |
Diminuisce l'umidita'. |
L'umidita` e` alta. |
| Cielo |
Azzurro o grigio chiaro
al sorgere del sole.
Foschie dense in pianura. |
Azzurro molto tenue
quasi celeste-grigio in
montagna.
Biancastro in pianura.
Aloni attorno al sole e
alla luna. |
Coperto al mattino.
Grigio all'alba, e
sereno al tramonto. |
Azzurro carico (in caso
di schiarite), rosso al
sorgere del sole.
Il sole tramonta dietro una
cortina di nubi. |
| Nubi |
Quando i sono, possono essere
alta con forma esile, quasi
trasparente, o basse a cumulo
(che non aumenta di dimensione
e svanisce la sera). |
Alte (cirri cirrostrati)
provenienti da SE, S, SW.
Al tramonto l'orizzonte e`
pieno di nubi. |
Orizzonte scoperto dalla
parte dove provengono le nubi.
A sprazzi si intravede l'azzurro
del cielo. |
Compatte, coprono tutto il
cielo. |
In prossimita` dei fulmini la temperatura arriva intorno ai 10000-15000
oC.
Bisogna quindi prestare attenzione alla attivita` elettrica durante
i temporali specialmente in montagna dove i fulmini sono piu`
frequenti.
Il problema principale non sono le scariche dei fulmini vere e proprie
(solitamente attratte piu` dalle cime delle montagne che da noi) ma
le scariche secondarie che dal basso (da terra) vanno verso le cime
seguendo il percorso a minor resistenza.
Riportiamo alcune regole di sicurezza in caso di
temporale:
[FIXME QUESTE REGOLE SONO DA VERIFICARE]
- Evitare di ripararsi sotto alberi isolati.
In generale stare lontani dagli alberi isolati almeno 200-300 m.
Stare in un bosco abbastanza fitto non da' problemi.
- Evitare i canaloni, i corsi d'acqua e le spaccature della roccia.
- Non tenere con se` oggetti metallici, specie se accuminati
(picozza)
- Stare lontani (50 m) anche dai conduttori metallici.
- Evitare di ammassarsi in gruppo: la colonna d'aria calda generata
puo` attirare il fulmine. L'aria calda contiene maggior
umidita` (in termini assoluti) ed e` un miglior conduttore dell'aria
fredda quindi la colonna d'aria costituisce un percorso preferenziale
per la scarica del fulmine.
- In caso di temporale ripararsi sotto un anfratto o una grotta;
meglio in valle che in cresta. Evitare di appoggiarsi alle pereti
umide e bagnate.
- Se non ci sono ripari sicuri, prendere piu` acqua possibile
perche i vestiti bagnati sono miglior conduttori del corpo umano
e quindi favoriscono la dissipazione della scarica.
- Si e` piu` sicuri dentro un riparo a rivestimento metallico,
automobile o rifugio. Il motivo di cio` e` che l'involucro metallico
forma una "gabbia di Faraday" al cui interno non si risente dei
campi elettrici esterni.
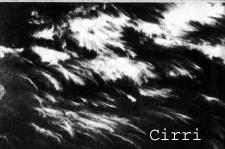 La previsione locale del tempo viene effettuata con osservazioni
dirette (venti, nuvole, aspetto del cielo) e con misurazioni
(pressione atmosferica, temperatura, umidita`)
ripetute ad intervalli regolari.
La previsione locale del tempo viene effettuata con osservazioni
dirette (venti, nuvole, aspetto del cielo) e con misurazioni
(pressione atmosferica, temperatura, umidita`)
ripetute ad intervalli regolari.
 Variazioni significative sono dell'ordine di 100-150 m in 12 ore.
Variazioni di poche decine di metri sono dovute al ciclo termico diurno.
In estate, durante le belle giornate la quota aumenta nel primo pomeriggio
e diminuisce alla mattina a causa del diverso riscaldamento dell'aria
che ne varia la temperatura e quindi la densita`.
A una maggior temperatura corrisponde una minor densita` (per la legge
dei gas: P/d = R T, la pressione diviso la densita`
e` proporzionale alla temperatura), e quindi una minor pressione
atmosferica (che e` data dal peso della colonna d'aria sovrastante);
questo viene rilevato dall'altimetro come un aumento di quota.
Variazioni significative sono dell'ordine di 100-150 m in 12 ore.
Variazioni di poche decine di metri sono dovute al ciclo termico diurno.
In estate, durante le belle giornate la quota aumenta nel primo pomeriggio
e diminuisce alla mattina a causa del diverso riscaldamento dell'aria
che ne varia la temperatura e quindi la densita`.
A una maggior temperatura corrisponde una minor densita` (per la legge
dei gas: P/d = R T, la pressione diviso la densita`
e` proporzionale alla temperatura), e quindi una minor pressione
atmosferica (che e` data dal peso della colonna d'aria sovrastante);
questo viene rilevato dall'altimetro come un aumento di quota.
 In estate si hanno variazioni rapide che generano spesso condizioni
temporalesche.
In inverno le variazioni sono piu` lente e meglio monitorabili
nel tempo.
In estate si hanno variazioni rapide che generano spesso condizioni
temporalesche.
In inverno le variazioni sono piu` lente e meglio monitorabili
nel tempo.
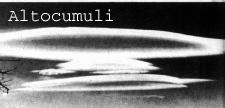 La direzione dei venti viene valutata osservando il movimento delle
nuvole allo zenit (cioe` sopra la testa); il movimento delle nuvole
nei pressi delle cime delle montagne e delle dorsali risente della
orografia.
La variazione della direzione dei venti e` indice di cambiamento del
tempo.
Se le condizioni migliorano i venti tendono a ruotare verso NW, N.
Se peggiorano verso SE, S.
La direzione dei venti viene valutata osservando il movimento delle
nuvole allo zenit (cioe` sopra la testa); il movimento delle nuvole
nei pressi delle cime delle montagne e delle dorsali risente della
orografia.
La variazione della direzione dei venti e` indice di cambiamento del
tempo.
Se le condizioni migliorano i venti tendono a ruotare verso NW, N.
Se peggiorano verso SE, S.
 La
brezza e` un leggero vento dovuto alla differenze di temperatura
causata dalla insolazione durante il ciclo diurno.
Di notte la brezza scende dai monti verso le valli (da terra verso il
mare), di giorno va nella direzione opposta.
Quindi il regime di brezza e` tipico di condizioni di bel tempo.
La cessazione di un regime di brezza e` indice di peggioramento delle
condizioni.
La
brezza e` un leggero vento dovuto alla differenze di temperatura
causata dalla insolazione durante il ciclo diurno.
Di notte la brezza scende dai monti verso le valli (da terra verso il
mare), di giorno va nella direzione opposta.
Quindi il regime di brezza e` tipico di condizioni di bel tempo.
La cessazione di un regime di brezza e` indice di peggioramento delle
condizioni.