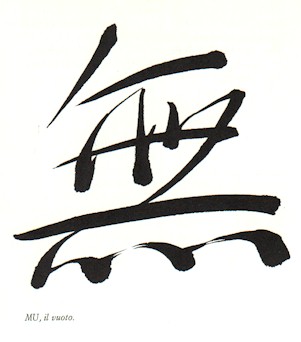|
Maria Grazia Tundo Saggi e scritture |
||
| HOME PAGE
SAGGI Lo spazio del cinema: specchio di vita La riscrittura della fiabe: La camera di sangue di Angela Carter L'impossibilità dell'autobiografia.L'amant di Marguerite Duras Estraneità e parola. Simultan di Ingeborg Bachmann Il corpo impuro della luna. Salomè di O. Wilde Le voci dell'in-concepibile nel sogno di una scrittura: Frankenstein di Mary W. Shelley SCRITTURE RECENSIONI Fiction, Fact, in Flux. Marisa Bulgheroni, Apprendista del sogno (in Italiano)
Maria Grazia
Tundo 1999:
|
Cosa fa sorgere il desiderio di leggere un testo? Forse il suo essere ben in vista, esposto in libreria nel posto giusto? Ma questo è solo il libro, funzionale al processo di riproduzione sociale, importante solo per il suo valore di scambio all’interno del circuito dell’editoria. Certamente a questa logica non si può sfuggire: si leggerà il libro perché è libro di successo, reso appetibile da una copertina adeguata, dal suo essere stato insignito di un importante premio letterario. Intanto ci si lascia portare dalle suggestioni del titolo: L’Amant (l984). Un titolo denso e, nel contempo, indifferente; un’unica, antica parola, che si carica di ambiguità. Un universo si riempie d’attesa: i segni dell’eros colpiscono sempre, incidono il nostro desiderio del testo, che è desiderio di quell’atopia che l’eros sempre offre come suo carattere. L’Amant e Marguerite Duras. Le notizie di lei, dell’autrice, i legami che i critici si ostinano a trovarle con l’école du regard, i suoi film, il premio Goncourt. Tutto ciò si compone nella mente, si lega in orizzonti di senso, condiziona l’approccio al testo dal punto di vista conoscitivo. Eppure. Marguerite Duras è anche un nome proprio, carico di suggestioni sonore, un segno da interrogare nella sua dimensione "fantasmagorica". La dimensione autobiografica del testo fa dell’autrice un personaggio romanzesco. Invece di porsi come garanzia di realtà, il nome proprio si disarticola dal referente (la scrittrice in carne ed ossa) ed entra nell’universo dell’immaginario. Tento di figurarmi un volto, un corpo. Sempre mi sfugge, non si delinea, riassorbito dal nome, dal fantasma da esso evocato. Tramite questo nome entro nell’immagine, nel mondo irreale che il mio desiderio di lettura inizia a comporre. Mi ostino a cercare nel testo il corpo fantasmatico dell’autrice e, nel contempo, so che lo perderò. Mi interrogo sull'autrice, su questa assenza sonora che mi investe di curiosità. Chi più sperduto e solo di un autore, di colui che firma l'opera con il proprio nome, di colui che l'opera stessa perde nel momento di questo suggello? Colui che si confronta, si lascia prendere dal gioco inesauribile della scrittura è colui che non può che provare l’angosciosa salvezza dello spossessamento della parola. Si trova dinanzi al paradosso di non esistere prima e al di fuori dei segni che lo rendono autore. (Blanchot 1981, it., 9-17). Se il linguaggio della normalità quotidiana, con le sue enunciazioni regolate dal Codice, può illudere la stabilità dell’io, può aiutare la delimitazione di un'identità, di un ruolo, la scrittura è proprio ciò che tale illusione infrange. Lo scrittore è, allora, colui che si affaccia all’esistenza come ad una grande narrazione, colui che all'ovvietà ed alla logica comune del quotidiano sostituisce un ascolto attento a percepire quel brusio ben più complesso, ben più articolato che si innalza dall’apparente semplicità dell’oggetto. Questa inclinazione all’ascolto è saper leggere oltre il nome ed il senso compiuto dell’oggetto stesso, fino a lasciare che esso riveli tutto il suo mistero. Ed è anche un rileggere se stessi, un interrogare la propria presunta identità. Ecco la solitudine dello scrittore, la sua solitudine anche rispetto al proprio io. Senza storia, benché immerso nello scorrere del tempo, e degli eventi, e dei libri. Senza passato, benché il suo corpo scritto conservi la memoria di tracce indelebili. Senza identità, benché questa stessa egli forse ricerchi, ogni volta sconfitto, nello spazio delle sue parole. Comincio ad esplorare il testo. La prima pagina. L’inizio. Forse un inizio è sempre casuale, eppure, in quanto principio, diviene altamente significativo nel nostro orizzonte di senso. Mi sottometto alla convenzione e vi cerco la densità dei segni. Penso all’autore. Iniziare la scrittura è sempre cominciare a sperdersi, a raddoppiarsi. Accetto la regola dell’inizio. Non perché un inizio abbia una qualche verità. Ma perché è lì che una superficie riflettente si infrange, che uno specchio si incrina, che un foglio si macchia. Mi affascina ogni inizio, anche se appartiene ad un puro gioco linguistico e non all’evento, come mi affascina ogni fine, perché avverto la loro insignificanza, la loro indifferente arbitrarietà. Eppure è questa arbitrarietà, questo tempo discontinuo a cui mi costringe il linguaggio ad offrirmi l’attimo di smarrimento che in ogni racconto ricerco. In fondo ogni scrittura è un perpetuo interrogarsi sul cominciare dell’evento, della narrazione. E sul loro cessare. Il romanzo si apre su notazioni temporali: l’essere vecchia, l’essere giovane. Il tempo cronologico, però, viene immediatamente negato: la giovinezza e la vecchiaia non si susseguono ordinate, ma sono inscritte l’una nell’altra. La scrittura della Duras vuole sfidare la griglia organizzatrice imposta dal linguaggio al tempo e, per farlo, rinuncia all’intreccio ed ai suoi nessi causali, rinuncia al concatenamento verosimile degli eventi importanti, alla loro sistemazione gerarchica. Forse una vicenda d’amore non è inscritta nel tempo, ma è fissa in un’immagine, e questa stessa immagine è ciò che dà l’avvio alla scrittura: "Je pense souvent a cette image que je suis seule a voir encore et dont je n’ai jamais parlé. Elle est toujours là dans le meme silence, émerveillante. C’est entre toutes celle qui me plaît de moi-même, celle où je me reconnais, où je m’enchante. " (Duras, L’Amant, 9). Con queste parole si vanifica ogni possibilità di cercare nello spazio della scrittura i segni dell’autrice come di colei che sola possa garantire il senso definitivo dell’opera, come creatrice di un universo compatto e coerente, sorretto dalla ferrea legge della totalità. Che scrittura autobiografica può essere questa che trova in un’immagine il suo punto di partenza? Non siamo di fronte ad una confessione; il fatto che l’io del narratore sembri rinviare senza maschere a quello dell’autore appare piuttosto una maniera per perdersi definitivamente nel gioco di specchi di ogni mimesi. Se esiste passato, appartiene all’immagine e la memoria non rinvia ad eventi reali, ma ad un niente che, inoltre, è il senso di ogni storia d’amore. L’universo dell’immaginario, presiede all’eros come alla scrittura, ospita i loro fantasmi. Se l’immagine è ciò che rende incerto il reale, in quanto afferma le cose nel momento del loro svanire, l’oggetto, investito dai segni dell’eros, dunque tramutato in immagine, si pone come inafferrabile (Blanchot 1955, it., 222-231). Il gioco d’amore è esattamente il lasciarsi incantare da questa immagine, sempre altra, che si avvicina in una ineliminabile distanza; questa stessa immagine è proprio ciò che sottrae il senso, il significato all’oggetto introducendolo in quella dimensione di imprevedibili possibilità che è l'immaginario. Se l’oggetto è solo sembianza, e come tale inappropriabile, il soggetto si sperde, si indebolisce, fluidifica nella malinconia (Agamben 1977, 28-35). La malia fascinatrice dell’immagine non può, allora, che rendere indeterminati i contorni dell’io che scrive, in quanto egli stesso inscritto nella logica della seduzione. Diviene polútropos, ovunque differente (Baudrillard 1979, 93-98). Il romanzo della Duras non è, dunque, una rievocazione di eventi o la storia della propria vita. E', piuttosto, il racconto di sé, pura affabulazione. Costruzione, sperimentazione. Le immagini salgono alla memoria senza coerenza temporale, senza una logica. Ritornano, si ripetono nella loro continua differenza. Forse è un’unica immagine, a cui tutte le altre appartengono: il fiume, il traghetto, l’incontro. Lei, la ragazza-bambina senza nome, adolescente bianca, di quindici anni e mezzo ed il suo amante, il giovane miliardario cinese, in un’Indocina che poco conserva della sua realtà geografica, ma si sviluppa come spazio composito in cui si condensa la sostanza dei molti altri luoghi che la ragazza ha attraversato. La scrittura oscilla, nei brevi lampi offerti dalla memoria e conservati dall’oblio, tra la narrazione in prima e quella in terza persona. In questo susseguirsi di punti di vista gli eventi si sfrangiano, si caricano dell’intensa enigmaticità di ogni vita: "L’histoire de ma vie n’existe pas. Ça n’existe pas. Il n’y a jamais de centre. Pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où 1’on fait croire qu’il y avait quelqu’un, ce n’est pas vrai il n’y avait personne." (Duras 1984, 14). Forse il romanzo è la ricerca di un momento perduto, di un evento prodottosi per caso che risuona, chiama, si ripete in ogni frase. Forse al fondo di questo momento non c’è niente. Ed ogni sforzo della memoria è solo uno spingersi più lontano nella dimenticanza. Una dimenticanza che ha una sua forma, un niente che cela il reale. La propria storia è allora una fuga di significanti, un attardarsi negli angoli, un perdersi nelle digressioni della parola: "Quelquefois je sais cela: que du moment que ce n’est pas, toutes choses confondues, aller à la vanité et au vent, ecrire ce n’est rien. Que du moment que ce n’est pas, chaque fois, toutes choses confondues en une seule par essence inqualifiable, écrire ce n’est rien que publicité." (Ivi, 15). La scrittura non può portare chiarezza, positività. E' piuttosto un labirinto fatto di vento e vanità, ove tutte le strade si confondono, ove c’è solo l’infinita possibilità dell’andare. Quando la memoria viene a contaminare la parola, a farsi parola, si perde ogni illusione referenziale, ogni cronologia. Quando una voce narrativa organizzante viene a mancare si aprono delle falle nella catena simbolica, brandelli di ricordi si ammassano, frammenti di esistenza si intrecciano. E dunque il ’racconto’ non può che ospitare nel suo centro una zona bianca in cui passato e futuro coincidono nell’istante, in cui l’autore-personaggio si spalanca, dispiega, sparpaglia, si mantiene in un eterno indefinito. La familiare cornice della realtà si sgretola, ogni pretesa realistica si vanifica. Solo all 'essenza inqualificabile' della scrittura è dato accostarsi all'unicità della relazione amorosa, che è sempre atopica. Lo stereotipo non potrebbe fissarla in quanto essa è inclassificabile e resiste al linguaggio, al bisogno di descrizione, di definizione (Barthes 1977, it., 38-39). In L’Amant l’incontro con l’immagine – il primo incontro che scatena il desiderio – avviene sul fiume Mekong, su di un traghetto. Luogo di transizione fra due limiti. Spazio aperto, di mutamento, come anche sono aperti gli spazi della scrittura del romanzo, che sempre interroga la propria possibilità di strutturarsi. Sul traghetto avviene l’incontro con il nuovo, con ciò che porta ad infrangere i consueti orizzonti di senso e di valore che legavano la ragazza alla madre, alla famiglia, all’ambiente soffocante di Saigon. Qui sul fiume ha luogo lo scontro con il proprio passato, con la propria identità di adolescente francese, bianca, in Indocina; qui si insinua la frattura che l’eros porta con sé, e l’impudenza di una scrittura che, invasa dai segni del corpo e del piacere, diviene atopos. Il testo si sviluppa in maniera labirintica, suddiviso in parti asimmetriche, dalla lunghezza irregolare, raccolte senza alcuna gerarchia. I piani e le prospettive si intersecano, i ritmi si sovrappongono creando, pur nell’apparente frenetico mutare di prospettive, spazi di lenta sonorità. La scrittura della Duras appare aspra, scarna, sincopata, con proposizioni brevi, raramente subordinate. Vi è un netto prevalere della paratassi, della giustapposizione. Le immagini si incrociano, si succedono senza che un periodare ampio possa concatenarle tramite rigidi nessi causali: "Et elle, lent, patiente, elle se ramène vers elle et elle commence à le déshabiller. Les yeux fermés, elle le fait. Lentement. Il veut faire des gestes pour l’aider. Elle lui demande de ne pas bouger. Laisse-moi. Elle dit qu’elle veut le faire elle. Elle le fait. Elle le déshabille. " (Ivi, 49). L’attimo del denudamento, così descritto, è tutt’altro che un disvelamento, un mettere a nudo la verità dei personaggi, del loro rapporto amoroso. La memoria può solo raccogliere dei gesti, accostarli, contrapporli, guardare il loro ripetersi in una costante differenza. Nessun aggettivo qualifica l’evento, nessun senso vi viene imposto. Non c’è profondità: il gesto è il puro apparire del gesto, che nella ripetizione si diluisce in musica, si dilata, si carica di ambivalenza. Senza che il corpo venga rappresentato, esso riempie la scrittura dissolvendone ogni significato finale: le sue immagini debordano dai codici linguistici consueti, il logos non le contiene. Dominique Noguez ben nota come il testo durassiano sia profondamente intriso di oralità, come si avvicini alla canzone grazie alla sua struttura ripetitiva e ricca di assonanze (1985, 27-28): la phoné, che vi risuona come eco, rinvia alle pulsazioni corporee ed alla loro ’pura potenzialità’ (Bologna 1981, 1257-1258). E' proprio questa musicalizzazione a rendere il senso plurale, ad operare quella lacerazione nel tetico che permette l’irruzione della pulsione ed il conseguente sfaldamento del soggetto di una simile pratica testuale. Il godimento può cosi introdursi attraverso l’incrinazione dell’ordine sociosimbolico (Kristeva 1974, it., 65-85); il corpo può irrompere con la sua ambivalenza, sfuggendo all’interdetto che è l’uno (la legge, la definizione), negando ogni pratica linguistica monologica. Il linguaggio eccentrico della Duras sfida la lettura canonica del reale codificata da pratiche letterarie di tipo monologico, infatti nello spazio di questa scrittura plurale diviene difficile individuare chi scriva: l’autore, in quanto metamorfosizzatosi in soggetto della narrazione, diventa un anonimato, un bianco, un’assenza che consente alla struttura di esistere in quanto tale. Nel contempo egli ritorna come interlocutore della propria stessa scrittura, come lettore del proprio testo: "Occorre pensare allo scrittore (o al lettore, ma è la stessa cosa) come a un uomo smarritosi in una galleria di specchi: c’è un’uscita dove manca la sua immagine e lì c’è il mondo." (Barthes 1979, it., 46). Si pensi un attimo al continuo passaggio al discorso diretto nel bel mezzo di un enunciato in forma indiretta che è caratteristico dello stile di questo romanzo della Duras. La voce del personaggio si intreccia a quella del narratore, il passaggio dalla terza alla prima persona del verbo, dall’imperfetto al presente, avviene senza espedienti grafici che possano distinguere e distanziare le funzioni narrative. Le voci slittano l’una nell’altra, le intonazioni si sovrappongono: "Il parlait. Il disait qu’il s’ennuyait de Paris, des adorables Parisiennes, des noces, des bombes, ah là, là, de la Coupole, de la Rotonde, moi la Rotonde je préfère, des boîtes de nuit, de cette existence ’épatante’ qu’il avait menée pendant deux ans." (Duras 1984, 45). Ci si trova di fronte ad un incrocio di scrittura, ad un intreccio di citazioni, ad un vero tessuto testuale che, rinunciando alla rappresentazione dell’oggetto, mette in crisi l’identità del soggetto stesso della narrazione. Non si assiste, però, ad un annullamento del soggetto, quanto piuttosto ad un suo indebolirsi, ad un suo fluidificarsi nella malinconia che la scrittura e l’amore, in quanto entrambe esperienze vissute nella perdita, nella dépense, portano con sé: "Qu’aujourd’hui cette tristesse, tout en la reconnaissant comme étant celle que j’ai toujours eue, le pourrais presque lui donner mon nom tellement elle me ressemble. Aujourd’hui je lui dis que c’est un bien-être cette tristesse, celui d’être enfin tombée dans un malheur que ma mère m’annonce depuis toujours quand elle hurle dans le désert de sa vie." (Ivi, 57). La ragazza ha infranto il divieto materno: divieto d’amare, divieto di scrivere. Si è resa sconveniente, esorbitante. E' divenuta un soggetto sovrano secondo l’accezione di Bataille, un soggetto, cioè, che è preso dalla vertigine dell’indifferenza, che può essere tutti e nessuno, che può prostituirsi senza rimorsi. Svergognato, osceno, indipendente. Seduttore. Ella è fin da principio consapevole che il suo amante viene affascinato dal suo mettersi in scena, dal suo offrirsi come pura superficie illusoria allo sguardo: "Ce que je veux paraitre, je le parais, [...] tout ce que I’on veut de moi je peux le devenir. Et le croire. Croire que je suis charmante aussi bien. Dès que je le crois, que cela devienne vrai pour celui qui me voit et qui désire que je sois selon son goût, je le sais aussi. " (Ivi, 26). Aspetto fantasmatico dell’esperienza amorosa, passione per l’immagine, epifania dell’inafferrabile (Agamben 1977, 28-35). Anche la ragazza si perde nell’universo della seduzione che essa stessa, con la sua indifferenza, inaugura. Nei dettagli ci si sofferma a descriverne l’abbigliamento, i segni aleatori con cui si è ricoperta: l’abito di seta liso, le scarpe di lamè dorato con i tacchi a spillo, il cappello da uomo. Ha rivestito il suo corpo di incongruenza, di sfacciataggine, di accessori contraddittori che sfidano anche l’identità sessuale. Ed ognuno di questi oggetti è, feticisticamente, il segno di un’assenza. Del proprio essere? Di se stessa come oggetto del proprio stesso desiderio? È una maschera ciò che seduce, una maschera che nulla cela se non la propria fantasmagoria di segni beffardi. È quest’immagine di bambina perversa, che si offre con impudicizia ed arrogante ingenuità allo sguardo dell’uomo, a far collassare un mondo ordinato di valori sicuri. L’uomo sfida la legge, la propria verità razziale, pur di lasciarsi portare nella vertiginosa "piccola morte" che la ragazzina può offrirgli. Affascinato dalla paura. La ragazza, a sua volta, si scioglie tra le braccia di un uomo nel cui sguardo vede riflesso il vuoto del proprio piacere, e nel cui corpo morbido vuole confondersi alle altre donne che egli ha posseduto per essere, cosi, rapita dalla mise en abyme della moltitudine dei corpi femminili che scivolano nella memoria di lui. Rinuncia al possesso per esperire l’ignoto che mai appaga: "Je lui dis que j’aime l’idée qu’il ait beaucoup de femmes, celle d’être parmi ces femmes, confondue." (Ivi, 53-54). Confondere se stessi è guardare incantati il proprio morire, la propria assenza, la propria metamorfosi. Allora anche il desiderio si espande, oltre ogni barriera; l’oggetto si muta, si raddoppia, si moltiplica: "Je suis extenuee du désir d’Hélène Lagonelle. Je suis exténuée du désir. Je veux emmener avec moi Hélène Lagonelle, là où chaque soir, les yeux clos, je me fais donner la jouissance qui fait crier. Je voudrais donner Hélène Lagonelle à cette homme qui fait ça sur moi pour qu’il le fasse a son tour sur elle. [...] Ce serait par le detour du corps de Hélène Lagonelle, par la traversée de son corps que la jouissance m’arriverait de lui, alors définitive. De quoi en mourir." (Ivi, 91-92). Il desiderio non è altro che questa estenuante emorragia in cui si diluiscono oggetto e soggetto. Nessun paradigma lo contiene: i limiti personali si ritrovano soppressi, e questo è il senso del morirne. La vita appare, nel momento di tale morte, come prodiga, eccessiva, minacciosa e sconfinata: non c’è più spazio per 1’accumulo dei segni. Tutto scorre e si disperde in un infinito languore. La scrittura che, metonimicamente, doppia l’eros, si situa in questo stesso spazio di flusso ed instabilità senza tentare di occultare quella frattura della presenza che è all’origine di ogni significare. Il soggetto compatto e la sua legge lasciano il posto ad una soggettività diluita, estenuata, diffusa. Ecco dunque l’impossibile autobiografia del romanzo della Duras: il corpo ed il suo inappagabile desiderare ne hanno invaso la parola, destituendola di ogni significato ultimo, destrutturandola in maniera che il volto dell’autrice ne emerge ormai rifratto e definitivamente oscurato. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Einaudi, Torino 1977. R. Barthes, Fragments d'un discours amoreux, Seuil, Paris 1977; tr. it. Einaudi, Torino 1979. Id., Sollers écrivain, Seuil, Paris 1979; tr. it., SugarCo, Milano 1979. G. Bataille, L’érotisme, Minuit, Paris 1957; tr. it., Mondadori, Milano 1969. Id., L’Expérience interieure, Gallimard, Paris 1973; tr. it., Dedalo, Bari 1978. J. Baudrillard, De la seduction, Galilee, Paris 1979. Id., Les strategies fatales, Grasset R Fasquelle, Paris 1983. M. Blanchot, L’espace littéraire, Gallimard, Paris 1955; tr. it., Einaudi, Torino 1967. Id., De Kafka a Kafka, Gallimard, Paris 1981; tr. it., Feltrinelli, Milano 1983. C. Bologna, "Voce", in Enciclopedia, vol. XIV, Einaudi, Torino 1981. M. Duras, L’Amant, Minuit, Paris 1984. J. Kristeva, La Révolution du langage poétique, Seuil, Paris 1974; tr. it., Marsilio, Venezia 1979. M. Marini, Une femme sans aveu, in "L’Arc", 98. D. Noguez, La gloire des mots, in "L’Arc", 98. M. Saporta, Le regard et l’école, in "L’Arc", 98. M. Solimini, Malinconia e disgressione, in "Lectures", 14.
© Maria Grazia Tundo 1999
|