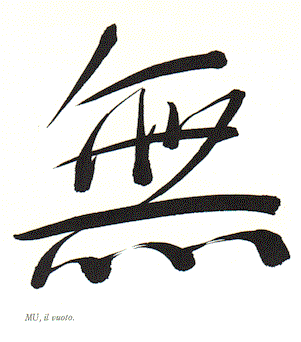|
Saggi e scritture |
|
| HOME PAGE SAGGI La riscrittura della fiabe: La camera di sangue di Angela Carter L'impossibilità dell'autobiografia.L'amant di Marguerite Duras Estraneità e parola. Simultan di Ingeborg Bachmann Il corpo impuro della luna. Salomè di O. Wilde Le voci dell'in-concepibile nel sogno di una scrittura: Frankenstein di Mary W. Shelley SCRITTURE RECENSIONI Fiction, Fact, in Flux. Marisa Bulgheroni, Apprendista del sogno
Maria Grazia Tundo 1999:
|
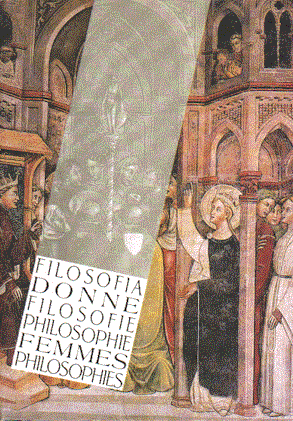
Identità e differenza in AAAA, Filosofia Donne Filosofie, Atti del convegno internazionale, (a cura di M. Forcina, A. Prontera, P. I. Vergine), Lecce 27-30 aprile 1992, ed. Milella, pp. 527-534.
Il concetto di identità si può articolare solo in ambito linguistico e semiotico: è nel linguaggio che un "soggetto" si pone e si differenzia dall'altro (1); è con l'acquisizione della parola che il bambino comincia ad elaborare la sua realtà di essere separato. Tale consapevolezza è carica di dolore ed incertezza. L'altro con cui si confondeva comincia ad apparire sempre più con chiarezza distinto da sé, il suo calore non è sempre disponibile, senza il suo nutrimento il corpo potrebbe morire, é in balia del suo potere e del bisogno, non ne può disporre a suo piacimento, bensì deve confrontarsi con la sua assenza. L'attività ludica aiuta a farsi carico di questa realtà inevitabile ed il linguaggio stesso si fa gioco raffinato per gettare un ponte verso l'altro. Ma questo linguaggio è dell'altro, non appartiene al bambino, è l'artificio che gli viene insegnato per colmare la sua pochezza ed entrare nel mondo civile, per trovare una collocazione nel sociale. Il suo corpo atopico, singolare non potrebbe parlare senza adeguarsi al posto che gli è stato assegnato: già il suo nome è frutto del desiderio dell'altro ed entrare nell'esistenza con un nome proprio, appositamente scelto, significa farsi carico dei sogni, dei desideri, delle fantasie di chi lo ha introdotto alla vita. Dunque ogni corpo che nasce si configura come già definito dal nome attribuitogli da chi ha deciso che dovesse far parte del mondo ed appartenere alla specie, alla stirpe, alla famiglia, ad un uomo ed una donna. A cominciare da questo nome si può dedurre la propria appartenenza al genere maschile o femminile e lentamente si impara che non tutto è concesso in maniera indistinta ai due sessi: ci sono "luoghi" femminili per eccellenza che hanno a che vedere con la cura, la riproduzione, l'affettività e la passività, mentre sono "maschili" quegli spazi legati all'attività cognitiva, razionale o operativa. Bisogna a questo punto prendere atto della propria realtà biologica e dalla configurazione anatomica del proprio corpo per trarne le debite conseguenze! Certamente nei primi anni di vita qualche incertezza sulla propria appartenenza di genere è plausibile, concessa. Si parla di bisessualità psicologica; il bambino può ancora essere un "perverso polimorfo" (con tutta la connotazione negativa di cui è carica la parola "perversione" ed il concetto di "normalità" che postula), ma c'è fiducia che seguendo lo sviluppo evolutivo ben delineato nei testi di psicologia questa posizione incerta venga superata per garantire all'individuo un perfetto inserimento nel sociale, per sancire l'acquisizione della tanto auspicata identità, in un ripudio dell'avidità onnipotente di chi vuole essere "tutto", uomo e donna insieme e nell'accettazione del proprio ruolo ben differenziato e distinto da quello dell'altro sesso, ma il più possibile simile a quello dei membri del proprio.(2) La differenza dell'altro, non radicale, ma codificata, ci restituisce dunque un senso di appartenenza ad un genere, ad una identità, rassicurando, creando limiti e confini, offrendo specchi in cui riconoscerci pacificati. Ma che questa pacificazione sia solo un inganno offerto dal simbolico condiviso lo dimostrano i segni di inquietudine ed incertezza che trovano espressione nei sintomi, nei sogni, nei giochi linguistici che rispondono ad una logica "altra" (lapsus; motti di spirito; metafore e metonimie idiosincratiche, non irrigidite in catacresi; forme artistiche; ecc.), in cui le opposizioni dicotomiche rivelano il loro statuto fantasmatico di costruzione meramente cognitiva. Non è possibile partire dall'anatomia come dato naturale per affermare che il rapporto conoscitivo e percettivo con il mondo sia condizionato dalla differenza sessuale in quanto si può tematizzare la differenza soltanto all'interno di un sistema che riunisca in generi e ponga in contrapposizione l'identico ed il diverso, espungendo tutti gli scarti e le eccedenze legate alla singolarità. Alla base dell'idea di differenza c'è dunque una preliminare operazione di selezione concettuale legata a delle gerarchie (cosa è più importante per il raggruppamento in categorie e cosa è marginale o accessorio; nel caso della differenza sessuale si privilegia l'evidenza genitale). Tale operazione, risponde alla smania di controllo e necessità di sicurezza dell'essere umano che maschera la sua insicurezza ontologica con poderose costruzioni razionali necessarie per arginare l'angoscia dell'incerto, dell'ambivalente, dell'irrisolvibile. L'opposizione binaria maschile/femminile serve a ridurre l'ambivalenza sessuale, come differenza inscritta potenzialmente nel corpo di ogni soggetto, perché altrimenti potrebbe sfuggire all'ordine sociale ed alle sue necessità di riproduzione.(3) Il riconoscimento della singolarità dell'altro e della sua irriducibilità in schemi e categorie implicherebbe ammetterne l'imprevedibilità (in quanto non potrebbe essere oggetto di una mathesis universalis), cioè accettare la propria impotenza e dimensione di esposizione all'ignoto che l'altro rappresenta, accettare che la presenza dell'altro si dia sempre su uno sfondo di impossibile possesso, cioè di possibile perdita. Ogni relazione intersoggettiva non può fare a meno di confrontarsi con tale ansia irrisolvibile. Alla luce di questo tutte le nostre costruzioni intellettuali e strategie linguistiche ed argomentative non possono che rivelare l'assenza di fondamento su cui si muovono. Se si accetta di confrontarsi con la "sapienza" in un'ottica non meramente speculativa, ma che parta da un rapporto con sé e con il mondo vissuto nella quotidianità di esperienze che non fanno la Storia, che non possono essere coagulate in una Narrazione, pur producendo un sapere ai limiti dell'eterogeneo e dell'idiosincratico, non si può non mettere in dubbio la presunta naturalità dell'esperire il proprio corpo e riconoscere che tutto ciò che ci sembra di percepire di esso è frutto di costruzioni immaginarie condizionate socialmente e storicamente. Non si vuole qui negare la "realtà" materiale del corpo biologico, ma solo mettere in guardia da facili essenzialismi, che nel rivendicare la differenza di relazione con l'ambiente (Umwelt) che le donne hanno rispetto agli uomini a causa della diversa anatomia (predominio del "tattile" rispetto alla visione (4), capacità relazionali più sviluppate, maggiore capacità di "prendersi cura" dell'altro, ecc. dovute alla potenzialità materna che è inscritta nel corpo(5), rischiano di riproporre in realtà una norma. La donna che non riconoscerà in sé tali caratteristiche emozionali e comportamentali verrà etichettata come gregaria all' etica ed ai valori "maschili". Sembra imporsi di nuovo la scelta oppositiva: stare dalla parte del Padre o della Madre. Mi domando se il singolo possa mai pienamente riconoscersi nel suo genere senza operare mutilazioni forti della propria esperienza. A livello concettuale può cercare di riportare alla "normalità condivisa" il proprio esperire, ma quanto ingannevoli siano tali reti di protezione e quanta complicità esse abbiano con i meccanismi sociali di dominio e sopraffazione è un discorso da affrontare con coraggio. Sicuramente le donne, da un punto di vista sia diacronico che sincronico, hanno subito ed ancora subiscono limitazioni potenti in ambito sociale soffrendo umiliazioni, marginalità, invisibilità politica.(6) Le attente analisi che su tali argomenti sono state condotte non possono essere minimizzate, appartengono ad una consapevolezza ormai acquisita non più soltanto nel pensiero delle donne, rimangono utili sfondi su cui elaborare delle strategie politiche e nello stesso tempo i saperi che tale "posizione" ha alimentato non devono essere disconosciuti o liquidati. Eppure credo sia oggi necessario rivedere in chiave critica, "genealogica" il concetto di differenza e scoprirne tutte le ambigue implicazioni. Mi permetto di partire dal disagio che mi provocano i discorsi sulla identità. Tale disagio voglio interrogare per farne un punto di vista parziale, provocatorio, che mi mette in gioco con le mie ansie e solitudini. Dal pensiero che riduce il mondo in concetti oppositivi, che della definizione fa un suo punto di forza e quindi sembra offrire protezione e percorsi non troppo accidentati su cui muoversi, mi faccio sovente sedurre. Non è possibile disconoscere o liquidare come risibile la necessità di orientamento nell'intricato universo naturale e relazionale a cui apparteniamo. E' però altrettanto necessario riconoscere la parzialità e relatività delle categorie a cui facciamo riferimento; tenerle come strumenti provvisori di lavoro nella consapevolezza piena che la "verità" è solo una funzione pragmatica di controllo del mondo che ci circonda. L'identità può essere individuale o di gruppo, in entrambi i casi può darsi solo come concetto oppositivo. Perché un gruppo si ponga come unità compatta è necessario espungerne le eccedenze, le singolarità che potrebbero comprometterne l'effetto di omogeneità; l'unica maniera per riuscire in tale compito è crearsi un "nemico" a cui affidare tutte le differenze, su cui proiettare tutte le proprie marginalità. Se è vero che tale operazione è stata compiuta in maniera sistematica e radicale nella contrapposizione uomo-donna, per cui il soggetto sociale e linguistico che ha parlato più forte è riuscito a tematizzare la differenza dell'altra, definendola alla luce delle proprie paure, del lato oscuro del proprio desiderio che rischiava di scompaginare l'unità del proprio gruppo, unità peraltro indispensabile nella ricerca e nel consolidamento del potere, è altrettanto vero che anche vedersi riflesse nello specchio dell'uomo ha permesso alle donne di trovare delle categorie di riferimento di gruppo a cui affidare il compito di sancire le proprie peculiarità: la differenza sessuale rimane uno dei modelli di identificazione a cui far riferimento e che vengono introiettati in maniera assolutamente capillare. Da un punto di vista linguistico, possiamo parlare di stereotipie, "luoghi comuni", cioè luoghi del discorso che presuppongono la comprensione condivisa dei gruppi che ne fanno uso e quindi rinsaldano l'idea di appartenenza. Non credo che si possa uscire da tale meccanismo avvilente e restrittivo semplicemente valorizzando la differenza di genere e dandole uno statuto forte, offrendo la possibilità alle donne di parlare con più autorevolezza per creare i propri modelli di riferimento comportamentale e di pensiero. L'operazione sarebbe speculare all'altra, sposteremmo la nozione di soggetto da universale a sessuato, il che, in realtà, implica un'altro lavoro di universalizzazione, di definizione e dunque di marginalizzazione delle singolarità. Una maniera per sottoporre ad investigazione critica i luoghi in cui gli stereotipi di genere si sono consolidati ed hanno contribuito ai meccanismi di dominio ed esclusione delle donne dagli spazi del potere e della libertà è rinunciare alla pretesa di trovare cause, origini o verità del desiderio femminile e dell'identità sessuale, e riconoscere la natura relazionale di concetti come donna o femminilità. Le categorie dell'identità sono gli effetti di quelle istituzioni, discorsi e pratiche politiche che svolgono compiti di definizione (7) ed il soggetto femminile per il quale si cerca di ottenere rappresentanza politica è esso stesso "prodotto" dai sistemi giuridici di potere che poi lo dovrebbero rappresentare e tutelare. Naturalmente asserire tutto ciò non implica negare l'esistenza della ripartizione in "generi" dell'umanità, bensì evidenziare come tale ripartizione non sia relativa a dei "corpi innocenti e naturali" e dunque precedente ad ogni tematizzazione concettuale o inscrizione nel simbolico, ma profondamente marcata dalle pratiche discorsuali e filosofiche che li hanno così suddivisi e gararchizzati. Sono veramente due i sessi? Non potremmo rivisitare transvalutandolo il concetto di "neutro" e riutilizzarlo come spazio della non-definizione, del "ne' l'uno ne' l'altra", dunque anche come spazio etico di rispetto per l'alterità che ci si rifiuta di tematizzare, mantenere tale spazio come sfondo che sembra interrogare le certezze acquisite per rimetterle sempre in gioco? (8) Non si tratta di riproporre la finta neutralità del soggetto che ha posto la propria parzialità mascherandola con l'universale. Si tratta piuttosto di cercare luoghi del discorso e del pensiero in cui non si rinsaldino altre universalità, per quanto di segno femminile. Naturalmente non è possibile essere ingenue o troppo radicali: non si può rinnegare la nostra appartenenza al simbolico, o rinunciare del tutto ad utilizzare concetti, categorie e tutte le altre "stampelle" linguistiche e filosofiche che ci servono per tenere a bada l'angoscia del non-sapere e per entrare in relazione con gli altri grazie ad un codice almeno in parte condiviso. Se è vero però che i limiti del linguaggio sono i limiti del nostro mondo possiamo provare a dilatare questi confini mettendo in dubbio quelle certezze sulla ripartizione binaria del mondo che si pongono come naturali evidenze ed invece, a ben guardare, sono costruzioni storiche e di discorso. Proviamo a focalizzare la nostra attenzione sulla pratica della scrittura letteraria. Sono recenti e diffusi i tentativi di caratterizzare una "scrittura femminile", di definirne gli aspetti salienti e ricorrenti in modo da contrapporla ad una modalità maschile di produzione di opere letterarie e da avere un corpus di testi in cui identificarsi, a cui far riferimento, in cui trovare risposte. Perché cercare nei testi di scrittura l'identità di genere? Proprio qui dove ogni concetto di identità, coerenza e compattezza del soggetto si rivela illusorio, viene messo in crisi o rivelato come inganno, dove si rendono visibili conflitti e contraddizioni di significato attivare una lettura critica del testo che voglia rintracciare somiglianze, caratteristiche comuni o addirittura definire le peculiarità di una scrittura femminile risulta restrittivo e funzionale ad un pensiero incapace di decostruire le opposizioni dicotomiche tra maschile e femminile e che ha necessità di inventarsi i propri "luoghi comuni", ad un pensiero che non riesce a figurarsi l'"eterogeneo", il "misto". Vorrei portare un esempio tratto da un testo letterario. C'è un racconto lungo di Doris Lessing che ha per titolo The Fifth Child [Il quinto figlio] (9), la cui lettura produce un effetto inquietante anche perché risulta difficile inserirlo all'interno di una categoria di "genere". Non è facile decidere se si tratti di un racconto realista o se appartenga alla fantasy, ma l'effetto più propriamente sconcertante è dato dalla tematica che affronta, cioè quella della maternità. Questo luogo sacro del femminile, da sempre soggetto alla retorica più melensa o più subdola, viene rappresentato come carico di ambivalenza ed indecidibilità. Il racconto si apre con una coppia felice, Harriet e David, che a dispetto di ogni ostacolo è in grado di costruire la vita da sempre sognata: una grande casa accogliente sempre piena di amici, quattro figli che nascono desiderati e che si integrano perfettamente nelle coordinate del progetto familiare. Quando la donna rimane incinta per la quinta volta qualcosa accade, qualcosa di indefinibile. Il suo rapporto con il bambino che ospita non ha più nulla della gioiosa vitalità che aveva caratterizzato le altre quattro gravidanze; c'è una istintiva, fisica repulsione per questo essere che invade l'interno del suo corpo ed asserisce la sua presenza con prepotenza, scalciando e provocando una serie di sintomi insopportabili. Sia il momento del parto che la successiva presenza del bambino rafforzeranno tale impossibilità di relazione: c'è nel bambino una vitalità spaventosa, che lo rende non inquadrabile nelle definizioni della normalità che di solito si danno, ma neanche tematizzabile come "diverso" da un punto di vista diagnostico. Riesce difficile classificare tale neonato che, però, con la sua sola presenza riesce a disgregare la serenità della vita familiare, a rompere l'incantesimo di un'esistenza immune dal conflitto e dal dolore: Ben non è bello o amabile, ma non è neanche fragile o malato al punto da poterne avere compassione. Al contrario è robusto, molto più pesante della media, muscoloso, resistente, forte. Su questa immagine di bambino ogni retorica dei buoni sentimenti si rivela inadeguata: "mostro", "alieno", "fatto di una sostanza differente", "nemico", non ordinario" sono alcune delle parole che nel corso del racconto vengono utilizzate per definirlo e che ne rimandano l'inclassificabilità. Anche il momento dell'allattamento è carico di sgomento in quanto l'avido neonato sembra volere prosciugare la donna, succhiarle tutto il suo essere, svuotarla di ogni nutrimento.(10) In queste descrizioni viene messo in luce il lato oscuro di un'esperienza come quella della maternità che è sempre stata espurgata di ogni inquietudine per ricondurla alla solarità di una funzione sociale condivisa e necessaria alla riproduzione del sistema. Invece essa emerge dal racconto come un'esperienza assolutamente singolare, non tematizzatile, ai limiti dell' abiezione (11) e relativa al rapporto tra due esseri (madre e figlio) che, pur essendo inscritti in una realtà storica, linguistica e sociale che ne determina e sancisce in buona misura i comportamenti, rimangono eccedenti l'uno all'altra: Ben è pensato come l'alieno, appartenente ad una razza diversa da quella umana, impossibile da comprendere e con cui non si può entrare in relazione se non abbandonando i codici sociali condivisi per cercare uno spazio di comunicazione in grado di leggere l'idiosincraticità dell'altro. Probabilmente Ben si dà come il lato oscuro dell'infante (di ogni in-fante) nel momento in cui viene al mondo e porta con sé la possibilità di disgregare con la sua atopia ed imprevedibilità ogni strutturazione familiare: è il paradosso dell'altro non ancora inscritto nel codice - quell'altro che anche noi eravamo e di cui ci resta forse un'oscura memoria - che viene ricondotto al noto con un'operazione di nominazione e categorizzazione atta a disattivarne la potenziale minaccia. Nel racconto la protagonista accetta di tenere quell'essere indefinibile ed eccessivo accanto a sé, rinunciando a comprenderlo, ma tentando sempre e comunque di entrare in rapporto con la sua vita: il prezzo da pagare è alto; significa sancire la rovina definita del sogno di vita familiare armonica ed esente dal dolore che solo la rimozione del "diverso" (12) potrebbe ancora permettere. Nel momento in cui riconosce il diritto inalienabile all'esistenza di Ben lei valica quel confine che stabilisce i criteri della normalità e dell'umanità e si avvicina al territorio estraneo che l'altro occupa. Questo luogo di frontiera diviene così uno spazio di relazione reale benché inclassificabile, legata esclusivamente ad un "guardarsi" (13) reciproco carico di domande senza risposta.(14) Mi sono dilungata su questo testo perché mi sembra ponga indirettamente delle questioni interessanti relative alla tematica di cui sto trattando. La "figura" del quinto figlio (il suo essere maschio rafforza la distanza dall'identità della protagonista rendendo ancora più difficile ogni forma di "identificazione" con lui) è l'ingombrante presenza di ciò che non può essere codificato nel discorso, la disturbante invadenza dell'inaddomesticabile, che pur avendo origine all'interno di sé si pone immediatamente come altro. E' la singolarità assoluta che richiede un rischio assoluto per poter essere ammessa a far parte del sociale. Eppure ancora più dirompente potrebbe essere leggere questo Ben come la propria stessa vitalità resa estranea, soffocata, che il discorso potrebbe forse definire "maschile", che ha familiarità con il dolore e la violenza, che non può riconoscersi in un'immagine limpida e definita, ma riceve dallo sguardo degli altri la condanna per la propria eccedenza. "Aspra e massiccia insorgenza di un'estraneità che se mi è stata familiare in una vita opaca e dimenticata ora m'incalza come radicalmente separata, ripugnante".(15) Riconoscere in sé la presenza di un'eterogeneità siffatta senza averne orrore, accettando il rischio che essa comporta di una confusione delle categorie, comprese quelle di genere, significa operare una svolta radicale rispetto a quei discorsi sulla differenza sessuale che rischiano di riproporre un femminile pacificato nella contemplazione della propria comunità di simili. Ciò porta ad auspicare e a lavorare per un mondo che mutili il meno possibile le differenze e non le riduca a luoghi di simmetria speculare dell'identità. Infatti solo tutto ciò che eccede l'identità (intesa come luogo di coerenza e continuità con sé e con il proprio genere) può dar vita a quello spazio di transizione tra sé e l'altrao in cui è la relazione a creare i soggetti ed a modificarli e che si pone come unico luogo di eticità possibile. Note Cfr. Franco Fornari, Genitalità e cultura, Milano, Feltrinelli, 1975, pp.58-62. Cfr. Umberto Galimberti, Il corpo: Antropologia, psicoanalisi, fenomenologia, Milano, Feltrinelli, 1984, pp. 187-188. Cfr. Luce Irigaray, Etica della differenza sessuale, Milano, Feltrinelli, 1985, p. 128. Cfr. Carol Gillian, Con voce di donna: Etica e formazione della personalità, Milano, Feltrinelli, 1987. Affinando però il pensiero, salta subito agli occhi che, comunque, le modalità di discriminazione nei confronti delle donne si intersecano con caratteristiche etniche, razziali, di classe, ecc., il che rende ogni discorso sull'oppressione della donna in generale poco proficuo anche dal punto di vista dell'operatività politica. Cfr. Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, Chapman & Hall, Inc., 1990, p. xi. Wanda Tommasi parla della necessità di tenersi in prossimità col ne-uter che, escluso dalla filosofia e dalla logica della non contraddizione, prefigura una modalità del pensiero e del linguaggio diversa dall'eterno gioco di riconduzione al Medesimo che invece procede per coppie di opposti, simmetrici e speculari. A tal proposito cfr. Wanda Tommasi, " La tentazione del neutro", in AA.VV., Diotima: Il pensiero della differenza sessuale , Milano, La Tartaruga, 1987, pp. 88-94. Utilizzo il termine "abiezione" secondo l'accezione di Julia Kristeva: "L'abietto non è un oggetto dinanzi a me che io possa nominare o immaginare. [...] Dell'oggetto l'abietto ha una sola qualità: si oppone a io. Ma se l'oggetto opponendosi mi equilibra nella fragile trama di un desiderio di senso che di fatto mi omologa a sé indefinitamente, infinitamente, l'abietto invece oggetto caduto è radicalmente un escluso e mi trae dove il senso sprofonda.", J. Kristeva, Poteri dell'orrore: Saggio sull'abiezione, Milano, Spirali, 1981, pp. 4-5. Ben viene, infatti, condotto in un "istituto" dove le famiglie ricche si sbarazzano dei propri figli anormali, un luogo di orrore e abbandono in cui Harriet non ha però il coraggio di lasciarlo. Cfr. D. Lessing, op. cit. , pp.78-85. "Un segno è ciò che si ripete. Senza ripetizione non vi è segno, perché non lo si potrebbe riconoscere, e il riconoscimento è ciò che fonda il segno. Ora [...] lo sguardo può dire tutto, ma non può ripetersi testualmente. Dunque, lo sguardo non è un segno, e tuttavia significa. Che cos'è questo mistero?", Roland Barthes, L'ovvio e l'ottuso, Torino, Einaudi, 1985, p.301. |