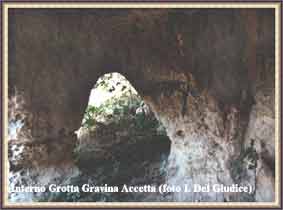|
Prefazione
Questo racconto popolare, ascoltato infinite volte negli anni dell'infanzia,
viene, come la maggior parte dei "cunti" che circolavano a Statte,
da molto lontano.
Nella mia famiglia risaliva, a memoria di mio padre,
almeno al trisavolo Grazio, ma la sua età doveva certamente essere più
antica, tanto da perdersi in un passato che può essere identificato
soltanto nell'avverbio 'Sempre'.
Il "fatto" di Giovanni senza paura
si
raccontava, perciò, da sempre: lo raccontò nonno Angelo
a mio padre, il
bisnonno-tataranne Biagio
al nonno, il trisavolo Grazio
al bisnonno e così
indietro fino a quel 'sempre' senza confini.
La storia appartiene al filone delle leggende 'omeriche' diffuse in tutta la Puglia, soprattutto nella Magna Grecia, dove le gesta degli eroi cantati da Omero attecchirono e trovarono il terreno ideale per quella grande fioritura di
"cunti" e di "fatti" che dai tempi della prima colonizzazione greca giunsero sino a noi.
Nel personaggio protagonista del 'fatto' che qui
presentiamo è facile, difatti, riconoscere il leggendario eroe della
guerra di Troia e prim'attore dell'Odissea, Ulisse, e nella storia
raccontata l'episodio di Polifemo, il ciclope accecato dall'astuto re di
Itaca, insuperabile nell'ordire inganni, che andava per il mondo "a
seguir virtute e conoscenza".
E, come lui, anche Giovanni senza paura, eroe
popolare di casa nostra, riesce ad avere la meglio di un altro Polifemo,
il favoloso Tatarannorco (a Manduria, dove si racconta una storia
simile, è detto, invece, "Uecchirussi", mostro orrendo che
insieme con gli scorciamani, I aùria, i mamòni ed altri mostriciattoli
senza nome, abitava di diritto quel mondo dell'infanzia vissuta in un
paese che forse non si è perduto per sempre e che questa storia ci
aiuta a recuperare.
Una storia che raccontiamo con gli stessi ritmi e
le stesse cadenze di una lingua popolare, tra il dialetto e 1'italiano,
nella quale l'ascoltammo e che abbiamo ritrovato, parola per parola,
scritta in un vecchio quaderno di scuola elementare.
Angelo Marinò

Altra grotta nella "gravina"
(cliccare sulla foto per ingrandirla)
Saggezza nostrana
Tre "C" so
pereculùse pe le
vijecchie:
catarre, cadute e cacarèdde.
A' troppa cunfedènze devènte malecrianze.
L'omme allègre Die l'aiute.
Vieste Ceppòne ca pare barone.
Dò pète inda nà scarpe nònce ponne
stè.
A' fémmene ne sèpe iune chiù du'
diaule.
La "poesia" dialettale.
ANTONIE PETROGLIE (alias Antonio Mastromarino)
Alla bececlétte,
de coste se métte,
ma appiede camine,
a sére e a matine.
Petroglie, fumanne
vé sèmbe carescianne,
do trozzele vjecchie
che fjierre e nu sicchjie.
E porte strascédde,
che spéghe e taulédde,
ca jidde appliche,
ca so rrobbe antiche.
Cu schérze e a battute,
a tutte salute,
e po all'occasione,
jiè pure chiacchiarone.
Mo tène a chitarre,
e a canzone l'angarre;
da fèste ha sunéte
e nà descrejiéte.
A' fatte a macchjiétte,
commà n'operétte;
u prime à reveète;
a coppe à pegghjiète.
A Nateéle ca véne,
Petroglie, a nuvéne,
secure à sunè,
e avva cantè.
Na vote decjieve,
purcè no te ljieve,
Antò, stu cazoone,
te vé a scialabroone.
E jidde, me disse,
tremendénneme fisse,
"no sacce nescjiune
c'acconze cazune".
Po Antonie Petroglie,
aprì ù portafoglie,
e assì che poésie,
na fotografie.
Quése chiangénne,
de coste me vénne,
e me disse: "spusète
na voote agghjie stète."
"No ténghe chjiù jiédde,
à mmorte puvrédde,
e mo stocke sùle,
comm-à nu cetrule."
E jìe rummanjieve,
e me commovjieve,
pe custe crestiéne,
ca paréve stréne.
Ma stréne no jiè,
crediteme a mè,
e assè chkiù norméle,
de nù, jiè chkiù uguèle.
Ce seèpe purcè
vé vite a comè,
ca spisse penséme,
accome cackéme.
Jiè propjie nu vizzie
ca spisse, giudizzie,
a vjiente nu déme,
e po ne sbagliéme.
No Jiè a cravatte,
ca dé cudde esatte;
no sembe ù strazzète,
jiè ù maresultète.
Antò, agghjie mbarète,
da te a sunète:
NO JIE' L'APPARE'NZE
A FE' A DIFFE'RE'NZE.
Gino Del Giudice 95
Risatédd a diend
stritt. (1)
Angelicchie z'moniche fescie solamende tre mise di
meletère
ca iére figghie sùle di mmama védove, vèrse a fine de le tré mise prime di iesse
cungedète le fècere fè l'esecitazione e u' capitène le désse cust'ordine:
-Tu a fè a spie vestùte da àruuele. Ta stè fèrme
fèrme, nongitamove assolutaménde.
Doppe se_ òre n'ota reclute le vè dèie u' cambie e dice:
-Beh! com'asciute?
-Ci ere stète sùle pe l'acque pà néve o pe le grànene...Ma a nù cèrte mùmend
nù scoiattole, cà mà pegghiète veraménde pe n'àrruele s'ànfilète inde alle
cazùne,
nchianève sùse a iamme e me dedechève, e sciève sembe cchiù sùse. U' uèie à stète
quanne vuléve acchiè u' buche che lassè le fragne pù vierne...
|
Stava na volta
un paese lontano lontano e qua abitava un giovane d'età più o meno sulla trentina, che no sapeva com'era
fatta la paura. Sia se stava al lavoro, sia se era festa e lui se n'andava a passare il tempo coi compagni, lo vedevi sempre contento, non pensava mai di vedere in faccia la paura, insomma ogni cosa la prendeva com'a un divertimento.
Pure quando si ritirava la notte, va', che no si
vedeva niente per il fatto che a quei tempi no stava ancora
l'illuminazione in mezz'alle strade, lui, chi trovava trovava davanti o
persone o animali pure bestie feroci, non si prendeva mai paura.
Perciò, quando nel paese si contavano fatti di latrocini o che si
trovava uno morto in mezz'alla strada che l'avevano ucciso, insomma cose
che uno se la faceva sotto, lui diceva: Ma che è sta paura, io ancora
no l'ho vista com'è fatta. Quando capitava poi che arrivava un
forestiero e domandava lui come si chiamava, rispondevano: Giovanni
senza paura. E così l'uscirono il nome di Senzapaura.
Un giorno disse: Voglio proprio vedere do' s'acchia sta cazza di paura,
e se n'andò dal paese, si mise la strada sott'ai piedi e cominciò a
girare il mondo. Cammin'e cammina, oggi un paese, domani n'altro, andava
senza direzione, insomma come capitava capitava, tanto che finì che
perse la strada e s'andò a trovare dentr'a un bosco.
Madonna mea del Rosario, quant'era! Stavano alberi che non vedevi mai la
fine e macchie a quante ne volevi, no si vedeva più la strada. Gira di
qua, gira di là, era quasi notte e lui stava sempre a un punto, quando
vide lontano na casa. Sia lodato Gesù e Maria, disse e andò. Andò e
bussò alla porta. Bussò la prima volta e niente. Bussò n'altra volta
e finalmente na vecchia che più brutta no potev'essere aprì.
Questa, mo, era Mammarannorca, ma lui no lo poteva sapere se no quando
quella domandò: Che vai trovando, lui no diceva: So' Giovanni
Senzapaura e camminò per tutt''il mondo per vedere se esiste la paura.
Insomma, Mammarannorca lo fece entrare. Siediti, disse, chiuse la porta
e l'andò a dire a Tatarannorco che era il marito e che stava dentr'al
giardino a passare il tempo.
Come senti il fatto, disse Tatarannorco: Fallo venire qua ché me la
vedo io. Così, Senzapaura, entrò dentr'al giardino e, quando vide,
stava un pezzo di santantonio quant'un gigante, na barba lunga lunga,
però cecato da n'occhio e più brutto del peccato mortale.
Tatarannorco, allora, per vedere che era capace di fare lo sfidò a due
prove. Alla prima prese na palla di ferro di cinque chili e la menò
all'aria. Si capisce che co la forza che teneva la palla arrivò tant'all'aria
che quasiquasi no si vedeva più. Dopo, Mo tocca a te, disse e
Senzapaura che, sangue della miseria, non poteva riuscire mai e poi mai
a fare la stessa cosa, fece na pensata: prima di menare la palla si mise
a gridare ai quattro venti: Alè, gente di tutto il mondo, levatevi da
sotto che mo deve piovere ferro! Come sentì, Fermati, disse
Tatarannorco, che no me la voglio prendere sopr'alla testa proprio io!
Così, passò all'altra prova per vedere se Giovanni Senzapaura la
faceva a partire da lontano cinquanta metri per colpire l'albero, però
no co la mano chiusa, ma co tutt'e cinque le dit'aperte. Senzapaura
disse: Va bene, e senza farsi vedere fece prima cinque buchi dentr'all'albero,
poi prese la rincorsa e andò a infilare la mano aperta dentr'ai buchi
senza farsi niente, anzi, siccome che dentro aveva messo il miele, si
leccava dito per dito ch'era un piacere! Allora, Tatarannorco, che no si
poteva capacitare, prese pure lui la rincorsa, ma s'andò a spezzare la
mano co tutte le dita. Figlio di puttana, disse e gli veniva da
bestemmiare che Cristo solo lo poteva sapere. Così finì la sfida e se
n'andarono dentr'a casa a mangiare.
Qua, Mammarannorca aveva messo già la tavola, il mesale co tutt'i
piatti bicchieri cucchiai la bottiglia del vino, e aveva cucinato na
minestra di carne. Allora si sedettero. Si sedettero e cominciarono a
mangiare, però Senzapaura, quando vide, nel primo piatto trovò
n'orecchio col sugo, nel secondo stava un naso arrostito e nel terzo
n'occhio lessato. Allora, capì che quelli erano Mammarannorca e
Tatarannorco che mangiavano solamente carne umana e che pure lui doveva
fare la stessa fine. Perciò, trovò la scusa che non teneva fame e non
mangiò, ma col pensiero cominciò a studiare un sistema per uscirsene
da quel guaio.
Pensa e pensa, prima di andarsi a coricare, siccome che Tatarannorco era
cecato da n'occhio, domandò: Che ti sei fatto all'occhio, e quello
contò il fatto di com'era successo. Allora, fece Senzapaura: Vuoi
essere sanato? E come può essere, domandò Tatarannorco. Tu non ci
pensare, disse Senzapaura, lo so io ciò che t'occorre per vedere pure
dall'occhio cecato, tu basta che fai come ti dico.
Quello, allora, disse: Va bene, e così
Senzapaura si fece dare da Mammarannorca na corda lunga e grossa per
attaccare Tatarannorco alla colonna. Così, disse, non ti muovi mentre
t'aggiusto l'occhio cecato, e l'attaccò forte forte tanto che quello
non si poteva muovere più. Poi, disse: Mo, chiudi l'occhio buono che ti
aggiusto quello cecato, e, mentre che Tatarannorco teneva chiuso
l'occhio, mise dentr'al fuoco vivo il coltello più lungo che stava e,
quando fece rosso rosso, un lampo e l'infilò invece che dentr'all'occhio
cecato, dentr'all'occhio buono.
Pezzo di catapezzo! Al dolore, Tatarannorco
gettò un grido da tremare la terra, si mise a bestemmiare com'a un
turco. Figlio di puttana, diceva e gridava che arrivavano a sentirlo
dall'America e tanta era la rabbia che dalla forza che teneva spezzò la
corda, si liberò e faceva che lo voleva afferrare sto cazzo di Giovanni
Senzapaura, ma andava attentoni e no vedeva niente. Più era il dolore e
più forte gridava, buttava all'aria ciò che trovava davanti, tavolino
sedie il letto, insomma peggio di un pazzo. Dove stai? diceva, ma
Senzapaura no fiatava per non farsi scoprire. E se ne andò cosi tutta
la notte e tutt'il giorno dopo. Tatarannorco girava tutta la casa per
vedere se lo trovava, Senzapaura, invece, a un cantone a studiare come
se ne poteva scappare.
In mezzo a quell'iradiddio, mo, che era successo? Era successo che le
pecore che Tatarannorco teneva dentr'a na specie di jazzo dentr'alla
camera di dietro erano due giorni che stavano chiuse e s'erano messe,
poverette, a sckamare che ti faceva il cuore! Più tempo passava e più
le fruscole si facevano sentire. Allora, Senzapaura fece n'altra
pensata. Disse: Tataranno', che male t'hanno fatto ste povere bestie, no
pensare più a me, mo pensa a loro e falle uscire, chè so' creature
com'a noi! E tanto disse, tanto fece, Tatarannorco si convinse e, quando
la mattina dopo stava per uscire il sole, apri la porta, si mise davanti
e, come le bestie passavano in mezz'alle gambe, le toccava un'a una per
essere sicuro che no se n'usciva pure Giovanni Senzapaura.
Ma, intanto, Senzapaura che aveva fatto? Aveva preso il manzariello che
era il capo di tutte le pecore, il montone va', l'aveva scannato, aveva
levato la pelle co tutta la lana e co questa sopr'alle spalle si mise in
mezz'alle pecore che uscivano a un'a una. Quando arrivò il turno suo,
Tatarannorco lo toccò bellobello, vide che era la lana del manzariello
e, Passa pure tu, manzariello mio, disse. Allora, Senzapaura uscì e
com'arrivò all'aria aperta si mise a gridare: Statti buono, Tataranno'!
Quando sentì, Tatarannorco quasiquasi li prendeva un colpo per la
rabbia che quello l'aveva fatto fesso n'altra volta. Allora, si levò
dal dito l'anello d'oro che portava e disse: Addò scappi più? Oramai
no posso fare niente, no stai vedendo come m'hai ridotto, disse. M'hai
cecato l'occhio buono, hai ucciso pure il manzariello più valente che
tenevo, che più mi dovevi fare? Vieni qua che ti voglio regalare
quest'anello, così ti devi ricordare di me. Si trattava, mo,
dell'anello fatato che chi lo pigliava rimaneva attaccato dove si
trovava. Senzapaura, che no si fidava, disse: Menalo qua, e così,
quando Tatarannorco lo buttò vicino, lui lo pigliò, se l'infilò al
dito e rimase che no poteva andare più né avanti né dietro.
Allora, Tatarannorco attentone attentone
cominciò a vicinarsi, sicuro mo che lo poteva finalmente afferrare, ma
Senzapaura, che no lo faceva fesso manco il demonio, un lampo, pigliò
da terra na pietra affilata com'un coltello, si tagliò il dito co
l'anello e se ne scappò. Se ne scappò più veloce del lepre e, il
tempo che Tatarannorco trovò il dito, se lo mangiò e disse, Almeno il
sangue tuo l'ho provato com'è, lui arrivò al paese e andò a trovare i
compagni, contò il fatto di Tatarannorco e disse: Sì, l'ho vista in
faccia la paura, e no na volta sola, però uno quando tiene un poco di
coraggio no si può prendere paura manco di Tatarannorco!
E così, "u fatte mije né cchiù - acque e do1eghe_ nnante a vù!
Angelo Marinò
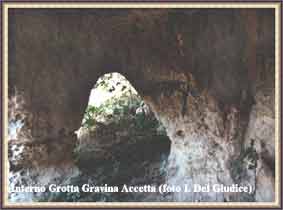
Interno di altra Grotta della Gravina di Leucaspide;
(cliccare sulla foto per ingrandirla)
|