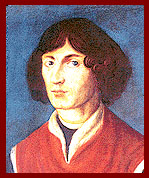Se si chiede a uno scienziato d'oggi quale sia il presupposto fondamentale del metodo scientifico-sperimentale, molto probabilmente si avrà come risposta: l'oggettività. L'oggettività scientifica è però in definitiva solo una mera intenzione, ancorché buona intenzione. Non è possibile infatti essere "oggettivamente scientifici" e pensanti insieme: se da una scienza rigorosamente oggettiva, si pretende che ricavi il proprio contenuto solo dall'osservazione, allora bisognerebbe pretendere che rinunci a tutto ciò che per sua natura va oltre ciò che si osserva. Ciò che però per sua essenza tende ad andare liberamente oltre ciò che si osserva è proprio il pensare. Se l'osservare fosse il mero sgranare gli occhi su un oggetto senza pensare alcunché, non vi sarebbe il problema, e l'osservazione non sarebbe molto diversa da quella fatta da un animale o da un soggetto allucinato. L'osservare presume ma non esclude il pensare. Oggi non se ne parla molto, ma questa cosa è essenziale se si vuole approfondire davvero il problema. Questo dilemma moderno ha le sue radici nella nascita e nello sviluppo storico della scienza stessa. Se andiamo indietro di qualche secolo, il vero significato della scienza moderna o il modo di pensare che ne sta alla base ci appare in due speciali testimonianze. Si tratta di due pubblicazioni significative distanti un secolo circa una dall'altra: la pubblicazione del cardinale Nicolò Cusano (1401-1464) della "Docta ignorantia" (1440), e la "De revolutionibus orbium coelestium" (1543) di Copernico (1473-1543).
Nella prima vi è l'ammissione chiara che la conoscenza di allora non era più in grado di raggiungere in modo diretto lo spirito e che esclusivamente attraverso la più certa fra le scienze - la matematica - sarebbe stato ancora possibile sperare di avvicinarvisi, mediante figure simboliche. Nell'altra pubblicazione, quella di Copernico, il pensiero matematico, il sapere matematico, applicato un secolo prima timidamente e simbolicamente alla conoscenza della sfera spirituale, viene invece applicato alla descrizione dell'universo, rivelato dalla sicura matematica. Da questo momento in avanti il mondo comincia ad essere visto in modo meccanico: se per i saggi antichi l'universo non era la macchina o un complesso meccanico, ora incominciava a divenire ciò che appare agli uomini d'oggi: un meccanismo. Per gli antichi, che erano personalmente inseriti nella spiritualità universale, il cosmo era un insieme vivente, un ente che tutto compenetrava e che comunicava loro attraverso un linguaggio cosmico, che sentivano vivere e operare entro l'infinito, il quale coi fenomeni cosmici rispondeva alle domande sui grandi problemi che essi ponevano all'universo. L'elemento "celeste", il celato, l'occulto, cioè quel che noi oggi, infinitamente indebolito e astratto, chiamiamo spirito, veniva concretamente percepito. L'uomo sentiva che lo spirito era presente ovunque e che ovunque poteva essere percepito. Guardando dentro di sé invece, egli riusciva a percepire l'anima, l'"animatrice" del pensiero e perciò messaggera dello spirito. Ed era con l'anima che sapeva di poter cogliere il mondo materiale-corporeo, come immagine dello spirito. In questa antica sapienza, non esisteva contraddizione fra corpo ed anima, né fra natura e spirito. E poiché il corpo umano era percepito come affine a tutti gli altri corpi della natura, l'uomo si sentiva un'unità, un "monon" con tutto il rimanente mondo, in quanto era capace di farsi consapevole della figura originaria dello spirito e della vastità dell'universo. Non vi era contrasto fra soggetto interno e oggetto esterno. Il contrasto fra il soggetto che sta dentro di noi e l'oggetto che sta fuori, è tipico invece dei tempi moderni, di quando cioè la natura incomincia a "trasformarsi" nell'oggetto della conoscenza, e la conoscenza, per propria stessa esigenza, si pone come méta, appunto, l'"oggettivo". Ma il cosiddetto "oggettivo" degli scienziati attuali - e di questa differenza bisognerebbe farsi consapevoli - non è la "natura" degli antichi. "Oggettivo" oggi è solo "ciò che è dotato di corporeità materiale", e in cui non viene più scorto nulla di spirituale. In tal modo la natura, che deve essere compresa da me (soggetto) come qualcosa (di "oggettivo") che sta fuori di me, diventa priva di spirito. L'uomo si mette alla ricerca di una scienza naturale esteriore in quanto ha perduto il proprio nesso interiore con la natura. Di tale perdita è testimone lo spirito stesso del nostro linguaggio: è notevole l'incongruenza che ci mostra: nella parola "natura" vi è un rapporto etimologico con il "nascere" vitale, mentre quel che oggi si intende per "natura" è solo e soprattutto un mondo che abbraccia - "scientificamente" - solo ciò che è morto: la conoscenza della natura del corpo umano è oggi ritenuta scientificamente valida in misura di autopsia, cioè se si acquista dal sezionamento di cadaveri. Anche la posizione attualmente assunta nei confronti della matematica e del suo rapporto con la realtà è significativa per la comprensione dell'attuale pensiero scientifico: per un matematico d'oggi esporre la geometria significa prendere le mosse dalle tre dimensioni dello spazio. Nello spazio tridimensionale egli distingue tre direzioni, ma non sarebbe mai giunto a concepirle, se non avesse in se stesso la possibilità di sperimentare un triplice orientamento:
- 2) simmetrico bilaterale, per esempio nel movimento del braccio destro e in quello simmetrico del sinistro; - 3) dal basso all'alto, nel cambiamento di direzionalità dell'infante che a poco a poco si erge in piedi, terminando la fase di strisciare per terra o di camminare a quattro gambe. Questi tre orientamenti dell'uomo vengono oggi considerati come qualcosa a lui esterno: i processi che nell'organismo si svolgono essenzialmente dall'avanti all'indietro, da destra a sinistra (o da sinistra a destra) e dall'alto in basso, non vengono sperimentati nella loro qualità interiore, ma solo osservati esteriormente: lo schema spaziale escogitato dalla geometria analitica che pone un punto in uno spazio astratto e traccia tre coordinate ortogonali, è sentito come vuoto e separato da qualsiasi sua esperienza. E' anche per questo motivo che la matematica insegnata a scuola è spesso vissuta dagli studenti come qualcosa di ostile. Non si tratta di antipatia immotivata verso questa materia, bensì del fatto che essa è stata nel corso di questi ultimo quattro secoli via via sempre più "disumanizzata" e inaridita: astrattizzata dal proprio umano contesto. La differenza fra l'antica concezione di matematica, legata all'esperienza umana, e quella moderna asetticamente estrapolata dalla vita interiore, appare caratterizzata anche dal fatto che oggi si perde sempre più confidenza già con lo spirito stesso del nostro linguaggio: ci si allontana talmente da esso che diventa sempre più difficile essere consapevoli della differenza, per esempio, fra "concetto" (contenuto concettuale, spirituale) e "parola" (materializzazione sonora o scritta del concetto). I nomi dei numeri sono esempi illuminanti di tale allontanamento. Si pensi per esempio alla parola "due", etimologicamente formatrice della parola "dubbio", che è uno stato d'animo incerto fra pensieri diversi o contrari ondeggiante quasi fra "due" pensieri. "Due", in tedesco "zwei", esprime ancora distintamente un processo concreto: il verbo "entzweien" significa infatti "spaccare in due", "separare", ed ha anch'esso un'affinità con il dubitare, che si dice "zweifeln". Se poi si tiene presente che la lettera U in latino si scrive V, si ritrova ancora un nesso con le lettere "dv" della parola italiana "dividere". Ciò dovrebbe bastare per prendere coscienza (o meglio riprendere coscienza) del rapporto fra matematica e interiorità. Per esempio, che il numero due venga espresso dalla radice di "entzweien" o di "dividere", non è per nulla attribuibile a qualcosa di esteriore - come è avvenuto per lo schema spaziale tridimensionale - bensì proprio a un'esperienza interiore di schema, così come era per gli antichi. Molte cose del nostro comune parlare sono tenute insieme da un vero e proprio organismo logico continuamente rivivificato dallo spirito del linguaggio. Grazie all'osservazione del linguaggio si può prendere atto di come sia profondamente radicato nella cultura odierna il "dilemma attuale" della nostra civiltà. Quanto segue ne mostra un ulteriore e importante aspetto. L'idea di "mistica" ha assunto sempre più nei tempi moderni un senso di morbosità dovuto all'uso ideologico-confessionale del termine(1). Nei primi secoli cristiani però mistica e matematica venivano poste sul medesimo piano di importanza. La vera mistica era ciò che si sperimentava nell'anima. La matematica, una mistica che si sperimentava anche esternamente, tramite il corpo. Geometria e matematica, generate dal sistema di movimento (metabolico) dell'organismo umano sono dunque mistica oggettiva. Ciò viene confermato anche dal linguaggio: "màthesis" significa in greco "dottrina", "oggetto di cognizione", "conoscenza" e da questo punto di vista, "mistica", "màthesis" e "matematica" sono davvero una cosa sola(2). In questi ultimi quattro secoli, in cambio di costruzioni matematiche e di rapporti fra i movimenti(3) esteriorizzati, la maggioranza degli esseri umani ha strappato via la matematica dalla sua connessione con l'interiorità, perdendo gradualmente anche l'esperienza del movimento corporeo precedentemente posseduta . Ciò che permise la nascita dell'astronomia copernicana fu un fatto storico determinante. La matematica (màthesis) era mistica oggettiva, e gli esseri umani, vivendo dentro l'astronomia, sapevano misurare il cosmo mediante il loro organismo in movimento. Poi posero nel cosmo un sistema di coordinate. Ma da tale sistema appena nato essi stessi uscirono progressivamente. L'affermarsi del sistema copernicano è insomma la naturale conseguenza derivante dalla progressiva perdita nell'uomo dell'antica facoltà di sperimentare le cose in se stesso. Fu un mutamento radicale di tipo sovversivo che si sviluppò in quell'oscuro periodo, caratterizzato, fra l'altro da eventi come quello dell'esecuzione di Giordano Bruno da parte della chiesa. Questo punto non è considerato dalla nostra cultura attuale, eppure è un importante fatto della storia dell'umanità: poter ammettere il centro di un sistema al di fuori della sfera terrestre consisteva in una completa sovversione dell'atteggiamento psichico dell'umanità civile di allora. Chi sa veramente immaginarsi i fatti, non può non riconoscere la nascita del pensiero scientifico moderno connesso con tale elemento di sovversione. Ed è in questo contesto che Giordano Bruno appare come il glorificatore della concezione moderna del mondo e dell'idea copernicana. Egli sarà ucciso non per queste sue idee ma perchè lasciò ancora spazio dentro di sè alla matematica mistica, alla mistica oggettiva. Giordano Bruno è profetico in quanto si accorge che non è assolutamente evolutivo per l'umanità passare dal dogmatismo allo scientismo(4). Oggi invale l'asserto: "è scientificamente dimostrato". Ieri valeva: "è un dogma di fede". Ambedue queste espressioni chiudono ogni possibile apertura alla ricerca della Verità ed è questo che Giordano Bruno aveva presentito, tanto da non dare eccessivo spazio alla depurazione della matematica dalla mistica. Egli infatti, possedendo ancora l'esperienza interiore, si esprime sull'universo in modo più lirico che matematico. Soprattutto, si esprime sul sistema copernicano in un modo diverso da come si espressero lo stesso Copernico, Galileo, Keplero, fino a Newton, vero fondatore della mentalità scientifica moderna. Con Newton si costruisce proprio quel quid cosiddetto oggettivo, congetturato senza più alcuna relazione con un'esperienza diretta dei fatti. Con Newton viene affermata l'aspirazione a separare del tutto l'esperienza fatta nel corpo fisico umano e ad oggettivare ciò che in passato si era concepito come strettamente congiunto con tale esperienza. Tramite tale separazione nasce la fisica moderna: "solo per effetto di tale separazione"(5). Con tale separazione però non è più possibile esprimere secondo criteri scientifici per esempio l'idea di moto. Senza la mia partecipazione al moto in quanto osservatore mi sarà infatti completamente indifferente se sia quel tale oggetto a muoversi rispetto a un altro o se sia quest'altro ad essere in movimento. Per far capire meglio quest'idea, si pensi al trucco usato nel cinema grazie al quale l'attore che sta al volante di un auto ferma in uno studio cinematografico, pare essere in corsa perchè numerose immagini di una strada e di un paesaggio sfilano dietro di lui in velocità. Se io guardo queste immagini ho l'illusione del movimento di un oggetto che però nella realtà è fermo. Quel movimento è dunque qualcosa di relativo. Nel caso in cui invece sia io a camminare realmente, nessuno, neanche la "Scienza" dovrebbe poter decretare, neppure secondo la teoria della relatività di Einstein, che è indifferente o relativo se sia io a muovermi o se sia il terreno a farlo in direzione opposta. Eppure la scienza di oggi ha ancora questa pretesa, una pretesa "scientifica" costruita su concetti totalmente inattuabili(6). Se da una parte Newton era ancora del tutto certo di poter ammettere dei moti assoluti, con pensieri basati su una concezione della matematica totalmente quantitativa(7), dall'altra, pensatori come Einstein si accorgono che assieme all'esperienza interiore l'uomo si stava perdendo anche la conoscenza del moto. Dopo quattro secoli di copernicanesimo esclusivamente matematico-quantitativo, era dunque ora necessario avvertire gli uomini che le cose non erano giuste. Ecco dunque l'impegno di superare questa concezione materialistica, che farà dire ad Einstein frasi come la seguente (Berlino, conferenza del 1921): "Nella misura in cui le si riferiscono alla realtà, esse non sono certe, e nella misura in cui sono certe, non si riferiscono alla realtà". Ovviamente tali "proposizioni matematiche" non hanno più nulla della "màthesis" mistico-qualitativa di Giordano Bruno. La teoria della relatività di Einstein è, da questo punto di vista, una necessità storica: dovrà esistere fino a quando si riuscirà a farne a meno. Essa esiste nella misura in cui l'uomo continua a valersi di concetti che prescindono del tutto dall'uomo. Infatti, "volendo conseguire conoscenza del moto o dello stato di quiete, occorre partecipare all'esperienza del moto o dello stato di quiete. Se non vengono sperimentati, perfino moto e quiete sono reciprocamente soltanto relativi"(8). Il dilemma di oggi è appunto questo: superare la teoria della relatività... assieme al relativismo del pensiero odierno, sconfinante nel nichilismo. Dopo queste necessarie premesse, che non hanno nessun'altra pretesa se non quella di stabilire una volta per tutte che l'operazione uno più uno fa due, e che il risultato di tale operazione non dovrebbe essere considerato relativo (almeno per per chi tale operazione sperimenta) inizierò il percorso, attraverso i numeri, verso la triarticolazione dell'organismo sociale. Può sembrare ridicolo, e lo è, premettere tutte queste parole per poter affermare qualcosa che il sano pensare umano reputa ovvio e cioè che uno più uno fa due. Invece oggi si arriva a sostenere, in nome del "pluralismo" del pensiero, che tutto è relativo e che quindi anche il pensiero matematico è relativo (escludendo però da quel tutto la conclusione del relativismo, che si considera invece assoluta. Ora incomincerò ad inoltrarmi nella numerologia del linguaggio. NOTE (1) Nel
concetto antico
della perfezione dei numeri infatti - scrive Arturo
Reghini nella sua opera sui numeri pitagorici - non vi è
"nulla di "mistico" nel senso moderno,
morboso e deteriore della parola; e del resto tutta
l'arcaica aritmetica mistica [...] di cui si occuparono
il cardinale Niccolò Cusano [...] e Giordano Bruno,
sebbene poco accessibile e poco conforme alla mentalità
occidentale odierna, è una cosa assai più seria di
quella "mistica dei numeri perfetti" di cui
Pareto si è fatto facile beffa" (A. Reghini,
"Dei numeri pitagorici", Ed. Ignis, p. 16;
Vilfredo Pareto, "Trattato di Sociologia Generale,
Firenze, 1916, 2 ed., Vol I, p. 497). Bicci di Lorenzo (attribuito): Madonna che allatta il Bambino. Affresco proveniente dallo scomparso oratorio di S. Maria a Sezzano, databile ai primi tre decenni del XIV sec. |
||||||
 Nereo Villa -
Numerologia della Triarticolazione Sociale - 3°
capitolo
Nereo Villa -
Numerologia della Triarticolazione Sociale - 3°
capitolo