|
La
Valtellina e la Valchiavenna sono costellate di numerosi
resti di fortificazioni. Erette in epoca medievale a tutela
di diritti e privilegi feudali, continuano a testimoniare
l’importanza strategica attribuita in passato alle
due valli situate a ridosso dei passi alpini. Il forte
degrado in cui versano, dovuto solo in parte alle ingiurie
del tempo, è generalmente iniziato a partire dal
1526 con la requisizione e lo smantellamento imposti dal
Governo delle Tre Leghe nell’intento di privare
i territori da poco acquisiti di punti di riferimento
e di forza che avrebbero potuto essere sfruttati in una
eventuale insurrezione. Al di là di qualsiasi considerazione
sul contenuto del patto di Teglio, che avrebbe dovuto
sancire rapporti di amicizia se non di fratellanza fra
le nostre valli e il Governo grigione, si può facilmente
dedurre che col rendere inoffensivi questi simboli di
potere e di autonomia divenne inequivocabilmente palese
il nostro stato di sudditi.
Nel contesto valtellinese, i resti più cospicui
per consistenza e stato di conservazione sono certamente
quelli relativi ai castelli di Grosio. Essi si incontrano
risalendo la valle dell’Adda, sul colle che separa
i centri di Grosotto e di Grosio, dove la Valgrosina confluisce
nella Valtellina. Si tratta di due strutture attigue,
realizzate in epoche diverse per rispondere ad esigenze
differenti e non complementari come era stato ipotizzato.
Risulta pertanto quanto meno equivoca la qualifica di
castelli gemelli come in alcuni studi era stata proposta.
La più antica fortificazione è evidenziata
dallo svettante campaniletto della cappella castellana
mentre la seconda si presenta dal fondovalle con un’imponente
cinta muraria merlata e turrita. I due castelli si trovano
all’interno del perimetro del Parco delle incisioni
rupestri e contribuiscono ad arricchirne le già
numerose attrattive. Si ha così la possibilità
di articolare un percorso che spazia dalla preistoria
al medioevo, con interessanti osservazioni di carattere
naturalistico.

La
lotta per le investiture e la situazione feudale nella
Valtellina.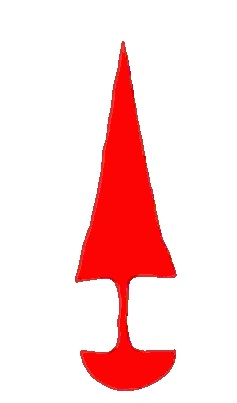
Per
inquadrare nel giusto contesto il primo documento che
menziona il castello di Grosio, risalente al 1150, dobbiamo
necessariamente premettere alcune considerazioni di carattere
generale sulla situazione politica di allora. Era quello
il periodo nel quale ferveva la lotta per le investiture
che contrapponeva impero e papato, guelfi e ghibellini.
Queste contese ebbero viva ripercussione anche nella Valtellina,
per i suoi valichi e per la propria configurazione geografica
guardata sempre con occhio geloso dalle potenze che ne
ambivano il possesso. L’organizzazione territoriale
della valle si basava allora sulla suddivisione in pievi.
Queste circoscrizioni avevano valenza amministrativa e
religiosa ed erano governate da un’autorità
civile e militare detta capitano e da una religiosa corrispondente
alla figura dell’arciprete. Differivano dalle altre
le pievi di Bormio e Poschiavo dove, invece del capitanato,
vi erano delle avvocazie con diritti regalistici e giurisdizionali
più ampi. Anche Mazzo, da cui Grosio dipendeva,
fu sede di pieve e venne fortificata, ma il vero e proprio
baluardo difensivo divenne il castello di Grosio. La motivazione
di tale scelta potrebbe essere stata duplice; sia perché
sede di una preesistente fortificazione sia a motivo della
sua posizione strategica potendo controllare contemporaneamente
il corridoio dell’alta Valtellina, lo sbocco dalla
Valgrosina e il passo del Mortirolo. Agli inizi del X
sec. la nobiltà valtellinese era ancora agli albori
e le famiglie che ricoprivano alti incarichi nella valle
erano prevalentemente immigrate, tale era il caso ad esempio
dei de Misenti, provenienti dal milanese e capitani della
pieve di Mazzo, e di una nobile famiglia della Val Venosta,
i Signori di Matsch che esercitava, per conto del vescovo
di Coira, l’avvocazia sulle pievi di Bormio e di
Poschiavo. L’autorità imperiale concesse
a questa famiglia una ulteriore opportunità per
consolidare ed espandere la propria influenza nella valle
dell’Adda allorquando nominò vescovo di Como
il loro congiunto Artuico che resse la diocesi dal 1091
al 1094. È verosimile che questo presule, forse
mai riconosciuto dalla curia comasca e pertanto costretto
a risiedere a Bormio sotto la protezione della propria
famiglia, abbia favorito le mire egemoniche dei propri
parenti su tutta l’alta Valle, allargano il loro
controllo anche alle pievi di Mazzo e di Villa e realizzando
così una continuità territoriale che andava
da Poschiavo a Bormio. A ridimensionare il ruolo dei Signori
di Matsch, che i documenti iniziano ad indicare semplicemente
con l’appellativo de Venosta, dal nome della valle
di provenienza, provvide, dopo alcuni decenni, il nuovo
vescovo di Como Ardizzone che, dopo aver ottenuto dall’imperatore
il controllo sul contado di Chiavenna, volle ribadire
la propria autorità anche sulle pievi di Villa
e di Mazzo e il controllo sul castello di Grosio.

Ipotesi
e congetture sull’origine del castello di Grosio.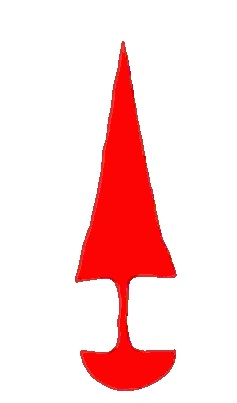
Il
documento del 1150, che sanciva tali diritti, ci dà
l’opportunità di ribadire l’esatta
denominazione del castello che prende il nome dal colle
di Groxio su cui sorge. I due nuclei rurali, che il documento
qualifica come villae , figurano come pertinenti al castello
stesso e mutuano il loro nome da questo colle con l’aggiunta
di suffissi locativi rapportati alla loro posizione a
monte, e quindi sopra, o a valle, e di conseguenza sotto
detta altura. Pertanto è evidente che non sono
i due villaggi di Gros-sura e di Gros-sotto che hanno
dato il nome al castello, come si è soliti credere
oggigiorno, ma bensì viceversa.
Occorre anche evidenziare che le vicinie di Gros-sura
o Grause superiore e di Gros-sotto daranno vita ai rispettivi
comuni solo in epoca successiva all’erezione del
castello.
Rimanendo in ambito toponomastico merita di essere ricordata
la probabile etimologia di Groxio che i linguisti fanno
derivare dall’etimo crös “incavo, concavo”,
attribuibile al sostrato ligure. Questa popolazione di
origine indoeuropea o comunque fortemente indoeuropeizzata
avrebbe popolato le nostre valli prima dell’arrivo
dei Celti e, sospinta da altre ondate immigratorie provenienti
dal nord, si sarebbe ritirata progressivamente nei territori
della regione costiera che ne perpetua il nome, la Liguria.
Nel dialetto ligure la crösa indica tuttora il sentiero
incavato, il solco. Esiste in effetti un’analogia
fra tale significato e la posizione del colle sul quale
sorgono i castelli di Grosio. Esso infatti è posto
a cavallo fra il solco della valle dell’Adda e la
profonda forra scavata dal torrente Roasco che forse servì
da sentiero ai primi esploratori della Valgrosina. Vale
la pena anche di evidenziare come la forma convessa del
colle contrapposta a quella concava dei solchi vallivi
sia compendiata nel significato ambivalente di crös
che, nell’accezione attuale, indica tanto la parte
interna come quella esterna del guscio. La toponomastica
e la linguistica per il loro carattere conservativo hanno
spesso fornito, attraverso alcune cristallizzazioni, indizi
importanti per la ricerca archeologica e storica. Quanto
evidenziato trova infatti conferma nelle numerose tracce
di presenza umana sui colli di Grosio databili anteriormente
all’arrivo dei Celti. La continuità di tale
presenza che elesse i colli grosini a sede abitativa e
cultuale dal neolitico all’età del ferro
non ha, per ora, rivelato tracce significative durante
il periodo della romanizzazione se escludiamo sporadici
rinvenimenti di monete imperiali lungo la piana abduana
sottostante. È vero che la ricerca archeologica
nella zona può ancora ritenersi allo stadio iniziale
e che non sono state rinvenute tracce delle sepolture,
localizzabili forse nella vallecola che corre dall’abitato
di Giroldo al castello , ma per sapere quali segni abbia
potuto lasciare, sarebbe innanzitutto interessante saper
quanto abbia inciso la civiltà romana in questa
valle. La Valtellina con i suoi passi allora strategicamente
poco rilevanti rispetto a quelli chiavennaschi probabilmente
rimase marginale ai loro interessi. L’assenza di
reperti di epoca romana non prova automaticamente che
i colli di Grosio siano stati abbandonati durante i primi
secoli dell’era cristiana, ma piuttosto che usi,
riti e consuetudini si siano perpetuati dalle epoche più
antiche a tutta la fase della romanizzazione senza sostanziali
variazioni. Roma lasciò invece probabilmente traccia
del suo ordinamento amministrativo in quella suddivisione
territoriale che, ricalcando forse una precedente ripartizione,
si manifestò nel pagus, istituzione che raggruppava
vari nuclei rurali periferici. Un’attestazione dell’esistenza
di terre appartenenti alla collettività del pagus
si è probabilmente 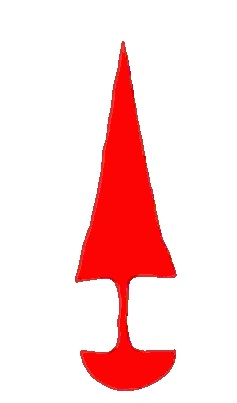 cristallizzata nel toponimo locale raspagän. Quanto
all’aggettivo paganus, si propende per un collegamento
diretto con il suo significato originario di “pertinente
al pagus”, in quanto i terreni “inutiles”,
cioè incolti e improduttivi come in questo caso,
unitamente ai boschi e ai pascoli erano beni che appartenevano,
notoriamente, o alla collettività della circoscrizione
del pagus o alla comunità dei residenti nel vicus.
Tali proprietà costituiranno poi la base delle
comunanze che, in epoca medievale, motiveranno il sorgere
del comune. Meno probabile, benché suggestiva,
ci sembra ipotizzabile un’accezione che muova da
paganus inteso come “non cristiano” e che
tale qualifica abbia voluto riflettere l’eco di
culti arcaici praticati sulla sommità del colle
sovrastante, ricco per altro di incisioni rupestri e con
tracce di insediamenti dell’età del bronzo
.
cristallizzata nel toponimo locale raspagän. Quanto
all’aggettivo paganus, si propende per un collegamento
diretto con il suo significato originario di “pertinente
al pagus”, in quanto i terreni “inutiles”,
cioè incolti e improduttivi come in questo caso,
unitamente ai boschi e ai pascoli erano beni che appartenevano,
notoriamente, o alla collettività della circoscrizione
del pagus o alla comunità dei residenti nel vicus.
Tali proprietà costituiranno poi la base delle
comunanze che, in epoca medievale, motiveranno il sorgere
del comune. Meno probabile, benché suggestiva,
ci sembra ipotizzabile un’accezione che muova da
paganus inteso come “non cristiano” e che
tale qualifica abbia voluto riflettere l’eco di
culti arcaici praticati sulla sommità del colle
sovrastante, ricco per altro di incisioni rupestri e con
tracce di insediamenti dell’età del bronzo
.
Il cristianesimo si innestò nel solco della tradizione
romana e, con la forza del suo messaggio di promozione
umana, completò anche quella penetrazione culturale
che non era riuscita agli eserciti. La sua capillare diffusione
fin nelle zone più periferiche diede rinnovato
impulso e nuove motivazioni anche alle antiche circoscrizioni
pagensi o concilive che si identificarono, a partire da
quel periodo, nei distretti delle pievi . Esse si riconoscevano,
nell’alto medioevo, nella chiesa battesimale, matrice
di tutte le chiesi minori. In seguito la pieve passerà
a designare la chiesa del capoluogo nel suo edificio materiale
e nella sua personalità giuridica, cioè
la massa di fedeli concepita corporativamente e congiuntamente
alla chiesa stessa. Gli storici ritengono che le più
antiche pievi valtellinesi possano risalire al VI sec.,
e quella di Mazzo, da cui Grosio dipendeva, potrebbe essere
annoverata fra queste.

Vicende
storiche riguardanti il castrum de Groxio detto anche
castello vecchio o di san Faustino.
Come
abbiamo già ricordato, nel 1150 il vescovo di Como
aveva 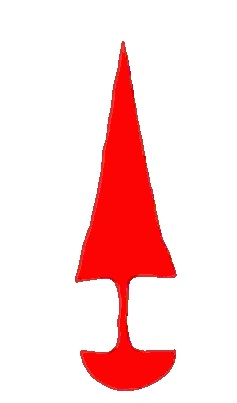 riconfermato
ad Artuico de Venosta e a suo figlio Eganone il capitanato
sulla pieve di Mazzo, già goduto in precedenza
da Bertaro de Misenti, riservandosi la giurisdizione diretta
sul castello di Grosio e su tutte le terre pertinenti
a detta castellanza. Placate le animosità e ristabiliti
i rispettivi ruoli, in epoca successiva ritroveremo nuovamente
i Venosta come custodi della rocca di Grosio ma non è
ben chiaro quando ciò sia avvenuto. Nella investitura
fatta da Enrico della Torre, che resse la diocesi comasca
tra il 1161 e il 1167, venivano riconosciuti a questa
famiglia diritti e prerogative che il vescovo in precedenza
si era riservato quali la giurisdizione penale e il fodro
regale oltre ad una rendita di 60 mogge da esigersi in
Grossura. Benché non se ne faccia esplicita menzione,
si ipotizza che già in quella occasione, con la
piena investitura dei diritti capitaneali sulla pieve,
anche il castello grosino sia ritornato sotto il controllo
dei Venosta. Se così fosse, a partire da questo
momento le vicende della fortificazione, che rimarrà
comunque di proprietà vescovile fino al XV sec.,
saranno strettamente legate alle alterne fortune di detta
famiglia. Una riconferma della precedente investitura,
senza ulteriori specifiche, fu sancita anche dal vescovo
Anselmo nel 1187. All’inizio del XII sec. la famiglia
Venosta aveva accresciuto il suo prestigio e accumulato
un cospicuo patrimonio. La vastità degli interessi
e delle proprietà che andavano dall’alta
valle dell’Adda a quella dell’Inn e al versante
atesino sono documentati nella spartizione della sostanza
lasciata da Gabardo ai figli Gabardino, Egano e Corrado,
avvenuta nel 1226. Purtroppo possediamo solo l’elenco
della sorte toccata a Gabardino, al quale andarono oltre
a terreni e affittanze anche alcune delle fortificazioni
possedute o semplicemente presidiate da detta famiglia
con le rendite inerenti. Fra queste sono ricordate le
torri di Pedenale, di Sparso, di Nova, di Sernio e quella
di Glurns sul versante atesino. Nell’elenco non
figura il castello di Grosio che probabilmente passò
in sorte a Corrado unitamente al feudo paterno di Mazzo
come sembra emergere dalla riconferma dell’investitura
feudale fatta nel 1266 dal vescovo Raimondo della Torre.
Corrado non si limitò ad amministrare i suoi possedimenti
e a riscuotere le copiose rendite ma prese parte attiva
alle lotte che contrapponevano il partito guelfo a quello
ghibellino, schierandosi apertamente a favore della fazione
comasca dei Rusconi rivale dei guelfi Vitani. Sarebbe
lungo tracciare le vicende avventurose che lo videro intrepido
protagonista e ci limiteremo pertanto a ricordare unicamente
l’avvenimento che interessa più direttamente
la nostra riconfermato
ad Artuico de Venosta e a suo figlio Eganone il capitanato
sulla pieve di Mazzo, già goduto in precedenza
da Bertaro de Misenti, riservandosi la giurisdizione diretta
sul castello di Grosio e su tutte le terre pertinenti
a detta castellanza. Placate le animosità e ristabiliti
i rispettivi ruoli, in epoca successiva ritroveremo nuovamente
i Venosta come custodi della rocca di Grosio ma non è
ben chiaro quando ciò sia avvenuto. Nella investitura
fatta da Enrico della Torre, che resse la diocesi comasca
tra il 1161 e il 1167, venivano riconosciuti a questa
famiglia diritti e prerogative che il vescovo in precedenza
si era riservato quali la giurisdizione penale e il fodro
regale oltre ad una rendita di 60 mogge da esigersi in
Grossura. Benché non se ne faccia esplicita menzione,
si ipotizza che già in quella occasione, con la
piena investitura dei diritti capitaneali sulla pieve,
anche il castello grosino sia ritornato sotto il controllo
dei Venosta. Se così fosse, a partire da questo
momento le vicende della fortificazione, che rimarrà
comunque di proprietà vescovile fino al XV sec.,
saranno strettamente legate alle alterne fortune di detta
famiglia. Una riconferma della precedente investitura,
senza ulteriori specifiche, fu sancita anche dal vescovo
Anselmo nel 1187. All’inizio del XII sec. la famiglia
Venosta aveva accresciuto il suo prestigio e accumulato
un cospicuo patrimonio. La vastità degli interessi
e delle proprietà che andavano dall’alta
valle dell’Adda a quella dell’Inn e al versante
atesino sono documentati nella spartizione della sostanza
lasciata da Gabardo ai figli Gabardino, Egano e Corrado,
avvenuta nel 1226. Purtroppo possediamo solo l’elenco
della sorte toccata a Gabardino, al quale andarono oltre
a terreni e affittanze anche alcune delle fortificazioni
possedute o semplicemente presidiate da detta famiglia
con le rendite inerenti. Fra queste sono ricordate le
torri di Pedenale, di Sparso, di Nova, di Sernio e quella
di Glurns sul versante atesino. Nell’elenco non
figura il castello di Grosio che probabilmente passò
in sorte a Corrado unitamente al feudo paterno di Mazzo
come sembra emergere dalla riconferma dell’investitura
feudale fatta nel 1266 dal vescovo Raimondo della Torre.
Corrado non si limitò ad amministrare i suoi possedimenti
e a riscuotere le copiose rendite ma prese parte attiva
alle lotte che contrapponevano il partito guelfo a quello
ghibellino, schierandosi apertamente a favore della fazione
comasca dei Rusconi rivale dei guelfi Vitani. Sarebbe
lungo tracciare le vicende avventurose che lo videro intrepido
protagonista e ci limiteremo pertanto a ricordare unicamente
l’avvenimento che interessa più direttamente
la nostra 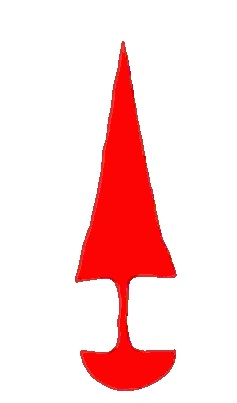 trattazione.
Nel 1270 il vescovo comasco Raimondo della Torre, esponente
del partito guelfo, entrava in Valtellina forse per compiervi
una visita pastorale o forse per soggiogare le famiglie
ribelli. Fra queste doveva esserci quella dei Venosta
che, secondo alcuni storici, non aveva prestato il giuramento
richiesto dal vescovo per sostenere la causa guelfa. Corrado
lo aspettò asserragliato nel castello di Boffalora
con l’intenzione di resistergli. Il Pedrotti sostiene
che “forse Corrado era già stato privato
del castello di Grosio, se a quelle forti difese aveva
preferito quelle del piccolo castello che guardava la
corte di Sondalo, già civilmente separata dalla
pieve di Mazzo benché ne facesse parte ecclesiasticamente”
. Il Venosta attese dunque l’arrivo del vescovo
e, con un’audace sortita, lo fece prigioniero resistendo
poi per tre anni nella rocca di Boffalora ad ogni tentativo
di assalto. Quando l’assedio si concluse, a Corrado
fu comminata la scomunica da parte degli inquisitori e
il castello fu smantellato ma agli altri difensori fu
concessa una resa dignitosa che prevedeva l’onore
delle armi. Nel contempo la parte guelfa, per premunirsi
contro altre sorprese, aveva restaurato e fortificato
quello di Grosio. Gli effetti della scomunica di Corrado
ebbero ripercussioni limitate nel tempo verso i suoi discendenti
perché nel 1299 il vescovo Leone reinvestiva il
nipote Corradino del paterno e antico feudo nella pieve
di Mazzo già tenuto in passato dalla sua famiglia.
Corradino abitava nel castello di Pedenale di Mazzo ma
i suoi figli Artuico e Federico presidiavano quello di
san Faustino. In questo periodo la Valtellina veniva riorganizzata
da punto di vista amministrativo con l’introduzione
di circoscrizioni più ampie dette
terzieri. La pieve continuava a svolgere le sue funzioni
dal punto di vista ecclesiastico con l’arciprete
quale diretto collaboratore del vescovo sul territorio.
Scompariva invece la figura del capitano di pieve in quanto
le competenze in materia di giustizia, di difesa e di
fisco erano passate al podestà che reggeva il terziere.
Di conseguenza veniva ridimensionato anche il ruolo dei
castelli di pieve. Ciò nonostante l’importanza
attribuita dai vescovi comaschi al castello di Grosio
e la vigile custodia dei diritti e delle prerogative feudali
traspare apertamente nelle formalità dell’investitura
fatta il 19 maggio 1355 da Rigaldo Astorgi, vicario generale
del vescovo Bernardo, a favore di Giuliano figlio di Artuico
e del nipote Federico. Nell’atto di affidamento
della rocca di san Faustino è ricordato il conferimento
materiale delle chiavi che attribuiva diritti e poteri
a chi le riceveva ma ricordava anche il pieno e assoluto
diritto di possesso da parte del vescovo. trattazione.
Nel 1270 il vescovo comasco Raimondo della Torre, esponente
del partito guelfo, entrava in Valtellina forse per compiervi
una visita pastorale o forse per soggiogare le famiglie
ribelli. Fra queste doveva esserci quella dei Venosta
che, secondo alcuni storici, non aveva prestato il giuramento
richiesto dal vescovo per sostenere la causa guelfa. Corrado
lo aspettò asserragliato nel castello di Boffalora
con l’intenzione di resistergli. Il Pedrotti sostiene
che “forse Corrado era già stato privato
del castello di Grosio, se a quelle forti difese aveva
preferito quelle del piccolo castello che guardava la
corte di Sondalo, già civilmente separata dalla
pieve di Mazzo benché ne facesse parte ecclesiasticamente”
. Il Venosta attese dunque l’arrivo del vescovo
e, con un’audace sortita, lo fece prigioniero resistendo
poi per tre anni nella rocca di Boffalora ad ogni tentativo
di assalto. Quando l’assedio si concluse, a Corrado
fu comminata la scomunica da parte degli inquisitori e
il castello fu smantellato ma agli altri difensori fu
concessa una resa dignitosa che prevedeva l’onore
delle armi. Nel contempo la parte guelfa, per premunirsi
contro altre sorprese, aveva restaurato e fortificato
quello di Grosio. Gli effetti della scomunica di Corrado
ebbero ripercussioni limitate nel tempo verso i suoi discendenti
perché nel 1299 il vescovo Leone reinvestiva il
nipote Corradino del paterno e antico feudo nella pieve
di Mazzo già tenuto in passato dalla sua famiglia.
Corradino abitava nel castello di Pedenale di Mazzo ma
i suoi figli Artuico e Federico presidiavano quello di
san Faustino. In questo periodo la Valtellina veniva riorganizzata
da punto di vista amministrativo con l’introduzione
di circoscrizioni più ampie dette
terzieri. La pieve continuava a svolgere le sue funzioni
dal punto di vista ecclesiastico con l’arciprete
quale diretto collaboratore del vescovo sul territorio.
Scompariva invece la figura del capitano di pieve in quanto
le competenze in materia di giustizia, di difesa e di
fisco erano passate al podestà che reggeva il terziere.
Di conseguenza veniva ridimensionato anche il ruolo dei
castelli di pieve. Ciò nonostante l’importanza
attribuita dai vescovi comaschi al castello di Grosio
e la vigile custodia dei diritti e delle prerogative feudali
traspare apertamente nelle formalità dell’investitura
fatta il 19 maggio 1355 da Rigaldo Astorgi, vicario generale
del vescovo Bernardo, a favore di Giuliano figlio di Artuico
e del nipote Federico. Nell’atto di affidamento
della rocca di san Faustino è ricordato il conferimento
materiale delle chiavi che attribuiva diritti e poteri
a chi le riceveva ma ricordava anche il pieno e assoluto
diritto di possesso da parte del vescovo. 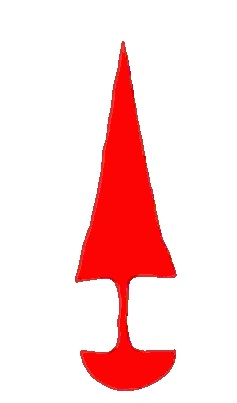
Per quanto riguarda i beni della mensa vescovile, dobbiamo
tener presente che con l’avvento dei Grigioni nelle
nostre valli stava diventando sempre più arduo
il controllo e l’esazione dei canoni dovuti. Il
vescovo di Como, al fine di evitare di vedere vanificata
ogni legittima pretesa, preferì monetizzare e incentivò
quindi una politica che ne agevolasse il riscatto. Non
abbiamo una documentazione che comprovi l’affrancamento
del castello da parte dei Venosta ma lo possiamo supporre
da una permuta effettuata il 12 febbraio 1522 fra Nicolò
fu Faustino Venosta, abitante nel castello di san Faustino,
e suo fratello Germino. In tale cambio, che riguarda alcuni
ambienti all’interno del castello, sembrerebbe che
i Venosta disponessero della piena proprietà della
struttura perché Germino si riservava il diritto
di poter costruire all’interno della corte in prossimità
della chiesa di san Faustino. L’atto è interessante
anche perché dai dettagli della permuta è
possibile una ricostruzione parziale della planimetria
del castello stesso . Come per altro è stato confermato
anche dai recenti scavi, la costruzione si sviluppava
con andamento longitudinale assecondando la morfologia
del colle. Gli ambienti, di ampiezza modesta, erano disposti
su più piani e si trovavano addossati alla cinta
muraria. Per tutta la lunghezza al centro correva una
corte che divideva e dava luce alle costruzioni disposte
sui due lati e verso la quale spiovevano i tetti ad una
sola ala, coperti da scandole. Gli scoli dell’acqua
piovana erano convogliati verso una cisterna interna.
Nell’atto si ricorda la presenza di forni, di cucine,
di stue, di dispense e di cantine che confermano, se mai
ce ne fosse bisogno, le caratteristiche residenziali della
struttura. In altra sede esprimevo l’opinione che
“la relativa angustia del fabbricato, costretto
a seguire la morfologia frastagliata dell’altura,
farebbe pensare più che a un opera difensiva vera
e propria ad una prestigiosa affermazione dell’autorità
e del potere del feudatario che vi dimorava, intento a
riscuotere i tributi dai sudditi” . In effetti l’assenza
di torri e la relativa modestia delle altre opere difensive
dovevano far apparire la costruzione come una dimora fortificata
piuttosto che come un temibile fortilizio. Non si spiegherebbe
altrimenti il fatto che il decreto di smantellamento dei
castelli valtellinesi del 1526 non abbia interessato anche
il castello di san Faustino che risultava ancora abitato
da vari membri della famiglia nel 1586 . L’assenza
di riferimenti archivistici dopo tale data ci induce a
credere che sul finire del XVI sec. la struttura sia stata
progressivamente abbandonata. Venute meno quelle motivazioni
legate al prestigio del blasone o più semplicemente
alle rendite che in passato competevano alla custodia
del castello, la fortificazione perse fascino e appetibilità.
Se a ciò aggiungiamo la dislocazione disagiata
unita alla necessità di radicali interventi di
restauro possiamo comprendere le motivazioni che indussero
i Venosta, che ancora vi abitavano, a trasferire la loro
residenza in dimore più confortevoli nei centri
del fondovalle di Grosio e di Grosotto.

La
chiesa dei santi Faustino e Giovita.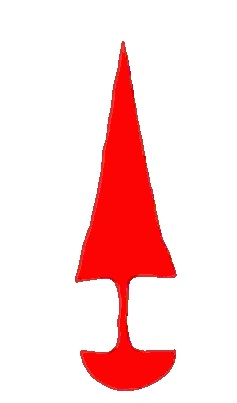
All’estremità
meridionale del colle dei castelli di Grosio è
posta la chiesa dei santi Faustino e Giovita. Benché
i muri perimetrali siano stati completamente rasi al suolo
a seguito dello sfruttamento della superficie a scopi
agricoli avvenuto nel corso del XVIII-XIX sec., l’area
su cui sorgeva è facilmente individuabile attraverso
la piccola torre campanaria che ne affianca l’abside.
Una relazione di fine 1800, ci fornisce i seguenti elementi
descrittivi: “Come tutte le chiese de’ primi
secoli della predicazione dell’Evangelio, anche
questa aveva l’altare a levante, che guardava a
occidente, e ciò è mostrato anche oggi dal
muro semicircolare rimasto sulla roccia a sfidare le secolari
intemperie e le mani vandaliche. Si entrava per due porte,
l’una in comunicazione col castello, verso nord,
e l’altra a ovest che metteva all’abitazione
del beneficiato. Era a volta interamente dipinta, come
l’attestano gli intonaci delle rovine esistenti
tuttavia sotto il leggero strato di terra coltivata a
vigna, che invero è alimentata dai calcinacci.
Sotto il pavimento, sorretto da volta, era un sotterraneo
che riceveva luce da mezzodì, e che forse serviva
per tomba de’ sacerdoti e comandanti del forte”
. Avremo modo più oltre di commentare e di puntualizzare
alcune di queste affermazioni che comunque ci forniscono
già una globale descrizione della costruzione.
Circa le origini dell’edificio, si sono già
vagliate le possibili motivazioni della sua dedicazione
ai due martiri bresciani. Si è anche accennato
alle tre fasi di interventi che l’hanno caratterizzato,
trasformandolo dal piccolo sacello funerario alto medievale
alla più ampia struttura del X-XI sec. L’edificio
è stato spesso identificato dagli studiosi come
cappella castellana, funzione che certamente svolse dall’epoca
del suo ampliamento definitivo, ma tale qualifica risulta
riduttiva per motivi che andremo a commentare. Innanzi
tutto le sue origini non necessariamente sono da collegare
con quelle della struttura castellana vera e propria.
Una tradizione popolare affermava che “la chiesa
è di data anteriore al castello”. Il ritrovamento
di frammenti di ceramica retica all’interno del
perimetro della chiesa, venuti alla luce durante i recenti
scavi, oltre a documentare una frequentazione del sito
in epoca preistorica potrebbero forse anche indicare che
già allora l’area era stata prescelta per
riti cultuali e che tale elezione sacrale sia continuata
fino all’epoca alto medievale. In secondo luogo,
benché la chiesa compaia più tardi come
patronato dei castellani Venosta, essa non era in uso
esclusivo a tale famiglia, ma aperta al culto di tutta
la popolazione. Ciò è testimoniato, dal
punto di vista strutturale, dalla sua collocazione esterna
al castello vero e proprio e dai due accessi che aveva.
Per quanto riguarda la sua 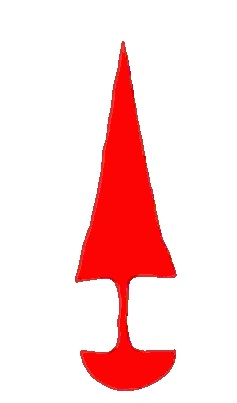 pubblica
fruizione vi è poi una leggenda locale ancora molto
viva fra la popolazione che narra come, in epoca alto
medievale, gli abitanti di Grosio si fossero miracolosamente
salvati da una rovina che aveva ricoperto il paese in
quanto si trovavano tutti ad assistere alle funzioni religiose
nella chiesa dei santi Faustino e Giovita . Si tratta
di una tradizione che si rifà ad un tempo lontano
e indefinito e perciò di difficile verifica ma
è significativo che nel racconto si faccia riferimento
a questa chiesetta e non a quella più accessibile
di san Giorgio, forse però non ancora costruita.
Una frequentazione pubblica della struttura traspare anche
dalla consuetudine antichissima praticata dai fedeli di
Grosio di compiervi una stazione, a dire il vero non solo
di carattere religioso, tanto nell’andata come nel
ritorno delle processioni rituali verso la chiesa pievana
di Mazzo. Nel 1469 ser Castello fu Olderico Venosta, abitante
nel castello di san Faustino, lasciava in legato ai “pauperes
Christi de Groxio” un fitto di 35 staia di biade
dovuto annualmente dal comune di Grosio con l’obbligo
della distribuzione del corrispettivo in pane, formaggio
e vino. Una parte doveva essere elargita “ad ecclesiam
ipsius terre de Groxio” il giorno di san Marco,
il rimanente “distribuantur ut supra annuatim personis
dicti communis Groxii que annuatim et prout per tempora
contingerint venire seu ire ad ecclesiam Sancti Faustini
sitam in suprascripto castro Sancti Faustini, et que postea
ire debeant ad letaneas usque ad ecclesiam Sancti Stefani
de Maze, in recessu a dicta ecclesia Sancti Faustini”
. La chiesa si trovava sul confine dei paesi di Grosio
e di Grosotto e, a tal proposito, troviamo un curioso
accenno già nel lodo arbitrale del 4 novembre 1540
che poneva fine alle contese sorte fra i due comuni. Nella
dettagliata relazione che partiva dalla Valgrosina e si
concludeva sul versante orobico si cita come punto divisorio
anche la chiesa dei santi Faustino e Giovita. Il confine
passava infatti attraverso la finestrella
mediana dell’abside della chiesa in modo tale che
tutte le costruzioni esistenti su quel dosso e il castello
fossero da intendersi sul territorio di Grosio . Con l’abbandono
del castello da parte dei Venosta anche la chiesetta iniziò
un lento decadimento sebbene continuasse ad avere un suo
beneficiale . Di ciò veniamo ragguagliati puntualmente
nei verbali delle visite pastorali effettuate a cavallo
del 1600. Il Ninguarda nel 1589 affermava che sopra il
colle, a lato del castello diroccato “est ecclesia
Sanctis Faustino et Jovitae dicata, et dotata; jus praesentandi
beneficiatum spectat ad haeredes quondam d. Ulderici Quadri
et pubblica
fruizione vi è poi una leggenda locale ancora molto
viva fra la popolazione che narra come, in epoca alto
medievale, gli abitanti di Grosio si fossero miracolosamente
salvati da una rovina che aveva ricoperto il paese in
quanto si trovavano tutti ad assistere alle funzioni religiose
nella chiesa dei santi Faustino e Giovita . Si tratta
di una tradizione che si rifà ad un tempo lontano
e indefinito e perciò di difficile verifica ma
è significativo che nel racconto si faccia riferimento
a questa chiesetta e non a quella più accessibile
di san Giorgio, forse però non ancora costruita.
Una frequentazione pubblica della struttura traspare anche
dalla consuetudine antichissima praticata dai fedeli di
Grosio di compiervi una stazione, a dire il vero non solo
di carattere religioso, tanto nell’andata come nel
ritorno delle processioni rituali verso la chiesa pievana
di Mazzo. Nel 1469 ser Castello fu Olderico Venosta, abitante
nel castello di san Faustino, lasciava in legato ai “pauperes
Christi de Groxio” un fitto di 35 staia di biade
dovuto annualmente dal comune di Grosio con l’obbligo
della distribuzione del corrispettivo in pane, formaggio
e vino. Una parte doveva essere elargita “ad ecclesiam
ipsius terre de Groxio” il giorno di san Marco,
il rimanente “distribuantur ut supra annuatim personis
dicti communis Groxii que annuatim et prout per tempora
contingerint venire seu ire ad ecclesiam Sancti Faustini
sitam in suprascripto castro Sancti Faustini, et que postea
ire debeant ad letaneas usque ad ecclesiam Sancti Stefani
de Maze, in recessu a dicta ecclesia Sancti Faustini”
. La chiesa si trovava sul confine dei paesi di Grosio
e di Grosotto e, a tal proposito, troviamo un curioso
accenno già nel lodo arbitrale del 4 novembre 1540
che poneva fine alle contese sorte fra i due comuni. Nella
dettagliata relazione che partiva dalla Valgrosina e si
concludeva sul versante orobico si cita come punto divisorio
anche la chiesa dei santi Faustino e Giovita. Il confine
passava infatti attraverso la finestrella
mediana dell’abside della chiesa in modo tale che
tutte le costruzioni esistenti su quel dosso e il castello
fossero da intendersi sul territorio di Grosio . Con l’abbandono
del castello da parte dei Venosta anche la chiesetta iniziò
un lento decadimento sebbene continuasse ad avere un suo
beneficiale . Di ciò veniamo ragguagliati puntualmente
nei verbali delle visite pastorali effettuate a cavallo
del 1600. Il Ninguarda nel 1589 affermava che sopra il
colle, a lato del castello diroccato “est ecclesia
Sanctis Faustino et Jovitae dicata, et dotata; jus praesentandi
beneficiatum spectat ad haeredes quondam d. Ulderici Quadri
et 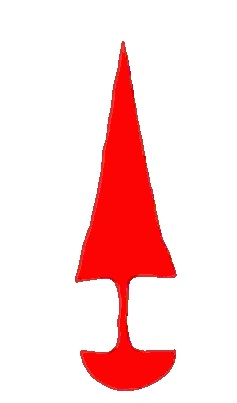 haeredes
quondam d. Castelli Venusta et penes hanc ecclesiam sunt
aliquot aedes rusticales” . Qualche ragguaglio in
più sullo stato della chiesa lo abbiamo dai decreti
emanati in tale visita: “Alla chiesa di san Faustino
e Giovita si rifaccia il crostato di pittura alla cappella
maggiore troppo vecchia e cadente; et all’altare
mancano i cancelli” . A queste bonarie raccomandazioni
del vescovo Ninguarda seguirono quelle ben più
drastiche dei suoi successori. Nel 1614 l’Archinti,
considerate le carenze strutturali e di paramenti, decretava
il divieto di celebrarvi . L’ultimo vescovo che
la vistò fu probabilmente il Carafino che nel 1629
ribadiva: “Nella chiesa dei santi Faustino e Giovita
del castello si faccia un altare in prospetto della porta
con la sua bradella alla forma e si provvegga de paramenti”
. La fiscalità dimostrata dai vescovi nella puntuale
applicazione dei decreti del concilio tridentino unita
alla carenza di mezzi per interventi radicali di restauro
e per una più dignitosa dotazione di paramenti
decretarono praticamente la chiusura al culto e il rapido
decadimento della vetusta struttura. Poco dopo la caduta
della volta della chiesa, che si pensa sia avvenuta attorno
al 1790, andò in rovina anche il campaniletto che
in alcune cartoline di fine ‘800 compare sbrecciato
sul lato occidentale e senza cuspide. Gli interventi di
restauro di questo furono realizzati agli inizi del 1900
perchè, alla morte del marchese Emilio Visconti
Venosta nel 1914, l’arrivo della salma nel territorio
di Grosio fu salutata col tocco di una campana appositamente
issata su quella torre. Gli ultimi interventi alla copertura
del campanile si ebbero solamente nel 1950 quando fu nuovamente
issata la croce patriarchina, probabilmente rinvenuta
in loco, e che testimonia la dipendenza per oltre un millennio
della nostra diocesi dal lontano patriarcato di Aquileia.
Il Serponti non accenna alle due tombe scavate nella viva
roccia in quanto allora la superficie risultava coltivata
a vite. Da testimonianze orali attendibili sembrerebbe
che la lastra che le ricopriva sia stata tolta da ricercatori
abusivi solamente attorno al 1920 ma si ignora il contenuto
delle stesse. haeredes
quondam d. Castelli Venusta et penes hanc ecclesiam sunt
aliquot aedes rusticales” . Qualche ragguaglio in
più sullo stato della chiesa lo abbiamo dai decreti
emanati in tale visita: “Alla chiesa di san Faustino
e Giovita si rifaccia il crostato di pittura alla cappella
maggiore troppo vecchia e cadente; et all’altare
mancano i cancelli” . A queste bonarie raccomandazioni
del vescovo Ninguarda seguirono quelle ben più
drastiche dei suoi successori. Nel 1614 l’Archinti,
considerate le carenze strutturali e di paramenti, decretava
il divieto di celebrarvi . L’ultimo vescovo che
la vistò fu probabilmente il Carafino che nel 1629
ribadiva: “Nella chiesa dei santi Faustino e Giovita
del castello si faccia un altare in prospetto della porta
con la sua bradella alla forma e si provvegga de paramenti”
. La fiscalità dimostrata dai vescovi nella puntuale
applicazione dei decreti del concilio tridentino unita
alla carenza di mezzi per interventi radicali di restauro
e per una più dignitosa dotazione di paramenti
decretarono praticamente la chiusura al culto e il rapido
decadimento della vetusta struttura. Poco dopo la caduta
della volta della chiesa, che si pensa sia avvenuta attorno
al 1790, andò in rovina anche il campaniletto che
in alcune cartoline di fine ‘800 compare sbrecciato
sul lato occidentale e senza cuspide. Gli interventi di
restauro di questo furono realizzati agli inizi del 1900
perchè, alla morte del marchese Emilio Visconti
Venosta nel 1914, l’arrivo della salma nel territorio
di Grosio fu salutata col tocco di una campana appositamente
issata su quella torre. Gli ultimi interventi alla copertura
del campanile si ebbero solamente nel 1950 quando fu nuovamente
issata la croce patriarchina, probabilmente rinvenuta
in loco, e che testimonia la dipendenza per oltre un millennio
della nostra diocesi dal lontano patriarcato di Aquileia.
Il Serponti non accenna alle due tombe scavate nella viva
roccia in quanto allora la superficie risultava coltivata
a vite. Da testimonianze orali attendibili sembrerebbe
che la lastra che le ricopriva sia stata tolta da ricercatori
abusivi solamente attorno al 1920 ma si ignora il contenuto
delle stesse.

Il
castello nuovo o visconteo.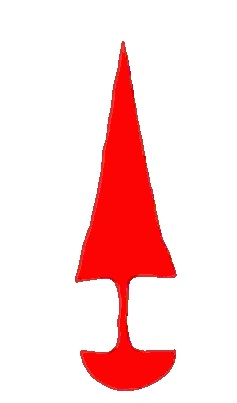
Nel
corso del 1300, sul lato nord del breve pianoro del colle
di Grosio, fu eretto un nuovo fortilizio ben più
possente del vecchio castello vescovile di san Faustino.
Tale struttura, benché affidata alla custodia della
stessa famiglia dei Venosta, non fu concepita come complementare
a quella più antica, ma venne realizzata dai Visconti,
nuovi signori della Valtellina per rispondere a precise
esigenze strategiche. Gli avvenimenti che determinarono
la sua costruzione possono essere così sintetizzati.
Il 2 luglio 1335 entrava trionfalmente in Como Azzone
Visconti, già signore di Milano, dove veniva eletto
“perpetuo e generale signore della città
e del vescovado di Como” . La Valtellina, che dipendeva
dal comune lariano, si sottometteva docilmente al dominio
dei Visconti ma Bormio, legata a Ulrico di Matsch, preferiva
giurare fedeltà al vescovo di Coira nel tentativo
di salvaguardare autonomia e privilegi daziari. I Visconti
intrapresero allora varie iniziative per superare le resistenze
dei Bormini, ma questi per oltre quindici anni rintuzzarono
le pretese dei signori di Milano. La tregua prorogata
nel 1339 da Giovanni Visconti risultava già rotta
nel 1343 e l’anno successivo era stato allestito
un esercito contro i Bormini che aveva però operato
invano per tre mesi tra Grosio e Sondalo. Nel 1348 Luchino
Visconti aveva anche applicato sanzioni economiche bloccando
il commercio del vino ma i Bormini, oltrepassata Serravalle,
avevano occupato la rocca di Boffalora e la loro avanguardia
aveva cozzato con l’esercito visconteo mosso da
Grosio. Nello stesso anno però Bormio veniva presa
con la forza e, oltre a dover accettare un podestà
visconteo, veniva sottoposta ad un censo di 400 fiorini
d’oro. Considerate le difficoltà incontrate
per il controllo dell’alta valle i Visconti decisero
di presidiare la zona di Grosio con una adeguata fortificazione
sfruttando quell’altura che permetteva anche il
controllo dell’accesso alla Valgrosina. Questo importante
punto di riferimento si rivelò determinante per
sottomettere nuovamente Bormio che era insorta con gran
parte dei comuni valtellinesi nel 1370 e che, a differenza
del resto della valle, nel 1375 resisteva ancora a Galeazzo
Visconti. “Nell’ottavo decennio del secolo
decimoquarto Grosio divenne il trampolino necessario per
balzare su Bormio; i Venosta di Mazzo, diventati ghibellini
e viscontei, si ponevano contro il vescovo di Coira ed
i lontani cugini di Matsch” . I Visconti avevano
acquisito l’importante sostegno dei Venosta largheggiando
nella concessione di privilegi. Già l’arcivescovo
Giovanni nel 1353 aveva concesso alla famiglia l’esenzione
d’ogni dazio e pedaggio e tali prerogative erano
state confermate il 23 febbraio 1372 da Galeazzo a beneficio
di tutta l’agnazione dei Venosta. Come atto di ritorsione
contro tale appoggio, l’anno successivo, i Bormini
facevano razzia di capi di bestiame pascolanti sull’alpe
di Verva in Valgrosina e appartenenti, probabilmente,
ai Venosta. I Visconti, rafforzato a spese di tutta la
valle il castello di Grosio, che quindi risultava già
interamente costruito, lo affidavano alla custodia di
Olderico Venosta detto Felino e allestivano una nuova
spedizione. Il 30 novembre 1376, muoveva da Grosio l’esercito
milanese al comando di Giovanni Cane, integrato con 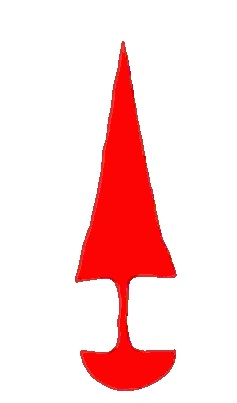 elementi locali, e, forzate le difese di Serravalle, metteva
a ferro e fuoco la terra di Bormio . Le condizioni di
resa furono pesanti. Il censo ducale fu portato a 300
fiorini, fu ordinato lo smantellamento delle difese meridionali
e fu imposto un risarcimento per i danni subiti dai Valtellinesi.
Nell’incontro convocato alle Prese di Sondalo per
accordarsi su tale rimborso i Bormini e i Venosta vennero
a contesa e nella rissa rimasero uccise ben trentasette
persone. Il castello di Grosio, o castrum novum come viene
definito nei documenti dell’epoca, conservò
rilevanza strategica ancora per alcuni decenni e tutta
la Valtellina fu costretta a concorrere per le spese di
custodia. Il 26 giugno 1377 Olderico Venosta dichiarava
di aver ricevuto dal canepario del terziere inferiore
lire 70 imp. “pro custodia castri Grosii”
. Nel 1382 il duca di Milano gli concedeva un credito
di 60 fiorini per rafforzare il castello, affidando al
comune di Como il controllo sulle spese, fino alla concorrenza
di tale somma. Lo scudo araldico rossocrociato del comune
di Como che ancor oggi si percepisce sotto gli spalti
del lato occidentale probabilmente fu realizzato a ricordo
di tale supervisione. Ancora nel 1416 Olderico, castellano
di Grosio, vantava crediti, relativi a tale mansione,
verso Franzino di Ambria del terziere di mezzo . La fedeltà
dimostrata e le benemerenze acquisite furono generosamente
ricompensate dai Visconti con l’incremento dei privilegi
già goduti in precedenza. Nel 1416 il duca Filippo
Maria lo nominava conservatore del castello e, a compenso
delle spese correnti, gli cedeva le onoranze e gli emolumenti
del dazio e del pedaggio che si riscuoteva nel territorio
di Grosio. A coronamento di una intera vita passa al servizio
dei Visconti, Olderico detto Felino, faceva tenere a battesimo
da un procuratore del duca di Milano un nipote natogli
dal figlio Gregorio al quale veniva imposto il nome di
Visconte. Da qui l’uso, invalso ufficialmente solo
nel XVII sec., di
qualificarsi col doppio cognome Visconti Venosta passato
a distinguere il ramo grosino dagli altri Venosta. Si
è disquisito molto sul fatto se questa struttura
sia stata abitata dal castellano o unicamente presidiata
da una guarnigione anche perché gli eventuali alloggiamenti,
posti nel recinto superiore, risultano attualmente rasi
al suolo e quindi poco leggibili. Da alcuni documenti
sembrerebbe emergere che Olderico Venosta via abbia effettivamente
vissuto fino al 1418 . Si direbbe che con la morte di
Olderico, avvenuta nel 1419, anche il castello abbia iniziato
una progressiva decadenza. Non essendo più strategicamente
rilevante nella politica dei Visconti, che finalmente
controllavano saldamente anche l’alta valle, i figli
di Olderico posero altrove la loro residenza . Il castello
di Grosio assunse nuova importanza solo sul finire del
1400 quando Ludovico il Moro cercava di organizzare una
valida difesa in previsione di una nuova invasione dei
Grigioni. Nel 1487 i Grigioni, scendendo da Bormio, con
relativa facilità avevano percorso tutta la valle
prima di incontrare una valida resistenza a Caiolo. Nella
pace di Ardenno avevano rinunciato alle terre occupate
in cambio della totale esenzione dei dazi e di un indennizzo
di 12.000 ducati d’oro ma questo primo fruttuoso
tentativo ne preannunciava altri. Lo Scaramellini, citando
il carteggio ducale, ci informa che “nell’ottobre
del 1493 il podestà di Bormio, Enea Crivelli, sentendo
vicino il pericolo di un’altra invasione, dopo aver
saputo da Scarioto, preposto alla
elementi locali, e, forzate le difese di Serravalle, metteva
a ferro e fuoco la terra di Bormio . Le condizioni di
resa furono pesanti. Il censo ducale fu portato a 300
fiorini, fu ordinato lo smantellamento delle difese meridionali
e fu imposto un risarcimento per i danni subiti dai Valtellinesi.
Nell’incontro convocato alle Prese di Sondalo per
accordarsi su tale rimborso i Bormini e i Venosta vennero
a contesa e nella rissa rimasero uccise ben trentasette
persone. Il castello di Grosio, o castrum novum come viene
definito nei documenti dell’epoca, conservò
rilevanza strategica ancora per alcuni decenni e tutta
la Valtellina fu costretta a concorrere per le spese di
custodia. Il 26 giugno 1377 Olderico Venosta dichiarava
di aver ricevuto dal canepario del terziere inferiore
lire 70 imp. “pro custodia castri Grosii”
. Nel 1382 il duca di Milano gli concedeva un credito
di 60 fiorini per rafforzare il castello, affidando al
comune di Como il controllo sulle spese, fino alla concorrenza
di tale somma. Lo scudo araldico rossocrociato del comune
di Como che ancor oggi si percepisce sotto gli spalti
del lato occidentale probabilmente fu realizzato a ricordo
di tale supervisione. Ancora nel 1416 Olderico, castellano
di Grosio, vantava crediti, relativi a tale mansione,
verso Franzino di Ambria del terziere di mezzo . La fedeltà
dimostrata e le benemerenze acquisite furono generosamente
ricompensate dai Visconti con l’incremento dei privilegi
già goduti in precedenza. Nel 1416 il duca Filippo
Maria lo nominava conservatore del castello e, a compenso
delle spese correnti, gli cedeva le onoranze e gli emolumenti
del dazio e del pedaggio che si riscuoteva nel territorio
di Grosio. A coronamento di una intera vita passa al servizio
dei Visconti, Olderico detto Felino, faceva tenere a battesimo
da un procuratore del duca di Milano un nipote natogli
dal figlio Gregorio al quale veniva imposto il nome di
Visconte. Da qui l’uso, invalso ufficialmente solo
nel XVII sec., di
qualificarsi col doppio cognome Visconti Venosta passato
a distinguere il ramo grosino dagli altri Venosta. Si
è disquisito molto sul fatto se questa struttura
sia stata abitata dal castellano o unicamente presidiata
da una guarnigione anche perché gli eventuali alloggiamenti,
posti nel recinto superiore, risultano attualmente rasi
al suolo e quindi poco leggibili. Da alcuni documenti
sembrerebbe emergere che Olderico Venosta via abbia effettivamente
vissuto fino al 1418 . Si direbbe che con la morte di
Olderico, avvenuta nel 1419, anche il castello abbia iniziato
una progressiva decadenza. Non essendo più strategicamente
rilevante nella politica dei Visconti, che finalmente
controllavano saldamente anche l’alta valle, i figli
di Olderico posero altrove la loro residenza . Il castello
di Grosio assunse nuova importanza solo sul finire del
1400 quando Ludovico il Moro cercava di organizzare una
valida difesa in previsione di una nuova invasione dei
Grigioni. Nel 1487 i Grigioni, scendendo da Bormio, con
relativa facilità avevano percorso tutta la valle
prima di incontrare una valida resistenza a Caiolo. Nella
pace di Ardenno avevano rinunciato alle terre occupate
in cambio della totale esenzione dei dazi e di un indennizzo
di 12.000 ducati d’oro ma questo primo fruttuoso
tentativo ne preannunciava altri. Lo Scaramellini, citando
il carteggio ducale, ci informa che “nell’ottobre
del 1493 il podestà di Bormio, Enea Crivelli, sentendo
vicino il pericolo di un’altra invasione, dopo aver
saputo da Scarioto, preposto alla 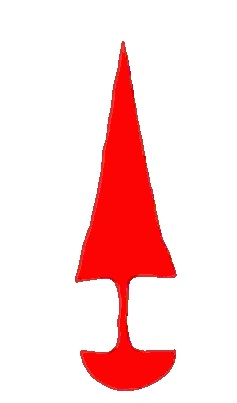 difesa
di Tirano, che avrebbe potuto contare su almeno 200 persone,
invitò lo stesso a studiare la possibilità
di rendere di nuovo agibile il castello di Grosio, quello
dei Venosta, che aveva bone murade al frixo e merlato
ed era situato in buona posizione per controllare il passaggio
di quisti barbari” . La struttura muraria doveva
essere sostanzialmente integra e gli interventi dovevano
riguardare le parti mobili in legno come gli impalcati
lungo gli spalti. Sembra però che la maggiore attenzione
venne allora riservata al rafforzamento della serra che
tagliava la valle. Non avendo goduto di particolari interventi
di restauro, la sua inagibilità di fatto preesisteva
alle disposizioni impartite dai Grigioni nel 1526 che
prevedevano lo smantellamento delle principali fortificazioni
valtellinesi. Si spiegherebbe in tal senso la disputa
per il possesso dei ruderi del castello e dei terreni
annessi che nel 1522 vide opposto il comune di Grosio
ai due frati agostiniani eremitani Vitale e Umiliato.
I due frati, che nella petizione rivolta agli oratori
delle Tre Leghe affermavano di provenire dalle terre venete
dove vi erano guerre e liti, erano giunti in Valtellina
e in Grosio erano stati loro offerti da persone pie alcuni
beni immobili nei pressi di un castello cadente dove intendevano
erigervi un convento. Il 15 dicembre 1522 le autorità
grigioni esprimevano parere favorevole concedendo loro
di costruire una casa o monastero con una chiesa, senza
danno, pregiudizio e detrimento di alcuna persona ivi
commorante . Contro tale parere ricorse il 4 luglio 1523
il decano del comune di Grosio affermando che la superficie
dove sorgeva il castello era un bene della comunità,
che la vedova di Fedregino Venosta non aveva nessuna veste
giuridica per compiere tale donazione e che i frati agostiniani
stavano già realizzando un altro monastero in Lovero
e cioè a circa quattro miglia da Grosio quando,
secondo le disposizioni di quell’ordine religioso,
un convento doveva distare almeno quindici miglia dall’altro.
L’epilogo della causa si ebbe solamente nel 1533
quando gli oratori delle Tre Leghe assegnavano “ad
pauperes Groxii” i ruderi contesi e condannavano
il comune di Grosio a riconoscere ai frati agostiniani
un indennizzo di lire 60 imp. . Confluito nei beni del
Capitolo delle Elemosine, il castello o più propriamente
i terreni all’interno della cinta muraria furono
oggetto di varie transazioni. Nel 1540 il comune dava
in affitto a Battista fu Giovanni de Tarabini alcuni fondi
“intra moenia” compreso il fossato, verso
sera, di quel castello, vicino alla strada “per
quam itur ad Sanctum Faustinum”, riservandosi un
“ortegello seu terreno existente in capite dicti
castri per se clauso” e quel tratto di terreno esistente
sopra detto fossato fra la cinta esterna dove è
sita la vigna di Antonio e Michino Venosta e la prima
cinta, “quae est intus a turre magna ruinata versus
nullaoram” . Da questa descrizione apprendiamo alcune
notizie molto importanti, ignorate in precedenza, che
ci permettono una migliore lettura della planimetria del
castello. Scopriamo così che il lato ovest era
difeso da un fossato, colmato difesa
di Tirano, che avrebbe potuto contare su almeno 200 persone,
invitò lo stesso a studiare la possibilità
di rendere di nuovo agibile il castello di Grosio, quello
dei Venosta, che aveva bone murade al frixo e merlato
ed era situato in buona posizione per controllare il passaggio
di quisti barbari” . La struttura muraria doveva
essere sostanzialmente integra e gli interventi dovevano
riguardare le parti mobili in legno come gli impalcati
lungo gli spalti. Sembra però che la maggiore attenzione
venne allora riservata al rafforzamento della serra che
tagliava la valle. Non avendo goduto di particolari interventi
di restauro, la sua inagibilità di fatto preesisteva
alle disposizioni impartite dai Grigioni nel 1526 che
prevedevano lo smantellamento delle principali fortificazioni
valtellinesi. Si spiegherebbe in tal senso la disputa
per il possesso dei ruderi del castello e dei terreni
annessi che nel 1522 vide opposto il comune di Grosio
ai due frati agostiniani eremitani Vitale e Umiliato.
I due frati, che nella petizione rivolta agli oratori
delle Tre Leghe affermavano di provenire dalle terre venete
dove vi erano guerre e liti, erano giunti in Valtellina
e in Grosio erano stati loro offerti da persone pie alcuni
beni immobili nei pressi di un castello cadente dove intendevano
erigervi un convento. Il 15 dicembre 1522 le autorità
grigioni esprimevano parere favorevole concedendo loro
di costruire una casa o monastero con una chiesa, senza
danno, pregiudizio e detrimento di alcuna persona ivi
commorante . Contro tale parere ricorse il 4 luglio 1523
il decano del comune di Grosio affermando che la superficie
dove sorgeva il castello era un bene della comunità,
che la vedova di Fedregino Venosta non aveva nessuna veste
giuridica per compiere tale donazione e che i frati agostiniani
stavano già realizzando un altro monastero in Lovero
e cioè a circa quattro miglia da Grosio quando,
secondo le disposizioni di quell’ordine religioso,
un convento doveva distare almeno quindici miglia dall’altro.
L’epilogo della causa si ebbe solamente nel 1533
quando gli oratori delle Tre Leghe assegnavano “ad
pauperes Groxii” i ruderi contesi e condannavano
il comune di Grosio a riconoscere ai frati agostiniani
un indennizzo di lire 60 imp. . Confluito nei beni del
Capitolo delle Elemosine, il castello o più propriamente
i terreni all’interno della cinta muraria furono
oggetto di varie transazioni. Nel 1540 il comune dava
in affitto a Battista fu Giovanni de Tarabini alcuni fondi
“intra moenia” compreso il fossato, verso
sera, di quel castello, vicino alla strada “per
quam itur ad Sanctum Faustinum”, riservandosi un
“ortegello seu terreno existente in capite dicti
castri per se clauso” e quel tratto di terreno esistente
sopra detto fossato fra la cinta esterna dove è
sita la vigna di Antonio e Michino Venosta e la prima
cinta, “quae est intus a turre magna ruinata versus
nullaoram” . Da questa descrizione apprendiamo alcune
notizie molto importanti, ignorate in precedenza, che
ci permettono una migliore lettura della planimetria del
castello. Scopriamo così che il lato ovest era
difeso da un fossato, colmato 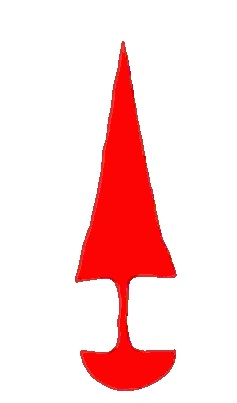 successivamente
dagli interventi agricoli, e che la cinta interna era
completata a nord da una grande torre, dove forse erano
situati gli alloggiamenti del castellano, che risultava
già franata a quell’epoca. Ignoriamo se il
crollo della torre sia avvenuto per cedimento statico
o sia stato provocato da un incendio, esso comunque giustifica
la breccia esistente sul lato nord-est delle cerchie murarie
superiore e inferiore. Nel 1544 i fondi precedentemente
locati venivano venduti al cavalier Antonio Maria fu Luigi
Quadrio di Tirano per la somma di 20 scudi d’oro,
fatti salvi i diritti dell’affittuario . Allo scoppio
della rivolta valtellinese del 1620, la possente struttura
muraria del castrum novum che, non ostante qualche cedimento,
aveva resistito al degrado, e si presentava pur sempre
temibile con ampie garanzie di solidità, fu nuovamente
ripristinata. Il perticatore Apollonio detto Fortuna di
Edolo che, allo scoppio della rivolta, era stato ingaggiato
dal cavalier Robustelli per curare le difese di Tirano
e di Piattamala e che conosceva molto bene Grosio per
aver redatto gli estimi nel 1618, così si esprimeva:
“Hanno quelli de Grossio un bellissimo castello,
fabricato in cima d’un sasso vivo, verso sera della
terra, discosto un mezzo miglio; fu già dei duci
di Milano lo fabricarno che si vede dentro alli merli
dipinta sopra tutti la biscia di Milano. Era andato a
male, adesso l’hanno ritornato a ricoverzere e vi
habitano fino a 80 soldati” . Da tale descrizione
apprendiamo quindi non solo che il castello era stato
riattato ma anche che i lacerti di intonaco sotto le merlature
esterne, recentemente rimessi in luce, ripetevano lungo
tutti gli spalti il blasone visconteo. Dopo la battaglia
di Morbegno del 10 novembre 1635, il duca di Rohan aveva
ordinato di fortificare il castello di Grosio . In ottemperanza
a tali disposizioni, il cancelliere del Terziere superiore
Robustelli decretava: “Grosio darà al castello
di Grosio per lavorare adì 17 dicembre carratori
5 et manuali 15”. E nuovamente il 2 febbraio 1636
stabiliva che: “Grosio darà per uso della
fortificazione del castello adì 7 febbraio 12 muratori,
12 legnamari et 12 manuali; et adì 8 febbraio,
7 muratori, 7 legnamari et 7 manuali che così gli
tocca per il comparto” . A questo successivamente
dagli interventi agricoli, e che la cinta interna era
completata a nord da una grande torre, dove forse erano
situati gli alloggiamenti del castellano, che risultava
già franata a quell’epoca. Ignoriamo se il
crollo della torre sia avvenuto per cedimento statico
o sia stato provocato da un incendio, esso comunque giustifica
la breccia esistente sul lato nord-est delle cerchie murarie
superiore e inferiore. Nel 1544 i fondi precedentemente
locati venivano venduti al cavalier Antonio Maria fu Luigi
Quadrio di Tirano per la somma di 20 scudi d’oro,
fatti salvi i diritti dell’affittuario . Allo scoppio
della rivolta valtellinese del 1620, la possente struttura
muraria del castrum novum che, non ostante qualche cedimento,
aveva resistito al degrado, e si presentava pur sempre
temibile con ampie garanzie di solidità, fu nuovamente
ripristinata. Il perticatore Apollonio detto Fortuna di
Edolo che, allo scoppio della rivolta, era stato ingaggiato
dal cavalier Robustelli per curare le difese di Tirano
e di Piattamala e che conosceva molto bene Grosio per
aver redatto gli estimi nel 1618, così si esprimeva:
“Hanno quelli de Grossio un bellissimo castello,
fabricato in cima d’un sasso vivo, verso sera della
terra, discosto un mezzo miglio; fu già dei duci
di Milano lo fabricarno che si vede dentro alli merli
dipinta sopra tutti la biscia di Milano. Era andato a
male, adesso l’hanno ritornato a ricoverzere e vi
habitano fino a 80 soldati” . Da tale descrizione
apprendiamo quindi non solo che il castello era stato
riattato ma anche che i lacerti di intonaco sotto le merlature
esterne, recentemente rimessi in luce, ripetevano lungo
tutti gli spalti il blasone visconteo. Dopo la battaglia
di Morbegno del 10 novembre 1635, il duca di Rohan aveva
ordinato di fortificare il castello di Grosio . In ottemperanza
a tali disposizioni, il cancelliere del Terziere superiore
Robustelli decretava: “Grosio darà al castello
di Grosio per lavorare adì 17 dicembre carratori
5 et manuali 15”. E nuovamente il 2 febbraio 1636
stabiliva che: “Grosio darà per uso della
fortificazione del castello adì 7 febbraio 12 muratori,
12 legnamari et 12 manuali; et adì 8 febbraio,
7 muratori, 7 legnamari et 7 manuali che così gli
tocca per il comparto” . A questo
intervento si deve, probabilmente, il tamponamento di
parte delle merlature con feritoie per le armi da fuoco.
Come è facile percepire dai fori mediani esistenti
nell’intradosso dei merli, precedentemente tali
interspazi disponevano di una portella lignea basculante
che offriva protezione ai difensori e permetteva il recupero
delle frecce scagliate dagli attaccanti. Passato il periodo
burrascoso della rivoluzione valtellinese, il castello
fu nuovamente smantellato e i suoi spazi interni riutilizzati
per scopi agricoli. Per evitare occupazioni abusive o
usurpazioni di beni comunali, nel 1786 il podestà
di Tirano Nicolò Christ de Sanz ordinava ai possessori
o affittuari dei terreni siti in località Castello
di notificare tale possesso . La riscoperta delle origini
e del ruolo svolto dalla famiglia Venosta, venuti alla
luce grazie alle ricerche archivistiche effettuate da
Nicola Visconti Venosta, indusse i suoi nipoti a valorizzare
quei ruderi castellani che erano stati già dimora
dei loro avi. Il 17 novembre 1863 il comune di Grosio,
in segno di gratitudine e di riconoscenza, cedeva ai fratelli
Emilio, Giovanni ed Enrico Visconti Venosta i resti del
castello di Grosio . La fortificazione ritornava dunque
nel possesso di quella famiglia che i Visconti, già
a suo tempo, avevano scelto come custode. Il Ministro
degli Esteri Emilio Visconti Venosta, abbandonato il sogno
di ripristinarla a sua dimora, ne consolidò i ruderi
contribuendo in tal modo a salvaguardarne la conservazione
fino ai nostri tempi. L’affetto manifestato dai
Grosini ai Venosta trovò sempre una controparte
grata, attenta ai bisogni di quella popolazione e pronta
a ricambiare con altrettanta generosità. Nel 1987
la marchesa Margherita Pallavicino Mossi, vedova di Giovanni
Visconti Venosta e ultima erede della casata, affidava
al costituendo Parco delle incisioni rupestri la tutela
e la valorizzazione di queste testimonianze storiche e
architettoniche tanto care alla sua famiglia. Con i recenti
restauri, che ci auguriamo possano garantire a lungo la
conservazione delle vestigia rimaste, abbiamo raccolto
idealmente il testimone lasciatoci dai Venosta e affidiamo
ai posteri questa struttura che resta “malgrado
la sua condizione di rudere, uno degli esempi castellani
più cospicui e attraenti dell’intera Valtellina”

La
serra di Grosso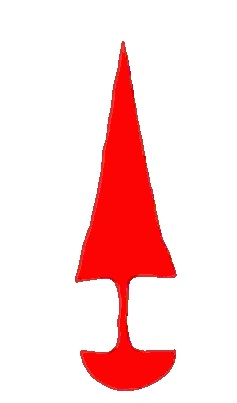
Concludiamo
la trattazione della storia delle fortificazioni grosine
con un accenno allo sbarramento che, scendendo dal castrum
novum, tagliava tutta la valle e giungeva fino all’Adda.
Attualmente di tale fortificazione non rimangono resti
emergenti se escludiamo il tratto di muro merlato che
dal castello scende fino al piano in prossimità
degli impianti dell’Azienda Energetica Municipale
di Milano. I lavori di bonifica agraria hanno invece totalmente
cancellato ogni segno visibile sul fondo valle e, a testimoniare
l’esistenza di tale difesa, sono rimasti unicamente
i due toponimi la sèra e i fusà. Lo sbarramento
fu realizzato a completamento delle opere difensive del
castello visconteo. Esso compare ufficialmente già
nel 1379 dove si ricordava “petia una terre campive
sub Seram ubi diciur ad Cloxuram”. La funzione dello
sbarramento non era solo difensiva ma anche di natura
fiscale in quanto i pedaggi, che vi si riscuotevano già
nel 1374 , costituirono parte degli emolumenti riconosciuti
dai Visconti alla famiglia Venosta per la custodia del
castello. Nel 1620 si ricordava ancora che “vi eran
muraglie e fosse che andavano dal castello al fiume Ada,
che dicono la Serra; come ancora tra Sondelo e Bormio,
che vi è una serra tra le montagne che poche persone
possono diffendersi d’un grosso numero di gente,
così qui altre volte vi era un baloardo su la strada
reale con ponte levatore”.A differenza dei documentati
interventi sul castello, i resti di questo sbarramento
non sembra che siano stati rafforzati nel corso degli
eventi bellici della rivolta valtellinese. Precedentemente
però, verso la fine del 1400, erano stati oggetto
quantomeno di una attenta valutazione da parte dei funzionari
sforzeschi preposti a rafforzare le difese in vista di
una nuova invasione grigione proveniente dal nord. Come
evidenziava anche il perticatore di Edolo, nel passo citato,
in alta Valtellina vi erano due serre ben distinte. Quella
di Serravalle, che i carteggi sforzeschi chiamano anche
murata dele Prexe, era stata realizzata, forse già
agli inizi del XIII sec. dai Bormini per difendersi da
attacchi provenienti dalla Valtellina e nel corso del
1300 l’esercito visconteo aveva incontrato non poche
difficoltà a forzarla. Quella di Grosio, allestita
dai Visconti, intendeva al contrario contrastare le invasioni
provenienti da nord. La murata di Grosio non era isolata,
ma completava un sistema difensivo imperniato su un castello
che, pur necessitando di restauri, aveva ancora “bone
murade al frixo e merlato”. A differenza di quelle
di Serravalle le opere difensive erano già predisposte
per contrastare attacchi provenienti dal nord. Inoltre
queste fortificazioni erano già state sperimentate
dai ducali quando nel febbraio del 1487 avevano tentato
col Trivulzio di sbarrare il passo ai Grigioni. Per contro
però la valle in quel punto si allargava per più
di un chilometro e le difese avrebbero potuto essere aggirate
se gli assalitori, passando oltre l’Adda, avessero
seguito i sentieri sul versante orobico. Nonostante il
parere contrario dei Bormini che si sarebbero di fatto
trovati privi di difesa, alla fine perciò si optò
per fortificare la murata dele Prexe “essendo Serravalle
il punto naturale più adatto ed economicamente
conveniente per una muraglia di sbarramento” .

|