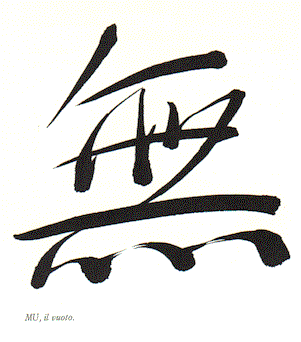|
Maria Grazia Tundo Saggi e scritture |
| HOME PAGE SAGGI Il nero virtuale. Topografie del desiderio in rete: le chat rooms Lo spazio del cinema: specchio di vita La riscrittura della fiabe: La camera di sangue di Angela Carter L'impossibilità dell'autobiografia.L'amant di Marguerite Duras Estraneità e parola. Simultan di Ingeborg Bachmann Il corpo impuro della luna. Salomè di O. Wilde Le voci dell'in-concepibile nel sogno di una scrittura: Frankenstein di Mary W. Shelley SCRITTURE RECENSIONI Fiction, Fact, in Flux. Marisa Bulgheroni, Apprendista del sogno
Maria Grazia Tundo 1999:
|
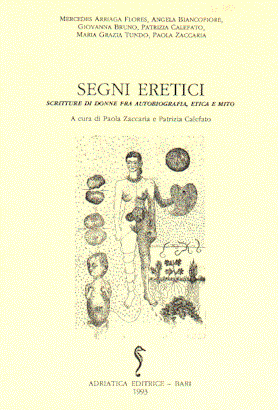
Estraneità e parola: Simultan di Ingeborg Bachmann in AAVV, Segni eretici. Scritture di donne tra autobiografia, etica e mito, (a cura di Paola Zaccaria e Patrizia Calefato), Bari, Adriatica Editrice, 1993, pp. 45-54.
Nel racconto Simultan di Ingeborg Bachmann, tradotto in italiano con il titolo Simultaneo (1), è possibile rintracciare spunti interessanti per una riflessione sul rapporto tra linguaggio, soggettività femminile e temporalità. Seguirò, a tal proposito, i percorsi di senso che i frammenti di esistenza di una donna, colti nella brevità di un racconto di poche pagine, mi hanno suggerito. Il racconto non presenta uno sviluppo lineare e conseguente: discorso narrato e discorso vissuto (erlebte Rede)(2) si intrecciano costantemente, i punti di vista slittano in maniera repentina, i tempi verbali narrativi e quelli commentativi (3) si sovrappongono. Non vi è nemmeno un'unità linguistica: il tedesco, lingua principale del racconto, viene spesso sostituito dal francese, dall'inglese, dall'italiano e dal russo senza segnali grafici che ne evidenzino le transizioni. Questa struttura complessa appartiene, in realtà, all'universo linguistico ed esperienziale della protagonista stessa, Nadja, travolta dalla repentina disgregazione delle usuali coordinate temporali e spaziali in cui era riuscita ad inquadrare la sua esistenza. Della simultaneità, infatti, aveva fatto una modalità di vita oltre che di lavoro. In fuga dal passato e dalla memoria, quella memoria che è «lo sfondo di tutte le lontananze e di tutti i silenzi che hanno accompagnato la nostra vita»(4), aveva abbandonato la lingua materna, luogo antico in cui si erano rapprese paure, desideri ed impossibilità, scegliendo di essere un'interprete simultanea, di lasciarsi attraversare da voci senza corpo e senza spessore che, per questo, non avrebbero potuto ferirla:
Secondo Julia Kristeva, attraversare una frontiera, staccarsi dalla famiglia, dalla propria lingua porta a negare ogni interdetto e a godere di un apparente senso di libertà. E' infatti possibile abitare la lingua straniera senza imbarazzo, perché il corpo e le passioni sono state lasciate in ostaggio alla lingua materna: ciò può accadere perché l'inconscio è stato allontanato dalla nuova lingua, in quanto, come già detto, essa non è abitata dalla memoria. In questo caso, ogni costruzione mentale si muove sul vuoto, in un'apparente levità che la rende però artificiale e raramente innovativa, nient'altro che la ri-produzione brillante di tutto ciò che c'è da imparare. (6) La stessa artificiale levità dominava la vita di Nadja. Era, infatti, un turbinio di sale, di palazzi, di congressi, di hall, di alberghi, bar, uomini, in una frenesia di simultaneità che rendeva tutto uguale, equivalente, sostituibile. La donna era stata capace di costruire per sé una rete linguistica e concettuale in grado di contenere tutto il reale, senza alcuna smagliatura: nomi limpidi, senza ombre, completamente traducibili grazie alla verità di senso che il vocabolario contiene. Trasformando se stessa in una sorta di meccanismo di traduzione "automatica" persino i libri da lei letti venivano ridotti al rango di dizionari su cui esercitarsi a passare da un codice all'altro (7):
Si era dunque posta al riparo dal rischio della messa in questione organizzando il rapporto con gli universi linguistici che via via incontrava secondo un meccanismo di commutazione riconducibile ad un ordine, ad un sistema di referenze che, illusoriamente, poteva espellere l'ambivalenza, lo scarto, lo slittamento dei significati, ogni eccedenza di senso. Protetta da un Codice unico immaginario, dove tutto trovava un posto ed un'identità stabile, la donna aveva potuto dimenticare il proprio passato e, con esso, i segni da esso incisi sul suo corpo, il balbettio erratico del desiderio che non ha una dimora linguistica. A proposito di situazioni di plurilinguismo come espediente difensivo, un libro piuttosto recente dal titolo La babele dell'inconscio (9) offre numerosi spunti di riflessione. Pur partendo dall'idea che un monolinguismo assoluto non esiste, se non come sogno mitico di una lingua originaria pre-babelica (in quanto altri idiomi, gerghi o dialetti sempre interferiscono nella realtà delle produzioni linguistiche), spesso l'apprendimento e l'uso di lingue naturali differenti da quella materna consentono al soggetto di mantenere una distanza di sicurezza dal conflitto primario legato alla necessità di separazione ed all'attrazione regressivo-fusionale verso l'oggetto d'amore. Cambiando registro espressivo sembra possibile poter adottare differenti percorsi di pensiero e di affetti, in quanto il nuovo contesto culturale ed emozionale che si adotta si presenta come non ipotecato da quei conflitti arcaici.(10) Inoltre si potrebbe aggiungere che nella lingua materna si sono costruiti i rudimenti di un'identità che alle convenzioni linguistiche e culturali del proprio gruppo sociale e nazionale di appartenenza è tributaria. Identità come già scritta e definita dall'Altro, con gli interdetti e le opportunità, le violenze e le lusinghe che si nascondono in ogni educazione al linguaggio, in quanto mezzo di trasmissione non neutro di valori e modelli. Come ci ricorda Rossi-Landi in un suo saggio che si propone di criticare la concezione contrattualistica del linguaggio (concezione secondo cui quest'ultimo viene inteso come una "convenzione" legata ad un "accordo" tra individui preformati), l'infante entra in relazione con gli altri subendo la lingua che apprende, in quanto non gli si offrono altre scelte possibili: la comunità linguistica di cui fa parte gli impone i propri sistemi di comunicazione, a cui egli deve passivamente sottostare e che deve condividere.(11) L'apprendimento di una lingua straniera pare poter offrire una possibilità di fuga, configurarsi come ipotesi di riscrittura della propria identità e, almeno in apparenza, come luogo di libertà; l'esperienza della protagonista della narrazione si configura proprio come intessuta di quest'inganno. Rifacciamoci nuovamente alle parole della Kristeva che parla dello straniero come di colui che, attraversando una o più frontiere, è stato in grado di trasformare il suo malessere, quello che lo portava ad essere ai margini della sua stessa lingua, in un duro carapace, che gli permette di moltiplicare le maschere e di non essere mai del tutto vero così come mai del tutto falso:
Sono i brandelli di questo sé obliato, che forse si è tentato di negare, che riemergono inaspettatamente nel racconto. In seguito ad un incontro casuale si disegna per la protagonista la possibilità di una storia d'amore che si snodi tra i suoni della vecchia lingua, il tedesco, la lingua dell'infanzia e dell'adolescenza, la lingua abbandonata in nome dell'indipendenza; l'unica di cui Nadja non riesce a sentirsi padrona, l'unica in cui le parole le vengono a mancare:
Eppure, proprio in questo "essere a casa", i sensi non sembrano più univoci, confusi come sono dall'eros e dall'inquietudine linguistica. E' ancora la Kristeva, nel suo Storie d'amore, a ricordarci che l'esperienza d'amore è smarrimento ed inevitabile ferita in quanto nel trasporto amoroso si perdono i limiti delle identità, e dunque del "senso" che ne dovrebbe essere garante, ma che nel discorso amoroso slitta continuamente insieme alla precisione delle referenze (14): i segni rivelano il loro gioco di metamorfosi perenne perché c'è l'altro inconoscibile, incomprensibile. Nel racconto quell'uomo, familiare per la lingua e la città d'origine comune, fa risuonare un'estraneità più antica che in quella stessa lingua è inscritta. Si tratta dell'estraneità, familiare ed inquietante così ben raccontata da Freud nel suo famoso saggio sul "perturbante", in cui al corpo materno, luogo dell'origine e primo oggetto d'amore, viene restituita tutta la sua carica conflittuale di desiderio e repulsione.(15) Da quel corpo, dal rapporto fusionale con esso, ci si è dovuti distaccare per disegnare i contorni di un'identità che però si rivela costruzione precaria, immaginaria, nel momento del ritorno alle arcaiche sonorità preverbali e pulsionali della lingua materna. Ogni nuova storia d'amore riattiva e rimette in gioco emozioni legate alla storia d'amore primaria, sepolta nella memoria di ognuno, e minaccia la temibile e agognata possibilità di una regressione ad uno stato di bisogno, di dipendenza, di totale dispersione nel corpo dell'altro. A questo punto non c'è più spazio per la sicurezza di una simultanea comprensibilità, perché il discorso riconosce la propria impotenza comunicativa nel momento in cui si contamina con il desiderio, la cui essenza è di porre l'altro come inafferrabile :
Nell'uso di ogni madrelingua si nasconde un fondo di malessere, una ferita permanente, una domanda irrisolta sulla propria identità: si comincia a parlare, a simbolizzare, per sostenere l'angoscia di una mancanza originaria, quella del corpo materno da cui ci si è dovuti separare.(17) Potremmo aggiungere che per una donna il rapporto con la figura materna si complica quando questo essere da cui ci si deve staccare è anche colei che fa da specchio e si pone come modello d'identità. L'impresa è difficile e dolorosa, in quanto al soggetto femminile si richiede un compito evolutivo paradossale: operare il distacco e la differenziazione dalla madre e, nel contempo, porsi come simile a lei, assumendo il proprio ruolo sociale secondo un modello di demarcazione sessuale rigidamente prefigurato, che proprio nella "madre" trova il suo compimento. Questa lacerazione è inscritta anche nella temporalità ed il linguaggio ne porta le tracce. Il tempo della madre e quello della bambina non coincidono più; nessuna fusionalità è possibile all'ombra della legge del Padre.(18) Non potrà più esserci sincronia, bensì scarto, intervallo, frattura tra sé e l'altro, e la parola dispiegherà il prezzo pagato per differenziarsi. Nel contempo a tale scarto, prezioso in quanto dal dolore della lacerazione potrebbe nascere la verità di un rapporto costruito sulla distanza e sull'alterità della figura materna rispetto a sé, non viene restituita tutta la sua valenza relazionale, dal momento che la differenziazione stessa è resa difficile dal linguaggio e dalle sue stereotipie, che pongono la divisione in generi come naturale e fondante, mentre nel contempo delineano i canoni della normalità a cui adeguarsi. La madre si fa garante della persistenza di tale paradosso, in quanto nell'educare alla parola restituisce alla bambina un' immagine di donna "mancante", figura dimidiata e gregaria, la cui anatomia si pone come destino già inscritto nell'area semantica del vuoto, la cui unica speranza di salvezza, oltre che di pienezza, è ripercorrere la strada materna della generazione secondo funzioni regolate socialmente. Come non ipotizzare la fuga linguistica come possibilità di salvezza? Ma fuggire è anche muoversi nell'area nella negazione, rifiutare di affrontare la propria verità storica ed individuale che è segnata dalla mancanza, dalla solitudine, dallo scarto temporale tra sé e l'altro. Ed è proprio il tempo del desiderio a riaprire antiche lacerazioni, a far sentire il suo richiamo di verità. Ad esso nessun linguaggio rigidamente codificato può offrire voce perché è assolutamente diverso dalla temporalità lineare e progressiva che il mondo insegna e su cui costruisce i suoi sistemi.(19) Eppure è anche alla luce di quest'altra temporalità singolare, idiosincratica, che sperimenta il tempo sempre troppo breve dell'ansia e dell'amore, o il tempo esausto ed immobile del lutto e della malinconia, che il soggetto dispiega il suo gioco linguistico inesauribile, ponte gettato verso l'altro che sfugge e che sempre viene interpretato nella distanza di un senso mai posseduto:
Non c'è assoluta coincidenza di desiderio, mai, né basta un codice comune o una lingua condivisa ad unire un uomo ed una donna poiché, in ognuno, il tempo del proprio sentire, incarnato nei segni che all'altro vengono offerti, (e che portano incisa la propria materialità storica e sociale oltre che individuale), ha delineato storie diverse, rendendo l'attimo di ogni vita singolare ed inenarrabile. Riconoscere questa distanza, riconoscere l'estraneità come inerente ai propri vissuti e la solitudine come segno di sé restituisce alla donna una percezione della propria soggettività forse meno alienata, senz'altro più dolorosa. Nel momento in cui l'illusione della padronanza linguistica non la sostiene più, il corpo fa sentire il suo richiamo isterico: il mal di testa che insorge quando ogni cosa sembra incerta ed incomprensibile; la sensazione del venir meno, del cadere; le vertigini; le crisi fobiche nel camminare su di una scogliera a picco sul mare. Si tratta del ritorno di un rimosso non simbolizzabile, di una dimensione emozionale così complessa ed arcaica che non sembrano esserci parole adatte per esprimerla:
Il "venir meno" è quello del senso di una vita ordinata, scandita dai tempi ossessivi ma rassicuranti del lavoro, ma è, ancora di più, il venir meno linguistico. Infatti quando si interrompe l'uso automatico della parola, che offre la sicurezza di un'identità inalterabile, ed il linguaggio non garantisce più lo scambio dei messaggi all'interno di un contratto sociale di comunicazione, la fobia si fa metafora (non linguistica, ma legata all'immagine ed alla pulsione) della mancanza, mostrando la fragilità del sistema significante del soggetto. (22) L'emergere dei segni del corpo, nella loro ambivalenza di paura e desiderio, portano Nadja a riconoscersi realmente straniera, in primo luogo a se stessa, ad apprendere qualcosa della propria eterogeneità ed impotenza. Si sente annientata, cosciente ormai dell'inganno contenuto in quella "simultaneità" (tra sé e l'altro, tra sé ed il mondo) che da sempre aveva costituito l'orizzonte della sua esperienza: fingere che la lingua dell'Altro potesse attraversarla senza lasciare tracce, cancellare dalla propria parola ogni indizio di "differenza" per adeguarsi a tutti i discorsi ufficiali, quelli delle Conferenze e dei Convegni, i discorsi degli "uomini". Dice infatti:
E' "banale" il discorso che parla in nome di un soggetto universale, misura di tutta la realtà e che sempre riconduce al noto ciò che appare nuovo e che potrebbe mettere in questione la rappresentazione sostenuta dalla logica del Medesimo; è "banale" il discorso autoritario, assertivo, dogmatico, che non riconosce l'inerente eterogeneità di ogni discorso vivo. Da questa banalità la donna si era lasciata invadere, facendosi specchio di parole a lei estranee e ricevendone, in cambio, la sicurezza di un'identità, di un ruolo, di una temporalità perfettamente coincidente con il tempo del sociale. Il disagio non può che palesarsi quando tutte le lingue che conosce si rivelano insufficienti a colmare lo scarto tra sé e l'esperienza dell'altro, amato e per questo appartenente ad un tempo a lei straniero, mai in sincronia. Come suggerisce M. Blanchot,
poiché la passione rende coloro che ne sono presi stranieri a se stessi, oltre che uno all'altro.
Perché ci sia relazione, dunque, è necessaria questa differenza non simmetrica, non complementare, che porti il segno dell'irriducibilità e del divenire. Alla luce di una tale consapevolezza, anche il rapporto della donna con il linguaggio non può che cambiare: scopre come nel suo tradurre non ci fosse stato spazio per una coscienza dell'alterità, ma solo l'illudere il possesso di un senso già dato, sempre e comunque definitivo. Quando tenterà di tradurre in tedesco una frase casualmente presa dal Vangelo posto sul comodino della sua camera d'albergo e scritto in italiano si accorgerà di non potersi più muovere con la consueta padronanza tra i due universi linguistici:
Eppure, paradossalmente, questa nuova consapevolezza del limite è indice del suo passaggio ad una dimensione plurilinguistica effettiva: il potersi finalmente porre delle domande sulla natura del significato, e dunque la scoperta della molteplicità dei percorsi di senso possibili nel tradurre, costituiscono il venire alla luce della presenza concreta, materiale, dell'altro nella lingua, lingua abitata da storie, memorie, vissuti individuali e collettivi, che non solo non convivono armonicamente, ma che proprio entrando in collisione provocano effetti di senso. Nadja, traduttrice simultanea, non potrà più semplicemente tradurre, protetta dalla sua professionalità, ma dovrà "traslare", nel senso di riconoscere la "padronanza" linguistica come realtà illusoria e mettersi in gioco in prima persona, (26) trasportando tra le lingue anche la propria storia, il proprio corpo che, nel senso continuamente messo in questione, cerca la materialità ed il corpo dell'altro da sé, confondendo i codici, incapace ormai di tenerli disgiunti, cercando nella contaminazione linguistica spazi nuovi per esprimere ciò che non riesce a trovare voce: quella soggettività che ricerca le parole ed i luoghi per far risuonare la propria atopia e distanza da ogni senso irrigidito dall'usura. E non potrà che parlare una lingua straniera, fatta di tutti i luoghi che ha attraversato e che tale estraneità le hanno restituito, una lingua in cui il dolore ed il desiderio potranno divenire parola per l'altro, senza doversi tramutare in sintomi muti, una lingua in cui potrà forse risuonare, nella distanza, l'eco indistinta di parole d'amore. Note
© Maria Grazia Tundo 1999 |