| |
La
strada per Los Angeles
(1930,
ma pubblicato postumo nel 1985)- Marcos y Marcos, pag.
168
|
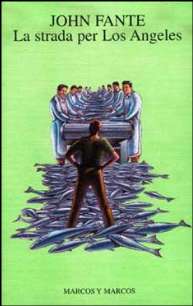 "Ho
sette mesi di tempo e 450 bigliettoni per scrivere un romanzo.
Mi pare piuttosto straordinario", scrive John Fante
a un amico, "dentro ci sono alcune cosette che metterebbero
il fuoco al culo a un lupo. Forse è un pochino troppo
forte, cioè mancante di 'buon' gusto. Ma non me ne importa
niente". "Ho
sette mesi di tempo e 450 bigliettoni per scrivere un romanzo.
Mi pare piuttosto straordinario", scrive John Fante
a un amico, "dentro ci sono alcune cosette che metterebbero
il fuoco al culo a un lupo. Forse è un pochino troppo
forte, cioè mancante di 'buon' gusto. Ma non me ne importa
niente".
Ebbene, questo romanzo "un pochino troppo forte" segna
l'esordio di un indimenticabile eroe della letteratura del nostro
secolo: Arturo Gabriel Bandini. Tenero e ribelle, ingenuo e
rancoroso, Bandini è in eterno, adolescenziale conflitto
con la parte di mondo che gli capita a tiro, e cambia volto
e umore, spesso passando dal paradiso all'inferno, nel giro
di poche righe. C'è ad esempio un Bandini-Führer
che attacca un branco di granchi facendoli a pezzi impietosamente,
un Bandini erotomane che si tappa con le sue riviste pornografiche
nello "stanzino dei vestiti", un Bandini saccente,
lettore esaltato di Nietzsche e di Spengler, che si vendica
sul padrone del fetente conservificio dove lavora chiedendogli
un parere sul superomismo...
... All'altezza della banca toccai il punto
in cui aveva sfregato il fiammifero. Eccolo, sui miei polpastrelli.
Magnifico. Un piccolo frego nero. Oh, frego, il tuo nome è
Claudia. Oh, Claudia, ti amo. Ti bacerò per provarti
la mia devozione. Mi guardai intorno. Non c'era nessuno nel
raggio di due isolati. Mi sporsi e baciai quel frego nero...
***
l'inizio...
Ho
fatto un sacco di lavori al porto di Los Angeles perché
la nostra famiglia era povera e mio padre era morto. Il mio
primo lavoro, poco dopo la maturità, fu quello di spalatore
di fossi. Di notte non potevo dormire per via del mal di schiena.
Stavamo facendo uno scavo in un terreno, non c'era neanche un
po' d'ombra, il sole picchiava dall'alto di un cielo senza nuvole,
e io giù in quella buca a scavare insieme con due cani
da valanga che avevano una vera passione per lo scavo, sempre
là a ridere e a raccontarsi barzellette, ridendo e fumando
un tabacco puzzolente.
Incomincia come una furia; loro ridevano, e dissero che dopo
un po' avrei imparato una cosa o due. Pala e piccone diventarono
pesanti. Succhiavo le mie vesciche piagate e odiavo quegli uomini.
Una volta a mezzogiorno mi sedetti,stanco , a guardarmi le mani.
Dissi a me stesso: perché non lo lasci perdere, questo
lavoro prima che ti uccida?
Mi alzai e lanciai la pala nella terra.
"Ragazzi " dissi "io ho chiuso. Ho deciso di
accettare un lavoro per l' Ente Porto".
Il lavoro successivo fu quello di lavapiatti. Tutto il tempo
a guardare fuori da un buco di finestra attraverso la quale,
giorno dopo giorno, vedevo mucchi di immondizie, e le mosche
che ci ronzavano intorno, ed ero come una massaia davanti alla
sua pila di piatti, con le mani che mi si ribellavano quando
li guardavo nuotare come pesci morti in quell'acqua bluastra.
Un cuoco grasso era il capo. Sbatteva padelle e mi faceva lavorare.
Ero felice quando una mosca atterrava sulla sua grossa guancia
rifiutandosi di ripartire. Quel lavoro lo feci per quattro settimane.
Arturo, mi dissi, il futuro di questo lavoro è assai
limitato; perché non lo lasci stasera? Perché
non dici a quel cuoco di andare a farsi fottere ?
Non mi riuscì di aspettare fino a sera. A metà
di quel pomeriggio d'agosto, con una montagna di piatti da lavare
davanti a me, mi tolsi il grembiule. Mi venne un sorriso.
"Che c'è di tanto divertente?" disse il cuoco.
"Ho chiuso. Finito. Ecco che c'è di tanto divertente".
Uscii dalla porta posteriore, un campanello trillò. Lui
rimase a grattarsi la testa in mezzo all'immondizia e ai piatti
sporchi. Ogni volta che pensavo a tutti quei piatti mi veniva
da ridere, mi è sempre sembrato così divertente.
***
frammenti..
[…]
Arrancai sotto il ponte ed ebbi la sensazione di essere l'unico
che l'avesse mai fatto. Le piccole onde del porto lambivano
le rocce lasciando qua e là pozzanghere di acqua verde.
Alcune rocce erano rivestite di muschio, su altre c'erano graziose
macchie di cacca d'uccello. Mi arrivava l'odore greve del mare.
Sotto i piloni era così freddo e buio che non e che ci
vedessi molto. Dall'alto mi arrivava il rumore del traffico,
il suono dei clacson, le urla degli uomini, lo schiocco degli
autocarri sopra le traverse di legno. Un fragore terribile che
mi martellava le orecchie; e se gridavo, la voce se ne andava
avanti per qualche piede e mi ripiombava addosso, come se fosse
stata fissata a una striscia di gomma. Arrancai lungo le rocce
finche uscii alla luce del sole. Era uno strano posto. Per un
attimo ebbi paura. Poco più in là c'era una grande
pietra, più grossa delle altre, con la cresta tutta segnata
dalla cacca bianca dei gabbiani. Era la regina di tutte quelle
pietre, incoronata di bianco. Mi avviai.
Tutt'a
un tratto ogni cosa, ai miei piedi, prese a muoversi. Era il
movimento rapido e molle di qualcosa che strisciava. Trattenni
il respiro, sul chi vive, e cercai di orientare il mio sguardo.
Erano granchi! Quelle pietre erano vive e ne brulicavano. Avevo
una tale paura che non potevo muovermi, e il rumore dall'alto
era nulla paragonato ai palpiti del mio cuore.
Mi addossai a una pietra e mi tenni la faccia tra le mani fino
a quando la paura se ne fu andata. Quando tolsi le mani riuscii
a vedere nell'oscurità: era grigio, faceva freddo, era
come un mondo sotterraneo. Un posto grigio e solitario. Per
la prima volta diedi un'occhiata adeguata alle cose viventi
che l'abitavano. I granchi più grossi avevano la stazza
di mattoni, silenziosi e crudeli si issavano sulla cima di quelle
grandi pietre, muovendo voluttuosamente le antenne minacciose,
quasi fossero braccia di ballerine di hula, con quei piccoli
occhi maligni e ripugnanti. Erano un sacco più numerosi
quelli piccoli, grandi all'incirca come la mia mano, che brulicavano
attorno alle piccole pozze nere alla base delle rocce, arrancando
l'uno sull'altro, spingendosi a vicenda in quello sciabordio
nerastro, in lotta per conquistarsi una posizione sulle pietre.
Si divertivano.
C'era un nido di granchi ancora più piccoli al miei piedi,
ciascuno grande come un dollaro, tutto un attorcigliamento di
zampe mischiate assieme. Uno mi si aggrappò al risvolto
dei pantaloni. Lo tirai via e lo tenni con le dita mentre si
dibatteva disperatamente cercando di morsicarmi. Ma lo tenevo,
e non aveva scampo. Tirai indietro il braccio e lo sbattei contro
una pietra. Scricchiolò, morto fracassato; per un attimo
rimase attaccato alla pietra, poi scivolo giù, stillando
sangue e acqua. Raccolsi quel guscio rotto e assaggiai il fluido
giallastro che ne usciva, salato come acqua di mare, e non mi
piacque. Lo scagliai lontano, nell'acqua profonda. Galleggiò
fino a quando uno sperlano non gli venne vicino esaminandolo
e prendendo poi a morsicarlo voracemente fino a trascinarlo
fuori dal mio campo visivo. Le mie mani insanguinate e attaccaticce
puzzavano di mare. Di colpo sentii crescere in me una frenesia:
dovevo uccidere questi granchi, tutti quanti.
I piccoli non mi interessavano, erano i grossi che volevo uccidere
e uccidere. I grossi di quella compagnia erano forti e feroci
e avevano mascelle possenti. Erano avversari degni del grande
Bandini, Arturo il conquistatore. Mi guardai intorno ma non
potei trovare un palo o un bastone. Sull'argine di cemento c'era
un mucchio di sassi. Mi rimboccai le maniche e cominciai a scagliarli
verso il granchio più corpulento che avessi visto, uno
che stava dormendo su una pietra a venti passi da me. I sassi
gli atterravano tutt'intorno, a non più d'un pollice,
volavano schegge e scintille, ma lui neanche apriva gli occhi
per vedere che cosa stesse succedendo. Mi ci vollero circa venti
tiri prima di centrarlo. Fu un trionfo. Il sasso gli sfondò
la schiena col rumore di un cracker che si spezza. Lo trapassò
inchiodandolo alla pietra. Poi cadde in acqua: bolle verdastre
e schiumose lo inghiottirono. Lo guardai scomparire e agitai
il pugno in segno di minaccioso congedo mentre calava verso
il fondo. Addio, addio! Di certo ci rivedremo in un altro mondo;
non mi dimenticherai, Granchio. Per sempre, per sempre mi ricorderai
come il tuo conquistatore!
Ucciderli coi sassi era troppo dura. I sassi erano cosi affilati
da tagliarmi le dita nel raccoglierli. Mi lavai il sangue e
il fango dalle mani e mi avviai nuovamente. Mi arrampicai sul
ponte e mi misi a camminare per la strada verso un negozio di
forniture navali che stava tre isolati più avanti e dove
si vendevano armi e munizioni.
Dissi a quella faccia bianca di un commesso che volevo comprare
un fucile ad aria compressa. Me ne mostrò uno molto potente
e io cacciai i soldi e lo comprai senza batter ciglio. Il resto
dei dieci dollari lo spesi in munizioni: pallini. Ero ansioso
di tornare sul campo di battaglia, perciò dissi al faccia
bianca di non impacchettarmi le munizioni ma di darmele così
com'erano. Lui dovette pensare che era strano e mi lanciò
un'occhiata mentre prendevo quei cilindretti dal bancone e uscivo
dal negozio il più svelto possibile, ma senza correre.
Fuori presi a correre e fu allora che ebbi la sensazione che
qualcuno stesse osservandomi e mi guardai attorno, e ovviamente
il faccia bianca stava sulla porta, mi stava scrutando nell'aria
calda del pomeriggio. Rallentai l'andatura, la trasformai in
una camminata rapida, ma svoltato l'angolo ripresi a correre.
Sparai al granchi per tutto quel pomeriggio, fino a che la spalla
su cui appoggiavo il fucile cominciò a dolermi e cominciarono
a bruciarmi gli occhi per il troppo prendere la mira. Ero Bandini
il Dittatore, l'Uomo d'Acciaio di Grancovia. E questo non era
altro che un nuovo Bagno di Sangue per il bene della Patria.
Ci avevano provato a depormi, quei granchi dannati: avevano
avuto l'ardire di cercare di fomentare una rivoluzione, e io
mi stavo vendicando. Ma pensa! C'era di che infuriarsi. Questi
granchi maledetti da Dio avevano addirittura messo in dubbio
il potere di Bandini il Superuomo! Che cosa gli era preso, che
erano diventati così presuntuosi? Beh, avrebbero avuto
una lezione indimenticabile. E questo sarebbe stato il loro
ultimo tentativo di rivoluzione, perdio. Digrignai i denti.
Ma pensa: una nazione di granchi in rivolta. Che ardire! Dio,
ero fuori di me.
Caricai e ricaricai finché la spalla mi fece male e mi
venne una vescica sul dito del grilletto. Ne uccisi più
di cinquecento e ne ferii il doppio. Animosi, venivano all'attacco
folli di rabbia e di paura mentre i morti e i feriti uscivano
dai ranghi. Era un assedio. Mi si accalcavano intorno. Altri
ne venivano fuori dal mare, altri ancora da dietro le rocce,
muovendo in gran numero sul pianoro di sassi verso la morte,
troneggiante su un'alta roccia fuori dalla loro portata.
Radunai un po' di feriti in una pozza, convocai un consulto
militare, e poi decisi di affidarli alla corte marziale. Uno
alla volta, li trascinai fuori dalla pozza, il sistemai davanti
alla canna del futile e premetti il grilletto. Ci fu un granchio
dai colori brillanti e pieno di vita, che mi fece l'impressione
di una donna: di sicuro era una principessa fra quei rinnegati,
una granchia ardimentosa seriamente piagata, con una gamba in
meno e un braccio penosamente penzoloni. Mi spezzò il
cuore. Ebbi una nuova consultazione e decisi che, a causa della
pressante urgenza della situazione, non ci sarebbe stata alcuna
discriminazione fra i sessi. Anche la principessa doveva morire.
Era spiacevole, ma si doveva fare.
Col cuore triste diedi l'annuncio, e là, in mezzo ai
morti e ai morenti, innalzai una preghiera a Dio, chiedendogli
di perdonarmi per questo, per il più bestiale dei crimini
di un superuomo: l'esecuzione di una donna. Eppure, dopotutto,
il dovere era il dovere, il vecchio ordine andava preservato,
la rivoluzione andava schiacciata, il regime doveva continuare,
e i rinnegati dovevano perire. Per qualche tempo parlai in privato
con la principessa, estendendo a lei le scuse formali del governo
Bandini e, attenendomi al suo ultimo desiderio - voleva che
le permettessi di ascoltare La Paloma - gliela fischiettai con
gran sentimento, tanto che, verso la fine, mi venivano le lacrime.
Puntai il fucile contro il suo bel viso e premetti il grilletto.
Morì all'istante, gloriosamente, in una fiammeggiante
miscela di guscio e di sangue giallastro.
Per rispetto e ammirazione, feci sistemare una pietra sul luogo
dove era caduta, incantevole eroina di una delle più
indimenticabili rivoluzioni del mondo, perita nelle sanguinarie
giornate di giugno del governo Bandini. Era stata scritta la
storia, quel giorno. Feci il segno della croce su quella pietra,
la baciai riverente, persino con un filo di passione, e restai
a capo chino in quella momentanea pausa dell'attacco. Ironia
di quel momento! Ebbi come un'illuminazione, e realizzai che
quella donna io l'avevo amata. Eppure... animo, Bandini! L'attacco
riprendeva. Poco dopo, colpii un'altra donna. Non era altrettanto
seriamente ferita, più che altro era lo choc. Fatta prigioniera,
mi si offrì anima e corpo. Mi scongiurò di risparmiarle
lo vita. Risi, diabolico. Era una creatura squisita, rossiccia
e rosata, e soltanto una conclusione che già mi appariva
scontata fece si che aderissi alla sua toccante offerta. Là,
sotto il ponte, nell'oscurità, la devastai mentre mi
supplicava di avere pietà. Ancora ridendo la portai fuori
e la feci a pezzi, scusandomi per la mia brutalità.
Quella carneficina finalmente si fermò allorché
mi venne il mal di testa per avere troppo sforzato gli occhi.
Prima di andarmene diedi un'ultima occhiata in giro. Quella
scogliera in miniatura era tutta macchiata di sangue. Era un
trionfo, una vittoria molto grande per me. Mi addentrai fra
i caduti e parlai loro con accenti consolatori perché,
per quanto fossero stati miei nemici, ero un uomo di nobile
cuore e li rispettavo e ammiravo in virtù della resistenza
valorosa che avevano opposto alle mie legioni. - La morte è
arrivata per voi - dissi. - Addio, cari nemici. Foste coraggiosi
nel combattere e ancor più coraggiosi nel morire, e il
Fuhrer Bandini non lo ha dimenticato. Apertamente egli tesse
il vostro encomio, pur nella morte -. Ad altri dissi: - Addio,
codardi. Sputo su voi, disgustato. La vostra codardia ripugna
al Fuhrer. Odiosa gli è la codardia quanto gli è
odioso un morbo. Non vi perdonerà. Possano le maree mondare
la terra dal crimine della vostra codardia, canaglie -.
Mi riarrampicai verso la strada proprio mentre incominciavano
a farsi sentire le sirene delle sei, e mi avviai verso casa.
In uno spiazzo più avanti c'erano dei ragazzi che giocavano
a palla, e diedi loro fucile e munizioni in cambio di un coltello
da tasca che uno di loro dichiarò valere almeno tre dollari,
ma non mi faceva fesso, perché sapevo che quel coltello
non costava più di cinquanta centesimi. Tuttavia volevo
sbarazzarmi del fucile, così conclusi l'affare. I ragazzi
pensarono che fossi un fesso, e glielo lasciai pensare.
***
Mattina, è ora di alzarsi, e allora alzati, Arturo, va'
a cercarti un lavoro. Va' là fuori a cercare ciò
che non troverai mai. Sei un ladro, un killer di granchi, un
donnaiolo da stanzino dei vestiti. Tu non lo troverai mai, un
lavoro.
Ogni mattina mi alzavo con questo stato d'animo. Ora devo trovarmi
un lavoro, mannaggia l' inferno. Facevo colazione, mi mettevo
un libro sottobraccio e le matite in tasca e mi avviavo. Giù
per le scale, in strada, a volte c'era freddo a volte caldo,
a volte c'era nebbia a volte era sereno. Non aveva mai molta
importanza, con un libro sottobraccio, andare in cerca d'un
lavoro.
Che lavoro, Arturo? Oh oh! Un lavoro per te? Ma ti sei guardato,
ragazzo? Un killer di granchi. Un ladro. Che guarda le donne
nude nello stanzino dei vestiti. E tu ti aspetti di trovare
un lavoro! Che ridere! Eccolo qua, l'idiota col suo grosso libro.
Dove diavolo stai andando, Arturo? Perché fai questa
strada e non quell'altra? Perché a est e non invece a
ovest? Rispondimi, ladro! Chi vuoi che te lo dia un lavoro,
porco che sei, chi? Ma c'è un parco dall'altra parte
delta città, Arturo. Si chiama Banning Park. E’
pieno di magnifici eucalipti e di prati verdi. Un gran posto
per leggere! Vacci, Arturo. Leggi Nietzsche. Leggi Schopenhauer.
Stattene in compagnia dei potenti. Un lavoro? Puah? Vatti a
sedere sotto un eucalipto a leggere un libro cercando un lavoro.
Eppure qualche volta lo cercavo, un lavoro.
***
Sveglio
o addormentato, che importava? La odiavo, la fabbrica, e puzzavo
sempre come una sporta piena di pesce.
Non mi lasciava mai, quel tanfo di cavallo morto sul ciglio
della strada. Mi inseguiva per via. Entrava con me nei palazzi.
Quando la sera m'infilavo nel letto, eccolo ancora lì,
come una coperta che tutto mi avvolgeva. Nei miei sogni, poi,
c'era pesce, pesce e ancora pesce, sgombri che guizzavano qui
e là dentro una pozza nera, e io legato a una trave che
veniva calata in quella pozza. Il tanfo era nel mio cibo e nei
miei abiti, me lo sentivo perfino sullo spazzolino da denti.
A Mona e a mia madre capitava uguale. Alla fine era diventato
così nauseabondo che quel venerdì mangiammo carne
per cena. Mia madre non sopportava l'idea del pesce, anche se
era peccato non mangiare pesce.
Fin da ragazzo mi era ripugnato anche il sapone. Non avrei mai
creduto che mi sarei abituato a quella roba viscida e untuosa
e al suo odore molliccio da effeminati. Adesso però lo
usavo contro il tanfo di pesce. Facevo più bagni che
mai. Un sabato feci due bagni, uno dopo il lavoro, e un altro
prima di andare a letto. Ogni sera rimanevo nella vasca a leggere
libri finché l'acqua diventava fredda e sembrava risciacquatura.
Strofinavo il sapone sulla pelle finché non luccicava
come una mela. Ma non aveva senso: era una pura perdita di tempo.
L’unica maniera per sbarazzarsi di quell'odore era: piantare
la fabbrica. Quando uscivo dalla vasca puzzavo sempre di due
odori mischiati: sapone e pesce morto.
Tutti capivano chi ero e che cosa facevo quando mi sentivano
arrivare. Essere uno scrittore non bastava a consolarmi. Sull'autobus
ero riconosciuto all'istante, a teatro lo stesso. E’ uno
di quei ragazzi del conservificio. Dio buono, sentite che odore?
|
|
![]()
![]()