| |
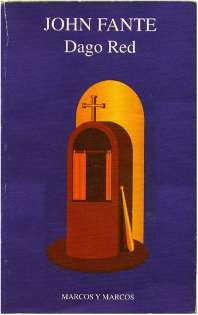
Dago Red, cioè il vino rosso degli
immigrati d'origine italiana, perchè Dago era uno dei
molti modi in cui, con un certo disprezzo, si potevano chiamare
gli italiani d'America.
Dago Red è la raccolta dei primi racconti di John Fante,
per cui questo splendido libro è una specie di incunabolo,
il preannuncio di tutta una carriera letteraria, il primo seme
di una lussureggiante fioritura romanzesca. Il padre burbero
muratore spesso senza lavoro, la madre apprensiva, la sorella
bigotta, i riti cattolici, le continue frizioni interrazziali,
l'adorato baseball, le donne sognate, amate e perdute, e la
morte: come l'esposizione al rallentatore di tutti i temi che
saranno sviluppati poi nei romanzi migliori...
***
L’Odissea
di un wop
I
Sto mettendo insieme pezzi di storie sul conto
di mio nonno. E’ la nonna a parlarmene. Quand'era vivo,
mi dice, era un brav'uomo, la cui bontà suscitava più
pietà che ammirazione. Era noto come "il bravo piccolo
Wop". Se c'era da passare una serata, gli piaceva di starsene
seduto al tavolo di un saloon a sorseggiare un bicchierino di
anisetta, tutto solo. Se ne stava là come una ragazzina
intenta a ciucciare un cono gelato. Gli piaceva, al vecchio,
quella roba verde, quell'anisetta; era la sua passione, e quando
i compari lo vedevano là seduto per conto suo, la cosa
li metteva di buonumore, perché lui era un bravo piccolo
Wop.
Dunque una sera, dice la nonna, il nonno se ne stava al suo
tavolo al saloon, lui e la sua anisetta. Si aprono i battenti
della porta a vento e irrompe un camionista sbronzo che si aggrappa
al bancone e bercia:
- Forza, tutti qui! Avanti, offro io! -
Mio nonno è rimasto seduto, immobile, con quella sua
vecchia lingua che faceva l'amore con l'anisetta. Tutti gli
altri si sono avviati al banco per brindare col camionista.
Quello si guarda attorno. Vede mio nonno. Lo insulta.
- Anche te, Wop! - dice. - Vieni a bere! -
Silenzio. Si alza il nonno. Caracolla sul piancito, oltrepassa
il camionista e poi che ti fa? Varca la porta a vento e se ne
esce sulla strada piena di neve. Alle sue spalle scoppiano le
risate. E questo gli brucia. Ma se ne va a casa, da mio padre.
- Mamma mia! - balbetta -Tummy Murray, m'ha
ditto Wop. A me! -
- Sangue della Madonna! -
A capo scoperto, mio padre si precipita in strada, e poi dritto
al saloon. Tommy Murray non c'era più, era andato a un
altro saloon mezzo isolato più avanti, ed è lì
che mio padre lo ha beccato. L'ha tirato da un lato e gliene
ha dette un paio in faccia. Mazzate! In un momento, capelli
strappati, sangue che schizza. Sedie rovesciate. Applausi dalla
clientela. Se le sono date per un'ora intera. Rotolando sul
pavimento, pigliandosi a calci, bestemmiando, morsicandosi.
Due corpi avvinghiati in mezzo al pavimento: un viluppo umano.
A un certo punto la testa, il petto e le braccia di mio padre
seppelliscono la faccia del camionista. Quello urla. Mio padre
ringhia. Aveva il collo irrigidito, e tremava. Il camionista
urla di nuovo, e poi resta lì, fermo. Si alza mio padre,
asciugandosi col dorso di una mano il sangue che gli era rimasto
sulla bocca aperta. A terra giace il camionista, con un orecchio
mezzo staccato dalla testa... Questa è la storia che
mi racconta mia nonna.
Penso a quei due, mio padre e il camionista; me li figuro mentre
lottano per terra. Accidenti! Mio padre che fa a botte!
Mi viene un'idea. I miei due fratelli stanno giocando nell'altra
stanza. Pianto la nonna e vado da loro. Stravaccati sul tappeto,
trafficano coi loro pastelli e i fogli da disegno. Alzano gli
occhi e vedono la mia faccia su cui brilla quell'idea.
- Qualcosa che non va? - domanda uno.
- Vi sfido a fare una cosa -.
- Che cosa? -
Vi sfido a chiamarmi Wop! -
Il mio fratello più piccolo, che non ha neanche sei anni,
salta in piedi e, ballandomi attorno, grida: - Wop! Wop! Wop!
Wop! -
Lo guardo. Puah! Troppo piccolo. E’ l'altro, è
il mio fratello più grande quello che voglio. Ha anche
le orecchie, oh se ce l' ha!
- Scommetto che hai paura di chiamarmi Wop -. Lui però
ha già sentito puzza di bruciato.
- Ma va là - dice. - Non voglio - .
-Wop! Wop! Wop! Wop! - grida il piccolo. - Chiudi quella bocca,
te! -
- Non ci penso nemmeno. Sei un Wop! Wop! Wop! Woppety Wop! -
La scatola di pastelli del mio fratello più grande è
lì per terra, giusto davanti al suo naso. Ci metto sopra
il tacco e la stritolo. Lui urla, afferrandomi la gamba. Io
mi divincolo, e lui attacca a piangere.
- Uh, me l'hai fatta sporca - dice.
- Ti sfido a chiamarmi Wop! -
- Wop! -
Vado alla carica, a caccia del suo orecchio. Ma entra la nonna,
agitando la coramella del rasoio.
II
Fin dall'inizio ho sentito mia madre usare
le parole "Wop" e "Dago" in un tono che
denota un profondo disgusto. E’ come se le sputasse fuori.
Come se le si slanciassero dalle labbra. Per lei, contengono
l'essenza stessa della povertà, dello squallore, della
sporcizia. Se non mi lavo i denti, se non mi scappello quando
è il caso, mia madre dice: - Non fare così. Non
fare il Wop -. Così, man mano che i suoi valori diventano
i miei, Wop e Dago sono sempre più sinonimi del male.
Ma lei, almeno, è coerente.
Mio padre no. Ha la lingua sciolta, lui. Come gli gira, così
la pensa. Capisco che per lui "Wop" e "Dago"
non hanno un significato preciso; tuttavia, se è un non
italiano a sbatterglieli in faccia, le cose cambiano: è
un insulto grave.
Cristoforo Colombo, dice mio padre, è il più grande
Wop che ci sia mai stato. E così Caruso. E così
questo e quello. Ma il suo carissimo amico Peter Ladonna non
è soltanto un porco ubriacone, per giunta di rotolo è
proprio un Wop; e naturalmente tutti i suoi cognati non sono
altro che dei Wop buoni a nulla.
Fa finta di odiare gli irlandesi. Non è vero, ma gli
piace pensarlo, e a noi bambini ci aizza sempre contro di loro.
Il nostro droghiere si chiama O'Neil. Spesso, senza accorgersene,
sbaglia i conti quando mia madre va alla sua bottega. Poi lei
racconta a mio padre che le ha pesato male la carne o le ha
dato un uovo marcio.
Subito mio padre si innervosisce, e il labbro inferiore gli
si increspa. - Questa è l'ultima volta che quel puzzone
d'un irlandese mi frega! - Poi esce, e a passi pesanti si avvia
alla bottega.
Poco dopo ritorna. Sorride. In un pugno stringe una manciata
di sigari. - D'ora in poi - dice - tutto a posto -.
A me non piace, il droghiere. Mia madre mi manda alla sua bottega
ogni giorno, e lui subito mi spezza il respiro con quel suo
saluto: - Salve, piccolo Dago! Che ti serve? - Lo detesto; non
entro mai nella sua bottega se in giro c'è qualche altro
cliente, perché esser chiamato Dago davanti agli altri
è un'umiliazione spaventosa, quasi fisica. Lo stomaco
mi si dilata e si contrae, ed è come sentirsi nudi.
Quando il droghiere mi da le spalle, rubo senza pudore. Mi fa
piacere derubarlo: di caramelle, dolci, frutta. Quando deve
andare nella cella frigorifera, mi sporgo sulla bilancia della
carne sperando di sgraffignargli una costoletta; oppure con
la punta del piede gli schiaccio un cesto di uova. Certe volte
rubacchio un po' troppo. E che piacere, allora, starsene lì
sul marciapiede, bello satollo, a buttar via le sue caramelle,
i suoi dolci, le sue mele nell'erbaccia gialla e incolta dall'altra
parte della strada!...
- Maledizione, O'Neil, non è che puoi chiamarmi Dago
e passarla liscia!-
Sua figlia ha la mia età. E’ strabica. Due volte
a settimana passa davanti a casa nostra per andare alla lezione
di musica. Dall'alto, tra i rami di un olmo, la osservo avanzare
lungo il marciapiede, dondolando la custodia del violino. E
quando ce l'ho sotto di me, le canto una bella filastrocca:
Marta è strabicaaaaaa! Marta è
strabicaaaaaa! Marta è strabicaaaaaa!
III
Crescendo, mi rendo conto che gli italiani
usano le parole Wop e Dago assai più spesso degli americani.
Mia nonna, il cui vocabolario inglese è ristretto ai
sostantivi più comuni, le adopera sempre quando si trova
a discutere di italiani contemporanei. Quelle parole non vengono
mai fuori serenamente, discretamente. Piuttosto irrompono. C'è
questa intonazione sfacciata, e poi è come se qualcuno
venisse tramortito, stroncato.
Fin dal primo giorno, alla scuola parrocchiale, ho il tremendo
timore di essere chiamato Wop. Non appena scopro per quale motivo
la gente usa cose come i cognomi, raffronto il mio con altri
tipici cognomi italiani come Blanchi, Borello, Pacelli, nomi
di altri studenti. Il paragone mi dà un piacevole senso
di sollievo. Dopotutto, penso, la gente dirà che sono
francese. Forse che il mio nome non ha un suono francese? Certo!
E da allora in poi, quando mi domandano di che nazionalità
sono, gli dico che sono francese. Qualche ragazzo comincia a
chiamarmi Frenchy. Mi piace. E’ bello.
Insomma prendo a detestare le mie origini. Evito i ragazzi e
le ragazze italiane dai modi amichevoli. Ringrazio Dio per la
mia pelle chiara e per i capelli, e i miei compagni me li scelgo
in base al suono anglosassone dei loro nomi. Se un ragazzo si
chiama Whitney, Brown, oppure Smythe, allora è amico
mio; però sto sempre un poco in apprensione quando sono
con loro; potrebbero scoprirmi. A ora di pranzo mi raggomitolo
sulla mia gamella, perché mia madre non è il tipo
che mi dà panini avvolti in carta incerata, li fa anzi
troppo grossi, con le foglie di lattuga che vengono fuori. Per
di più, e pane fatto in casa, non di panetteria, non
pane "americano". Mi lamento assai perché non
posso avere maionese e altre cose "americane".
Il parroco è un buon amico di mio padre. Gironzola per
i campi di gioco della scuola, dà un'occhiata ai bambini
che giocano. Mi da una voce, mi domanda che fa mio padre, poi
mi dice che dovrei essere orgoglioso di studiare i miei grandi
compatrioti. Colombo, Vespucci, Giovanni Caboto. Parla a voce
alta, allegramente. Gli altri studenti fanno capannello intorno
a noi, ascoltano, e io mi mordo le labbra e prego Gesù
che la smetta e se ne vada.
Capita poi che senta parlare di un tizio chiamato Dante. Ma
quando scopro che era italiano mi viene da odiarlo, come se
fosse vivo, come se stesse passeggiando tra le aule e puntasse
il dito verso di me. Un giorno trovo il suo ritratto in un dizionario.
Lo guardo e mi dico che non ho mai veduto un bastardo più
brutto.
Un giorno, siamo un po' di studenti alla lavagna, e al mio fianco
c'è una ragazza italiana dagli occhi dolci, una che odio
ma che insiste nel dire che sono il suo moroso. Mi tira per
una manica, si struscia, un po' impacciata, un po' in punta
di piedi, mi fa dei sorrisetti strani. Io ghigno e le volto
le spalle, poi mi allontano da lei più che posso. La
suora nota l'ampio spazio che ci separa e mi dice di mettermi
più vicino alla ragazza. Lo faccio, e quella si scosta,
avvicinandosi alto studente che sta dall'altra parte.
Allora mi guardo i piedi ed ecco, c'è una macchia umida
che si allarga. Do una rapida occhiata alla ragazza, e quella,
col capo ciondoloni, mi sta guardando come se volesse chiedermi
di farmi carico della sua colpa. Attiriamo l'attenzione dagli
altri, e presto tutta la classe comincia a ridacchiare. Arriva
la suora. Penso di essere di nuovo nei guai, ma quella mi abbraccia
e mormora che avrei dovuto farle segno con due dita e certamente
mi avrebbe dato il permesso di uscire. Però, dice, ormai
non ce n'è più bisogno; non mi resta che andare
a darmi una ripulita. E’ quello che faccio, in preda a
un'isteria che mi rafforza nella convinzione che solamente una
ragazza Wop, solamente una venuta fuori da una famiglia di Wop,
avrebbe potuto fare una cosa come questa.
Oh, Wop! Oh, Dago! Mi date fastidio pure quando dormo. Sogno
di difendermi dal miei tormentatori. E’ un giorno vengo
a sapere da mia madre che da giovane papà se n'era andato
in Argentina e per due anni aveva vissuto a Buenos Aires. Mia
madre mi racconta di quello che gli era capitato laggiù,
e io per tutto il giorno non riesco a pensare ad altro, anche
quando è ora di andare a letto. Quella notte mi risveglio
con un sobbalzo. Nel buio, brancolo verso la camera di mia madre.
Al suo fianco dorme mio padre, e io la sveglio piano, in modo
che lui non si desti.
Sussurro: - Sei sicura che papà non è nato in
Argentina? -
- No. Tuo padre è nato in Italia -.
Torno a letto, sconsolato, disgustato.
IV
Durante una partita di baseball sul campetto
della scuola, un ragazzo della squadra avversaria si mette a
prendere in giro il mio modo di giocare. Siamo al nono inning,
e io mostro di ignorare le sue battute. Stiamo perdendo, però,
se mi riesce di mettere a segno un solo colpo, le nostre possibilità
di vittoria sono piuttosto buone. Sono deciso a farcela, e affronto
il battitore con sicurezza. Il mio tormentatore vede che sono
al piatto.
- Oh oh! - grida. - Guarda chi c'è!
C'è il Wop. Facciamolo fuori, quel Wop! -
Questa è la prima volta che a scuola qualcuno si permette
di far volare quella parolina; sono così arrabbiato che
sbaglio il lancio come un fesso. Dopo la partita ci picchiamo,
quel ragazzo e io, e lo costringo a rimangiarsi tutto.
Ed e così che i giorni di scuola sono diventati giorni
di risse. Quasi ogni pomeriggio alle tre e un quarto si raduna
una folla per vedere come faccio rimangiare tutto a qualcuno.
C'è da divertirsi: eccomi qua, sto arrivando, dunque
fatevi avanti, vi sfido a chiamarmi Wop! Alla fine, quando non
c’è più nessun ragazzo che osa sfidarmi,
gli insulti mi vengono riportati da confidenti, così
mi tocca di cercare i colpevoli. Incedo nei corridoi. I ragazzi
più piccoli mi ammirano. - Eccolo! - dicono, e restano
lì a contemplarmi. I miei due fratelli minori frequentano
la stessa scuola, e il più piccolo, una canaglietta di
sette anni, mi porta i suoi amici e mi chiede di tirarmi su
la manica e mostrar loro i muscoli. Bene ragazzi: guardate.
Mio fratello, a casa, fa resoconti furiosi delle mie battaglie.
Mio padre ascolta avidamente, e io sto lì in piedi, pronto
a correggere ogni dettaglio impreciso. Giorni tristemente felici!
Mio padre mi istruisce: così devo tener la guardia, così
devo proteggermi il capo. Mia madre, troppo impressionata per
sentirne di più, si preme le tempie, strizza gli occhi,
se ne va.
Sono nervoso quando porto a casa qualche amico: quel posto ha
un'aria troppo italiana. Qua c’è appeso un ritratto
di Vittorio Emanuele, e più sopra c’è una
foto del Duomo di Milano, e vicino ce n'è una di San
Pietro, poi sulla credenza c’è una caraffa di foggia
medievale, piena sempre fino all'orlo di un vino rosso rubino.
Tutte queste cose sono cimeli di famiglia di mio padre e, chiunque
venga a casa nostra, a lui piace piazzarsi là sotto e
vantarsi.
Così, comincio a rinfacciarglielo. Gli dico di smetterla
di fare il Wop e di diventare americano una buona volta. E lui
subito prende la coramella del rasoio e me le suona di santa
ragione, incalzandomi di stanza in stanza fino a fuori. Mi rifugio
nel ripostiglio e mi tiro giù i pantaloni e tendo il
collo per controllare i lividi sul sedere. Un Wop, ecco che
cos'è mio padre! Non esiste un solo padre americano che
picchi suo figlio in questo modo. Bè, per questa strada
non andrà molto lontano; un giorno o l'altro gliela faccio
pagare.
Poi penso che mia nonna è una Wop senza speranza. E’
una piccola contadina tracagnotta che va in giro con le braccia
incrociate sulla pancia, una vecchia sempliciotta appassionata
di bambini. Entra in camera mia e cerca di parlare coi miei
amici. Parla inglese con un pessimo accento, con questo incessante
rotolio di vocali. Quando, con quel suo fare semplice, con quei
vecchi occhi sorridenti, si mette davanti a uno dei miei amici
e dice: - Ti piace a te di andare alla scola delle monache?
- , il cuore ml si ribella. Mannaggia! Che disgrazia: ormai
lo sanno tutti, che sono italiano.
Mia nonna mi ha insegnato a parlare la sua madrelingua. Verso
i sette anni, la conosco abbastanza bene, e con lei la parlo
sempre. Però, sui dodici-tredici anni, quando ci sono
i miei amici, fingo di non capire quello che dice, e faccio
dei sorrisi affettati. I miei amici non si arrischiano a pensare
che possa parlare altra lingua al di fuori dell'inglese. Certe
volte, questo atteggiamento la manda in bestia. Si irrigidisce,
le si tende la cute della gola, e allora bestemmia, bestemmia
poderosamente.
[...]
***
Rapimento
in famiglia
C'era un vecchio baule nella camera da letto di mamma.
Era il più vecchio baule che avessi mai visto, uno di
quelli col coperchio arrotondato, come la pancia di un ciccione.
Ficcata dentro questo baule, sotto la biancheria del corredo
che non si usava mai appunto perché era il corredo; sotto
l'argenteria che non si usava mai perché era un regalo
di nozze; e sotto ogni sorta di nastri fantasia, bottoni, certificati
di nascita; sotto tutto questo c'era una scatola con le foto
di famiglia. Mamma non permetteva a nessuno di aprire il baule,
e teneva nascosta la chiave. Ma un giorno io la trovai. La trovai
nascosta sotto lo zerbino.
Quell'anno, nei pomeriggi di primavera, tornavo a casa da scuola
e trovavo mamma che sfaccendava in cucina. Lavorava così
tanto che aveva le braccia molli, bianche come argilla disseccata,
i capelli secchi e sottili incollati alla testa e gli occhi
scavati, grandi e tristi.
La foto! pensavo. Oh, quella foto nel baule!
Quando mia madre non guardava, me la svignavo in camera da letto,
chiudevo a chiave e aprivo il baule. C'erano molte foto là
dentro, e mi piacevano tutte, ma ce n'era una sola che le mie
dita bramavano stringere e i miei occhi non vedevano l'ora di
ammirare ogni volta che trovavo mamma conciata in quel modo.
Quella foto le era stata scattata una settimana prima di sposare
mio padre.[...]
|
|
![]()
![]()