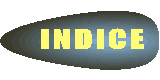IL TEMPO
La misura del tempo - Gli orologi
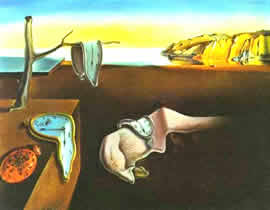 L'unità
di misura più immediata per misurare gli intervalli di tempo è
probabilmente il giorno, inteso come il periodo di tempo compreso fra
due albe o due tramonti consecutivi. Per le normali attività quotidiane
è però spesso necessario misurare
un intervallo di tempo molto minore del giorno. Per questo
motivo nacque ben presto la necessità di avere strumenti che misurassero
brevi intervalli di tempo con buona precisione. Per molti secoli gli unici
strumenti per misurare il tempo restarono le meridiane e le clessidre,
orologi noti fin dalla più remota antichità.
L'unità
di misura più immediata per misurare gli intervalli di tempo è
probabilmente il giorno, inteso come il periodo di tempo compreso fra
due albe o due tramonti consecutivi. Per le normali attività quotidiane
è però spesso necessario misurare
un intervallo di tempo molto minore del giorno. Per questo
motivo nacque ben presto la necessità di avere strumenti che misurassero
brevi intervalli di tempo con buona precisione. Per molti secoli gli unici
strumenti per misurare il tempo restarono le meridiane e le clessidre,
orologi noti fin dalla più remota antichità.
Lo gnomone e la meridiana
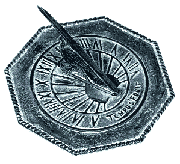 Lo
gnomone è probabilmente il
più antico strumento di misura del tempo inventato dall'uomo. Esso
è un bastone che proietta sul suolo l'ombra del Sole. Al cambiare
delle ore e dunque della posizione del Sole nel cielo cambia di conseguenza
la direzione dell'ombra; osservando tale direzione è possibile
conoscere l'ora. Lo gnomone fu inventato dai Sumeri; in Europa esso fu
introdotto dal filosofo Anassimandro intorno al 600 a.C.
Lo
gnomone è probabilmente il
più antico strumento di misura del tempo inventato dall'uomo. Esso
è un bastone che proietta sul suolo l'ombra del Sole. Al cambiare
delle ore e dunque della posizione del Sole nel cielo cambia di conseguenza
la direzione dell'ombra; osservando tale direzione è possibile
conoscere l'ora. Lo gnomone fu inventato dai Sumeri; in Europa esso fu
introdotto dal filosofo Anassimandro intorno al 600 a.C.
[clicca
qua se vuoi conoscere la storia di Anassimandro e lo gnomone.]
La meridiana è
formata poggiando lo gnomone su di un piedistallo dove sono state poste
delle tacche. Osservando la posizione dell'ombra del Sole rispetto alle
tacche è possibile sapere con buona approssimazione l'ora del giorno.
[Se vuoi sapere di più sul funzionamento della meridiana e dello
gnomone, leggi
cosa scrive il Professore.]
Alcuni allievi hanno fotografato dele belle meridiane! Clicca qua per vedere le loro foto.
La clessidra
L'orologio solare funziona solo di giorno e solo
se il cielo è sereno. Per segnare il tempo di notte o quando
il cielo è nuvoloso andrebbe bene la  clessidra,
parola di origine greca che significa "ladra d'acqua". Si
tratta di uno strumento molto semplice che misura il passare del tempo
facendo sgocciolare dell'acqua attraverso un foro, da un contenitore
ad un altro. Attraverso il lento svuotamento (o riempimento) di un recipiente
(che presentava eventualmente incise all'interno delle tacche di riferimento),
le clessidre mostravano con chiarezza gli “intervalli di tempo”, ossia
misuravano la durata di un determinato evento o fenomeno.
clessidra,
parola di origine greca che significa "ladra d'acqua". Si
tratta di uno strumento molto semplice che misura il passare del tempo
facendo sgocciolare dell'acqua attraverso un foro, da un contenitore
ad un altro. Attraverso il lento svuotamento (o riempimento) di un recipiente
(che presentava eventualmente incise all'interno delle tacche di riferimento),
le clessidre mostravano con chiarezza gli “intervalli di tempo”, ossia
misuravano la durata di un determinato evento o fenomeno.
Nel 1300 furono inventate le prime clessidre a sabbia di cui vennero costruiti diversi modelli in grado di misurare intervalli di tempo variabili da pochi secondi a ventiquattro ore.
Svariati furono anche gli utilizzi di tali orologi. Essi erano usati sulle navi dove non si potevano imbarcare orologi di altro tipo, nei tribunali per misurare il tempo da concedere agli avvocati per la difesa dei loro assistiti, nelle officine e, fino al 1800, per sentire il polso dei malati.
I primi orologi meccanici
Bisognerà aspettare fino alla fine del XIII secolo per vedere la nascita di un nuovo tipo di orologio, il cosiddetto orologio meccanico, un marchingegno piuttosto complicato e ingombrante che implicava il lavoro sincrono (cioè contemporaneo) di molti elementi. A muovere il tutto provvedeva un peso legato ad una corda avvolta intorno ad un asse orizzontale, o "tamburo". Via via che il peso si portava verso il basso la corda costringeva l'asse a girare su se stesso. Quest’asse rotante, a sua volta, metteva in azione una serie di ingranaggi i quali erano collegati ad una lancetta che indicava le ore o a dei campanelli che suonavano ad intervalli di tempo regolari. Naturalmente quando la corda si era completamente srotolata dal tamburo, bisognava riavvolgerla: più che di un orologio si trattava quindi di una specie di argano.
Il pendolo
Nel 1581, all'età di soli 17 anni, Galileo
Galilei scoprì che l'oscillazione di un pendolo avviene
ad intervalli regolari di tempo, e ciò indipendentemente dalla
massa usata e dall'ampiezza dell'oscillazione stessa. In altre parole,
il tempo impiegato dal pendolo per andare e tornare in un viaggio di
oscillazione 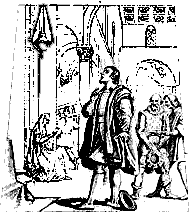 completa
è sempre lo stesso, tanto per l’oscillazione molto ampia quanto
per quella poco ampia qualunque sia la massa del corpo che oscilla (quest'effetto
si chiama isocronismo del pendolo,
cioè pendolo che oscilla con uguale tempo).
completa
è sempre lo stesso, tanto per l’oscillazione molto ampia quanto
per quella poco ampia qualunque sia la massa del corpo che oscilla (quest'effetto
si chiama isocronismo del pendolo,
cioè pendolo che oscilla con uguale tempo).
La storia vuole che lo scienziato pisano arrivasse a questa scoperta osservando una lampada oscillare, sotto la spinta di una corrente d'aria, nella cattedrale della sua città, mentre assisteva ad una funzione religiosa. Si dice anche che per controllare l'isocronismo delle oscillazioni della lampada il giovane Galilei, a quel tempo studente di medicina, si sia avvalso delle pulsazioni del proprio polso.
L'isocronismo del pendolo non è affatto ovvio perché l'intuizione ci porterebbe a credere che le oscillazioni ampie debbano durare di più di quelle strette, invece Galilei notò che quando l'ampiezza era grande il moto era veloce, mentre quando era piccola il moto era lento e quindi il tempo per completare l’oscillazione in definitiva era lo stesso (Oggi sappiamo che non è esattamente così, ma la differenza è veramente minima e per molti aspetti insignificante).
Un orologio scientifico: l'orologio a pendolo
 L'isocronismo
del pendolo fu sfruttato dal grande astronomo e fisico Christian
Huygens che costruì il primo orologio a pendolo intorno
alla metà del XVII secolo, pochi anni dopo la morte di Galilei.
L'orologio a pendolo divenne ben presto il principale strumento per
misurare il tempo; esso venne sempre più perfezionato utilizzando
leghe d'acciaio indeformabili e sistemandolo all'interno di un ambiente
in cui veniva creato il vuoto per proteggerlo da variazioni di temperatura,
dalla polvere e dall'attrito dell'aria. L'orologio a pendolo diventava,
in questo modo, uno strumento di grande precisione, adatto
a misurazioni scientifiche.
L'isocronismo
del pendolo fu sfruttato dal grande astronomo e fisico Christian
Huygens che costruì il primo orologio a pendolo intorno
alla metà del XVII secolo, pochi anni dopo la morte di Galilei.
L'orologio a pendolo divenne ben presto il principale strumento per
misurare il tempo; esso venne sempre più perfezionato utilizzando
leghe d'acciaio indeformabili e sistemandolo all'interno di un ambiente
in cui veniva creato il vuoto per proteggerlo da variazioni di temperatura,
dalla polvere e dall'attrito dell'aria. L'orologio a pendolo diventava,
in questo modo, uno strumento di grande precisione, adatto
a misurazioni scientifiche.
L'orologio al quarzo
 L'innovazione
successiva si avrà nel 1927 a causa di due tecnici inglesi di nome
W. A. Marrison e J.
Hortonon che inventarono i cosiddetti orologi
a quarzo. Essi sfruttano una particolare proprietà di
questi minerali. In breve un orologio a quarzo permette il passaggio di
impulsi elettrici ad intervalli di tempo ben definiti (circa 50.000 impulsi
al secondo - il numero esatto cambia da orologio ad orologio). Contando
il numero di impulsi trasmessi è possibile conoscere quanto tempo
è passato.
L'innovazione
successiva si avrà nel 1927 a causa di due tecnici inglesi di nome
W. A. Marrison e J.
Hortonon che inventarono i cosiddetti orologi
a quarzo. Essi sfruttano una particolare proprietà di
questi minerali. In breve un orologio a quarzo permette il passaggio di
impulsi elettrici ad intervalli di tempo ben definiti (circa 50.000 impulsi
al secondo - il numero esatto cambia da orologio ad orologio). Contando
il numero di impulsi trasmessi è possibile conoscere quanto tempo
è passato.
[Non hai capito bene questo concetto? Fai
un semplice esercizio per comprenderlo!]
L'orologio al Cesio
Attualmente, l'orologio forse più preciso
è quello al Cesio, inventato nel 1955 dal professore Louis Essen.
Su tale orologio è basata l'attuale
definizione del secondo.
[per maggiori informazioni sull'orolgio al Cesio, clicca
qua]
(Pagina presa ed adattata dalla pagina Web "Cose di Scienza", a cura di Antonio Vecchio)
|
Se volete altre informazioni su cosa
è il Tempo, |
||||
| Il Tempo: cosa è? | ||||
| L'orologio più antico del mondo: il Sole e le stelle! | ||||
| Archeoastronomia e il Tempo nell'antichità | ||||
| Il Tempo e le sue Unità di Misura | ||||
|
|
|