La guerra è pace?
«La parola “ocolingo” (duckspeak) - scriveva con ragione Orwell nel 1948 - esprime il limite estremo a cui si vuol far giungere il processo di riduzione linguistica: “ocolingo” è chi può “articolare il discorso nella laringe stessa, senza chiamare in causa i centri del cervello” (parlare con lo stesso meccanismo con cui l’oca emette i propri versi)» (George Orwell, “1984”, Milano, Mondadori,1967, p. 324).
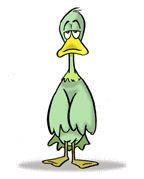 Oggi
parlare in “ocolingo” è normale ed è addirittura considerato una forma di
terapia per curare persone portatrici di handicap.
Oggi
parlare in “ocolingo” è normale ed è addirittura considerato una forma di
terapia per curare persone portatrici di handicap.
In diversi libri che descrivono metodi per la formazione di operatori socio assistenziali usati nelle strutture sanitarie pubbliche si sostiene mediante appunto “ocolingo”, cioè manipolazione linguistica, qualsiasi cosa, come ad esempio che “l’aggredire” comporta “il gradire” e che quindi, in definitiva, il male è bene, dato che l’aggressione sarebbe gradevole!
Questa etimologia è errata eppure la si insegna per curare l’handicap. Si insegna cioè l’aggressività come cosa buona e piacevole. Ecco perché dico che l’ocolingo porta alla guerra!
Questo neolinguaggio inventa un latino maccheronico, “ad-gradere”, per connetterlo fonicamente all’“aggradire” o all’“aggradare” nel senso di “avere come cosa gradita” o di “accettare con piacere”, dandosi così una parvenza culturale. Ma la forma “ad-gradere” NON esiste in latino. Esiste tutt’al più “gràdere” come seconda persona singolare dell’imperativo presente del verbo “gradi” (da “gradior”), che significa “camminare”, “avanzare”, “procedere”, “andare”.
Lo stesso vale per “aggredi” (infinito di “aggredior”), che significa in ordine di importanza: “avvicinarsi, accostarsi”,“ avvicinare qualcuno per parlargli”, “accingersi a, cominciare”, “aggredire, assalire”, “accattivarsi, corrompere”, ed il cui imperativo presente (2ª persona singolare) è “aggrédere”.
L’etimologia dell’italiano “aggredire” si compone della particella “ad” e di “gradi” (da “gradior” e da “gradus”, che significa “passo”), indicanti, appunto, l’andare verso qualcuno per assalirlo, non certo per fargli “gradire” qualcosa. Per esempio “graditur ad bellum” significava “egli va alla guerra”, non significava “egli gradisce la guerra”; ed ancora: “fidenti animo gradietur ad mortem” significava “con animo imperturbabile egli andrà incontro alla morte”, non significava “con animo imperturbabile egli gradirà la morte”!
Dunque l’imperativo latino “gràdere” (e non “ad-gradere”) significava “Va’!” e non “Va’ verso il piacere o il gradimento di qualcosa”. Per dire “ricevere grandi onori”, i latini dicevano casomai “aggredi magnos honores”.
Sostituire “aggredi” (di “aggredere”, forma secondaria attiva del verbo “aggredior”) con l’inesistente “ad-gradere” è un errore gravissimo, cioè quello di usare la deficiente conoscenza del verbo “aggredior”, per “formare” con essa la convinzione negli operatori o nei lettori che la parola aggressione comporti “gradimento”…
Abbiamo anche qui dunque a che fare con lo lo stile “ocolingo”, che induce il lettore a cogliere l’assonanza con l’italiano “gradire”, facendo dell’inesistente “ad-gradere” un latinorum con qualità di latino reale, confondendo così il bene col male. Infatti essere aggressivi non potrà mai essere qualcosa di piacevole, così come la guerra non potrà mai essere la pace!
.jpg)
Ecco perché ipotizzare un “piacere dell’aggressività”, come si fa in questi testi di Stato, mi sembra qualcosa di demenziale.
È ovvio che nell’“aggradire”, cioè nel piacere di accogliere una cosa gradevole, si tratti di un grado buono, e ciò è testimoniato anche da espressioni come “a buon grado”, “di buon grado”, ecc. Ma nell’“aggressione” non si può e non si potrà mai parlare di bontà o di piacere, a meno che non si opti per il piacere del male, perché il piacere dell’aggressività può trovarsi solo in una mente molto bacata.
Insomma, per aggressività si è sempre inteso una forza avente fini tutt’altro che piacevoli o gradevoli. Oggi invece abbiamo “formatori” talmente ignoranti da insegnare il piacere dell’aggressività. La cosa è tragica o… comica, o tragicomica. Insomma, delle due l’una: in questo stile “ocolingo” c’è malattia mentale oppure iniquità essenziale.
Oggi così va il mondo della cultura di Stato. Perché è lo Stato a pagare fior di quattrini questa formazione affinché si insegni l’etimologia, la linguistica, il latinorum e molte altre baggianate sulle terapie per i portatori di handicap.
Oggi si parla di “arteterapia” solo per business, cioè solo per spillare soldi. Così i formatori di Stato si inventano ogni teoria e terapia di sorta, dato che i benefici reali di queste cure non sono mai stati provati e tantomeno documentati. L’aggiungere il termine “terapia” ad azioni piacevoli come l’ascolto della musica (“musicoterapia”), l’andare a cavallo (“ippoterapia”), l’odorare un profumo (“aromoterapia”), ecc., mi sembra da considerarsi solo espressione del decadimento e dell’alienazione dell’uomo d’oggi, che chiama “terapeutico” il proprio piacere sensoriale e da esso si fa aiutare in quanto non riesce a volare più alto. Pur di far soldi tutto diventa terapia: una passeggiata all’aria aperta, la vista di un tramonto, odorare il profumo di una rosa... Siamo arrivati al punto che le azioni che un tempo tutti facevano semplicemente per godere di un piacere fisico o spirituale, oggi necessitano della presenza di un maestro, un esperto, un tecnico, o un “formatore professionale”, appunto, che ti guidi nel fare ciò.
Ogni volta che sento questi termini “formazione”, “terapeuta”, “arteterapia”, ecc., avverto come un brivido nella schiena… Proprio là, dove non è più possibile ulteriore discesa, perché manca una sostanza prima da degradare ulteriormente, oggi si tenta di spiritualizzare il grado della caduta, secondo il valore concepibile a tale livello, e pertanto ci si propone il compito di una reintegrazione di ciò che è morto. È la vivificazione del cadavere: nasce il concetto di “animatore sociale” e diventa una categoria di lavoro. Ma in tal modo si entra nel sub-umanesimo. È l’estremo tentativo del subumano di inventarsi una propria dignità inesistente.
Insomma la menzogna codificata col latinorum, non dovrebbe essere tollerata, perché porta alla guerra. Tutto ciò appartiene alla realtà del grado di abiezione raggiunta. Sono tutte dottrine di reintegrazione del subumano, divenuto stato esistenziale.
Oggi le cose stanno così: i pazzi insegnano come curare i pazzi. Siamo in una società marcia, che per coprire il marcio continua a far mostra di buonismo, con tanto di pseudoterapie e di pseudoterapeuti, statalizzati: negli ospedali pubblici oggi si pratica la “comicoterapia”, e nelle cooperative sociali - detentrici del medesimo potere statale, anche se subappaltato all’interno di qualsiasi struttura di cura comunale, provinciale o regionale che dir si voglia - si fa finta di curare gli handicappati con la ceramica e la pittura, mentre i veri operatori di queste strutture, costretti a stare al gioco se vogliono mangiare, sono tutti sfruttati, sottopagati, e sottoposti a condizioni di lavoro da anni cinquanta. È umano questo?
Sempre nei testi di formazione professionale di Stato, si afferma che l’etimologia della parola “umano” proviene - udite udite - dalla parola “mano”! È incredibile…
Credo che un editore di certi libri, così superficialmente scritti da realizzare la “neolingua” orwelliana, dovrebbe farsi attento all’elemento base del suo lavoro, e cioè alla parola. La parola, anche se impiegata per comunicare argomenti importanti a proposito dei portatori di handicap, sarà sempre in esilio ed estraniata dai contenuti logici della realtà, nella misura in cui la si vuole manipolare nell’essenza. Dunque solo chi diventa ocolingo può arrivare a tanto, sia egli editore o autore.
Il procedere manipolativo, secondo cui la parola “umano” è oggi codificata da scribacchini del costrutto “u”-“mano” è davvero aberrante. Per una neolingua di tale livello, costrutti come questo sono architettati senza giustificarne alcuna ragione etimologica, né epistemologica, forse col pretesto che essi siano di per sé evidenti in quanto percepibili foneticamente già nella loro pronuncia. Si confonde così la linguistica con l’enigmistica o col principio del rebus, in cui i segni grafici o fonogrammi che esprimono i suoni, sono utilizzati per rappresentare le cose, alle quali essi vengono associati, astraendo da ciò che realmente evocano. Se per esempio volessimo, secondo questo superficiale (o idiota?) procedimento, scrivere la parola rosario, si potrebbe accostare alla figura di una rosa quella di un ruscello, di un “rio”! Ma questa non è cultura.
L’etimologia di “umano” proviene da “uomo”, dal latino “homo”, e a sua volta da “humus”, in senso di terrestre: l’humus è infatti il terriccio fertile, la terra, e ciò è in armonia con l’antica conoscenza di Adamo, il primo uomo terrestre, dato che la stessa parola ebraica “adam” significa sia umanità che terra rossa. Solo non tenendo in considerazione che la parola italiana “umano” deriva dal latino humanus e da homo si può pretendere di dividere la parola in due per mettere da un lato “u” e dall’altro “mano”. Ma una simile congettura, in cui il fonema “u” è collocato accanto al monema “mano” - anche se ad un’analisi superficiale può apparire sensata - è del tutto insensata e assurda. Infatti, se prendiamo altri derivati foneticamente simili, come ad es., “maremmano”, “germano”, “romano” , dovremmo anche per queste parole asserire - con la stessa logica - una loro relazione con la “mano” umana solo perché quei termini incorporano “mano” come monema. La medesima cosa dovrebbe inoltre valere anche per altre unità lessicali come per esempio “talismano” o “caimano” e simili, ma sarebbe abbastanza pazzesco o ridicolo pretendere di enucleare etimologicamente il concetto di “mano” da quello di “caimano”. Credere ciò assennato semplicemente perché da un termine può essere fatto comparire un monema (peraltro inesistente nel termine originario “homo”) è ingiustificato quanto per esempio pretendere che la parola “normale” voglia significare una sorta di “norma del male” in quanto entrambi questi monemi, “norma” e “male”, vi sarebbero implicati!
Secondo l’invenzione di tali bislacche congetture (scritte e pubblicate al tempo in cui era di moda la parola “globalizzazione”), il principio su cui si fonda la cosiddetta “globalità dei linguaggi” sarebbe la corporeità, come “elemento unificante di tutte le possibilità espressive”. Qui l’ovvio si sposa col materialismo più acefalo. Sarebbe come dire: niente corpo, dunque niente comunicazione, niente voce o onda sonora meccanica, dunque niente linguaggio; come se non vi fosse un vivente spirito del linguaggio o come se il linguaggio in quanto mero aggruppamento di parole fosse privo di vivente correlazione con concetti e idee: linguaggio da oche, appunto, o da pappagalli o da struzzi… Forse potrà anche essere così per molti portatori di becchi da tucano, o forse è davvero così, data l’ignoranza imperante nella maggior parte dei nostri attuali politici. In ogni caso, una “globalità dei linguaggi” in quanto sistema di segni, generati dalla “corporeità-fondamento”, che sostituisca il pensare umano, comporta un problema, che potrà anche passare inosservato per le attuali condizioni mentali di molti lettori ed editori, ma che prima o poi, credo, dovrà essere chiarito. Si tratta della necessaria distinzione fra linguaggio e sistemi di segni studiati dalla semiologia. Se, ammettendo tale “globalità” da scimmie, ci si chiedesse dove incominci il linguaggio e dove termini la semiologia, non credo si potrebbe ottenere risposta. Riassunto con altre parole, se il linguaggio fosse solo un sistema di segni, ogni sistema di segni usato dagli esseri viventi per comunicare dovrebbe chiamarsi linguaggio; si potrebbe così parlare di linguaggio animale, inserendovi l’uomo come appartenente alla specie animale. Molti reputano scientifico ragionare in questi termini. Ma allora non si riesce più a giustificare quel dato secondo cui le lingue umane si distinguono da tutti gli altri sistemi di comunicazione. Sono in molti oggi a non comprendere questa distinzione: nelle lingue umane ogni segno può, sì, provenire da un impulso ma può provenire anche da un motivo. Negli animali predomina invece l’impulso rispetto al motivo.
Certo, ci sono anche umani in cui prevale l’impulso, cioè i sub-umani. Ma queste sono eccezioni rispetto agli umani. L’umano non è solo spinto ad agire da impulsi. Ha anche dei motivi per cui agire, e questi motivi sono costituiti dal pensare. Chi osserva l’azione di un ladro che deruba o uccide un suo simile per mangiare vede che la sua azione è dettata non da un motivo umano ma da un impulso. In tal modo si riesce a distinguere anche fra liberismo e libertà.
La kultura di Stato può solo mostrare l’uomo come mera specie animale e non come individualità, dato che in essa non vi è accenno alcuno al linguaggio umano come sistema di segni talmente diversi da tutti gli altri da costituire la prerogativa stessa dell’uomo nella catena biologica. Ed è proprio per questo motivo che l’“umano” è ridotto all’espressione “u” (vocale della paura) dell’uomo primitivo, o tutt’al più a ciò che l’uomo sa compiere con la propria “mano” (fare utensili, costruire capanne, battere il ferro, ecc.), ricacciando sempre ed ancora l’uomo all’immagine dello schiavo o tutt’al più all’uomo primitivo, o lavoratore, in realtà anti-umano, subumano.
In questo modo di procedere ci si rivolge ad un reale aspetto degenerativo del linguaggio e dell’“umano”…
Con simili alterazioni di concetti, l’“u”-“mano” diventa (e probabilmente lo è già) capace di mera “obbedienza” (dal latino ob audire) o, ancor peggio, di… “u”-“dito”, cioè di mera ignoranza.
Al di là di questo aspetto umoristico (a volte si ride per non piangere), credo che bisognerebbe distinguere fra scrittori e “scriventi”, soprattutto quando si vive in un contesto sociale in cui gli scriventi di Stato sembrano avere il predominio nella cultura.
Per costoro, cioè per i generatori di carestia culturale (che poi è anche un aspetto della crisi economica in cui siamo piombati) credo non sia possibile accettare come correttezze certi errori, e che, anzi, sia doveroso scoprirli, almeno per rettificarne la possibilità del danno che comporterebbero se lasciati circolare come virus dell’ignoranza. Bisognerebbe dire insomma che proprio grazie ad una reale libertà dello spirito non vi dovrebbero essere transazioni possibili col male, o col male mascherato da bene.
In fondo, per accorgerci che un portatore di handicap ci comunica qualcosa, non ci vogliono tante parole, o tante etimologie, bensì solamente un’autentica quanto inesauribile capacità di amore. Questa capacità, essendo di per sé luminosa, non abbisogna di abbagli e/o di titoli onorifici.
Queste masturbazioni mentali esercitano un particolare fascino sull’attuale uomo indebolito, che ha nostalgia di forze magiche new age: nei testi tantrici sembrano infatti possedute quelle conoscenze, che assieme agli dèi occidentali, hanno lasciato l’uomo affinché si sorreggesse da sé, e realizzasse in sé con la propria forza umana, la propria originaria natura.
Chi vuol tornare indietro, segue invece la “via dei morti” o delle oche o degli struzzi, in quanto non fa che disseppellire in sé antichi stati di coscienza, cadaveri sopra cadaveri, esigenti appunto l’“animazione sociale”, in cui l’umano diventa l’“u”-mano e l’udito, l’“u”-dito, e la globalizzazione dell’ocolingo, la globalizzazione bestiale della neolingua di Orwell…