 |
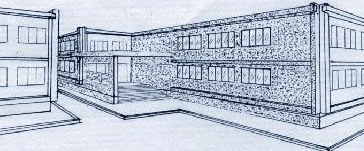 |
|
|
 |
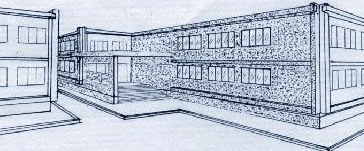 |
|
|
|
VAJONT: UNA TRAGEDIA DA NON DIMENTICARE Così la ricordiamo dopo 40 anni
Il 9 ottobre 1963, circa 2000 persone persero la vita, soltanto in pochi minuti, a causa di una poderosa ondata sollevata da una gigantesca frana di materiali rocciosi caduta nel bacino artificiale della diga del Vajont. L’ondata fu tale da raggiungere la sponda opposta scorrendovi sopra in parte. La tremenda pressione della massa spostò un volume di 50 milioni di metri cubi d’acqua; l’energia della massa d’acqua in caduta da quell’altezza, creò uno spostamento d’aria due volte più potente della bomba atomica di Hiroshima e devastò alcuni paesi. Vari fattori geologici avevano determinato la frana, e in particolar modo l’indebolimento dei ripidi e instabli pendii rocciosi della zona da parte dell’acqua trattenuta dalla diga. Infatti, durante le operazioni di invaso e svaso, effettuate durante il controllo della diga, avevano determinato delle fessure nelle rocce, peggiorandone la coesione ed alterandone la permeabilità. La valle del Vajont e la connessa zona longaronese vennero prese in considerazione soprattutto per la loro grande sfruttabilità idroelettrica. Era il progetto più grande mai tentato fino ad allora. E’ il 1940 quando prende corpo il progetto: convogliare le acque residue del Piave e di alcuni suoi affluenti incanalandole in un unico grande serbatoio, chiamato di riserva, da usare nei momenti di siccità. Nel 1943, la S.A.D.E. ottiene illegalmente l’autorizzazione a costruire. Nel 1956 arrivano le prime squadre di costruzione e i primi progetti vengono fatti tutti senza la minima consultazione con gli organi amministrativi locali. I padroni della S.A.D.E. continuano a domandare permessi su permessi e ottengono tutto. Nei primi progetti la diga raggiunge un’ altezza di 200 metri ma alla fine la costruzione viene portata a 266 m. Nel periodo di pasqua del 1959 una frana si stacca all’improvviso dal fianco destro della montagna e cade nell’acqua seppellendo un operaio incaricato di perlustrare i pendii della montagna. La notizia desta clamore, si cerca di nascondere la dinamica, ma tutti i cittadini sono consapevoli del pericolo che stanno correndo. La prima prova di invaso della diga del Vajont viene effettuata nel 1960; l’acqua, dopo aver raggiunto la quota di 660 m sopra il livello del mare, avrebbe dovuto fermarsi e non superare questo limite. Ma non è così e la S.A.D.E., che ha fretta di collaudare l’impianto idroelettrico, senza svuotare il serbatoio dopo la prima prova, ottiene il permesso per iniziare la seconda. Nell’inverno del 1960, molte piogge cadono sull’arco alpino e il 4 novembre una frana di 800.000 metri cubi si stacca dal monte Toc, provocando un’onda di 2 metri. Il pericolo è evidente ma la S.A.D.E. continua a invasare, pur non avendo il permesso della Commissione, che immediatamente impone lo svaso. Il livello dell’acqua sale rapidamente e la montagna trema. IL 23 dicembre 1961 arriva l’autorizzazione a riempire il lago fino a 680 m., ma l’acqua è a quel livello da ben due mesi. Nell’ottobre del 1962 finisce la seconda prova d’invaso, ed in aprile inizia la terza e ultima prova. Quando l’acqua arriva a 680 m., si ripetono gli stessi fenomeni già descritti e le scosse si fanno più forti; ma i lavori non si fermano e la velocità di invaso viene aumentata. Pur essendo consapevoli che il crollo della montagna sarà inevitabile, si continua a pensare erroneamente che il crollo avverrà in modo graduale. Gli invasi continuano ad essere approvati e vengono portati così a quota 700 poi a 705 e la situazione crolla: ormai si nota a vista d’occhio l’allargamento della frattura. Nell’agosto 1963 il livello dell’acqua raggiunge i 710 m. e il 2 settembre il Toc si ribella e manda una scossa così forte che viene sentita anche a Longarone. A questo punto, i tecnici decidono di abbassare il livello dell’acqua. 9 ottobre 1963. Sono le 22:39. L’assassinio si compie: prima un forte boato, poi una luce improvvisa e il vento terribile; il blocco è precipitato per intero nel bacino sollevando due ondate: la prima ad est, verso la valle del Vajont, e l’altra a ovest, dove ci furono peggiori conseguenze: le città circostanti furono completamente distrutte. Lungo questo versante morirono 1.450 persone, e nella valle del Vajont i morti furono 158. Il disastro era compiuto. Dopo 40 anni c’è ancora chi lotta contro il grande colosso che è lo stato, contro i suoi soprusi, contro strane scomparse e misteriosi documenti persi nel vuoto. Là c’è un certo Guglielmo Cornaviera che ha istituito il comitato superstiti per la difesa dei diritti del Vajont e che ha dedicato tutta la vita per riconquistare ciò che ha perduto tanti anni fa. Dopo il Vayont: la diaspora La storia del popolo ertano, a partire dal giorno seguente la disgrazia, è segnata da un nuovo lungo periodo di lotta, per avere giustizia e per potere ricostruire la propria civiltà su quelle tanto amate montagne. Non tutto fu facile per i cittadini: gli era stato imposto il divieto di tornare a vivere sui pendii ancora troppo pericolosi, perché l’acqua era ancora troppo alta e la montagna avrebbe potuto creare altri problemi. Non avevano sofferto abbastanza: infatti l’Enel non si preoccupò di salvaguardare i diritti dei superstiti ertani e non, ma solo di poter mettere in funzione l’impianto il prima possibile. Fu redatto un referendum e la popolazione si divise ulteriormente tra chi aveva ceduto alle offerte della società e chi ancora lottava perché i loro diritti dovevano essere rispettati, perché loro potevano decidere dove vivere senza l’autorizzazione di nessuno, quelle erano le loro montagne e nessuno poteva torgliele. Molti si sistemarono nei paesi vicini ma gli ertani non erano visti di buon occhio dai paesani locali, perché non avevano più una coscienza: infatti persero la loro fisionomia, si ubriacavano e ciondolavano per le strade dalla mattina alla sera. In gran parte tornavano a Erto nei fine settimana e nonostante i divieti i piccoli ertani cominciarono a ricostituirsi, e in poco tempo i cittadini in paese sono già trecento. Passa un anno dal disastro e proprio in occasione della ricorrenza gli ertani ottengono la loro prima vittoria: torna la luce. Ci sono proprio tutti in questa giornata di lutto e le 22:39 vengono celebrate a loro modo: le campane suonano rintocchi e sulla riva del lago vengono accesi falò. E’ solo nel 1965 che chi vuole rimanere in paese ha veramente l’assicurazione di poterlo fare. Viene proposto un nuovo referendum e questa volta si parla di costruire la cittadina di Sortan a quota 830 m; la gente del Vajont ha così ottenuto un altro successo. Lo stato si impegnò da subito a far rinascere l’economia nel Vajont prima di tutto con la costruzione di impianti industriali; sembrava un po’ per tutti un esempio di solidarietà nazionale ma per la gente del Vajont era solo un altro imbroglio; quindi furono avviate altre proposte per i temibili diffidenti. Per i nuovi abitanti del Vajont, niente sarà più come prima: quella non è la loro città, trattengono ricordi, emozioni passate, dolori, parlano a stento; appena possono tornano a visitare le loro vecchie origini; insomma, ormai vivono in un mondo di fantasia, di ricordi e di illusioni; il futuro è aperto solo ai giovani. (Alessandra Di Meo) |
|