
6. L' ALCHIMIA NELLE CORTI MEDIEVALI | L'Alchimia Metallurgica |

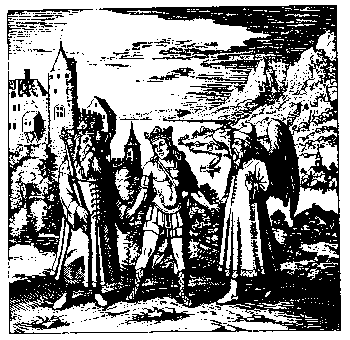 Il primo testo d' alchimia tradotto in latino nel 1144, il Testamento di Morieno, presentava l'
insegnamento del sapiente eremita ad un sovrano, l' arabo Calid, ed il prologo del traduttore Roberto di
Chester metteva in evidenza la ricaduta sociale dell' opera solitaria dell' alchimista, parlando della
quantità d' oro che annualmente egli inviava a Gerusalemme.
La lettura che inizialmente gli occidentali dettero dell' alchimia come arte della trasmutazione
metallica era del resto comprensibilmente destinata a trovare riscontro nella preoccupazione dei sovrani
per l' approvvigionamento di metalli preziosi essenziali per battere moneta.
Troviamo non a caso alchimisti già alla corte di Federico II (Michele Scoto, il celebre intellettuale della
corte federiciana, scrisse tra l'altro un trattato d'alchimia), mentre le ricerche sull' oro potabile
hanno radici nell' interesse assai vivace della Curia papale per i temi legati alla prolongevità,
condivisi dai sovrani catalani e napoletani e si diffondono col tema della quintessenza nell'ambito
della tradizione spirituale e profetica del tardo Medioevo. Vari documenti della corte inglese
dei primi decenni del '300 mostrano con chiarezza l' interesse di questi sovrani per la trasmutazione,
destinato ad espandersi ancora di più in età rinascimentale.
Ma il valore attribuito al segreto della fabbricazione dell' oro, che si supponeva gli alchimisti
possedessero, poteva essere un' arma a doppio taglio nei loro confronti. Infatti, quando gli esperimenti
non giungevano a buon fine o l' oro prodotto si rivelava falso, gli alchimisti cadevano rapidamente in
disgrazia.
A questo tema si collegano le discussioni dei giuristi circa la possibilità di battere moneta con l' oro
alchemico, e la creazione di leggende riguardanti i rapporti degli alchimisti con i sovrani (come nella
leggenda di Lullo) o con le comunità cittadine (come nella leggenda di Nicolas Flamel).
Nei racconti leggendari si può in genere cogliere un divario fra la finalità dell' alchimista e quelle del
sovrano, originato da un fraintendimento del fare alchemico, che non è orientato da valori mercantili o
economici, ma ha il valore di un contributo creativo alla salvezza del mondo, ed è quindi impregnato
nelle intenzioni degli alchimisti di valori etico-religiosi.
Il rapporto fra gli alchimisti e le corti si mantenne ben oltre l' età medievale (si pensi solo al ben noto
esempio della corte praghese sotto Rodolfo II), ma fin dall' inizio si collega a temi quali quello del
continuo viaggiare degli alchimisti, del loro operare segreto, della cautela comunicativa alla quale
invitano i loro testi, anche mediante l' uso del linguaggio allegorico e di studiate strategie
retoriche. La coscienza del potere conferito dalla capacità di interagire in maniera efficace con la realtà
materiale è anche consapevolezza del rischio insito in una diffusione imprudente di questo sapere. La
corte, più che l' aula universitaria, sembra un ambiente adatto ad un lavoro solitario e segreto dall'
ambizione vastissima: il laboratorio alchemico di cui si è trovato traccia nella parte più interna della torre
centrale del palazzo reale di Maiorca è l' emblema architettonico del paradosso di un lavoro individuale
e segreto che si propone di aumentare infinitamente il potere di chi può goderne i frutti.
Il primo testo d' alchimia tradotto in latino nel 1144, il Testamento di Morieno, presentava l'
insegnamento del sapiente eremita ad un sovrano, l' arabo Calid, ed il prologo del traduttore Roberto di
Chester metteva in evidenza la ricaduta sociale dell' opera solitaria dell' alchimista, parlando della
quantità d' oro che annualmente egli inviava a Gerusalemme.
La lettura che inizialmente gli occidentali dettero dell' alchimia come arte della trasmutazione
metallica era del resto comprensibilmente destinata a trovare riscontro nella preoccupazione dei sovrani
per l' approvvigionamento di metalli preziosi essenziali per battere moneta.
Troviamo non a caso alchimisti già alla corte di Federico II (Michele Scoto, il celebre intellettuale della
corte federiciana, scrisse tra l'altro un trattato d'alchimia), mentre le ricerche sull' oro potabile
hanno radici nell' interesse assai vivace della Curia papale per i temi legati alla prolongevità,
condivisi dai sovrani catalani e napoletani e si diffondono col tema della quintessenza nell'ambito
della tradizione spirituale e profetica del tardo Medioevo. Vari documenti della corte inglese
dei primi decenni del '300 mostrano con chiarezza l' interesse di questi sovrani per la trasmutazione,
destinato ad espandersi ancora di più in età rinascimentale.
Ma il valore attribuito al segreto della fabbricazione dell' oro, che si supponeva gli alchimisti
possedessero, poteva essere un' arma a doppio taglio nei loro confronti. Infatti, quando gli esperimenti
non giungevano a buon fine o l' oro prodotto si rivelava falso, gli alchimisti cadevano rapidamente in
disgrazia.
A questo tema si collegano le discussioni dei giuristi circa la possibilità di battere moneta con l' oro
alchemico, e la creazione di leggende riguardanti i rapporti degli alchimisti con i sovrani (come nella
leggenda di Lullo) o con le comunità cittadine (come nella leggenda di Nicolas Flamel).
Nei racconti leggendari si può in genere cogliere un divario fra la finalità dell' alchimista e quelle del
sovrano, originato da un fraintendimento del fare alchemico, che non è orientato da valori mercantili o
economici, ma ha il valore di un contributo creativo alla salvezza del mondo, ed è quindi impregnato
nelle intenzioni degli alchimisti di valori etico-religiosi.
Il rapporto fra gli alchimisti e le corti si mantenne ben oltre l' età medievale (si pensi solo al ben noto
esempio della corte praghese sotto Rodolfo II), ma fin dall' inizio si collega a temi quali quello del
continuo viaggiare degli alchimisti, del loro operare segreto, della cautela comunicativa alla quale
invitano i loro testi, anche mediante l' uso del linguaggio allegorico e di studiate strategie
retoriche. La coscienza del potere conferito dalla capacità di interagire in maniera efficace con la realtà
materiale è anche consapevolezza del rischio insito in una diffusione imprudente di questo sapere. La
corte, più che l' aula universitaria, sembra un ambiente adatto ad un lavoro solitario e segreto dall'
ambizione vastissima: il laboratorio alchemico di cui si è trovato traccia nella parte più interna della torre
centrale del palazzo reale di Maiorca è l' emblema architettonico del paradosso di un lavoro individuale
e segreto che si propone di aumentare infinitamente il potere di chi può goderne i frutti.

| [Home] [1.Perfezione dei metalli] [2.Teoria dei metalli] [3. Trasmutazione] [4.Operazioni] [5.Oro] |
[Bibliografia] [Profili biografici] [English Version] [Micrologus] [The Alchemy Web Site] |

di Michela Pereira
html di Francesco Di Pietro