VIVA L’ITALIA

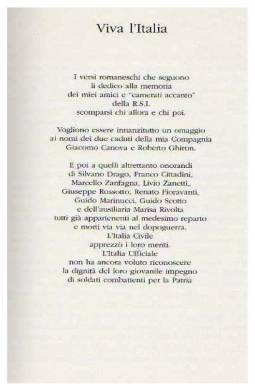

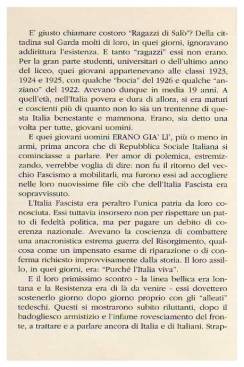
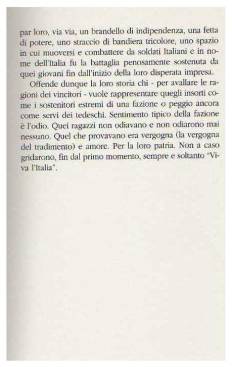
Trascriviamo qui di seguito i 29 sonetti con cui Mario
Castellacci, autore di “Le donne non ci vogliono più bene” racconta la
storia sua e dei ragazzi che, con lui, reagirono alla vergogna dell’armistizio
dell’8 settembre 1943 arruolandosi, prima ancora della costituzione della
Repubblica Sociale Italiana, nella sopravvissuta all’armistizio Legione
Tagliamento del Maggiore Zuccari
CINQUE GIORNATE
DISPERATE E BELLE DE QUER SETTEMBRE DER ‘43
I – Gli ultimi sopravvissuti
Quanti settembri, Peppe (1), so’ passati
da quer settembre del Quarantatre !
Tu
ciài settantasette anni sonati.
Io
uno, pe’ bon peso, più de te.
E l’amici via via ciànno lassati:
e Franco e Guido e l’artri. E’ come se
giocassimo vecchietti scojonati,
ar moscaceca der Quannovievviè.
Semo
rimasti fra de noi sett’otto
De
cui certuni se po’ dì che vive
Già
mezzi su la tera e mezzi sotto.
Passa er fiume. E noi stamo su le rive
Aspettanno er momento de fa ‘r botto
No. Quarcuno ‘sta storia l’ha da
scrive.
II - Cantami o diva
Ce provo io, la mana che me trema
E
‘na mordacchia in cima a le budella.
Perché
contà ‘na storia come quella
Nun
so’ bignè de pastafrolla e crema.
‘Na storielluccia, ma che cià pe’ tema
un’avventura disperara e bella
che si ce fusse Omero o Pascarella
magara ce farebbero un poema.
Io
però nun ciò muse che me intona
ne
santi ispiratori a cap’a lletto.
Ar
più pozzo fa un voto a San Lumìno
E principià, che Dio me lo perdona,
arubbanno l’attacco d’un sonetto
ar sor Belli Giuseppe Giovacchino. (2)
III – L’8 Settembre
C’era ‘na vorta un re che dar palazzo
disse
a un Badojo: “Firma l’armistizio!”
“E
poi, Sire?” “Scappamo a precipizio”.
“E
l’Italiani?” “S’attaccasse ar cazzo!”
E fu così che nacque er quadro a
sguazzo
de quer famoso Giorno der Giudizio
in dove che Sempronio e Caio e Tizio
tutti coreva pe’ sarvasse er mazzo.
Li
tedeschi sparaveno ner mucchio
e
le donne a strillà da le terazze
e
li nostri a ‘nguattasse ne la fogna.
E
laggiù, tra ‘na rosicata e un succhio,
puro li sorci de le peggio razze
a disse fra de loro: “Che vergogna!”
IV – La mattina del 9
La matina der nove. C’era er patto
che
noi vecchi compagni de la scola (3)
ce
se ‘ìncontrassi, all’accadè de ‘n fatto,
ar
Colle Oppio llà su ‘na piazzola.
E nell’annacce intesi a tratt’a tratto
un brontolà lontano, ‘na gragnola
de schioppettate e quarche sparo matto
de bomba giù verso la Cicchignola.
E
viddi fantaccini a mane arzate
messi
in colonna da un tedesco fiero
che
je puntava un mitra ne la schina.
E chi da ‘na finestra a urlà: “Scappate!”
All’Oppio m’aricordo – perché c’ero –
s’aritrovammo in una quindicina.
V – Farsi avanti
Pochi.
Ma llà pe’ llà pareva tanti.
“Regazzi,
er fatto è chiaro” disse Pietro.
“L’Italia
scappa. Ir Re se tira indietro.
Semo
allo scenufrèggio,(4) ‘n ce so santi.
E qua nun serve lagrimucce e pianti.
L’onore nun se vende a ‘n tant’ar
metro.
Si ciavèmo le palle, e no de vetro,
qua noi bisogna che se famo avanti”.
Avanti,
sì. Ma ‘ndove? Da che parte?
Chi
cerco? ‘Ndo me butto? Co’ chi provo?
P’avè
un fucile a chi s’ha da ricore?
E fu così che ce ‘nventammo l’arte
de fasse avanti cor “nemico novo” (5)
p’arimedià du’ bbriciole d’onore.
VI – Le porte in faccia
Annavamo
a trattà, dovunque c’era,
cor
crucco armato ar pizzo de la via.
Noi
de qua, lui laggiù su la trincera:
“Noi
esse amici!” E quello: “Pussa via!”
“Ma noi volere continuare guera!”
“Raùs!” gridava. E – ‘n colpo che te
pija –
sparava a guercio co’ la mitrajera.
Un pèar d’ore durò ‘sta litania.
Finchè
de sito in sito pe’ furtuna
trovammo
un crucco meno ‘ncavolato
co’
cui noartri se potè parlà.
E lui ce disse: “So che s’ariduna
certi de voi ‘nd’un campo impruvisato
giù da le parte de Cinecittà”.
VII – Sul tram dei Castelli
Nun
se partiva dunque all’isolata:
già
s’era desti in giro artri fratelli!
Ce
demmo appuntamento a la fermata
der
tranve bianchebblù de li Castelli.
Passai pe’ casa. E a mamma, sventurata,
je dissi: “’A ma’, me vado a fa i
capelli”.
Povera donna! E poi via de volata
a risicà la morte inzieme a quelli.
Er
tranvetto lo presimo d’assarto.
E,
appena fummo su, co’ tutto er fiato
Ce
mettemmo a cantà fino all’arivo.
Come che lì ce fusse stato un parto
e noi fossimo er pupo appena nato
che strilla e fa sapè: “Sto qua, so’
vivo!”
VIII – Cinecittà quel giorno
Cinecittà
pareva un firm de guera.
Li
studi, li viali, l’isolati
formicolava
tutti de sordati
vestiti
ognuno ne la su’ maniera.
Tedeschi e, inzieme, gente d’ogni tera:
e russi ex priggionieri e poi croati
e rumeni e francesi spicciolati
che manco noi sapevimo che c’era.
Co’
indosso ancora l’abbiti civili
in
quer Campo de Marte dell’Europa
c’era
venti italiani come noi.
Aggitanno nell’aria tre fucili
e un vessillo su un manico de scopa
pareva recitasse a fa’ l’eroi.
IX – La prima adunata
E
ce vennero incontro senza affanno,
ner
senso che nisuno fece festa.
Come
pe’ dì: “Ve pare l’ora, questa?”.
Come
pe’ dì: “Ve stavimo aspettanno”.
Certi li conoscevo. C’era Lanno
E c’era Carlo a fà da capintesta.
Disse: “Già presentammo la richiesta.
Fra poco, prima o poi, ce chiameranno”.
Defatti
sortì fora un capitano.
Era
de Vienna, a quer che poi se seppi,
e
parlava più o meno l’italiano.
Davanti a lui ce sistemammo a schiera
allineati e dritti come zeppi
cor manico de scopa pe’ bandiera.
X – Il nostro primo no
E lui ce fece: “Volontari, ià?
Questo
vor dì che voi ciavete core.
Apprezzo
chi dimostra federtà
e
me dichiaro vostro estimatore.
Ma a ‘sto punto, signori, che se fa?
L’Italiano è ‘no Stato traditore.
E tuttavia la Nostra Autorità
ve concede in estremi un grosso onore.
Chi
defatti tra voi ciabbi vaghezza
d’entrà
ner Grande Esercito Germano
de
fronte a me facesse avanti un passo!”
Ma noi nun se movettimo de pezza.
Guardanno dritt’all’occhi er capitano
ognuno restò fermo come un sasso.
XI – Il chiarimento
Vallo a capì pe’ quali vie segrete
l’omo
reaggisce all’accadè de ‘n fatto!
Er
capitano se ‘ncazzò, direte.
Macchè!
Se mise a ride come un matto.
Rideva, e ce ‘ndicava co’ le dete.
Ma poi ciaripenzatte. E ippisifatto
se nn’uscì: “Ma che cazzo pretennete?”
e da llì, mo’ de lama e mo’ de piatto,
ce
massacrò: “Bruttissima marmaglia!
Co’
che porco coraggio t’arifiuti
de
stà sotto le insegne dei Germani?”
Silenzio. E Piero fa: “Semo Italiani!
E co’ tutti i rispetti a voi dovuti
ce piacerebbe d’arifà l’Itaglia”
XII – La schiera s’ingrossa
“Ah!”
fece quello. Ossia: “S’era capito”.
Poi
disse: “Beh, vedrò che si può fare”.
Salutò
cor saluto militare
e
se n’annò pe’ ‘ndove era sortito.
E Pietro co’ ‘na faccia da ‘mpunito
ce domannò: “Regazzi, che ve pare?
Ho detto giusto?”. “Giusto! Regolare!”
je fece Carlo. E tutti: “Garantito!”.
Fu
allora che laggiù da quer cancello
un camio
dell’esercito italiano
sboccò
drent’ar cortile a gran cariera.
Sopra ce stava un piccolo drappello
de matti come noi, sei bombe a mano,
quattro cinque fucili e ‘na bandiera.
XIII – La bandiera col buco
‘Na bandiera ariccorta a Tor de Nona
in
un vecchio presidio saccheggiato.
Grande.
Vera. Ner bianco era stampato
lo
stemma co’ lo scudo e la corona.
M’aricordo fu Carlo de persona
che, co’ ‘n rasore riccapezzolato,
sgarrò ‘n tondo lo stemma rinnegato.
Ne sortì fora un “O” fatto a la bbona.
(O,
come l’O de la parola Onore)
E a
quer vessillo je facemmo festa
che
manco a ‘n Santo sull’artar maggiore.
De quello sgarro la morale è questa:
“In punt’estremo sarva er tricolore!
Li stemmi passa, ma l’Italia resta”.
XIV – Si parte
E così fu che – la bandiera ar vento –
Carlo
ce corse a dì: “Regazzi, è l’ora!
Pare
che in d’un paesetto llà de fora
ce
stanno i resti della Tagliamento!
Se parte pe’ laggiù!”. Da quer momento
fu certo che l’Italia c’era ancora:
la nova compagnia de la malora
arinsanguava un vecchio reggimento.
Tre
camioni tedeschi, quella notte,
portattero
quaranta disperati
giù
giù pe’ le campagne verso Ardea.
Nino, l’esperto delle storie dotte
disse solenne: “Cari camerati,
sappiate che pe’ qua ce passò Enea!”
XV – Storia nostra
“E nun se dice Ardèa” , rifece Nino
seguitanno
a parlà tra ‘r lusco e ‘r brusco
der
camio che coreva ar su’ destino.
“L’accento
va sull’A de la maiuscola.
Àrdea, se dice, come che in latino
già se diceva ar tempo dell’Etrusco.
Oggi è solo un paesucolo burino,
ma de groria ‘na vorta fu corusco.
Là
regnattero i Rutuli de Turno
e
llà ‘nzinanco er Console Cammillo
esiliato
passò le su’ priggioni”.
E doppo che ste cose dette furno
er silenzio fu grande. E manco a dillo,
Pietro fece ammirato: “Me cojoni!”
XVI – Un “Alto là!” in italiano
S’era in quaranta e pieni de pretese
-
mancava un sordo a potè fa ‘na lira –
in
viaggio verso er mitico paese.
E
chi canta e chi sogna e chi sospira.
Sur camio – uno dei tre che, svorta e
gira,
scapicollava pe’ salite e scese –
l’autista era un sergente bavarese.
Che defatti coreva a tutta bira.
A
‘n certo punto se sentì du’ spari.
Poi
‘na voce strillò ne la nottata:
“Arto
là! Chi va là! Dite chi sete!”
Er tedesco frenò. Se accese i fari.
Se vidde ‘na pattuja attrincerata.
Nino arispose: “Semo leggionari!”
XVII – Il primo legionario
“Leggionario so’ io!” prutestò quello
sortenno
a mano armata da la fossa.
Pe’
paura chissà de che tranello
saliva
piano e mossa dopo mossa.
Montò sur camio. E tutti ner vedello
provassimo quaggiù come ‘na scossa:
portava er fezze nero pe’ cappello
e lì, sulle mostrine, l’Emme Rossa.
Disse
Pietro: “Venimo a la Leggione!
Semo
li vostri novi camerati!”
E
quello: “Nun me dì che sete eroi!”
Pietro minnimizzò: “Semo persone!
Pe’ tutta Roma, fra ‘r Quadraro e
Prati,
ne poi riccapezzà quanti ne voi!”
XVIII – La “Tagliamento” quella notte
Arivammo laggiù, pe’ falla lesta
a
notte fonna ossia verso le trene.
E
llà se scatenò l’andiriviene
dei
leggionari vecchi a facce festa.
Chi dannoce ‘na sleppa su la testa
e chi ‘na manatella ne’ le rene
tutti contenti a dicce: “Bravi! Bene!
Ve manna Iddio! Che bella nova è
questa!”
Erano
scesi a furia da le brande
sicchè
girava chi co’ le canotte
e
chi co’ solamente le mutande.
E brindaveno arzanno er gavettino
der Frascatello preso da ‘na botte
che stava giusto llà co’ quer destino.
XIX – Il Comandante
Cor gavettino in mano pure lui
-
ma vestito però da capo a piede –
er
Comandante Zuccari ce diede
de
quer contento la ragion per cui.
Disse: “Avemo passato giorni bui.
Pareva morta ogni speranza e fede.
Ma la speranza è qua, come se vede.
E cià er core e la faccia di costui!”
E
indicava cor dito tremarello
le
capocce de Carlo e Pietro e Nino
e
‘nzomma de noartri sciagurati.
Poi disse: “Erimo avanzi de macello,
urtimi ormai, ridotti ar lumicino.
Ma stasera, co’ voi, semo rinati!”
XX – La camicia nera
Ce accompagnò – la notte era passata –
lui
stesso fin laggiù nel cappannone.
E
llà vedemmo tra la cunfusione
la
montagna de panni abbandonata.
Divise vecchie: ognuna era già stata
addosso a un chissacchì de la Leggione
che all’ora vergognosa der fugone
a gambe pure lui se l’era data.
Lo
so. Lo so che mo’ quarcuno obbietta:
“Inzomma,
come fu come nun fu,
là
te capasti la camicia nera!”
Nu’ rompe li cojoni, Sor Cazzetta!
‘N’arta vorta, ar mi’ posto, viecce tu.
Là de camicie, giusto quella c’era!
XXI – La vestizione
Noi
stessi all’alba, come lavannare,
quelle
camicie le sciacquammo ar fosso.
Poi
le stennemmo ar sole ancora rosso
in
una vigna ai fili d’un filare.
Li carzoni e le ggiubbe nun me pare
che le lavammo. Ar massimo ‘no sghrosso
co’ la scopetta. L’infilammo addosso
all’uso sbrigativo militare.
Quei
panni borbottaveno quarcosa
co’
la voce de chi, de punto in bianco,
l’aveva
smessi pe’ ‘un combatte più.
Dicevano: “Sta ggiubba fu groriosa.
La portai pe’ quattr’anni. Mo’ so
stanco.
Te prego, giovanò: portala tu!”
XXII – Finalmente soldati
Vestiti a novo in quell’antichi panni
e
armati de moschetti e de pistole
quer
giorno stesso ce schierammo ar sole
co’
la bella ruganza dei vent’anni.
Ma non era finiti i nostri affanni.
Vestivamo italiano, se Dio vole;
ma p’arifà l’Italia, e no a parole,
toccava a quistionà coll’alemanni.
La
“Tagliamento”, infatti, era aggregata
a
la famosa Divisione “Stude”(6),
fior
fiore de li crucchi combattenti.
E fin dalla primissima adunata
Un animo ce disse: “Nun te illude:
qua lotterai coll’ugne e co’ li denti”.
XXIII – Il tenentino Franz
Er tenentino Franze era contento
der
fatto che ce fussimo arrolati.
Ce
portava a trottà pe’ campi e prati
pe’
fa’, diceva lui, l’addestramento.
E felice strillava a ‘gni momento:
“Fe farò difentà boni sordati!”
E noartri, sbuffanti e sderenati,
a corre appress’a lui pe’ fora e
drento.
Poi
venne l’istruzione musicale.
Chè
Franze, co’ quell’aria un po’ da fesso,
a
‘n tratto disse: “Mo’ fe inzegrerò
a cantare con me Di fane oh. (7)
Io fe la canto e foi fenite appresso!”
E Pietro fece: “Qua se mette male”.
XXIV – Il secondo “no”
“Di fane oh, di rane mit ghesciorze…”
cantava
dunque Franze alla tedesca.
Ognun
de noi nun ce capì ‘na fresca
ma
la cantò co’ tutte le su’ forze.
Ne la pausa, però, se ne discorze.
Fu Nino - credo - a organizzà la
tresca.
"Tutti d'accordo?".
"Sì". La sordatesca
aricantò fin'a cche Franze vorze.
E
fummo pronti. E ir crucco, ai sette celi,
fiero
e gioconno ce sparò la botta:
"Mo'
la cantamo all'oberkommandante!"
Annammo. E, in bella schiera llà
davante,
ar "Pronti via!" - da fiji de
'na mignotta -
cantammo invece l'Inno de Mameli.
XXV - Testa alta
Nun
ce fu né prutesta né vendetta.
A
quello sgarro ce passorno su.
E
doppo la famosa canzonetta
er
poro Franze nun se vidde più.
Perché 'na cosa, fra de noi, va detta.
Er sordato tedesco ha 'sta virtù:
che si tu ciai coraggio t'arispetta,
ma se te fai vijacco te da giù.
Volevamo
onorà l'arme italiane?
Subbito
se capì: questa è la via!
Riarzà
la testa, er fegheto e l'orgojo.
'Sta terra che t'arigalò Badojo,
camerata Richarde, è terra mia!
Te dirò, finchè pozzo: "Giù le
mane!".
XXVI - La difesa di Roma
Frammischiati
er tedesco e l'italiano
tutti
coll'armi in pugno a par'e patta
pe'
du' notti così, fratta pe' fratta
annammo
a presidià l'Agro Romano.
Era previsto un lancio americano
de paracadutisti in quella tratta.
Quell'invasione poi nun fu mai fatta.
Ma noi, l'orecchio attento a 'gni
rioplano
che
passava, a 'gni segno de pericolo
che
minacciasse Roma e la contrada,
ce
sentivamo er core antico e bello
de Goffredo Mameli sur Giannicolo
o quello de Manara a Villa Spada
o de Giacomo Medici ar Vascello.
XXVII - La tradizione
Repubbricani
- e no "repubbrichini"
noi
ce se disse già da quer momento.
Ce
davano coraggio e sentimento
l'ombre
d'Orazio ar Ponte (8) e de Mazzini.
"L'elmo de Scipio" che
cantammo ar vento
l'avevamo 'mparato regazzini.
E' vero: erimo fiji de Mussolini
Però nipoti d'ogni antico evento.
Erimo
camerati ossia fratelli
d'Italia
ognuno in fila su la traccia
de su
padre e der padre de su' padre.
Rinnegavamo le gentacce ladre,
i Maramaldi, i vili, i vortafaccia,
i cacasotto, i servi dei bordelli.
XXVIII - Quella storica
notte
La
notte avant'ar 13 annavamo
pe'
le campagne tra scarupi e buce
quanno
ar Commando s'appicciò 'na luce.
Finchè
frammezzo a voci de richiamo
laggiù - che a malapena sentivamo -
venne lo strillo: "Hanno sarvato
er Duce!"
Stavo co' Pietro. E lui bulletto e
truce
me fa: "Tu che dici?
L'arruolamo?"
La
Storia scriverà: "Nei giorni bui
quei
regazzi risposero all'appello
de Mussolini
e accorsero a Salò".
E' vero, sì, ma è vero pure no.
Perché - la Storia avrebbe da sapello -
Noi stavamo già llà senza de Lui.
XXIX - C'eravamo noi tutti
Tutti
stavàmo llà fin dar tramonto
de quell'8
settembre. Puntuarmente.
Stavamo
tutti llà pe' dì: "Presente!
Io
ce so'. So' Italiano! E pago er conto!
La guera è persa? E' disparo er
confronto?
È finita? Nun voio sapè gnente!
Me 'nteressa l'onore solamente.
E se me tocca de morì so' pronto!"
Se
pensava: "L'Italia in un domani,
de
quer che ho fatto se n'accorgerà.
E ne
sarà felice e consolata.
Ma i posteri nun so' boni cristiani.
E fra cent'anni ancora se dirà
Che la tu' parte, Peppe, era sbajata.
NOTE:
(1) Peppe è il professor Giuseppe Sermonti
(2) Il sonetto del Belli è “Er dispotismo” che inizia “C’era ‘na vorta un re, che ddar palazzo…”
(3) I “compagni de la scola” erano quelli del Liceo “Cavour” prossimo al Colle Oppio. Buona parte dei convenuti all’appuntamento lo avevano frequentato prima dell’università.
(4) Scenufreggio = disastro massimo
(5) Nemico novo = i tedeschi
(6) La Divisione Paracadutisti “Student”
(7) Era la canzone delle S.A., qui storpiata in romanesco.
(8) Orazio Coclite