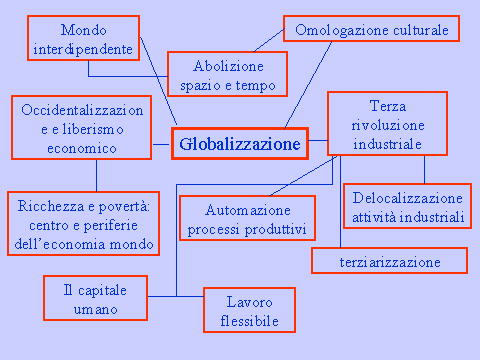
a cura di Paolo Alpino
CLASSE TERZA UNITA' DI LAVORO N° 9
La globalizzazione
Filone Educazione allo sviluppo
Introduzione. E' l'unità conclusiva. Le dinamiche che approfondisce - quelle dello sviluppo - sono centrali per l'intero curricolo di geostoria, non solo di quello di terza media. Si parla del presente, anche dell'attualità più recente ma con parole, conoscenze, concetti, modelli di spiegazione che si sono formati nel corso dei tre anni descrivendo tematiche di altri contesti temporali e spaziali. Qui questi strumenti vengono in gran parte ripresi per conoscere la svolta che va sotto il nome di globalizzazione, di cui insegnanti e alunni hanno il vantaggio di esserne, più o meno consapevolmente, testimoni diretti.
Il percorso proposto riassume il lavoro già svolto anche metodologicamente. I primi tre capitoli hanno un taglio più induttivo: nel primo e nel terzo capitolo gli studenti a partire da esempi forniti dall'insegnante o ricavati dalla loro esperienza provano a generalizzare, e con l'aiuto dell'insegnante definiscono alcuni aspetti del fenomeno. Nel secondo capitolo si fa ricerca, le informazioni sono numeriche, appartengono al database della ricchezza che si può interrogare usando - se si vuole - gli strumenti forniti da Excel. Nel quarto capitolo è più centrale la posizione dell'insegnante: sulla base delle informazioni che si ottengono dalla lettura dei testi egli propone modelli esplicativi, stimola confronti fra situazioni di diversa scala, produce in conclusione mappe via via più potenti per rendere ragione dei cambiamenti in corso.
E' anche tempo d'esame. La formazione a distanza si defila, lascia il posto alla didattica in presenza, fatta di parole dell'insegnante che spiega, degli alunni che fanno domande, che si cimentano soprattutto nell'esposizione di un percorso di lavoro complesso, in preparazione della prova orale dell'esame di terza media: il colloquio interdisciplinare.
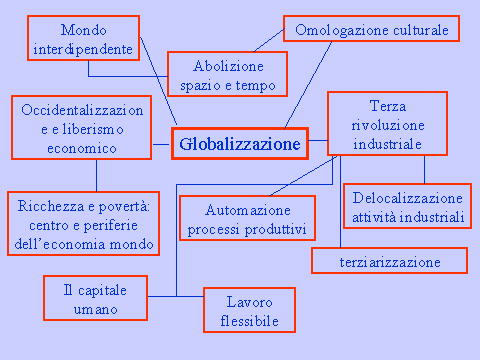
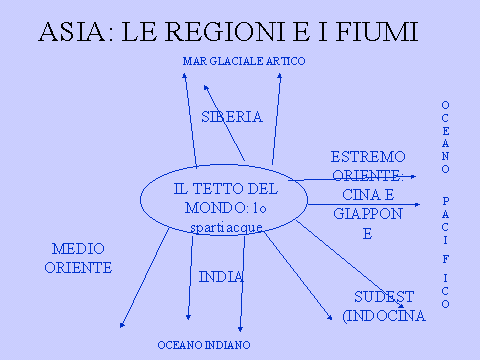
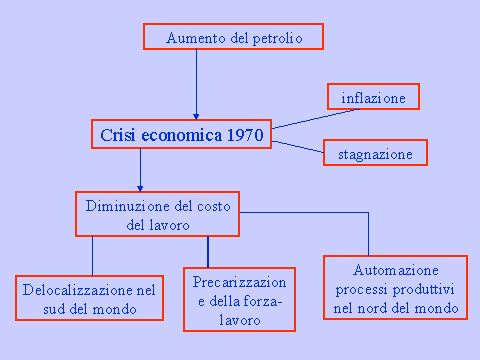
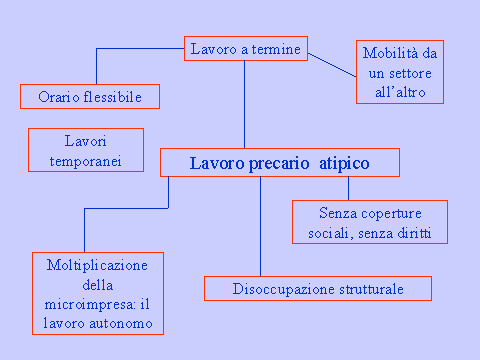
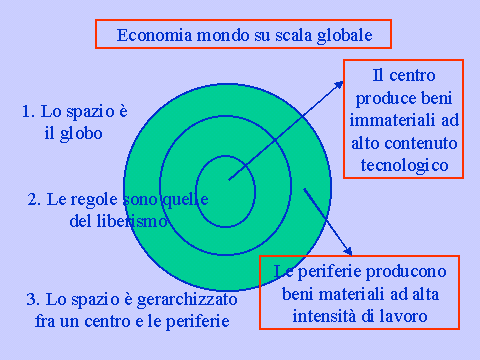
Cap. I Esempi e definizioni
Lettura di testi per ricercare informazioni sul fenomeno globalizzazione e ricerca di significati
Confronto tra definizioni fornite e ricerca di elementi comuni
Definizione del fenomeno globalizzazione in termini di interdipendenza di attività economiche su scala globale
Ricerca di informazioni sulle attività necessarie alla fabbricazione dei prodotti globali
Lettura del testo sulle malattie e definizione del fenomeno globalizzazione in termini di abolizione dello spazio e del tempo
Esemplificazione della definizione mediante elenco delle tecnologie di comunicazione e di trasporto.
Lettura degli altri testi e definizione del fenomeno globalizzazione in termini di omologazione culturale
Definizione conclusiva di globalizzazione da parte dell'insegnante in termini di "sistema di produrre le merci e i servizi in un contesto di liberismo mondiale"
Aggiornamento del modello liberistico di economia di mercato: globalizzazione della scala spaziale, potenza delle imprese transnazionali, debolezza degli stati nazionali
Periodizzazione del sistema della globalizzazione: scoperte geografiche ed imperi coloniali, imperialismo tra prima e seconda rivoluzione industriale, crollo dell'URSS, e inserimento della Cina nel WTO
Ideazione di una scaletta e/o di una mappa e produzione di un testo scritto (oppure orale)
Cap. II La geografia della povertà e della ricchezza
Cap. III Il secolo cinese (asiatico)?
Cap. IV La III rivoluzione industriale
Ideazione di una scaletta e/o di una mappa e produzione di un testo scritto (oppure orale)
Documento 1 Globalizzazione. Leggi i seguenti esempi del fenomeno, ricava alcuni significati generali del termine e riportali sul quaderno:
Si intende l’insieme di quei fenomeno per cui la vita
di ogni abitante del pianeta dipende, almeno in parte, da decisioni prese oltre
i confini del paese in cui vive, e sulle quali non ha la possibilità di
esercitare alcuna forma di controllo (B. Guillochon).
Se un cittadino statunitense compera per 10.000 dollari
un’auto della General Motors, 3.000 dollari vanno in Corea del Sud per
lavorazioni di routine e operazioni di assemblaggio, 1750 in Giappone per
componenti ad alta tecnologia, 750 in Germania per il design e per per il
progetto delle parti meccaniche, 4.000 a Taiwan, Singapore e Giappone per
piccole componenti, 250 nel Regno Unito per la pubblicità e i servizi
commerciali e altre 250 in Irlanda e nelle Barbados per l’esecuzione di
calcoli al computer (J. Brecher – T. Costello).
Per tornare in Europa nel ‘300, dall’oriente dove
era endemica, la peste impiegò qualche secolo; venticinque anni esatti ci
vollero perché il vaiolo trasmigrasse dall’Europa alle Americhe a fare stragi
di indios; pochi anni all’Aids per diffondersi dall’Africa centrale al resto
del mondo. Per la Sars poche settimane sono bastate per mettere in allarme il
mondo intero: questa fulmineità nella trasmissione è frutto dei nostri tempi e
dei ritmi veloci di circolazione di persone e di cose… (Massimo Livi Bacci, L’antidoto
globale in La Repubblica del 30.4.2003)
1.
Vai in qualsiasi posto del mondo e ci trovi la Coca-Cola. O le Nike. O le
Marlboro.
2.
Possiamo comprare azioni in tutte le Borse del mondo, investendo in
aziende di qualsiasi paese
3.
I monaci tibetani collegati a Internet
4.
Il fatto che la mia auto sia costruita a pezzi, un po’ in Sud America,
un po’ in Asia, un po’ in Europa e magari un po’ negli stati Uniti
5.
Mi seggo al computer e posso comprare tutto quel che voglio on line
6.
Il fatto che dappertutto, nel mondo, hanno visto l’ultimo film di
Spielberg, o si vestono come Madonna, o tirano a canestro come Michael Jordan
( Da A. Baricco, Next. Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che
verrà, Milano 2002)
Quando sorge il sole su un qualunque giorno di scuola, in tutto il mondo comincia la tipica giornata degli adolescenti della classe media. Il teenager statunitense si infila nei suoi jeans e la cilena rovista nei cassetti cercando la T-shirt giusta. La taiwanese si allaccia le scarpe da ginnastica, mentre l’ungherese si butta lo zaino sulle spalle e esce di casa. Le analogie, secondo una delle più ampie inchieste mai condotte sugli adolescenti di tutto il mondo, vanno al di là dell’amore per i Levi’s o per le Nike. Il Brain Waves Group, una società di New York che si occupa di ricerche di mercato, ha intervistato 25mila teenager dei cinque continenti: secondo i risultati del sondaggio, i giovani tra 15 e i 18 non solo hanno gli stessi gusti, ma condividono anche opinioni, valori e obiettivi … (da un’inchiesta del Washington Post)
“Happy Birthday, Globalisation”, celebra il Financial Times. La globalizzazione compie oggi venti anni ed il mondo che ha plasmato è irriconoscibile rispetto al 1983: allora non c’erano i cellulari né la Cnn né Internet, i nostri figli non vestivano Nike, non esisteva l’euro, non avrei scritto questo articolo su un computer, e metà del pianeta era governata da sistemi comunisti… (Federico Rampini, Globalizzazione i vent’anni che sconvolsero il mondo in La Repubblica dell’8 maggio 2003)
Documento 2 Globalizzazione come interdipendenza di attività economiche

Documento 3 I prodotti globali. Attività: dopo aver letto il testo a) sottolinea nel testo le informazioni riguardanti i diversi momenti della lavorazione del jeans e gli spazi in cui in cui essi avvengono; b) Trova sulle carte i luoghi in cui avvengono le diverse fasi della produzione del jeans c) Riporta sulla carta sottostante tante didascalie quante sono le diverse fasi produttive del jeans e mediante frecce collegale ai diversi luoghi della produzione. Infine dai un titolo alla carta appena creata
In
un centro commerciale di Ipswich, tutto di vetro e acciaio con le doppie porte e
le scale mobili, c’è il Cromwell’s Madhouse: un negozio pieno di
pile di jeans, felpe, pantaloni sportivi, e poi ancora jeans. Più o meno al
centro, su una pedana, eccolì lì, il nostro jeans 3000 sotto un grosso
cartello con la scritta “Grandi marche a 19,95 sterline”
…“Lavare a rovescio separatamente” dice
l’etichetta all’interno. Cento per cento cotone. Non dice da dove vengono,
ma in fondo meglio così …perché Cromwell’s Madhouse è l’ultima
fermata di un percorso che, se lo si misurasse, sarebbe uguale a una volta e
mezzo il giro del mondo. Secondo un calcolo molto approssimativo e cauto, un
viaggio di circa 60 mila chilometri, durante il quale componenti e materiali
grezzi si incrociano attraverso il pianeta in una frenetica e folle danza.
Questi jeans sono arrivati qui qualche giorno fa, in
un furgone che ha risalito la A12 dal deposito della jeans 3000, proprio
in fondo alla M1 di Londra nord. Lì gli hanno attaccato l’etichetta Cromwell,
prima di inscatolarli e spedirli in tempo per lo shopping di fine settimana.
Prima erano passati attraverso la Manica su un camion proveniente da un deposito simile che si trova ad Amiens, in Francia, e prima ancora in nave e treno dalla Tunisia. Da Ras Jebel, per essere più precisi, un’ora abbondante di macchina a nord di Tunisi. …Qui cinquecento donne lavorano furiosamente, gli occhi bassi, i muscoli contratti. Ognuna ha la sua piccola parte da fare: cerniere lampo, tasche, cuciture laterali, orli. E ognuna lavora come un automa, prende un capo da un carrello al suo fianco, lo scaraventa nella macchina da cucire, e segue velocemente la cucitura e lo getta di nuovo sul carrello.
…Anche se il prezzo di fabbrica di questi jeans è
di 5 sterline e il trasporto in Francia costa solo 10 pence l’operaia Famedi
non è affatto sorpresa che il loro prezzo al Cromwell’s Madhouse sia
di 29 e 95…
Questa fabbrica, questa piccola comunità di
lavoratori, non è l’inizio del nostro paio di jeans. In un certo senso è la
fine, la destinazione. Il posto in cui decine di diversi componenti, materiali,
merci, prodotti chimici e rondelle si incontrano per subire una trasformazione.
Prendiamo, per esempio, quel cotone spesso e blu scuro, il denim del
Kansas, per chiamarlo con il suo nome. Viene portato qui per mare e per terra da
un’azienda di Milano, a mille chilometri di distanza, dove viene filato,
tessuto e tinto usando l’indaco sintetico prodotto cinquecento chilometri più
a nord, a Francoforte, in Germania. A ras Jebel viene tagliato, cucito e poi
trasformato in un tessuto morbido e inossidabile in grosse lavatrici
industriali, con l’aiuto della pomice di un vulcano inattivo della Turchia.
E da dove viene il cotone che serve per fare il denim?
L’azienda italiana lo compra in diversi posti ma soprattutto nel Benin, in
Africa occidentale. Il cotone che viene dal Benin non è il solo cotone usato
per fare i nostri jeans. Quello per l’interno delle tasche viene coltivato in
Pakistan o in Corea, e lavorato in Pakistan.
C’è poi il rivestimento di cotone dei fili di poliestere, che ha una storia a parte. E’ un’azienda specifica a fabbricare questi fili: vengono prodotti a Lisnakea nell’Irlanda del Nord, come anche in Ungheria ed in Turchia. Vengono tinti in Spagna e avvolti in rocchetti a Tunisi, prima di arrivare a Ras Jebel.
La fibra di poliestere che dà forza al filo viene acquistata dalla società in Giappone dove è fabbricata con derivati di petrolio. Come il nastro di poliestere della lampo, che viene prodotto in Francia da una società giapponese. Anche l’ottone con cui sono fatti i denti della lampo viene dal Giappone.
L’ottone naturalmente è una lega costituita principalmente di rame con un po’ di zinco. Ed è sempre l’ottone che serve a fare i bulloni di guarnizione e i bottoni. Questi vengono, da una ditta con sede in Germania che produce l’ottone, usando zinco e rame provenienti rispettivamente da Australia e Namibia nell’Africa del sud… (testo adattato da F. Abrams e J. Astill, The Guardian, 2001)
Documento 4 Definizione conclusiva di globalizzazione
La globalizzazione è il sistema di produrre le merci ed i servizi in un contesto di liberismo mondiale. Infatti ogni impresa è libera di operare in ogni paese del mondo, dove ha più convenienza, in concorrenza con le altre imprese. Questo sistema è reso possibile dalle telecomunicazioni moderne (telefono, fax, internet) e dai trasporti integrati (terra, mare, aria) che hanno fortemente ridotto le distanze di spazio e tempo.
Nell’economia globalizzata agiscono soggetti dotati di “forza” molto diversa:
La globalizzazione non significa uguaglianza economica ma competizione e concorrenza. Spesso le imprese, i paesi più deboli, le forze sociali con poco potere contrattuale, devono soccombere di fronte a forze economiche immensamente più grandi di loro
(testo adattato da G. Paci, Geografia per immagini, vol. 3°, pag. 166, Bologna 2003)
Documento 5 Il secolo cinese di Federico Rampini Nel
febbraio 2005 gli schermi radar dell'economia mondiale hanno avvistato un
sorpasso denso di significato. La Cina è diventata il maggiore consumatore
mondiale di prodotti industriali e agricoli sottraendo questo primato agli
Stati Uniti, che lo detenevano da quasi cent'anni. Un
mese prima, il 6 gennaio, la signora Lan Hui, impiegata trentunenne della
Shell a Pechino, aveva partorito un maschìetto di 3,66 chili. Il bambino
finì sulle prime pagine dei giornali perché, con la sua nascita, la
popolazione cinese raggiungeva ufficialmente un miliardo e 300 milioni. È la dimensione demografica dell'Europa sommata a quella degli Stati Uniti
e moltiplicata per due. Nel
corso dello stesso 2005 il numero di cinesi che hanno accesso a Internet
(134 milioni) raggiunge e supera quello degli americani. La forza del paese è
una combinazione di tutti questi elementi: le grandi dimensioni,
l'inesauribile manodopera a buon mercato, le punte avanzate di modernità. Il
boom cinese, ormai, detta i ritmi e le regole del sistema in cui noi tutti
viviamo. Nessun settore, neanche quello tecnologicamente più avanzato, è
al riparo dalla concorrenza del gigante asiatico: la Cina incarna il più
grande popolo di consumatori, il più vasto bacino di forza lavoro e una
nazione che riesce a eccellere nella ricerca scientifica, nella conquista
dello spazio, nelle biotecnologie. Minaccia o opportunità, non ci si può
permettere di ignorarla.
Elenca tre
record dell’economia cinese
Precisa i tre
fattori della forza della Cina
Secondo la banca
americana Goldman Sachs, nel giro di trent'anni l'economia cinese sarà tre
volte maggiore di quella degli Stati Uniti. «The Economist» ha stimato che
nel prossimo mezzo secolo lo sviluppo della Cina aggiungerà all'economia del
pianeta una ricchezza pari alla scoperta di altre quattro Americhe. Siamo
entrati, in tutti i sensi, nel «secolo cinese». Agli
inizi del Novecento, nessuno poteva immaginare quanto sarebbe cambiata la
vita durante quello che poi sarebbe diventato il «secolo americano». Oggi
è altrettanto difficile prevedere in che modo e fino a che punto la Cina ci
condizionerà negli anni a venire. In ogni caso, dobbiamo prepararci: oggi il
nostro pianeta è molto più «stretto» e interdipendente di quanto non fosse
cent'anni fa.
Descrivi le
previsioni sulla Cina
Quali sono
rispettivamente i secoli “americano e cinese”?
Ci
siamo dovuti abituare ai miracoli asiatici: il Giappone, la Corea del Sud,
Hong Kong e Singapore sono paesi che hanno dimostrato di saper bruciare le
tappe dello sviluppo. Ma la Cina è un caso a sé e di dimensioni tali che il
suo decollo genera shock senza precedenti. Assistiamo a uno di quegli
spostamenti sismici
che
cambiano il corso della storia umana. Mentre trasforma se stessa a una
velocità inaudita, la Cina trasforma inevitabilmente l'intero pianeta. Mai,
nel mondo contemporaneo, un paese emergente ha avuto lo stesso potere di
scuotere i rapporti di forza economici e gli equilibri diplomatici e
militari. Mai si era visto nascere dal nulla, in soli vent'anni, un nuovo ceto
medio urbano di 200 milioni di persone dotate di un potere d'acquisto
«occidentale». La Cina è l'unica potenza che sfida l'influenza degli Stati
Uniti, e questo non solo in Asia, ma anche in America Latina e in Africa. È il
paese che, avendo accumulato oltre 600 miliardi di dollari di riserve
valutarie, esercita un potere cruciale sulle finanze di Washington. Gli
americani sono i primi ad averlo capito. Secondo il «Wall Street Journal»,
in un sondaggio condotto fra i presidenti delle maggiori multinazionali
americane, alla domanda «qual è il singolo fattore che ha il potere di
cambiare il mondo in cui viviamo», la risposta è unanime: la Cina. Il
National Intelligence Council, una divisione della Cia, in un rapporto sugli
scenari del futuro sostiene che la Cina possiede gli stessi requisiti che
cent'anni fa permisero agli Stati Uniti di effettuare il sorpasso
dell'Inghilterra: dimensioni geografiche (è il terzo paese del pianeta),
peso demografico, un mercato interno grande e in espansione, un buon livello
di istruzione, accesso a capitali e tecnologie e, infine, una moneta
sottovalutata. Lo studio della Cia conferma che l'emergere della superpotenza
cinese avrà sulla situazione mondiale un impatto paragonabile all'ascesa
degli Stati Uniti nel secolo scorso. Un riconoscimento emblematico: il suo
maggiore rivale strategico è il primo ad ammettere che questo secolo
apparterrà alla Cina. Quali sono le
aree economiche dell’Estremo Oriente che negli ultimi tempi (prima della
Cina) hanno conosciuto un’accelerazione economica? In quanto tempo
è avvenuto il boom economico cinese? Indica due esempi numerici di questo boom
Quali stime
fanno i servizi americani di “Intelligence” sulla Cina?
…
La Cina suscita anche diverse paure. La più immediata, quella che riempie
le prime pagine dei nostri giornali, è la paura economica. Ed è anche la
meno giustificata. Se in Cina i tessuti filati costano un decimo di quello che
costano da noi, anche in Italia c'è chi riesce a guadagnare disegnando
vestiti che si possono produrre più a buon mercato. Se i computer «made in
China» costano un terzo, ogni agenzia turistica italiana risparmia su un
apparecchio indispensabile per offrire i propri servizi ai clienti del mondo
intero. I benefici della produttività cinese circolano invisiblli in mezzo
a noi, nelle nostre case e nei nostri uffici. ll «prezzo cinese» - cioè
il fatto che questo paese è ormai in grado di produrre pressoché tutto, e
con il 50-70 per cento di sconto - è una realtà economica che non si può
rifiutare. Cercare di sottrarsi alla concorrenza cinese è impossibile,
perché serve anche a noi. Abbiamo smesso da tempo di fabbricare computer
o telefonini. Chiudere alla Cina vorrebbe dire amputarci di una parte del
nostro tenore di vita. Quello sconto cinese che per alcuni di noi è una
minaccia, per altri rappresenta un guadagno (consumatori, imprese che
delocalizzano). Il 59 per cento delle esportazioni «made in China» in
realtà sono «nostre», cioè fabbricate da multinazionali dei paesi
ricchi. Certo, i molti benefit che otteniamo senza neppure saperlo coesistono
con i danni immediati e dolorosi per industrie e lavoratori spazzati via da
una competizione massacrante … Oltre
all'ossessione del «made in China», si individuano altre paure ben più
legittime. A questo ritmo di sviluppo, tra vent'anni la Cina avrà 200
milioni di automobili. Già oggi lo smog cinese contamina l'atmosfera di tutta
la Terra: polveri tossiche di Shanghai vengono rintracciate nell'aria che si
respira in Europa e in America. Per soddisfare il bisogno di legname
dell'economia cinese, ogni anno in Indonesia vengono distrutte foreste pari
alle dimensioni della Svizzera. L'impatto sulle risorse naturali del pianeta
è una delle incognite più gravi del nostro futuro. Il
regime politico di Pechino rappresenta un'altra seria ragione di
preoccupazione. Se nei prossimi anni non avverranno cambiamenti profondi,
siamo destinati ad avviarci verso una situazione inedita nella storia
contemporanea: per la prima volta la più grande economia del pianeta non
sarà governata da un sistema democratico. Chi oggi mal sopporta l'egemonia
americana rischia di fare i conti, in un futuro molto vicino, con un'altra
superpotenza in cui le decisioni vengono prese senza trasparenza, senza
contropoteri interni, senza gli anticorpi di un'opposizione, di una stampa
libera, di una magistratura indipendente…
Qual è la prima
forma di paura che la Cina esercita su noi occidentali? Secondo l’autore
questa paura non è ragionevole. Perché?
Qual è la seconda
forma di paura? Descrivila.
Indica la terza
forma di paura? Delle tre qual è la più temibile?
Fai
esempi del miracolo economico del Giappone.
Secondo
l’autore come si spiega?
In
forma molto schematica traccia la giornata tipo di Taro
Spiega
le differenze principali tra il sistema scolastico giapponese ed il
nostro.
Analizza
il rapporto giovani / anziani basandoti sull’episodio del parco di
Harajuku
Dai una spiegazione per il titolo che è stato scelto per la corrispondenza del giornalista
La stanza è immersa nel buio e solo una lampada snodabile da tavolo
proietta una chiazza di luce sopra la scrivania. Nel piccolo ovale illuminato,
la mano di un bambino giapponese traccia geroglifici con il pennellino da
calligrafia, silenziosamente.
- La prego, non lo distragga, - mi scongiura a bassa voce la madre, con
una nota di durezza più forte della sua cortesia di ospite.
La manina continua a disegnare i segni dei geroglifici, che sono le
lettere dell' alfabeto giapponese, e la madre chiude morbidamente la porta
alle nostre spalle, per tenere lontani i rumori e le voci degli ospiti nel
soggIorno.
- Mi scusi, ma che sta facendo suo figlio?
- Ma come «che sta facendo », - mi risponde stupita - i compiti per
domani, no?
- I compiti? - Guardo l'orologio: è l'una passata. L'una di notte. -
E quando dorme? - mi permetto di chiedere. - Dorme quando può, - taglia
corto la signora, gentilmente, ma fermamente, spingendomi fuori dalla camera
del bambino. Benvenuti in Giappone.
Ormai sappiamo tutti, anche senza volerlo, che il Giappone è diventato
una «grande potenza industriale», una nazione che produce enormi quantità
di cose bellissime e moderne vendute in tutto il mondo.
Anche chi non si è mai mosso di un chilometro dalla propria città e
dalla propria casa, è stato in qualche modo «toccato» dalle lunghe mani
della potenza giapponese.
L'orologio digitale che portiamo al polso, il televisore che guardiamo
a casa, la radiolina portatile, il registratore, lo stereo, il motorino
elettrico che fa funzionare l'aspirapolvere, il cervellino elettronico nascosto
che regola il motore dell'auto, sono con ogni probabilità prodotti
giapponesi, anche quando 1'etichetta o la marca sembrano diversi.
Nomi come Sony, Honda, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Seiko, Citizen,
Sanyo, Toyota, Nintendo, solo per citarne qualcuno, sono entrati nel
vocabolario e nelle case di tutto il mondo, dall'Italia alle Filippine, dalla
Cina alla Russia.
Come trent' anni or sono si diceva dell'Italia, così oggi si parla di
un «miracolo giapponese». Una nazione che nella seconda guerra mondiale
aveva perduto due milioni di soldati e un milione di civili, che aveva
visto la sua capitale Tokyo andare interamente in fiamme in una sola notte di
bombardamenti incendiari (morirono 180.000 persone) e altre due, Hiroshima e
Nagasaki, polverizzate in pochi secondi dalla bomba atomica, è divenuta in
quarant'anni appunto una «grande potenza» industriale.
E al centro di questo «miracolo» c'è quella piccola chiazza ovale di
luce proiettata sulla scrivania di un bambino alla una di notte. Ci sono la
fatica, l'impegno, la disciplina di un popolo che per uscire dalle macerie -
e dalla vergogna - di una guerra, non ha chiesto aiuto alla fortuna o
elemosine agli altri paesi, ma ha pescato nella sola risorsa che in Giappone
abbonda: la capacità dei singoli di sacrificarsi per il bene di tutti.Un
sacrificio che comincia dai bambini: in quella stanzetta semibuia dove vedevo
la manina tracciare le parole alla una di notte.
Come ti chiami? - chiesi al bambino che faceva i compiti.
- Taro.
- Quanti anni hai?
- Undici. E mezzo, - si affrettò ad aggiungere.
- Che classe fai?
- La sesta, - l'ultima delle sei classi elementari, seguite poi da tre
medie, obbligatorie, e tre di scuola superiore .
Mi racconti come passi la tua giornata, Taro?-
Si sveglia alle 6 e30 del
mattino, e non c'è bisogno di un grande matematico per fare subito il conto:
se alla una è ancora sveglio a fare i compiti, non dorme più di cinque ore
per notte. Una pacchia. - Ma non hai sonno durante il giorno?
- Beh si, molto, - rise Taro scuotendo il testone fitto di capelli
dritti e neri, - ma il sonno mi passa quando penso a tanti dei miei compagni
di scuola che si alzano alle 5 del mattino per fare ancora un po' di compiti
e per ripassare le lezioni. La mia mamma mi lascia dormire di più. - Una
santa, quella donna.
Taro frequentava una scuola privata, costosa, scelta con cura dalla
madre e pagata con grande sacrificio dalla famiglia che non era certo ricca ma
sa che non basta andare bene a scuola, per fare carriera domani. Bisogna
frequentare le scuole migliori, fin dall' asilo, per essere ammessi alle
università migliori e poi avere i buoni posti di lavoro.
- Per arrivare a scuola devo prendere due metrò, in tutto sono 50
minuti di corsa.
- Che seccatura.
- Ma no, ci divertiamo un sacco, corriamo sui marciapiedi, ci diamo
spinte, qualche volta pestiamo i piedi alle gente nei vagoni del metrò. -
Talmente pieni, a quell'ora, che sul marciapiede ci sono incaricati speciali
che devono letteralmente spingere i passeggeri dentro le porte per farcene
stare qualcuno in più, come si fa con le valigie nel portapacchi quando si
parte per il mare.
La scuola comincia alle 8 e 50 e va avanti per quattro ore prima
dell'intervallo. Ogni giorno, si fanno due ore di lingua giapponese, che è lo
studio, durissimo, dei kanji, i caratteri complicatissimi
dell'alfabeto cinese che anche i giapponesi usano. È uno studio che comincia
in prima elementare e in pratica non finisce mai. Solo per leggere un
giornale, è necessario conoscere circa 1500 di questi «ideogrammi» e una
persona colta, un avvocato, uno scrittore, un medico, deve impararne 20.000.
Pensate: per leggere un libro come questo in giapponese, dovreste
conoscere 20.000 lettere. E voi vi lamentate.
Per fare un confronto, nel nostro alfabeto latino, il vecchio, caro «A,
B, C», ci sono solo 21 lettere, 26 se vogliamo aggiungere le lettere entrate
nell'uso anche da noi, come «j», «k», «X», «y» e «w».
Dopo le due ore immancabili di giapponese e dello studio - tutto a
memoria - di migliaia e migliaia di geroglifici, arriva un'ora di
matematica, tutti i giorni, severissima. Anche per questo gli scolari
giapponesi risultano sempre fra i migliori nel mondo quando si fanno
confronti e concorsi internazionali di matematica. Poi c'è un'ora di «scienze
sociali», materia un po' vaga sotto la quale si fanno storia, geografia, politica,
etnologia che è lo studio dei popoli.
A mezzogiorno e mezzo arriva l'obento, la colazione che passa
la scuola nel refettorio.
Riso con pesce, riso con carne, riso con verdure, riso con alghe, riso
con questo e riso con quello, sempre riso, che è la base di tutta
1'alimentazione giapponese, come per noi è la pasta.
- E non ti scocci del riso, Taro?
- Si, mi piacciono più gli spaghetti e la pizza, - confessò, ma subito
aggiunse: - Non lo dica alla mamma, per favore. - Giuro.
Digerito il riso, arrivano altre due ore di scuola al pomeriggio. Un'ora
di - indovinate? - giapponese, un' ora di scienze. Poi a casa.
- A casa? - mi guardò stupito Taro. - No, no, prima di uscire dalla
scuola dobbiamo naturalmente pulire. Scopiamo i pavimenti delle aule,
mettiamo in ordine i gabinetti, spolveriamo i banchi ...
- Aspetta un momento. Come sarebbe a dire «puliamo i gabinetti»? Gli
scolari stessi puliscono la propria scuola?
- Certo, - mi rispose T aro tornandomi a guardare come se fossi matto, -
è ovvio, perché? Gli scolari nel suo paese non puliscono la scuola prima di
uscire? - E già molto se non la sporcano, ma andiamo avanti.
Tra giapponese, matematica, riso e pulizie si fanno le 4 del pomeriggio.
Gli scolari si rituffano nel metrò, cambiano treno, camminano (nessuno
va a prendere i figli in auto, non nel traffico congestionato di Tokyo) e
tornano allegramente a scuola. Anzi, al doposcuola.
Alle 5 del pomeriggio comincia lo juku, il corso di ripetizioni
integrative, a pagamento, al quale tutti i genitori che possono, o che
vogliono, mandano i figli. L'« obbiettivo» è prepararli fin da piccoli,
fino dalle elementari, alla prova cruciale che deciderà della loro vita di
adulti: 1'esame di ammissione alle università.
Tutti gli ordini e i gradi di scuole private, dalle elementari fino
all'università hanno esami di ammissione per entrarci. Quelle pubbliche, di
Stato, no, e ci si entra per forza. Nessuno viene mai bocciato, tutti sono
promossi e, se la cosa vi sembra una cuccagna, aspettate.
Poiché tutti sono promossi (a meno di gravi infrazioni disciplinari
che possono causare l'espulsione) i voti e i diplomi non contano nulla. Quello
che conta è «dove» questi voti e questi diplomi sono stati presi, in quale
scuola. Se la scuola è buona, famosa, severa, i voti e i diplomi conteranno
per andare avanti ed essere accettati in altre buone scuole. Se la scuola è
mediocre, facile, di cattiva fama, anche i suoi diplomi e voti saranno
considerati scadenti e si potrà entrare solo in altre scuole scadenti.
Ma neppure un «buon» diploma basta. Occorre comunque passare
attraverso la porticina strettissima e crudele degli «esami di ammissione».
Da noi, in Italia, gli esami si fanno soprattutto per «uscire», alla fine.
In Giappone, gli esami si fanno per «entrare». E sono esami terribili, senza
spazio per improvvisazioni o colpi di fortuna. Soprattutto gli ultimi, gli
esami di ammissione alle grandi università, costringono i candidati a
rispondere per iscritto a centinaia e centinaia di domande concrete, fatti,
date, formule, nozioni e i voti vengono dati contando il numero delle risposte
corrette e di quelle sbagliate. Punto e basta. Chi sa di più passa. Chi sa di
meno torna indietro.
I doposcuola - gli juku - non fanno altro che imbottire la
testa degli allievi, fino da quando hanno cinque o sei anni, con altre
nozioni, trapanandogli il cervello con sempre più informazioni. Ai più
bravi, gli gli insegnanti mettono una fascia bianca attorno alla fronte,
come simbolo di sacrificio, dedizione, vittoria, ccme la fascia che
portavano i kamikaze, i piloti degli aerei-suicida che cercavano di
colpire le navi nemiche americane, precipitandovi sopra e uccidendosi.
Al primo cenno di esitazione, alla prima caduta dei voti, gli tolgono la
fascia. A Taro fu tolta proprio pochi giorni prima che gli parlassi io. - Che
è successo? gli chiesi. - Avevo perso un giorno di lezione, una domenica,
- mi rispose abbassando gli occhi neri dentro una faccia arrossata dalla
vergogna, - perché ero andato a sciare con mio padre. Chi va a sciare non
è un eroe e non merita la fascia del kamikaze, mi aveva detto il maestro.
Meglio uno sciatore vivo che un kamzkaze morto, .. secondo me, ma io
sono italiano e Taro era disperato sul serio.
Il doposcuola di preparazione agli esami funziona sette giorni alla
settimana, 365 giorni l'anno, ogni anno. E dura quanto uno vuole.
Le mamme tenere di cuore vanno a prendere i loro figli alle 9 di sera,
dopo quattro ore di ripetizioni, e li portano a casa per la cena, come fa la
mamma di T aro.
Altre, le «dure», quelle che i bambini chiamano con terrore le kyozku
mama, le «mamme-drago», gli portano un cestino con qualcosa da mangiare
e li lasciano sui banchi fino alle 11 e 30 di sera, quando anche gli
insegnanti finalmente si stancano e chiudono.
- lo sono fortunato, - mi spiegò T aro, - perché ogni sera torno a
casa e posso guardare la televisione fra le 9 e le 9 e mezza, prima di
rimettermi a fare i compiti. Però quando guardo la televisione ho un po' di
rimorso ... -
Una sciata ogni tanto alla domenica e una mezz' ora di televisione al
giorno. Questo Taro è un gran lazzarone, no? Ma almeno non diventa pazzo.
Altri, i figli delle «mamme-drago» rischiano la salute mentale, qualche
volta la vita.
Ogni anno, quando si avvicina il momento degli esami di ammissione,
quello che i ragazzi chiamano «l'inferno», qualcuno non ce la fa più e si
toglie la vita. Purtroppo, i suicidi degli scolari che si arrendono, o che
hanno capito di non essere abbastanza bravi sono frequenti. Per fortuna, in
Italia non è cosl, o io sarei già morto da molti anni.
Oppure, la grande disciplina, la pressione per far bene a tutti i costi,
ogni tanto esplode come una caldaia. Capita che classi intere,
improvvisamente, inaspettatamente, diano fuori di matto e si mettano a sfasciare,
senza ragione apparente, le classi e le scuole che hanno fino a un momento
prima amorevolmente pulito. I pediatri e gli psicologi dicono che la pressione
mentale, lo «stress» come si dice adesso, su questi bambini e ragazzi è
assurda: - Vengono da me ragazzi di dieci o undici anni che soffrono di
esaurimento nervoso, di insonnia, addirittura di ulcera gastrica o di
emorroidi - (le malattie che di solito colpiscono gli adulti sedentari e con
molte preoccupazioni) mi raccontò un pediatra.
La scuola è tutto, l'inizio e la fine di ogni pensiero e di ogni
giornata, per chi vuole andare avanti nella vita giapponese. Quando le società
giapponesi di ricerca demoscopica, quelle che fanno i sondaggi di opinione e
chiedono alla gente che cosa pensa, domandano agli scolari dell'età di Taro,
nove, dieci, undici anni, quali siano le colpe più tremende di cui si possa
macchiare un ragazzo, le risposte sono sempre queste: primo: marinare la
scuola. Secondo: disobbedire a un ordine dell'insegnante. Terzo: dire una
bugia all'insegnante. Quarto: non fare i compiti.
Per chi non è giapponese è difficile capire il senso di responsabilità,
la dedizione al dovere che impregna questa gente ammirevole e i suoi figli.
Quando studiano e quando si divertono.
La domenica, per esempio, in un bellissimo parco nel centro di Tokyo
chiamato Harajuku, gruppi di ragazzi e di ragazze si ritrovano per
suonare all'aperto, per ballare, per esibirsi. E una fiera della follia, con
diecine e diecine di complessini «rock» che suonano tutti insieme e
contemporaneamente all'aperto, armati di chitarre, altoparlanti e generatori
elettrici per alimentare i loro amplificatori spaccaorecchie. Fianco a
fianco ci sono «punk» dai capelli tosati a punte come la Statua della Libertà
e «metallari» coperti di catene e di borchie. Gruppetti con i capelli
gialli, «skinheads» con le teste rapate e ragazzine con minigonne e
magliette coperte da scritte offensive, parolacce, immagini oscene. Se non
fosse perché sono tutti, inconfondibilmente, giapponesi, questi apparenti
«duri del rock» potrebbero essere inglesi, americani, tedeschi, italiani.
Ma ogni somiglianza, e ogni sospetto che quell'aspetto truce nasconda
cattive intenzioni, si dissolvono come nebbia al sole quando scende la sera e
i ragazze e le ragazze di Harajuku tornano a casa.
Come a un segnale militare, i complessi cominciano a smontare le loro
fragorose attrezzature. Ripongono le chitarre e gli amplificatori nelle
casse. Si tolgono le parrucche gialle, arancioni, viola. Si puliscono la
faccia con cura e con la stessa cura fanno pulizia nella zona di parco che
avevano occupato, cartaccia dopo cartaccia, sacchetto dopo sacchetto. Quando
se ne vanno, il parco di Harajuku, che è pubblico, dunque appartiene a
tutti ed è responsabilità di tutti, torna pulito come se un esercito di
giardinieri e di netturbini lo avesse passato al pettine.
Le ragazze corrono nella più vicina stazione della metropolitana, si
chiudono nei gabinetti ed estraggono dalle loro borse i vestiti. In pochi
minuti spariscono le truccature «scandalose», scompaiono le minigonne
vertiginose, le magliette e le felpe «offensive », le collane, le catene e
la chincaglieria che portavano al collo e alle braccia. In una metamorfosi
fulminea e impressionante, le spregiudicate, aggressive ragazze di Harajuku
escono dai gabinetti sotterranei trasformate in educande, ragazze timide e
tutte uguali, nelle gonne a piegoline, nelle camicette bianche coi colli
alla marinaretta, nelle scarpe basse di vernice coi calzettoni bianchi.
Vestite per tornare a casa.
A noi questa metamorfosi può sembrare ipocrisia, menzogna. Per loro, è
un segno di rispetto per gli anziani, per i genitori, per la collettività
che si sentirebbe offesa da quell'abbigliamento “punk”.
- Se mio padre e mia madre soffrono perché mi vesto da metallara,
perché dovrei farli star male? - mi spiegò un giorno con grande semplicità
Yukiko, una delle ragazze di Harajuku. - Che cosa ci guadagno, io, a
farli soffrire per una maglietta? O a lasciare il parco pubblico sporco di
cartacce?
Forse non sono poi cosi matti, questi giapponesi.
Documento 7 Gli
anni della terza rivoluzione industriale
L'industrializzazione:
la più grande rivoluzione del nostro tempo.
Poco più di 10000 anni fa una parte della popolazione del mondo imparò a
coltivare la terra e a produrre cibo: fu la rivoluzione neolitica. Da allora
l'agricoltura rimase per millenni l'attività principale - se non l'unica
- degli esseri umani.
La
situazione cominciò a cambiare solo a partire da due secoli fa, quando
ebbe inizio la rivoluzione industriale, la più grande rivoluzione del nostro
tempo. Alla debole energia degli uomini e degli animali, a quella
dell'acqua e del vento si sostituirono l'energia del carbone, del vapore,
e poi del petrolio, dell'elettricità, dell'atomo. Fu un cambiamento
radicale e irreversibile. Nei paesi industrializzati uomini e donne ebbero
a disposizione comodità impensabili in precedenza (illuminazione,
riscaldamento, abitazioni confortevoli, abiti a buon mercato, trasporti e
comunicazioni rapidissime...); fame e fatica fisica furono molto ridotte;
si diffuse l'istruzione; invenzioni e scoperte resero più lunga la vita
umana.
Elenca le due rivoluzioni economiche
compiute dalla specie homo sapiens sapiens, localizzale nel tempo e indica
gli effetti comuni a questo tipo di rivoluzione.
La
terza rivoluzione industriale: calano gli operai .
In età industriale anche l'agricoltura si modernizzò. Nei campi grandi
macchine agricole (mietitrici, trebbiatrici, trattori...) sostituirono il
lavoro umano, nuove tecniche resero la terra più produttiva. Se in età
preindustriale un contadino poteva produrre cibo per 2, al massimo per 3
persone, un suo discendente in età industriale poteva sfamarne fino a 60.
Poiché le macchine riducevano il bisogno di manodopera, molti agricoltori
abbandonarono i campi. Così, quanto più l'agricoltura progrediva, tanto
più calava il numero di contadini.
Negli
ultimi decenni del Novecento ciò che in passato era accaduto
all'agricoltura si è ripetuto anche per l'industria. Come già sappiamo,
con l'automazione e l'informatica l'economia è entrata in una nuova fase,
la terza, della rivoluzione industriale. E quanto più una società si
industrializza, tanto meno ha bisogno di manodopera, perché grazie all'automazione
e all'uso di robot industriali le aziende riescono a produrre di più anche
riducendo il numero degli operai. Così il numero degli addetti all'industria
cominciò a diminuire.
Comune alle rivoluzioni industriali è
una diversa distribuzione della popolazione attiva nelle tre attività
fondamentali dell’economia. Descrivi i cambiamenti nel passato e nel
presente e indica le cause comuni.
La
svolta degli anni Settanta. A questo
calo però contribuirono anche altri fenomeni - negativi - che colpirono
in quel tempo l'economia dei paesi industrializzati. La svolta ebbe inizio
negli anni Settanta del Novecento, dopo un trentennio - i Trenta Gloriosi
- di incessante ripresa economica.
Come
già sappiamo i decenni 1970 e 1980 furono caratterizzati da due forti
aumenti del prezzo del petrolio, imposti nel 1973 e nel 1980 dai paesi
produttori. Per la grande importanza del petrolio nel funzionamento di
industrie e trasporti, il rincaro di questo prodotto spinse al rialzo anche
quello di tutte le altre merci. Si produsse così un'ondata di inflazione
che rese tutti un po' più poveri. I consumi diminuirono e con essi anche
la produzione industriale rallentò.
Finita la seconda guerra mondiale,
iniziò l’epoca d’oro del capitalismo mondiale caratterizzata da alti
tassi di crescita del PNL. Quanto durò quest’epoca? Come sono chiamati
quegli anni dagli storici dell’economia?
Descrivi la crisi del capitalismo degli
anni ’70 costruendo uno schema di relazione in cui siano nel giusto ordine
le seguenti informazioni: impoverimento generale, rincaro di tutte le altre
merci, rincaro del petrolio, stagnazione.
Gli storici dell’economia chiamano tale
crisi come un esempio di stagflazione. Cosa indica il termine? (Rispondi
alla domanda pensando alle due parole da cui proviene il neologismo)
Le
industrie reagiscono alla crisi. Al
periodo di crisi che seguì le industrie reagirono in modi diversi. Alcune
furono costrette a fallire. Altre trasferirono parte delle lavorazioni
industriali in paesi stranieri dove il costo del lavoro (cioè il salario
degli operai) era più basso. Altre ancora introdussero nuove tecnologie,
come l'utilizzo di robot comandati da computer. Un robot costa molto, ma
lavora 2 o 3 volte di più di un dipendente in carne e ossa, non si stanca,
non si ammala, non va in ferie, non fa scioperi: anche l'operaio meno
pagato costa di più della macchina che lo sostituisce.
Tutto
ciò determinò una rapida diminuzione dei posti di lavoro e molte industrie
si svuotarono di operai, soprattutto nei settori di più antica industrializzazione,
come il tessile o il siderurgico. Contemporaneamente si indebolivano i
potenti sindacati operai, la cui forza si basava proprio sulle forti
concentrazioni di lavoratori nelle fabbriche.
Un modo di reagire alla crisi è detto
“delocalizzazione”. A cosa si allude?
L’altro modo di reagire fu l’automazione
dei processi produttivi attraverso l’impiego di robot.Perché un robot è
preferibile ad un operaio in carne ed ossa?
Perché diminuisce la forza contrattuale
dei sindacati?
Una
disoccupazione elevata e di lungo periodo.
Di solito la
disoccupazione
tende a crescere in condizioni di crisi e a calare con la ripresa. Ma
la disoccupazione che fece la sua comparsa negli anni Settanta non seguì
questa regola e continuò a mantenersi elevata anche nelle fasi di crescita
economica.
Anzi,
negli ultimi decenni del Novecento la disoccupazione restò
costantemente più alta di quanto fosse prima del 1973 e molti dei posti
di lavoro perduti non furono ricuperati mai più. Da cosa può derivare
questo preoccupante fenomeno? Secondo gran parte degli economisti la
disoccupazione dei paesi industriali avanzati è prodotta dalla
trasformazione
profonda che attraversa l'intero sistema economico in questo momento di
passaggio dalla seconda alla terza rivoluzione industriale.
In
termici economici questo tipo di disoccupazione che non scompare neppure in
caso di ripresa si chiama disoccupazione strutturale. Le statistiche
dicono che essa colpisce più duramente giovani, donne e operai poco
qualificati.
Perché la disoccupazione è considerata
strutturale e di lungo periodo? Chi ne è particolarmente colpito?
Cambia
il mercato del lavoro.
Si chiama mercato del lavoro il rapporto fra la domanda (da parte del
datore di lavoro) e l'offerta di lavoro (da parte del lavoratore). Se la
domanda è alta, tutti (o quasi) troveranno lavoro. Ma se l'offerta supera
di molto la domanda o non corrisponde alla domanda (se, ad esempio, c'è
domanda di informatici e si offrono tranvieri) alcuni resteranno
disoccupati. Oppure dovranno accontentarsi di lavori più scomodi o meno
pagati, meno sicuri, di breve durata.
A
partire dagli anni Settanta, mentre la disoccupazione si alza e il potere
dei sindacati diminuisce, molti lavoratori si trovano appunto in
quest'ultima situazione.
Si
comincia a sentir parlare di «mobilità» e di «flessibilità» del
lavoro. «Mobilità» significa che un lavoratore può essere spostato da un
settore di lavorazione a un altro o anche da un'azienda a un'altra distante
territorialmente.
«Flessibilità»
che il lavoratore deve essere disposto ad adattare il suo orario di lavoro
alle esigenze dell'azienda. Non più, ad esempio, 40 ore settimanali dì
lavoro per lutto l'anno, ma una media di 40 ore per settimana, con aumento
o diminuzione del carico orario settimanale secondo le necessità
aziendali.
Per
gli imprenditori infatti è vantaggioso lasciar libera la manodopera se il
lavoro scarseggia e poterne disporre quando ce n'è bisogno. Per i
lavoratori invece può esserlo molto meno, specialmente per quelli che nei
periodi di forzato riposo non ricevono salario.
Indica e spiega le due caratteristiche
richieste al lavoro nella attuale fase
Dal
lavoro garantito alle occupazioni precarie e a termine.
Cambiano le caratteristiche del posto di lavoro. Il «posto fisso» a
tempo pieno, che garantiva ai dipendenti la sicurezza del lavoro, la
pensione, la previdenza, tende a diventare sempre più raro e limitato alle
aziende pubbliche.
Si
diffondono invece lavori a tempo parziale (part time), lavori occasionali,
temporanei, lavori con contratto di formazione. In questi casi la sicurezza
del posto di lavoro è scarsa e mancano a volte le coperture pensionistiche
e previdenziali. Si assiste anche alla rapida crescita del lavoro sommerso
o «lavoro nero», che sfugge ad ogni controllo e sfrutta - non solo nel
Terzo mondo - manodopera femminile e minorile o manodopera immigrata,
sottopagata e priva di tutti i diritti. Soprattutto nelle situazioni di
lavoro
sommerso vengono spesso trascurate le fondamentali precauzioni per la
sicurezza sul lavoro (uso di caschi, di maschere, di imbragature...): anche
da questo deriva l'inquietante aumento di infortuni sul lavoro.
Riaffiora nelle nuove condizioni una
questione ritenuta ormai superata: la questione sociale. Descrivine i
diversi aspetti.
Si
espandono i servizi, cioè il settore terziario. La
contrazione di posti di lavoro nell'industria è accompagnata
dall'espansione dei servizi. Il settore dei servizi, detto anche terziario
(dopo quello agricolo e industriale che sono chiamati rispettivamente
primario e secondario) contiene al suo interno attività numerose e
diversissime per retribuzione, prestigio sociale, livello di preparazione
richiesta, in pratica tutte quelle che non fanno parte dell'agricoltura e
dell'industria. Lavorano nel terziario, ad esempio, commercianti e
camionisti, medici e postini, benzinai e insegnanti, assicuratori, bancari,
scienziati, cantanti, calciatori, addetti al centralino, animatori in
villaggi turistici, personale dei grandi magazzini... il gruppo emergente è
costituito da coloro che creano e gestiscono la conoscenza - in America li
chiamano knowledge workers ,gli uomini e le donne le cui idee
alimentano la società informatica.
Tuttavia proprio
la rivoluzione dell'informatica minaccia di far scomparire posti di lavoro
anche nel settore dei servizi (ad esempio, nelle banche, nelle
assicurazioni, nelle telecomunicazioni. ..) e dagli anni Novanta molti
lavoratori del terziario non sono più così sicuri del loro lavoro e del
loro futuro.
Sai dire perché l’attuale società si
dica postindustriale? Qual è il settore in espansione? Chi vi lavora? Fai
esempi di nuove “fabbriche”
Nel testo si allude all’importanza del
“capitale umano”. In che occasione?
Fordismo
e Toyotismo. Il fordismo
fu introdotto nel 1914 da H. Ford nella sua industria automobilistica di
Detroit.
Ford
ebbe l'idea di portare automaticamente davanti agli operai i pezzi di
automobile da montare, allo scopo di risparmiare movimenti superflui e di
guadagnare tempo prezioso: era la prima catena di montaggio.
Dalla
catena di montaggio le automobili uscivano in milioni di esemplari
perfettamente identici fra loro (produzione in serie) avevano prezzi
accessibili ed erano destinate al mercato di massa. Alla catena di montaggio
gli operai, isolati uno dall'altro, eseguivano un lavoro monotono e
ripetitivo, ma ricevevano un buon salario. I sindacati erano potenti e
difendevano gli interessi dei lavoratori.
Negli
anni Settanta e Ottanta l'arresto della crescita e la rivoluzione
informatica spinsero le industrie a rinnovarsi, introducendo nuovi metodi
di lavoro. Uno di questi fu il toyotismo sperimentato per la prima volta
negli anni Cinquanta da una azienda automobilistica giapponese, la Toyota
(da cui il nome).
I
dipendenti della fabbrica giapponese sono tutti forniti di un alto livello
di istruzione. Essi non si limitano ad eseguire monotonamente azioni
meccaniche, ma vengono sollecitati a prender parte alla progettazione e a
fare proposte per migliorare la lavorazione.
La
manodopera non è isolata, ma lavora a piccole squadre, dette gruppi di
qualità, che sono responsabili di tutto il ciclo di lavorazione, dalla
regolazione
delle macchine al controllo della qualità. All'interno dei gruppi ciascuno
collabora con gli altri in base alle proprie conoscenze e alla propria
esperienza. Le scorte di magazzino sono ridotte al minimo per non tener
bloccati dei capitali.
La
produzione avviene su ordinazione e all'ultimo momento (just in time).
Macchine modernissime permettono di adeguarla ai bisogni e ai
capricci del mercato.
Descrivi le due organizzazioni del lavoro
compilando la seguente tabella:
|
indicatori |
Fordismo |
Toyotismo |
|
Azienda
in cui fu applicato per la prima rivolta |
|
|
|
È
simbolo di quale rivoluzione industriale? |
|
|
|
Tipo
di produzione e caratteristiche dei prodotti finiti
|
|
|
|
Organizzazione
del lavoro
|
|
|
|
Tipo
di forza lavoro e di abilità richieste
|
|
|
New
economy.
La nuova economia è l'aspetto più appariscente della terza rivoluzione
industriale basata sul computer. Essa produce di preferenza beni
«immateriali», privi di peso e di fisicità, come i software informatici o
vari tipi di servizi per il pubblico. Via Internet, ad esempio, si possono
trovare informazioni di ogni tipo, consultare archivi e biblioteche,
prenotare alberghi e biglietti d'aereo, cercare un posto di lavoro,
acquistare libri, dischi, videocassette, eseguire operazioni bancarie,
pagare tasse...: il tutto a prezzi più convenienti che per altre vie.
Nella
new economy la componente più importante è il contributo di intelligenza
e di sapere umano speso in progettazione e ricerca; è, come dicono gli
Americani, l'energia della mente (in inglese, brainpower).
Per
questo i paesi che puntano sulla nuova economia devono anzitutto investire
sul sistema scolastico, sull'istruzione dei giovani: senza una buona scuola
non si può costruire la società del sapere informatico.
Le merci più caratteristiche della terza
rivoluzione industriale non appartengono alla sfera dell’ “hard” ma a
quello del soft. Non sono beni materiale ma immateriali. Riporta gli esempi
che fa il testo e altri che puoi ricavare dai consumi più tipici tuoi o
della tua famiglia
Documento 8 Confronto tra le tre rivoluzioni industriali
Indicatori |
Prima rivoluzione |
Seconda rivoluzione |
Terza rivoluzione |
|
Decollo temporale |
|
|
|
|
Stato guida |
|
|
|
|
Fonti energetiche e materie prime
|
|
|
|
|
Materiali
|
|
|
|
|
Settori trainanti
|
|
|
|
|
macchine |
|
|
|
|
trasporti |
|
|
|
|
Attivita prevalente |
|
|
|
|
Tipologia prevalente beni prodotti
|
|
|
|
|
Organizzazione del lavoro
|
|
|
|
Documento
9 Il
lavoratore del 2000. Leggi
il testo e completa la mappa concettuale prelevando le informazioni adeguate
Quali
caratteristiche saranno quindi richieste al lavoratore negli anni a venire?
Alcune di esse sono già oggi indispensabili: professionalità (cioè
buona preparazione culturale di base, conoscenze e capacità specifiche), intraprendenza,
senso di responsabilità, creatività. Viene anche richiesto di saper
lavorare in gruppo, collaborando con soggetti diversi (centri studi,
università, altre aziende o semplicemente con i colleghi che perseguono gli
stessi fini produttivi), prendendo decisioni con gli altri e assumendosi
responsabilità individuali e collettive. A questo tipo di requisiti se ne
aggiungono altri determinati dai cambiamenti nei metodi di lavoro, dal
continuo mutare delle conoscenze e dei prodotti, dalle dinamiche aziendali,
dalla internazionalizzazione della produzione e dei mercati. Iniziamo da
quest'ultimo aspetto.
Il processo di unificazione dell'Europa è ormai in
fase avanzata: sono state abolite le dogane e le merci circolano liberamente,
i cittadini possono circolare senza restrizioni tra gli Stati membri, presto
avremo una moneta unica, l'Euro. Le imprese italiane sono sempre più
impegnate a collaborare con quelle del resto d'Europa, ma anche a far loro una
spietata concorrenza. A sua volta il sistema produttivo europeo compete e
collabora con quello americano e quello asiatico. Prodotti italiani possono
essere costruiti con macchinari americani, contenere parti fabbricate in Asia
ed essere venduti in Europa o in altri continenti. Analogamente prodotti di
imprese americane possono essere fabbricati in Asia e consumati in Italia
(pensa alle tue scarpe da ginnastica!). Tutto ciò produce la necessità di
instaurare continui rapporti fra metodi di lavoro differenti lingue e
culture diverse.
Ecco allora che, a coloro che desiderano inserirsi
in questo sistema produttivo “mondializzato”, viene richiesta la conoscenza
di almeno una lingua straniera, la capacita di comprendere e adattarsi
a modalità produttive diverse
dal/a propria, la disponibilità a capire e confrontarsi con culture
diverse, soprattutto se il tipo di lavoro richiede di soggiornare o
addirittura di risiedere all'estero.
In quest'ultimo caso viene richiesto al lavoratore
anche un altro tipo di caratteristica, quella di essere disponibile a
spostarsi dal luogo in cui vive o del quale è originario per lavorare
altrove; gli si chiede di accettare una certa mobilità. Ciò accade
non solo per i motivi già accennati, ma anche a causa di ristrutturazioni
aziendali dovute a innovazione tecnologica o in seguito all'apertura di
uffici e filiali in nuove aree.
Sempre a proposito di mobilità, occorre ricordare
che recentemente sono stati
stipulati accordi tra governo, organizzazioni sindacali e imprenditoriali,
che prevedono una nuova forma di occupazione, il lavoro interinale: i
lavoratori non sono più assunti dalle aziende. ma da agenzie per
il lavoro, le quali “affittano" le prestazioni del lavoratore a
questa o quell'azienda in un luogo o in un altro, per il tempo necessario a
svolgere un determinato lavoro.
Spesso, nel caso di innovazione tecnologica, al
lavoratore viene richiesto di riqualificarsi, cioè di imparare a
svolgere mansioni diverse da quelle esercitate fino a quel momento. Questo
accade anche quando un'azienda modifica il tipo di prodotti per adattarsi alle
richieste del mercato o per partecipare a nuove produzioni. oppure quando
cessa l’attività e viene assorbita da una concorrente o all'interno di un
gruppo produttivo. Al lavoratore si chiede di saper cambiare, di aggiornarsi,
di adattarsi alla nuova realtà, si richiede flessibilità.
Preparazione
culturale. professionalità, affidabilità. capacità di lavorare in gruppo,
visione internazionale del lavoro. mobilità, flessibilità sono le
caratteristiche richieste al lavoratore del 2000. Sarà sufficiente rispondere
a questi requisiti per trovare lavoro? Certamente. chi possiederà, tutte o in
buona parte queste qualità sarà avvantaggiato rispetto agli altri.
Purtroppo, però, non tutti troveranno in fretta un lavoro, molti non
troveranno l’impiego preferito, e qualcuno potrebbe dover aspettare a lungo
un'occupazione.
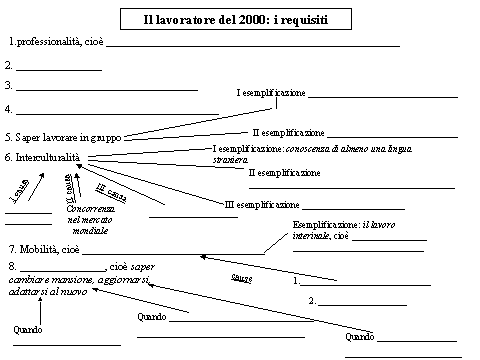
Documento
10 Lavoro
minorile oggi: facciamo il punto! Svolgi la traccia proposta
scrivendo un testo espositivo (presentazione del problema, descrizione dei
suoi aspetti, storia di alcuni esempi, ipotesi sulle cause, la normativa in
proposito, che cosa si può fare, ecc. ecc.). Per scrivere il testo saccheggia
liberamente - ma in modo intelligente e logico - le informazioni dei documenti
sottostanti, e le altre che hai appreso dalla lezione dell’insegnante.
Palloni da calcio. I palloni da calcio dei
mondiali di Francia alla fine degli anni ’90 scandalizzarono gli sportivi di
tutto il mondo perché erano cuciti a mano da migliaia di bambini
Diritti dei bambini. Dall’Art. 32 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino. “… il diritto del
bambino a essere protetto dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di
qualsiasi lavoro rischioso, che interferisca con la sua educazione, che sia
dannoso per la sua salute e per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o sociale”.
La multinazionale delle scarpe. Secondo la rete
televisiva americana CBS una nota ditta di scarpe recluta in Vietnam ragazzi
giovanissimi pagandoli 20 centesimi di dollaro all’ora, e ha offerto ad un
famoso giocatore di basket 20 milioni di dollari per fare pubblicità: una
somma superiore al totale dei salari pagati in un anno a tutte le giovanissime
operaie indocinesi, spesso bambine, che lavorano per il corrispondente di 3
euro la settimana.
Le cifre dello sfruttamento. Dalle stime dell’OIL
(Organizzazione Internazionale del Lavoro). 180 milioni i bambini che lavorano
in condizioni estremamente pericolose e dannose per la salute … 8,4 milioni
i bambini vittime della schiavitù, della prostituzione, della pornografia e
di altre attività illecite.
Child labour e child work. Secondo l’OIL il primo dovrebbe indicare tutte le attività lavorative svolte da bambini all’esterno della propria famiglia in qualità di dipendenti e con tempi e ritmi tali da impedire la frequenza scolastica, quindi a tempo pieno con gravi rischi per la salute mentale e fisica. Spesso in condizioni di sistematica violazione dei diritti umani fino a vere e proprie forme di schiavitù.
Il child work dovrebbe indicare invece tutte le forme di
lavoro che non violano i diritti dei bambini e delle bambine e non ostacolano
la frequenza scolastica.
Localizzazione del lavoro minorile. Asia 61%,
Africa 32 %, America latina 7%.
Globalizzazione e lavoro minorile. Il lavoro minorile non è un fenomeno episodico e occasionale del sistema economico mondiale, bensì un dato strutturale se non addirittura un pilastro per alcuni settori produttivi… La povertà, l’aumento del debito internazionale, i salari bassi, l’aumento delle famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta, la disoccupazione degli adulti, le scelte dei datori di lavoro per aumentare i profitti,, le scelte spregiudicate delle multinazionali nella delocalizzazione delle produzioni sono tutti elementi che favoriscono lo sfruttamento dei bambini … Secondo una stima il 5% dei bambini al di sotto dei 15 anni lavora per le multinazionali.
Alle origini dello sfruttamento. La prima e
fondamentale causa del lavoro minorile, a tutte le latitudini, è la povertà.
Spesso all’origine della storia di un bambino schiavo c’è la morte o la
malattia di un genitore, la necessità di pagare i debiti e di provvedere ai
nuovi fratellini. I pochi soldi guadagnati fanno la differenza tra la fame e
la sopravvivenza.
Adulti e bambini. Per ogni bambino sfruttato c’è
sempre un adulto che sfrutta, approfitta e finge di non vedere. I bambini più
“fortunati” lavorano a tempo parziale, dopo la scuola, insieme ai propri
fratelli e vengono sottopagati “in nero” illegalmente.
Commercio equo e solidale. E’ una forma
originale di lotta alla povertà basata sul commercio …. L’obiettivo è di
arrivare al riconoscimento di un marchio a garanzia del lavoro dignitoso alla
base del prodotto venduto e di incentivare i consumi di quei prodotti “made
in dignità”, per i quali in altre parole si può certificare che sono il
risultato di un lavoro (anche infantile) che rispetta però i diritti.
Messico: le scarpe (da Stranieri come noi,
di Vittorio Zucconi)
E da noi? Ragazzini sul mercato a un euro l’ora.
Per trovarli non serve andare nelle miniere
di sale dell’Africa. Basta cercare nei cantieri edili del pianeta
Italia dove lavorano per lo più stranieri, molti dei quali non in regola. (da
Oggi sfruttati domani espulsi di Paolo Rumiz, giornalista del Corriere
della Sera)
Da un discorso di Kofi Annan, Segretario generale
delle Nazioni Unite: “Se vogliamo migliorare la vita dei bambini, delle
loro famiglie e della loro comunità, l’imperativo è categorico: dobbiamo
mettere gli interessi dei bambini al centro di ogni decisione politica ed
economica e al centro del nostro comportamento e delle nostre attività di
ogni giorno”
Esempi di lavoro infantile e schiavitù nel mondo.
Bambini indiani e nepalesi, rapiti o comprati ai genitori, che lavorano alla
tessitura dei tappeti, che a quattro anni respirano fumi tossici per
fabbricare braccialetti in vetro … Bambine tailandesi o brasiliane,
costrette a prostituirsi per i turisti occidentali … I bambini egiziani che
lavorano alla raccolta di fiori di gelsomino sul delta del Nilo: si alzano all’una
di notte, d’estate, per raccogliere i fiori quando l’umidità mantiene
intatta la loro essenza … I bambini messicani che lavorano come clandestini
in California, per aiutare i genitori braccianti agricoli nella raccolta di
aglio, per conto dei proprietari americani.
Schiavitù classica e schiavitù contemporanea. Il
valore commerciale dello schiavo nero americano delle piantagioni di cotone o
tabacco era alto; lo schiavo era un investimento costoso che andava protetto,
se non altro per interesse. Lo schiavo attuale ha valore zero, vista l’abbondanza
della merce e può quindi essere sfruttato e gettato via, come un qualsiasi
oggetto, quando “si rompe” o non serve più.
Barriere doganali? “Non si possono accettare
barriere doganali che fermino i paesi in via di sviluppo, e allo stesso tempo
non possiamo accettare che questi paesi producano merci che incorporano il
valore dell’ingiustizia”. (Risoluzione approvata da un gruppo di
parlamentari italiani appartenenti a schieramenti politici differenti.)
Una storia ancora da raccontare. “… Vengo a sapere dai telegiornali d’una nave che vaga come un vascello fantasma lungo le coste del Golfo di Guinea. Pare sia una nave negriera, carica di bambini. Quando finalmente la nave approda, a bordo dei bambini non c’è nessuna traccia. Sarà stato un abbaglio, un’invenzione dei giornali.? A molti il dubbio che quei bambini fossero davvero su quella nave è rimasto, insieme a una domanda: in quale fossa dell’Oceano indiano si trovano adesso?” (Francesco D’Adamo, dalla Postfazione a Storia di Iqbal, Salani Narrativa)
Documento 11 Siamo tutti cacciatori? (Zygmunt Bauman, Modus vivendi, Inferno e utopia del mondo liquido, Laterza Bari 2007, pp. 112-114)
Si può dire che, se l'atteggiamento premoderno nei confronti del mondo
era simile a quello di un guardacaccia, la metafora più
adatta per esprimere la concezione e la pratica del mondo dell'era moderna è
quella del giardiniere.
Il compito principale del guardacaccia è di difendere il territorio assegnato alla sua vigilanza contro ogni interferenza umana, allo scopo di difendere e preservare, per così dire il suo «equilibrio naturale», incarnazione dell'infinita saggezza di Dio o della Natura. Compito del guardacaccia è di scoprire prontamente e neutralizzare le trappole piazzate dai bracconieri e impedire l'accesso a cacciatori estranei, non autorizzati, in modo da non mettere a repentaglio la perpetuazione di quell' «equilibrio naturale». I servizi del guardacaccia si basano sulla convinzione che le cose stanno meglio se non ci si mettono le mani; in epoca premoderna la convinzione di fondo era che il mondo fosse una catena divina dell'essere, in cui ogni creatura aveva il suo giusto posto e la sua funzione, anche se le capacità mentali umane erano troppo limitate per comprendere la saggezza, 1'armonia e 1'ordine del disegno di Dio.
Non la pensa così il giardiniere; egli presuppone che nel mondo (o
almeno in quella piccola parte del mondo affidato alle sue cure) non ci
sarebbe alcun ordine se non fosse per la sua attenzione e i suoi sforzi
costanti. Il giardiniere sa quali tipi di piante devono crescere e quali no nel
terreno affidato alle sue cure. Dapprima elabora nella sua testa la disposizione
migliore, e poi provvede a trasformare questa immagine in realtà. Impone al
terreno il suo progetto precostituito, incoraggiando la crescita dei tipi di
piante giusti (per lo più, piante da lui stesso seminate o piantate) ed
estirpando e distruggendo tutte le altre, adesso ribattezzate «erbacce», la
cui presenza non richiesta e non desiderata, non desiderata perché non
richiesta, non si accorda con l'armonia generale del disegno.
Sono i giardinieri i più appassionati ed esperti (si sarebbe tentati di dire professionali) fabbricanti di utopie. È all'immagine dell'armonia ideale del giardiniere, concepita inizialmente come modello nella sua mente, che «approda di continuo» il giardino, un prototipo di come l'umanità, per richiamare il postulato di Oscar Wilde, tenderebbe ad approdare sempre nel paese chiamato «utopia».
Se oggi i dibattiti contemporanei sono infarciti di espressioni come «la morte dell'utopia», o «la fine dell'utopia», oppure «1'esaurimento dell'immaginario utopistico», tanto da mettere radici nel senso comune ed essere considerate verità ovvie ed evidenti, è perché ormai 1'atteggiamento del giardiniere sta cedendo il passo all' approccio del cacciatore.
Diversamente dalle due figure simboliche che l'hanno preceduto, il cacciatore non è mimimamente interessato all' «equilibrio generale delle cose», sia esso «naturale» oppure progettato e meditato. L'unico compito che i cacciatori perseguono è «uccidere» e continuare a farlo, finché i loro carnieri non sono colmi fino all'orlo. Sicuramente non ritengono loro dovere garantire che la disponibilità di selvaggina nela foresta possa ricostituirsi dopo (e malgrado) la loro caccia. Se i boschi sono rimasti senza selvaggina a seguito di una scorribanda particolarmente proficua, i cacciatori possono spostarsi in un'altra zona relativamente intatta, ancora pullu1ante di potenziali trofei di caccia. Può darsi che a un certo punto, in un futuro lontano e ancora indefinito, il pianeta rimanga a corto di boschi ancora ricchi di selvaggina; ma se così sarà, loro non lo vedono comunque come un problema immediato (e certamente non come un loro problema). Una prospettiva così remota, dopo tutto, non mette a repentaglio i risultati della caccia in corso, o della prossima, e perciò non obbliga in alcun modo me, singolo cacciatore fra tanti, o noi, singola associazione di cacciatori fra tante, a ragionar ci su e tanto meno a fare qualcosa in proposito.
Adesso siamo tutti cacciatori, o così ci dicono, e siamo chiamati o costretti ad agire da cacciatori, pena l'esclusione dalla caccia, o addirittura (Dio ne scampi!) la retrocessione a selvaggina. E ogni volta che ci guardiamo attorno, vedremo probabilmente altri cacciatori solitari come noi, oppure cacciatori che cacciano in gruppo, come ogni tanto anche noi cerchiamo di fare. E dovremo impegnarci molto prima di scorgere un giardiniere intento a vagheggiare, dietro la staccionata del suo giardino privato, una qualche armonia già progettata, e poi uscire per trasformarla in realtà (questa relativa penuria di giardinieri e la crescente abbondanza di cacciatori è quello di cui parlano gli studiosi di scienze sociali indicandolo col dotto termine di «individualizzazione»). Sicuramente non incontreremo molti guardacaccia, e neppure cacciatori con i rudimenti della concezione del mondo di un guardacaccia: e questa è la principale ragione per cui le persone con una «coscienza ecologica» sono allarmate e fanno del loro meglio per mettere in guardia il resto di noi (questa lenta ma costante estinzione della filosofia «del guardacaccia» insieme al declino della sua variante, la filosofia «del giardiniere», è ciò che gli uomini politici esaltano sotto il nome di deregulation).
Documento 12 Il cacciatore a pancia vuota (da V. Zucconi, Messico: Zapatos in Stranieri come noi, Einaudi scuola)
-Zapatos!
-Scarpe! -Zapatos
... zapatos ... zapatos, ripeteva
la bambina messicana con il dito e gli occhi puntati sulle mie scarpe. Non erano
niente di speciale, quelle mie scarpe, un paio di stivaletti bassi di pelle con
la suola grossa di gomma, come si usano per camminare nella polvere e nel fango.
Anzi,
ora che me le faceva guardare, mi accorgevo di quanto fossero sporche,
impolverate e macchiate, quelle scarpe, e pensai che me le sarei dovute pulire e
spazzolare per bene rientrando in albergo. Ma delle mie piccole vergogne, alla
bambina messicana non importava nulla. A lei interessava soltanto il fatto che
quelle fossero scarpe. Scarpe come non aveva mai visto prima. Scarpe come non
avrebbe forse visto mai piti nella sua vita tra la spazzatura.
La
bambina era spuntata all'improvviso da un mucchio di bottiglie rotte alto come
una casa di due piani, dietro un piccolo somaro talmente spelacchiato ed esausto
che la povera bestia non aveva nemmeno più la forza e la voglia di annusare.
Stava a mala pena diritto, e immobile, come se volesse risparmiare quelle
poche energie che ancora gli rimanevano.
La bambina mi
aveva sorpreso alle spalle, facendomi sobbalzare con la sua vocina acuta: «zapatos!
».
Non
ho idea di quanti anni avesse. La miseria, la denutrizione, la fame stravolgono
i ritmi normali di sviluppo di un essere umano, peso, statura, muscoli, ossa, e
lei poteva avere cinque anni o dieci, sei o dodici. Era molto piccola, molto
sporca, magra e fragile come una pianticella che sta morendo e due gambette
scheletriche le uscivano dalla sottanina per finire nei piedi nudi e anneriti da
anni di sporcizia. Piedi, appunto, senza zapatos, senza scarpe.
-
Come ti chiami? - le domandai, non sapendo davvero che altro dire. - Ida, - mi
rispose sorridendo orgogliosa. - Questo è il tuo somaro? - S1. - Dove abiti? -
chiesi, pentendomi subito della domanda della quale già sapevo la risposta. - A
qui, - disse infatti, qui, indicando con il braccino il mare di immondizia che
si stendeva attorno a noi, a perdita d'occhio.
«Qui»
era la più grande estensione di spazzatura che avessi mai veduto. Come altri
bambini, come migliaia di adulti precipitati al fondo della società, Ida viveva
- se quella si poteva chiamare vita - nella Ciudad de la Basura, la Città della
Spazzatura alla periferia della capitale messicana, Città del Messico.
Tutti
noi abbiamo visto qualche volta montagnole di spazzatura, discariche di rifiuti,
cataste di immondizia abbandonata in attesa che un giorno qualcuno si decida a
mandare un camion a portata via. Ma nessuno che non abbia visto la Città
dell'Immondizia può immaginarne la grandezza e 1'orrore.
La
Ciudad de la Basura non è, naturalmente, una vera città. La chiamano cosi i
messicani, con disperato umorismo, perché essa è tanto grande e tanto popolata
da sembrare ormai davvero un città. Si estende per chilometri, fra spazzatura
di ogni genere, cibo andato a male, cocci, bidoni, cartacce, lattine, stracci,
cartoni, carcasse di automobili e di animali, tazze del gabinetto e sanitari
sbrecciati, in un panorama agghiacciante di tutto quello che una grande città
produce, consuma e getta via.
Ogni
giorno, 1500 camion arrivano a scaricare nuova immondizia fresca di giornata,
che va ad aggiungersi alla vecchia e che nessuno porta via. Sotto il sole
violento del Messico, la spazzatura marcisce lentamente e s'imputridisce,
sprigionando un fetore di fogna, di morte, di carogna, che non si può neppure
cominciare a descrivere. Se l'inferno avesse un odore, puzzerebbe come la Città
della Spazzatura, ma forse questo è già l'inferno. Si resiste per pochi
minuti, cercando di respirare il meno possibile coi denti stretti come per
filtrare l'aria, di centellinare le boccate d'aria come se quel puzzo potesse
mangiarti i polmoni, e presto o tardi lo stomaco si ribella. Il fotografo che mi
accompagnava cominciò a vomitare subito. lo resistetti qualche minuto in più.
Non molti.
«Zapatos»,
insisteva la bambina additandomi le scarpe che non mi erano sembrate nulla dl
speciale alla mattina, uscendo dall' albergo e che ora cominciavano a
sembrare, anche a me, bellissime. Perché quelle scarpe e la loro robusta,
spessa suola di gomma, erano tutto quello che separava il mio corpo dalla
superficie della putredine infetta sulla quale camminavo.
Erano
come la zattera che tiene a galla il naufrago sul mare, come l'ala che tiene in
volo un aereo. Erano, improvvisamente, il bene piti prezioso che un uomo potesse
possedere in quell'inferno. Molto più prezioso dell' orologio di marca che
portavo al polso, o della catenina d'oro che portavo al collo, o del
costosissimo registratore tascabile che tenevo nella borsa.
Non
importava nulla, in quel mondo di spazzatura, che l'orologio da polso costasse
venti volte il prezzo delle scarpe. Il valore delle cose, che per noi fortunati
e viziati figli del mondo sviluppato si misura in soldi, cambia jmmediatamente
quando le circostanze cambiano. E più preziosa una borraccia d'acqua e una
collana di diamanti, se si cammina nel deserto? E meglio avere un paio di scarpe
ai piedi o un orologio d'oro massiccio al polso, se sotto i tacchi ribolle e
fermenta l'immondizia di una città?
«Zaapatos»,
mormorava Ida, mentre il somaro muoveva lentamente la coda nel tentativo
impossibile di allontanare dai suoi fianchi gonfi e malati milioni di mosche,
fameliche quanto lui. Come altri bambini e adulti che vedevo attorno a noi, non
soltanto Ida viveva tra le montagne di rifiuti, accampata sotto baracche
costruite con lamiere arrugginite e sacchetti di plastica legati insieme. In
quella città della putrefazione, Ida e gli altri «lavoravano ».
Tutto
il giorno, sotto il sole di Città del Messico velato dai fumi e dall'
inquinamento che si sprigionano dalla città e restano intrappolati nel catino
delle montagne e dei vulcani che la circondano, questi dannati dell'immondizia
frugano a mani e piedi nudi fra i rifiuti. Cercano qualcosa da mangiare,
qualche rottame da recuperare e da vendere ai rigattieri che la sera arrivano
con i loro camioncini e carretti per comprare.
I
più fortunati - e Ida era una di quelle fortunate- avevano un somarello per
aiutarli a trasportare i pezzi più grossi, le carcasse di un elettrodomestico,
i sanitari ancora utilizzabili, che qualche persona ricca aveva buttato via
magari perché non gli piaceva più il colore o la forma, e qualche povero
avrebbe volentieri ricomprato.
Un
somaro permette di collezionare piti rifiuti e quindi di guadagnare un po' più
di pesos, la moneta messicana. Anche se il somaro di Ida aveva Paria di una
bestia che, a mettergli un foglio di carta sulla schiena, si sarebbe spezzato in
due.
E
tu quanto guadagni? - chiesi a Ida. Mi disse una cifra, una somma di danaro che
non sarebbe bastata a comperare neppure i bei laccetti di cuoio che mi
chiudevano gli zapatos ai piedi.
-
In un giorno? - insistetti, temendo di sapere già la risposta. Ida rise,
mettendosi le manine sudice sopra la bocca per coprire i pochi denti superstiti
marroni e neri che le restavano appollaiati sulle gengive, in un gesto
commovente di pudore, o di civetteria, verso un uomo straniero. - No, no, in
molti giorni. -
-
Quanti giorni? - Si strinse nelle spallucce: molti.
Una
settimana, un mese, un anno. Il tempo non ha senso in una vita fatta di giorni
tutti uguali, tutti consumati nella Città della Spazzatura.
Qualcuno
di questi bambini va a scuola, uno o due anni, prima di tornare a frugare nelle
immondizie. I loro genitori muoiono giovani, stroncati dalla fatica e dalla
vita. I fratelli più grandi si curano dei più piccoli, quando possono, ma
ciascuno è abbandonato a se stesso, spazzatura fra la spazzatura.
Il
governo messicano manda assistenti sociali, cerca di strappare quante più
creature può - grandi o piccole - all'inferno della basura, della
spazzatura, ma ci sono sempre più poveri che soldi, sempre più bambini come
Ida che case disposte a ospitarli. Nelle nazioni del Terzo Mondo, come si dice
quasi che le nazioni potessero essere messe in classifica, prima, seconda e
terza, ci sono sempre più bocche che soldi, sempre più piedi che scarpe. Per
questo restano nazioni povere.
Per
bonificare la città dei rifiuti occorrerebbe costruire enormi inceneritori,
riciclare milioni di tonnellate di spazzatura, spendere milioni di miliardi che
il governo non ha e non avrà mai. L'inferno riproduce se stesso, sempre più
grande, sempre più profondo, sempre più popolato. E non vedo vecchi e vecchie
a rovistare, perché nessuno diventa vecchio, qui. I più fortunati muoiono
prima di arrivare a trent'anni.
Ammesso
che siano fortunati, quelli che vivono più a lungo, qui.
-
Zapatos, - insisteva Ida, asfissiante e per un attimo ebbi la tentazione di
spingerla via, di allontarla da me come il somaro faceva con le mosche.
Mi
venne addosso una rabbia inspiegabile, contro quella bambina che mi tormentava
con la sua insistenza, con la sua ossessione per le mie scarpe, con la sua
esistenza. La miseria, come la malattia, fa paura. Ida non mi arrivava all'
altezza della vita, ma mi faceva paura.
«Torna
nella tua immondizia, piccola scocciatrice», avrei voluto dirle. «Portati via
quel somaro osceno e gonfio e moribondo. Vai da tua madre e da tuo padre, se ce
li hai, e lascia in pace me e i miei maledetti zapatos», mi suggeriva una voce
dentro. «Che colpa ho io, se tu sei nata fra la spazzatura e sei condannata a
essere, tu stessa, per sempre spazzatura? Perché tormenti proprio me, che vivo
lontano, che non ti ho mai vista prima di adesso, che non ti ho mai fatto male?
».
-
Zapatos. «E dai.»
Lo
sapevo, 1'avevo capito da un pezzo, che Ida faceva la corte alle mie scarpe.
Non mi sarebbe costato molto dargliele. lo avevo tante scarpe nella mia valigia
in albergo e nel mio armadio a casa (<< già, è vero », pensai, «io ho
una casa»). Non era un problema di soldi o di valore delle scarpe. Il problema
che mi angustiava era sapere che, se me le fossi sfilate, poi avrei dovuto
attraversare a piedi nudi, soltanto con le mie calzette di cotone a proteggermi,
tutta la distesa infetta della spazzatura. E se dopo mi fossi ammalato? E se mi
fossi tagliato i piedi, fra quei cocci di vetro, fra quelle lattine appuntite, e
mi fosse venuta un'infezione?
Un
paio di scarpe in più o in meno - cercai di convincermi - non facevano
comunque nessuna differenza per Ida, che sarebbe rimasta una disgraziata con o
senza le mie scarpe.
E
poi erano troppo grandi per lei. Nella mia taglia 42 i suoi piedini rattrappiti
ci avrebbero nuotato.
E
poi qualcuno gliele avrebbe rubate subito, ne ero Sicuro.
E
poi lei stessa sarebbe andata a venderle immediatamente, da un rigattiere avaro
che l'avrebbe imbrogliata, dandole due soldi per le mie belle scarpe con la
suola di gomma e i laccetti di pelle, e cosi io avrei fatto del bene a un
rigattiere anziché alla piccola Ida ... E poi, e poi.
-
Zapatos. - Oh, come sono noiosi i poveri, come sono insistenti e invadenti e
maleducati. - Zapatos, zapatos, zapatos..., - «e va bene, maledizione a te,
prenditi queste scarpe».
Mi
sfilai gli zapatos. Glieli passai, Ida non mi disse neanche grazie. Se li tenne
stretti per un momento come se fossero una bambola e poi corse via verso un
altro gruppo di bambini e di adulti curvi sopra le montagnole di spazzatura
gridando ancora «zapatos... zapatos ... zapatos». Persino il somaro si scosse
dalla sua immobilità cadaverica e mosse la sua spelacchiata carcassa per
seguire Ida.
Lei
era già lontana, che correva reggendo le mie scarpe. La vidi inciampare, cadere
a faccia in avanti nella spazzatura e rialzarsi ridendo, come un bambino che
gioca sulla spiaggia. Mi sentii molto buono, molto generoso. E non avevo fatto
nulla, non avevo cambiato nulla. Nulla. Ida sarebbe rimasta Ida, io sarei
tornato nella mia bella casa lontana, piena di belle scarpe.
Camminai
con i piedi rattrappiti dallo schifo, sopra i rifiuti disgustosi, cercando di
evitare i cocci di vetro e di posarli laddove anni di sole e di vento avevano
indurito la spazzatura.
Era
quasi sera, e una bava di venticello che scendeva dalla montagne attorno a
Città del Messico alzava refoli di polvere e di puzza. Il fotografo tentava
ancora di vomitare, ma ormai aveva lo stomaco vuoto. lo ero troppo preoccupato
dei miei piedi nudi per avvertire i conati.
Quando
tornammo finalmente in albergo, un bell'albergo di lusso con la piscina e un
muro altissimo tutto intorno perché gli ospiti non fossero disturbati dalla
vista di altri miserabili come Ida mentre facevano il bagno, il portiere e i
camerieri ci guardarono con il naso storto e tutti nell' atrio mi sembrava
fissassero i miei piedi senza scarpe. Una nube di puzza ci circondava ancora.
Corsi
in camera, mi spogliai tutto furiosamente, mi misi a mollo nella vasca da bagno
e poi feci una doccia e poi ancora un bagno, per lavare via l'odore e il ricordo
della Città della Spazzatura.
Con
la punta delle dita, come si prende la carogna di un sorcio, raccolsi i vestiti,
li infilai in un sacchetto di plastica per la lavanderia e scesi nell'atrio dell'hotel,
non per farli lavare, ma per gettarli nel bidone della spazzatura. Nella notte,
sarebbe passato il camion della nettezza urbana per portarli via. Per scaricarli
nella Città della Spazzatura.
Erano
vestiti ancora buoni, che si sarebbero potuti rivendere bene a un rigattiere.
Spero almeno che li abbia trovati Ida.
Documento 13
Acqua. Se il
pianeta finisce a secco di Fred Pearce (da Repubblica del 6 marzo
2007). Leggi il testo e rispondi alle domande sottostanti
In
tutto il mondo alcuni dei fiumi più grandi - quelli che noi tutti ricordiamo
di aver studiato a scuola -sono sempre più in secca. Per buona parte dell'anno
il fiume Giallo in Cina, l'Indo in Pakistan, il Murray in Australia, il Colorado
negli Stati Uniti e il Nilo in Egitto praticamente non convogliano più acqua
nel mare. Negli ultimi due anni in alcuni punti si è abbassato di livello
perfino il possente Rio delle Amazzoni, che da solo trasporta un quinto di tutta
l'acqua di tutti i fiumi della Terra. E il Po in Italia nelle ultime estati ha
fatto registrare livelli al minimo storico.
Gli atlanti non dicono più il vero. In Asia centrale l’antico fiume Oxus non raggiunge più le sponde del lago d’Aral: la sua acqua è prelevata per le coltivazioni di cotone. Il lago d'Aral un tempo era il quarto più grande "mare" interno del mondo. Oggi è soltanto un deposito di sale in pieno deserto. Se ci si ferma in piedi in corrispondenza della vecchia linea costiera del Mynak in Uzbekistan, davanti a sé si scorge lo spoglio letto del mare - un nuovo deserto - che si distende per oltre cento chilometri.
Il problema è in parte una conseguenza del
cambiamento del clima. Alle sorgenti di tutti questi fiumi le precipitazioni
sono diventate scarse. Buona parte dell'area mediterranea, Italia inclusa, sta
diventando sempre più secca e i modelli climatici prevedono che in futuro le
aree aride del pianeta diventeranno ancora più aride. In realtà, i nostri
fiumi si stanno prosciugando essenzialmente a causa del nostro eccessivo consumo
di acqua, destinata soprattutto all'irrigazione. L'agricoltura è responsabile
dei due terzi di tutta l'acqua che gli esseri umani prelevano dalla natura nel
mondo. In Italia questa percentuale sale intorno al 50 per cento, e nelle
regioni molto aride tale quantità aumenta ancor più, raggiungendo il 90.
L'anno scorso ingegneri, politici e finanzieri
convenuti a Città del Messico in occasione del World Water Forum che si tiene
ogni tre anni hanno suggerito di creare molte più dighe e di definire nuovi parametri
di prelievo dell'acqua per far fronte alla crescente domanda in tutto il mondo
di acqua pulita. Ma a che scopo erigere altre dighe, se i fiumi si stanno già
prosciugando.
In molti Paesi stiamo esaurendo anche le riserve
idriche sotterranee, sia legalmente sia illegalmente. Si calcola che l'Italia
abbia più di un milione di pozzi
illegali. In India, dove i fiumi sono già secchi per buona parte dell'anno,
negli ultimi dieci anni i coltivatori hanno scavato oltre venti milioni di
condutture sotterranee sotto i loro campi, al fine di prelevare l'acqua presente
in profondità. Poiché le loro pompe funzionano 24 ore al giorno, le falde
freatiche si stanno rapidamente abbassando. Di recente i ricercatori hanno
calcolato che ogni anno i coltivatori prelevano la sbalorditiva quantità di
cento chilometri cubici d'acqua in più di quello che le precipitazioni riescono
a sostituire. Attualmente l'India è autosufficiente da questo punto di vista,
ma come numerosi altri Paesi asiatici sta per esaurire il tempo e l'acqua a sua
disposizione.
I presupposti di questa emergente crisi idrica
globale risalgono alla "rivoluzione verde", la crociata scientifica
combattuta negli anni Settanta e Ottanta per produrre nuove varietà di
colture ad alto rendimento con le quali dar da mangiare alla popolazione
terrestre che stava crescendo a ritmi incalzanti.
Allora si temeva che miliardi di persone avrebbero
potuto morire di fame di questi nostri tempi. Così non è stato. La
"rivoluzione verde" ha fatto il suo dovere, producendo maggiori
quantità di cibo. Ma ciò ha avuto un suo costo. Se da un lato le nuove
colture hanno assicurato rendimenti eccezionali, al contempo dall'altro
utilizzano l'acqua in modo meno efficiente rispetto alle colture di un tempo. Di
conseguenza, oggi nel mondo si coltiva circa il doppio delle colture degli anni
Settanta, si è al passo con la crescita della popolazione, ma dai fiumi e dalle
riserve idriche sotterranee si preleva almeno tre volte l’acqua di allora.
La quantità di acqua che occorre per riempire la
nostra borsa della spesa è impressionante. Occorrono cinquemila litri di
acqua per ottenere un chilo di riso, 11 mila per far crescere il foraggio
sufficiente ad alimentare una mucca affinché questa ci dia un hamburger, tremila
per un sacchetto da un chilo di zucchero e 20 mila per ottenere un barattolo da
un chilo di caffè. Con simili presupposti, non stupisce che nel mondo l'acqua
scarseggi, o che le organizzazioni delle Nazioni Unite che si occupano di cibo e
agricoltura affermino che in almeno un terzo dei campi coltivati esistenti al
mondo "l'acqua, e non la terra, è il vero vincolo" per la produzione.
Non stupisce neppure che le tensioni internazionali
per il controllo sulle risorse idriche stiano moltiplicandosi. Allorché un
paese a monte riesce a dare fondo alle acque di un fiume prima che questo
attraversi il confine, la popolazione confinante a valle comprensibilmente è
molto preoccupata. Le dighe erette in Turchia possono prosciugare completamente
l’Eufrate prima che questo arrivi a scorrere in Siria e in Iraq. Gli Stati
Uniti svuotano pressoché del tutto il Rio Grande e il Colorado prima che questi
corsi d'acqua riescano ad attraversare il confine messicano. Israele preleva
tutta l'acqua del fiume Giordano prima ancora che esso arrivi a scorrere nel
Paese dal quale prende il nome. Le guerre per l'acqua sono imminenti.
L'acqua in natura si ricicla naturalmente: evapora
dagli oceani e ricade sulla Terra sotto forma d pioggia. Ciò nonostante
abbiamo soltanto una data quantità di acqua a disposizione. La buona notizia
è che possiamo utilizzarla più efficientemente. In India migliaia di villaggi
hanno iniziato a raccogliere l’acqua delle precipitazioni monsoniche che
cadono ogni estate e a immagazzinarla in bacini e pozzi. “ Raccogliere
l’acqua piovana” non è certo una novità, ovviamente. Un tempo raccogliere
l’acqua dal tetto delle abitazioni e immagazzinarla in seguito in agricoltura
era prassi usuale dalla Toscana a Katmandu. Più avanti però si è iniziato a
fare affidamento soltanto sulle riserve idriche pubbliche. Ora che i fiumi si
stanno prosciugando, in ogni caso, raccogliere l’acqua piovana è un sistema
che sta sicuramente riprendendo piede.
Dobbiamo anche riciclare l'acqua e adoperarci per
ridurre le sempre più esorbitanti perdite che si verificano in buona parte dei
sistemi idrici. L'evaporazione che ha luogo dalle riserve idriche, per esempio,
è esorbitante. Il lago Nasser, situato dietro l'Alta Diga di Assuan in Egitto,
nel deserto nubiano, per l'evaporazione perde più acqua ogni anno di quanta
l'Italia intera ne consumi nello stesso arco di tempo. Le piccole riserve
idriche situate in varie zone d'Italia ogni anno arrivano a perdere il 40 per
cento del loro contenuto.
Milioni di contadini in tutto il pianeta ancor oggi
irrigano i loro campi allagandoli: la maggior parte dell' acqua così
utilizzata evapora ed è ben poca quella che penetra effettivamente nel terreno
raggiungendo le piante. Sistemi d’irrigazione a goccia a goccia, economici
quanto moderni, in grado di far sì che ogni singola goccia di acqua cada
accanto alla radice della pianta coltivata, possono tagliare il fabbisogno
odierno di acqua del 70 o dell'80
per cento.
Gli ingegneri parlano e discutono molto di come
reperire maggiori quantità di acqua per poter far fronte alla domanda in
netto aumento, ma la vera soluzione consiste invece nell'iniziare a contenere
la domanda. Occorre considerare definitivamente finiti i giorni in cui l'acqua
era ritenuta una risorsa gratuita e disponibile per diritto naturale. Un mezzo
molto valido per riuscirci è quello di imporre all'acqua un prezzo
realistico. I coltivatori in Italia e nella maggior parte degli altri Paesi
ancor oggi pagano l'acqua a un prezzo nettamente inferiore a quello reale. E
questo incoraggia gli sprechi.
Adesso, dopo decenni di sprechi, è giunta l'ora di
lanciare una "rivoluzione blu", e dare quindi inizio a una gestione
migliore della nostra acqua Se questa rivoluzione non partirà, allora i
conflitti e le guerre per questa risorsa umana, la più importante, l'unica
della quale non possiamo fare a meno e sopravvivere neppure un giorno, saranno
inevitabili.
Disegna sulla carta del planisfero le
informazioni geografiche (relative a fiumi, laghi, ed altro) citate nel
testo e per ciascuna componi una didascalia
Descrivi il ciclo dell’acqua sul pianeta terra
Indica le due cause della scarsità d’acqua.
Per ciascuna specifica se si tratta di cause naturali o imputabili
all’uomo
Spiega cosa c’è all’origine dell’aumentato
impiego di acqua nell’agricoltura?
Fai esempi di consumi agricoli di acqua in
agricoltura che risultano dei veri sprechi.
Fai esempi di tensioni internazionali per il
controllo delle risorse idriche
Indica le possibili risposte tecnologiche ed economiche all’attuale carenza di acqua
a cura di Paolo Alpino