IL MITO DI MEDEA IN CHRISTA WOLF
di Concetta Malvasi
Nel 1996 Christa Wolf, scrittrice tedesca
della Germania dell’est, dopo aver reinterpretato
il mito di Cassandra (dando alla sacerdotessa
troiana una voce che finalmente viene ascoltata
e che è portatrice di verità) decide di occuparsi
di Medea diventando la prima donna ad aver
scritto una opera rilevante ed estesa incentrata
su questa figura. Un lavoro, quello della
scrittrice tedesca, che ha portato sulle
scene una Medea “positiva” e suscitatrice
di pietà, che improvvisamente non è più fratricida
né infanticida ma diventa capro espiatorio
delle tensioni sociali, una selvaggia, una
profuga, un’immigrata disprezzata e mai accettata
dalla sua nuova città. Christa Wolf dissente
dalla versione di Euripide in cui Medea è
l’incarnazione della vendetta, dell’irrazionalità,
dell’istinto ferino della donna tradita.
La sorprendente reinterpretazione del mito
di Medea da parte della scrittrice tedesca
può stimolare qualche riflessione. Senza
esplicitamente nominarlo, e forse senza nemmeno
conoscere il suo lavoro, dato che Christa
viveva nella DDR, un paese in cui le idee
non circolavano liberamente, la Wolf sembrava
attuare un’opera di decostruzione alla Jacques
Derrida, mettendo così al centro una critica
al logocentrismo, inteso soprattutto come
paternalismo patriarcale. Il logocentrismo
non investiva solo la filosofia, ma anche
l’opera d’arte, la tragedia classica. Il
logocentrismo – termine che ovviamente non
compariva nel corpo del romanzo della Wolf
– era quanto di più simile ad un logomaschilismo,
la giustificazione di una società patriarcale
intrinsecamente violenta.
Wolf propone un ripensamento
della storia
invitandoci ad ascoltare
le singole voci
dei personaggi (sei voci
undici monologhi
che accostati l’uno all’altro
ci forniscono
la storia) lei stessa,
Giasone, il fratello,
la rivale Glauce, l’allieva
Agameda, Acamante,
mettendo in rilievo il
conflitto tra due
culture diverse che nel
romanzo diventa riflessione
sulle origini stesse dell’idea
di potere.
Medea non vuole entrare
in competizione con
Euripide, lei dà la sua
versione del mito
ricollegandosi alla versione
pre-euripidea
proprio perché il primo
ad attribuire la
morte dei figli a Medea
fu Euripide.
In una intervista del 1997, Christa Wolf
spiega come nacque l'idea di dedicare un
romanzo alla figura della principessa della
Colchide, lei incominciò ad interessarsi
a Medea lo stesso anno che la DDR stava sparendo
dalla storia e si chiedeva come mai nella
società in situazioni delicate c’è sempre
bisogno di un capro espiatorio. Mentre rifletteva
su Medea le venne in aiuto il caso. Una studiosa
di Basilea, curatrice del sarcofago di Medea
presso il museo locale, le spedì un suo articolo
dal quale risultava che Euripide per primo
attribuì a Medea l'infanticidio, mentre fonti
antecedenti descrivono i tentativi di Medea
di salvare i tre figli portandoli al santuario
di Era. Christa Wolf vide che anche un’altra
studiosa la pensava come lei.
Il sospetto che Euripide
avesse manipolato
la vicenda per assolvere
gli abitanti di
Corinto – colpevoli di
aver massacrato i
figli di Medea – emerge
anche dalla storiografia
antica, onorario compreso:
quindici talenti
d’argento, ricorda Robert
Graves, sarebbero
stati versati al drammaturgo
per questa storia
di disinvolta cosmesi di
Stato, utile per
presentare al meglio Corinto
sulla scena
del teatro greco durante
le feste di Dioniso.
Medea proveniva da una
cultura matriarcale,
legata alla vita, non poteva
aver ucciso
i suoi figli, una guaritrice,
un'esperta
di magia, originata da
antichisismi strati
del mito, dai tempi in
cui i figli erano
il bene supremo di una
tribù, non poteva
aver ucciso i propri figli.
Questa intervista sottolinea
elementi interessanti
con diversi livelli di
profondità, di rilettura
del mito e porta alla luce
verità soggettive,
e soprattutto la donna
come soggetto autonomo,
capace di sfidare l’ordine
razzista, sessista
e classista della società
greca,. Christa
Wolf, che continuò ad essere
marxista, applicò
categorie marxiste all’analisi
del logomaschilismo
greco. Ovvero, nella sua
visione era la posizione
sociale a determinare la
filosofia e l’arte
di Socrate e Euripide.
Oltre che non schiavi,
avevano il gravissimo difetto,
quasi una
colpa originaria, di essere
non donne, quindi
del tutto incapaci di pervenire
alla comprensione
della condizione femminile
servile. Medea
diventa rappresentante
degli altri, ovvero
i diversi, gli schiavi,
le donne in nome
di un ideale di cittadino
e di civiltà. La
rilettura del mito diviene
una riflessione
sulle origini delle forme
occidentali del
potere: il principio della
regalità, il ruolo
della ricchezza e la centralità
della forza.
Al marxismo di fondo, quindi,
Christa Wolf
aggiunse il “colore” della
differenza sessuale
come componente aggiuntiva
e certamente determinante,
l’imperdonabile difetto
di una teoria che
si era limitata a considerare
classi formate
da individui produttori,
e non di differenze
sessuali. A prescindere
da tutte le immaginabili
influenze di pensatrici
democratiche e femministe,
Christa Wolf prese una
direzione molto più
determinata, riportando
a dignità una rielaborazione
del mito di Medea e puntando
decisamente
alla tesi che una società
matriarcale non
possa produrre madri infanticide.
Occorre qui fare due riflessioni che conducono
oltre la Wolf
La prima: Euripide fu l’autore di Ifigenia in Aulide, ossia la denuncia più spietata della stupidità
e dell’arroganza maschile
dell’antichità.
Non è sostenibile che Euripide
mancasse di
sensibilità alla condizione
femminile, anche
perché nella sua versione
di Medea egli non si guadagnò fino in fondo l’onorario
(i famosi 15 talenti d’argento)
nonostante
l’enormità dei crimini
ascritti a Medea,
il suo mito continua ad
affascinare per l’orgoglio,
per il suo essere indomita,
e a sorprendere
per la modernità delle
istanze femministe
di cui si fa portatrice.
Forse Euripide alla
fine cedette al suo fascino,
tanto da lasciarsi
‘sfuggire’ riflessioni
che assomigliano pericolosamente
a una denuncia dello stato
di soggezione
della donna: “Di quanti
esseri al mondo hanno
anima e mente, noi donne
siamo le creature
più infelici. Dobbiamo
anzitutto, con dispendio
di denaro, comperarci il
marito e dare un
padrone alla nostra persona;
e questo è dei
due mali il peggiore.......Dicono
anche che
noi donne vivendo in casa
viviamo senza pericoli
e l’uomo ha i pericoli
della guerra. Ragionamento
insensato. Vorrei tre volte
trovarmi nella
battaglia anziché partorire
una sola”
La seconda: l’idea stessa di “società matriarcale”:
Come ci si può immaginare una sorta di età
dell’oro del matriarcato, senza considerare
tutte le possibili degenerazioni di una società
dominata dalle donne? Così come una società
esclusivamente patriarcale. Resta che senza
la Wolf, non si può andare oltre la Wolf.
Christa Wolf aggiunse un ulteriore elemento
da ponderare: il valore dell’identità collettiva.
Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino
e la riunificazione della Germania, scomparve
la DDR e i cittadini della Germania dell’Est
si trovarono a dover ricomporre la propria
identità. (in una intervista Christa Wolf
affermò che di fatto ai tedeschi orientali
si chiese di rinunciare alla propria identità).
I vincitori dell’Ovest pretesero una sorta
di lavaggio e nello stesso tempo di oblio
di una delle due identità ed ovviamente quella
che sparì fu l’identità dei perdenti.
Nella interpretazione di Christa Wolf, Medea
diventa una straniera, una barbara, una emarginata,
la sua figura è occasione per una riflessione
sul mondo che cambia, sulla diversità femminile,
Medea è molte donne odierne, donne profughe,
sole, abbandonate, è colei che sceglie le
passioni al posto del calcolo, la tolleranza
al posto della divisione, colei che chiede
disperatamente di essere accettata. Non più
una maga dai poteri divini e soprannaturali,
ma una donna, un essere umano che rimane
vittima dei giochi di potere che freneticamente
si susseguono in questo mondo. Giasone sposerà
la figlia del re, è deciso, ma a differenza
di Medea non ha il coraggio di ribellarsi
a scelte imposte per lui da altri.
Medea scopre il delitto della figlia del
re, Ifnoe, la figlia della regina, colei
che avrebbe dovuto regnare, dietro c’è e
la logica di dominio che regge l'ordine (patriarcale
maschile) fondato dal re di Corinto Creonte;
il palazzo del re Creonte è edificato sopra
un misfatto (l’omicidio della giovane Ifinoe,
figlia di re Creonte, per ordine dello stesso
re) perché l’ordine deve regnare,
Allo stesso tempo, la drammatica
scoperta
riapre la ferita mai rimarginata
della vera
ragione che l’ha indotta
ad abbandonare la
Colchide. Non l’innamoramento
per Giasone,
bensì la rabbia e il dolore
per il barbaro
assassinio del fratello
Aspirto, perpetrato
per decisione del re padre,
simile negli
intenti all’assassinio
di Ifinoe: un sacrificio
umano, necessario per la
conservazione del
potere, messo a rischio
dalla stessa Medea
(che aveva sposato la causa
dei giovani,
aiutandoli, con la collaborazione
della madre-regina).
Un dolore reso più amaro
dal senso di colpa
per non aver capito in
tempo, per avere sottovalutato
il pericolo.
È evidente che, in una
società che si fonda
sull’ipocrisia, la sua
lucidità e la sua
onestà intellettuale non
possono che nuocerle.
In una tribù in cui tutti
vanno fieri della
loro arrogante innocenza,
riconoscersi una
parte di responsabilità
equivale a salire
spontaneamente sull’altare
sacrificale. Medea
diventa vistoso monito
del grande rimosso
collettivo, un marchio
da cancellare, un
ostacolo da eliminare,
per poter continuare
a vivere. Lei, la straniera
non doveva conoscere
il segreto. Lei la straniera
doveva uniformarsi
all’ordine patriarcale.
A questo punto l'esito
della sua vicenda
personale è scontato. Privata
dei figli (lapidati
dai Corinzi) Medea è costretta
ad abbandonare
la città che vede in lei
il portato di una
cultura tenebrosa e inquietante.
Medea è una donna sola,
alla deriva, tradita,
è il capro espiatorio per
i delitti commessi
da quella società. Il romanzo
termina con
una frase: “… quando tutto
è perduto, una
sola cosa resta RESTO IO”
, quando tutto
è perduto alla donna resta
sempre se stessa
ed è da lì che deve ripartire
per reinventarsi
una nuova vita priva di
violenze. Centralità
della donna che deve essere
riconosciuta
prima di tutto da sé stessa.
CM - 1 maggio 2013
|
| |













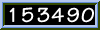
|