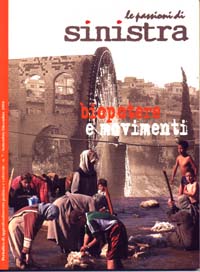La
repressione del corpo e la reazione delle forze. Contributo
per una riflessione sulle nozioni di forza e di reazione nel Nietzsche
di Deleuze
|
Un
tiepido pomeriggio di primavera fui, mio malgrado, invitato a danzare
per un finto spettacolo tragico e grottesco che le forze di reazione ordinariamente
servono come piatto prelibato alle urla delle macchine desideranti.
Fui indotto al dolore in virtù della colpa.
Pena e condanna per desiderio anelato: era questa la mia colpa, era un semplice interdetto d’azione, soprattutto perché frutto di libera scelta o semplicemente determinata dal piacere.
La mancanza del tempo induceva all’esitazione le mie pulsioni. Rumorosamente urlavano i silenzi di Steve Reich e lì come né altrove né prima raccolsi la miseria dell’esistenza. A pochi passi di lì udii il trillo delle chiavi: mai come allora suonò così angosciante e ridondante.
Era l’assurdità della morale della sofferenza che inscenava la propria capacità di limare e inibire la forze creative dei soggetti e che relegava la libertà di scelta ad un regime di clandestinità. Quella clandestinità poi ritorse il mio principio autonomo e creativo dell’agire a mediocre condizione di reazione: derubricò la mia azione a rancore e innescò l’effimero processo del desiderio di vendetta, ma quest’ultima recitava con troppa vanagloria, a tal punto da ritenerla eccessivamente banale.
Così in me prese forma pratica l’illuminante osservazione di Nietzsche per il quale la vita è l’affermazione dell’esistenza della molteplicità e della coesistenza di forze. Mi chiesi dove poter individuare un punto d’origine delle stesse: tempo dopo alcune pagine del filosofo tedesco mi suggerirono di cercarle nel senso affermativo di chi soffre di sovrabbondanza della vita e mi indicarono che in fin dei conti tutto l’agire umano nel tempo è stato il trionfo delle forze reattive(1).
La numerosità delle forze mi fece pensare ai millepiani dell’essere in virtù delle sue pieghe e dalla sua costitutiva molteplicità che mi suggerirono la natura differenziale dell’essere contro la visione dialettica e cristiana della realtà(2).
L’idea dell’esistenza perpetrata dalla tradizione ci consegna la vita come originariamente colpevole e bisognosa del dolore per riscattare la sua condizione di deficienza originaria. Questa concezione rifiuta l’esistenza in quanto divenire e in quanto percorso ed espressione delle forze che lo costituiscono ed esige un dispositivo di repressione che induce l’ottundimento delle sinfonie del divenire.
Nella lettura che Deleuze dà di Nietzsche l’essere è molteplice e mutevole ed è animato dalla coesistenza di forze che non hanno bisogno di giustificare la loro esistenza né nel riscatto dal peccato né dalla colpa. L’esistenza è l’insieme dei concatenamenti delle macchine desideranti, è il brulicare delle pulsioni, è l’apertura ai millepiani possibili.
Il brulicare delle pulsioni delle forze è la potenza delle istanze, è il potere creativo e desiderante inconscio: ogni desiderio è immediatamente concatenazione, ovvero è concatenamento macchinico operato dall’investimento pulsionale, processo che afferma l’essere in quanto divenire. L’essere molteplice vive nella pluralità delle forze e delle moltitudini che lo animano e ne determinano la sua condizione di giustizia. La repressione antidesiderante mette in moto un circuito di adeguamento alla repressione che istituisce un regime di reazione che è vissuto sotto le spoglie di resistenza, cioè si instaura un sistema di attività desiderante che agisce secondo una dinamica passiva e che ha ceduto la sua autonoma capacità propositiva.
L’esistenza scevra di limitazioni alla sua volontà danzante e creatrice è piano del divenire, è l’affermarsi delle forze in quanto investimento pulsionale e desiderante delle micropolitiche individuali. Se a tale regime di autogoverno delle pulsioni si sostituisce una volontà di dovere, se si afferma l’agire come agire eteronomo si innesca un processo di elaborazione delle pulsioni che è solo reattivo.
Le forze reattive separano la forza attiva da ciò che è in suo potere(3), la repressione innesca un meccanismo che assume la macchina desiderante come un’articolazione di ingranaggi: elabora il concetto di soggetto e ad esso pospone l’oggetto desiderato. Istituita questa separazione le forze reattive sono nella condizione di fantasmare il desiderio e creare l’oggetto desiderato(4) per poi cingerlo di interdetti.
Il dispiegamento pratico della volontà libera si afferma prescindendo dall’oggetto, poiché essa non è rappresentazione dell’oggetto, essa è l’affermazione del principio della sintesi delle forze. E’ la condizione di coesistenza di forza e volontà, che è altresì la condizione in cui le forze attive sono tutt’uno con ciò che è in loro potere.
Le forze reattive s’inventano un soggetto neutro con libero arbitrio e negano alla volontà la capacità di soppesare la terra e alla forza la capacità di interpretare l’esistenza.(5) In queste condizioni il divenire è ridotto a regime delle forze reattive in cui l’essere e l’esistenza sono spoglie delle loro possibilità propositive, per aspirare alle quali è necessaria un’altra sensibilità.
E’ necessaria un’affettività(6) che sia regime di composizione di corpi ed affetti in cui la volontà di potenza si affermi in quanto creatrice e dominante, che sia la virtù che dona, che affermi l’essere in quanto divenire(7), perché ”è allora che il vostro corpo si solleva e risorge; con la sua gioia sprona lo spirito a farsi creatore ed estimatore e amante e benefattore”(8).
1 F. Nietzsche, Genealogia della Morale, Opere vol.VI, tomo II, Adelphi, Milano 1968.
2 G. Deleuze & F. Guattari, Come farsi un corpo senza organi?, Milano 1967, pp.190-201
3 Cfr G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, Feltrinelli, Milano 1992, p.85.
4 Cfr. G. Deleuze e F. Guattari, L’anti-Edipo, Einaudi, Torino 1975, p.29.
5 Cfr G. Deleuze, ivi, pp. 35-6.
6 Cfr. ivi, p. 93 e nota.
7 Cfr. ivi, p. 127.
8 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Mursia, Milano 1965, p. 72.
Fui indotto al dolore in virtù della colpa.
Pena e condanna per desiderio anelato: era questa la mia colpa, era un semplice interdetto d’azione, soprattutto perché frutto di libera scelta o semplicemente determinata dal piacere.
La mancanza del tempo induceva all’esitazione le mie pulsioni. Rumorosamente urlavano i silenzi di Steve Reich e lì come né altrove né prima raccolsi la miseria dell’esistenza. A pochi passi di lì udii il trillo delle chiavi: mai come allora suonò così angosciante e ridondante.
Era l’assurdità della morale della sofferenza che inscenava la propria capacità di limare e inibire la forze creative dei soggetti e che relegava la libertà di scelta ad un regime di clandestinità. Quella clandestinità poi ritorse il mio principio autonomo e creativo dell’agire a mediocre condizione di reazione: derubricò la mia azione a rancore e innescò l’effimero processo del desiderio di vendetta, ma quest’ultima recitava con troppa vanagloria, a tal punto da ritenerla eccessivamente banale.
Così in me prese forma pratica l’illuminante osservazione di Nietzsche per il quale la vita è l’affermazione dell’esistenza della molteplicità e della coesistenza di forze. Mi chiesi dove poter individuare un punto d’origine delle stesse: tempo dopo alcune pagine del filosofo tedesco mi suggerirono di cercarle nel senso affermativo di chi soffre di sovrabbondanza della vita e mi indicarono che in fin dei conti tutto l’agire umano nel tempo è stato il trionfo delle forze reattive(1).
La numerosità delle forze mi fece pensare ai millepiani dell’essere in virtù delle sue pieghe e dalla sua costitutiva molteplicità che mi suggerirono la natura differenziale dell’essere contro la visione dialettica e cristiana della realtà(2).
L’idea dell’esistenza perpetrata dalla tradizione ci consegna la vita come originariamente colpevole e bisognosa del dolore per riscattare la sua condizione di deficienza originaria. Questa concezione rifiuta l’esistenza in quanto divenire e in quanto percorso ed espressione delle forze che lo costituiscono ed esige un dispositivo di repressione che induce l’ottundimento delle sinfonie del divenire.
Nella lettura che Deleuze dà di Nietzsche l’essere è molteplice e mutevole ed è animato dalla coesistenza di forze che non hanno bisogno di giustificare la loro esistenza né nel riscatto dal peccato né dalla colpa. L’esistenza è l’insieme dei concatenamenti delle macchine desideranti, è il brulicare delle pulsioni, è l’apertura ai millepiani possibili.
Il brulicare delle pulsioni delle forze è la potenza delle istanze, è il potere creativo e desiderante inconscio: ogni desiderio è immediatamente concatenazione, ovvero è concatenamento macchinico operato dall’investimento pulsionale, processo che afferma l’essere in quanto divenire. L’essere molteplice vive nella pluralità delle forze e delle moltitudini che lo animano e ne determinano la sua condizione di giustizia. La repressione antidesiderante mette in moto un circuito di adeguamento alla repressione che istituisce un regime di reazione che è vissuto sotto le spoglie di resistenza, cioè si instaura un sistema di attività desiderante che agisce secondo una dinamica passiva e che ha ceduto la sua autonoma capacità propositiva.
L’esistenza scevra di limitazioni alla sua volontà danzante e creatrice è piano del divenire, è l’affermarsi delle forze in quanto investimento pulsionale e desiderante delle micropolitiche individuali. Se a tale regime di autogoverno delle pulsioni si sostituisce una volontà di dovere, se si afferma l’agire come agire eteronomo si innesca un processo di elaborazione delle pulsioni che è solo reattivo.
Le forze reattive separano la forza attiva da ciò che è in suo potere(3), la repressione innesca un meccanismo che assume la macchina desiderante come un’articolazione di ingranaggi: elabora il concetto di soggetto e ad esso pospone l’oggetto desiderato. Istituita questa separazione le forze reattive sono nella condizione di fantasmare il desiderio e creare l’oggetto desiderato(4) per poi cingerlo di interdetti.
Il dispiegamento pratico della volontà libera si afferma prescindendo dall’oggetto, poiché essa non è rappresentazione dell’oggetto, essa è l’affermazione del principio della sintesi delle forze. E’ la condizione di coesistenza di forza e volontà, che è altresì la condizione in cui le forze attive sono tutt’uno con ciò che è in loro potere.
Le forze reattive s’inventano un soggetto neutro con libero arbitrio e negano alla volontà la capacità di soppesare la terra e alla forza la capacità di interpretare l’esistenza.(5) In queste condizioni il divenire è ridotto a regime delle forze reattive in cui l’essere e l’esistenza sono spoglie delle loro possibilità propositive, per aspirare alle quali è necessaria un’altra sensibilità.
E’ necessaria un’affettività(6) che sia regime di composizione di corpi ed affetti in cui la volontà di potenza si affermi in quanto creatrice e dominante, che sia la virtù che dona, che affermi l’essere in quanto divenire(7), perché ”è allora che il vostro corpo si solleva e risorge; con la sua gioia sprona lo spirito a farsi creatore ed estimatore e amante e benefattore”(8).
1 F. Nietzsche, Genealogia della Morale, Opere vol.VI, tomo II, Adelphi, Milano 1968.
2 G. Deleuze & F. Guattari, Come farsi un corpo senza organi?, Milano 1967, pp.190-201
3 Cfr G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, Feltrinelli, Milano 1992, p.85.
4 Cfr. G. Deleuze e F. Guattari, L’anti-Edipo, Einaudi, Torino 1975, p.29.
5 Cfr G. Deleuze, ivi, pp. 35-6.
6 Cfr. ivi, p. 93 e nota.
7 Cfr. ivi, p. 127.
8 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Mursia, Milano 1965, p. 72.
| |
|
settembre - dicembre 2004