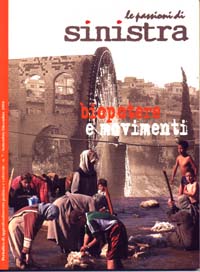La città imprevista
|
Gentile
Ernesto,
è la prima notte di luglio, notte di afa e di veglia, notte di pensieri lenti. Di notte i pensieri fluttuano, e io voglio parlarti di città imprevista, di città e di usi, abusi, espropri di funzioni e di significati, di disordine, di movimenti e di interstizi.
Voglio parlarti di abitanti, di persone e di luoghi, appropriazione e invenzione di luoghi. La città imprevista, così la chiama Paolo Cottino (La città imprevista. Il dissenso nell’uso dello spazio urbano, Elèuthera 2003) che racconta storie di abitanti che, ai margini della “Milano da bere”, si arrangiano, adattano, recuperano, riciclano luoghi abbandonati, interstizi della metropoli, attuano pratiche spontanee che producono fenomeni urbani informali e autorganizzati. Così la forma che quei luoghi prendono appare la forma del disordine, dove il disordine è resistenza a un ordine che semplifica e irrigidisce, fuoriuscita da regole che non sanno vedere i bisogni non garantiti, i bisogni inespressi di chi non ha rappresentanza, i bisogni clandestini e i desideri senza cittadinanza.
Mi interessa questa questione del disordine, del rapporto con l’ordine e le regole, e della continua ridefinizione dei significati partendo dalle azioni, dalle pratiche sui luoghi. E allora ti racconto qualcosa di Molfetta, degli interstizi della “Molfetta da bere” dove, a mettersi gli occhiali agli infrarossi, si possono vedere quei buchi neri di significato dove restano invisibili gruppi di persone, pratiche abitative e sociali non normate, usi ibridi e di fantasia urbanistica.
Dietro Molfetta Vecchia, tra la cortina di case e il mare: è un posto dove la parietaria cresce tra le pietre dei muri, la ghiaia scivola verso i massi che bordeggiano l’acqua del porticciolo, le gru dei cantieri edili fanno da scena fissa alle barchette per andare a “fare i polpi”. E’ un posto dove vengo sempre attratta, tra città e mare, un posto di confine, un bordo dove le linee di separazione si sfumano e si sfrangiano le giurisdizioni. E’ un posto sospeso, in attesa, una specie di off limits che sfugge al controllo e fuoriesce dalle regole. Negli anni in cui Molfetta è stata fiorente mercato della droga potevi trovarvi siringhe usate disseminate tra il pietrisco, escrementi e immondizia come bava di lumaca che in controluce disegna la mappa del degrado di una città.
Sui massi lungo la riva ho visto un giorno brucare una capra, uno spaesamento come se fossi stata catapultata in un film, e Vittorio mi ha portato a conoscere Michele. Michele si è preso uno “iuso” abbandonato, ne ha aperto l’ingresso murato che dà sul mare, lo ha ripulito, vi ha messo due asini, vicino ha recintato, riciclando gli scarti di una città che butta la sua immondizia dove non è vista, e ci ha messo le galline e un coniglio, ha costruito una vasca per i pesci. L’odore dell’aia è forte e si mescola col sale del mare.
Sull’altro lato del porticciolo in estate alcune famiglie “d’ind a la terr” (cioè Molfetta vecchia) allestiscono una specie di villaggio balneare a proprio uso, con tende per dormire, cucinare, mangiare, stare all’ombra, ombrelloni, stuoie, radio e calciobalilla. Per due mesi quel pezzo di margine tra città e mare diventa loro, diventa il loro posto delle vacanze. Quest’anno lì c’è il cantiere edile che costruisce l’allungamento della diga frangiflutti, ma i bagnanti non hanno rinunciato al loro lido e si adattano tra la pesa dei camion e le ruspe.
Ora quel limite è conteso tra le ruspe e gli abusivi che vi praticano usi impropri rispetto alle regole scritte e disegnate. Poi stanno i progetti che lo vogliono recuperare per costruirci un teatro all’aperto e un porticciolo, per assorbirlo alla città visibile e in vista. In passato vi sono stati allestiti temporanei spazi per lo spettacolo. Oggi agli abusi che ne fanno un lido balneare o un’aia se ne aggiunge un altro più scontato e invasivo, un abusivo parcheggio di macchine.
Teatro all’aperto, porticciolo, lido balneare, parcheggio, fattoria di animali o zoo? Come vengono decise le destinazioni d’uso? I progetti e le pratiche abitative come dialogano?
Altrove a Molfetta è già avvenuto lo scivolamento di “vuoti urbani” verso un uso a parcheggio auto, anch’esso abusivo, non normato ma accettato tacitamente anche da chi esercita il controllo delle regole e da chi amministra, diventato un uso quasi lecito per “consuetudine”: penso a largo Amente a Molfetta vecchia, penso a piazza Paradiso. A volte tale uso nei fatti diventa indicazione per rivedere le destinazioni d’uso di quelle aree nei piani urbanistici. Mi chiedo, ti chiedo, perché in questo caso un uso di fatto viene inteso dagli amministratori come una indicazione degli abitanti, abitanti che si comportano da aggressivi consumatori di risorse, la risorsa spazi liberi, la risorsa città, la risorsa luoghi di socializzazione? Mi chiedo e ti chiedo perché in questo caso gli abitanti-automobilisti sono letti come portatori di istanze, di bisogni, di desiderata, veicoli di un modello di utilizzo della città che così viene riconosciuto come trasversale e universale? Perché questo modello non può essere messo sotto osservazione critica e valutato, piuttosto che assunto acriticamente come “naturale”? E se lo stesso atteggiamento di “sensibilità” a una “domanda del mercato” o alle pratiche degli “utenti” – cittadini o dei “consumatori” – abitanti fosse applicato alle altre forme abusive di uso del territorio, sarebbe altrettanto ragionevole pensare di fare dietro al duomo una spiaggia pubblica o un allevamento di capre o un giardino zoologico?
E invece, prova a ripensare a Michele e ai bagnanti del lido libero sullo sfondo del duomo: le loro pratiche restano fuori dall’attenzione degli amministratori e dei progettisti, sono semplicisticamente ridotte a deviazioni insignificanti, espressioni di marginalità e abuso, produttrici di degrado ambientale. In quel caso il progetto canonico non si pone domande su quelle forme di esproprio, l’ordine non dialoga col disordine, normalizzarlo vuol dire banalmente eliminalo. Eppure le forme di quel disordine potrebbero essere una occasione per spingerci a scandagliare significati per ciò che è escluso, sfasato, non appartenente, per “risignificare” dove i linguaggi si impastano, sfumano, diventano balbuzie e si aprono a nuove possibilità, sui margini della città, ai margini della comunità dei cittadini, tra le comunità di abitanti, tra regole e non regole, tra individui, tra spazi di vita, bisogni e desideri. Non indicatori di funzioni d’uso ma segnali di problemi di coesistenza e di diritti negati a settori della comunità insediata su cui mettere attenzione per costruire progetti di qualità della vita per tutti. E non solo questo, quelle pratiche spontanee possono far riflettere su stili alternativi a quelli della nostra modernità arrogante, costruita nel modello del “progresso” e del dominio della tecnologia, delle “monocolture della mente” (è il titolo del libro di Vandana Shiva, Bollati Boringhieri, 1995) che distruggono le diversità per una globalizzazione della scala dei privilegi.
è la prima notte di luglio, notte di afa e di veglia, notte di pensieri lenti. Di notte i pensieri fluttuano, e io voglio parlarti di città imprevista, di città e di usi, abusi, espropri di funzioni e di significati, di disordine, di movimenti e di interstizi.
Voglio parlarti di abitanti, di persone e di luoghi, appropriazione e invenzione di luoghi. La città imprevista, così la chiama Paolo Cottino (La città imprevista. Il dissenso nell’uso dello spazio urbano, Elèuthera 2003) che racconta storie di abitanti che, ai margini della “Milano da bere”, si arrangiano, adattano, recuperano, riciclano luoghi abbandonati, interstizi della metropoli, attuano pratiche spontanee che producono fenomeni urbani informali e autorganizzati. Così la forma che quei luoghi prendono appare la forma del disordine, dove il disordine è resistenza a un ordine che semplifica e irrigidisce, fuoriuscita da regole che non sanno vedere i bisogni non garantiti, i bisogni inespressi di chi non ha rappresentanza, i bisogni clandestini e i desideri senza cittadinanza.
Mi interessa questa questione del disordine, del rapporto con l’ordine e le regole, e della continua ridefinizione dei significati partendo dalle azioni, dalle pratiche sui luoghi. E allora ti racconto qualcosa di Molfetta, degli interstizi della “Molfetta da bere” dove, a mettersi gli occhiali agli infrarossi, si possono vedere quei buchi neri di significato dove restano invisibili gruppi di persone, pratiche abitative e sociali non normate, usi ibridi e di fantasia urbanistica.
Dietro Molfetta Vecchia, tra la cortina di case e il mare: è un posto dove la parietaria cresce tra le pietre dei muri, la ghiaia scivola verso i massi che bordeggiano l’acqua del porticciolo, le gru dei cantieri edili fanno da scena fissa alle barchette per andare a “fare i polpi”. E’ un posto dove vengo sempre attratta, tra città e mare, un posto di confine, un bordo dove le linee di separazione si sfumano e si sfrangiano le giurisdizioni. E’ un posto sospeso, in attesa, una specie di off limits che sfugge al controllo e fuoriesce dalle regole. Negli anni in cui Molfetta è stata fiorente mercato della droga potevi trovarvi siringhe usate disseminate tra il pietrisco, escrementi e immondizia come bava di lumaca che in controluce disegna la mappa del degrado di una città.
Sui massi lungo la riva ho visto un giorno brucare una capra, uno spaesamento come se fossi stata catapultata in un film, e Vittorio mi ha portato a conoscere Michele. Michele si è preso uno “iuso” abbandonato, ne ha aperto l’ingresso murato che dà sul mare, lo ha ripulito, vi ha messo due asini, vicino ha recintato, riciclando gli scarti di una città che butta la sua immondizia dove non è vista, e ci ha messo le galline e un coniglio, ha costruito una vasca per i pesci. L’odore dell’aia è forte e si mescola col sale del mare.
Sull’altro lato del porticciolo in estate alcune famiglie “d’ind a la terr” (cioè Molfetta vecchia) allestiscono una specie di villaggio balneare a proprio uso, con tende per dormire, cucinare, mangiare, stare all’ombra, ombrelloni, stuoie, radio e calciobalilla. Per due mesi quel pezzo di margine tra città e mare diventa loro, diventa il loro posto delle vacanze. Quest’anno lì c’è il cantiere edile che costruisce l’allungamento della diga frangiflutti, ma i bagnanti non hanno rinunciato al loro lido e si adattano tra la pesa dei camion e le ruspe.
Ora quel limite è conteso tra le ruspe e gli abusivi che vi praticano usi impropri rispetto alle regole scritte e disegnate. Poi stanno i progetti che lo vogliono recuperare per costruirci un teatro all’aperto e un porticciolo, per assorbirlo alla città visibile e in vista. In passato vi sono stati allestiti temporanei spazi per lo spettacolo. Oggi agli abusi che ne fanno un lido balneare o un’aia se ne aggiunge un altro più scontato e invasivo, un abusivo parcheggio di macchine.
Teatro all’aperto, porticciolo, lido balneare, parcheggio, fattoria di animali o zoo? Come vengono decise le destinazioni d’uso? I progetti e le pratiche abitative come dialogano?
Altrove a Molfetta è già avvenuto lo scivolamento di “vuoti urbani” verso un uso a parcheggio auto, anch’esso abusivo, non normato ma accettato tacitamente anche da chi esercita il controllo delle regole e da chi amministra, diventato un uso quasi lecito per “consuetudine”: penso a largo Amente a Molfetta vecchia, penso a piazza Paradiso. A volte tale uso nei fatti diventa indicazione per rivedere le destinazioni d’uso di quelle aree nei piani urbanistici. Mi chiedo, ti chiedo, perché in questo caso un uso di fatto viene inteso dagli amministratori come una indicazione degli abitanti, abitanti che si comportano da aggressivi consumatori di risorse, la risorsa spazi liberi, la risorsa città, la risorsa luoghi di socializzazione? Mi chiedo e ti chiedo perché in questo caso gli abitanti-automobilisti sono letti come portatori di istanze, di bisogni, di desiderata, veicoli di un modello di utilizzo della città che così viene riconosciuto come trasversale e universale? Perché questo modello non può essere messo sotto osservazione critica e valutato, piuttosto che assunto acriticamente come “naturale”? E se lo stesso atteggiamento di “sensibilità” a una “domanda del mercato” o alle pratiche degli “utenti” – cittadini o dei “consumatori” – abitanti fosse applicato alle altre forme abusive di uso del territorio, sarebbe altrettanto ragionevole pensare di fare dietro al duomo una spiaggia pubblica o un allevamento di capre o un giardino zoologico?
E invece, prova a ripensare a Michele e ai bagnanti del lido libero sullo sfondo del duomo: le loro pratiche restano fuori dall’attenzione degli amministratori e dei progettisti, sono semplicisticamente ridotte a deviazioni insignificanti, espressioni di marginalità e abuso, produttrici di degrado ambientale. In quel caso il progetto canonico non si pone domande su quelle forme di esproprio, l’ordine non dialoga col disordine, normalizzarlo vuol dire banalmente eliminalo. Eppure le forme di quel disordine potrebbero essere una occasione per spingerci a scandagliare significati per ciò che è escluso, sfasato, non appartenente, per “risignificare” dove i linguaggi si impastano, sfumano, diventano balbuzie e si aprono a nuove possibilità, sui margini della città, ai margini della comunità dei cittadini, tra le comunità di abitanti, tra regole e non regole, tra individui, tra spazi di vita, bisogni e desideri. Non indicatori di funzioni d’uso ma segnali di problemi di coesistenza e di diritti negati a settori della comunità insediata su cui mettere attenzione per costruire progetti di qualità della vita per tutti. E non solo questo, quelle pratiche spontanee possono far riflettere su stili alternativi a quelli della nostra modernità arrogante, costruita nel modello del “progresso” e del dominio della tecnologia, delle “monocolture della mente” (è il titolo del libro di Vandana Shiva, Bollati Boringhieri, 1995) che distruggono le diversità per una globalizzazione della scala dei privilegi.
Ho incontrato
Michele l’altro giorno, lì dietro al duomo: non ha più
gli animali che con qualche ordinanza gli hanno ingiunto di portare
via. Mi ha detto che i vigili gli spiegavano il divieto di tenere in
città animali che non fossero per “compagnia”, cani
gatti etc., e lui si chiedeva perché quel “etc.” non
potessero essere asini capre e galline che pure a lui facevano molta
“compagnia”. Insomma, ora Michele ha chissà quale altra
occupazione in chissà quale altro posto dimenticato dalla città,
ancora a barcamenarsi, inventando modi per resistere creativamente alla
disoccupazione, alla città dei ghetti.
E solo ora mi ricordo, Michele era venuto a una riunione del Coordinamento
di Quartiere di Molfetta Vecchia a dire che gli avevano mandato l’ingiunzione
di andarsene, e noi eravamo senza risposte per lui, non siamo riusciti
a distrarci dagli altri temi che stavamo affrontando. Invece quello
era un posto giusto dove portare domande, dove venire a raccontare storie,
le tante storie individuali in cerca di ascolto, dove l’ascolto
reciproco ci rende capaci di disegnare il territorio che abitiamo anche
nei suoi tratti più nascosti, meno rappresentati o senza rappresentanza,
di disegnarne la complessità e la conflittualità, con
il disagio di chi è clandestino e quello di chi è precario,
di chi è disoccupato e di chi cerca una casa e deve sbattere
la testa contro i prezzi degli affitti che a Molfetta sono stratosferici,
di chi è straniero e di chi vede l’immigrato come suo concorrente
, di chi vorrebbe un giardinetto per fare giocare i propri figli al
riparo dalle automobili e di chi chiede il vigile di quartiere per arginare
l’arroganza dei più forti.
Sai, Ernesto,
siamo immersi in una realtà complessa, molteplice e in continuo
rapido cambiamento, e penso che abbiamo necessità di guardare
le cose con attenzione e liberati dai pregiudizi, e intuisco che possiamo
trovare indizi di direzioni là dove le strade si perdono. Chi
è obbligato al cambiamento ha necessità di riorganizzare
tutto il proprio mondo e di inventarsi soluzioni spesso non collaudate
e perciò creative. Ci sono nelle nostre città molti invisibili
“laboratori” di pratiche di questo tipo. E chi ancora non
si sente costretto al cambiamento, ma comunque deve già fare
i conti con questo, sui margini della propria quotidianità, della
propria “normalità”, può usare quel disagio
latente come spinta a guardare con interesse a quei laboratori, a organizzarsi
in gruppi di lavoro, per partecipare, per uscire dall’isolamento
e ritrovare la dimensione collettiva dei propri bisogni.
Ciao Ernesto, siamo in cambiamento, con il mal di mare di quando si
lasciano i porti sicuri, e con la necessità vitale di immaginare
gli approdi dove vogliamo andare a mettere le tende, forse portare le
capre e magari andare a fare i bagni di mare tra il cielo e “la
terr”.
Angela
| |
|
settembre - dicembre 2004