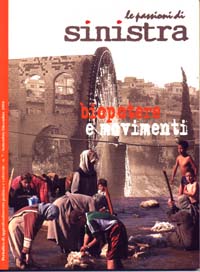Il
lavoro operaio: le dinamiche del mutamento e le condizioni di lavoro
|
La
recente mobilitazione degli operai della Stata di Melfi ha riportato all’attenzione
una realtà, quella del lavoro operaio, che sembra scomparsa assieme
alla fase economico-sociale di cui è stata protagonista; una realtà
che ha subito profonde trasformazioni, ma che non si è ancora estinta
e merita attenzione e lavoro politico.
In questo articolo si tenterà, molto sinteticamente, di prendere in considerazione le trasformazioni che hanno investito il lavoro operaio. A tal fine si procederà all’individuazione e alla discussione di alcuni processi economici tendenziali considerati rilevanti al fine di ricostruire un quadro generale dei mutamenti verificatisi. Successivamente mediante i dati relativi a un’inchiesta svolta dalla rivista Finesecolo sui lavoratori della Stata di Melfi si faranno alcune considerazioni relative alla nuova condizione lavorativa associata al lavoro operaio e ai problemi in termini di qualità del lavoro e di vita che essa solleva.
I processi economici considerati (il processo di deindustrializzazione, il processo di ridimensionamento dell’impresa, il processo d’automazione) prendono avvio tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta in risposta alla crisi economica e sociale determinatasi in quegli anni. Un elemento essenziale di tale risposta è svolto dal progresso tecnologico connesso all’ondata di innovazioni dell’elettronica e dell’informatica.
Il processo di deindustrializzazione
Il processo di deindustrializzazione, inteso come processo di riduzione dell’occupazione industriale, può essere colto dall’analisi dei dati che fotografano la struttura dell’occupazione. A partire dal 1960 e fino al 1980 l’occupazione nel settore dell’industria cresce costantemente, dopo questa data il trend si inverte e comincia a decrescere in modo lento ma persistente. Il declino del settore dell’industria è accompagnato dall’impennata occupazionale, soprattutto a partire dai primi anni Settanta, del terziario privato.
Si tratta di un cambiamento strutturale nella composizione dell’occupazione di grande portata, che per le sue implicazioni, anche in termini di struttura di classe e di organizzazione sociale del paese, è paragonabile solo al massiccio esodo agricolo che aveva avuto luogo tra la prima metà degli anni Cinquanta e la seconda metà degli anni Sessanta.
Nella prima parte del periodo, dal 1960 al 1980, all’aumento dell’occupazione industriale corrisponde l’affermarsi del modello economico e sociale di sviluppo fordista: si assiste alla forte crescita economica delle regioni del triangolo industriale, alla comparsa della grande impresa della produzione di massa nei settori più avanzati del sistema produttivo italiano, a una nuova forma di organizzazione del lavoro ispirata ai principi tayloristi e alle disperate migrazioni dal Mezzogiorno d’Italia per fornire braccia al Nord che si industrializza. “E’ difficile, per inciso, dire quanto sia legittimo parlare di modello di sviluppo fordista in Italia anche per quegli anni, dati la persistenza e il notevole peso della piccola e media impresa, che determinavano così un dualismo nella struttura industriale italiana”(1). Nonostante per l’Italia non si possa parlare di modello produttivo fordista compiuto, o meglio se ne possa parlare solo con riguardo a determinate aree del paese, la crescita del settore industriale in questi anni corrisponde a un processo di crescita numerica e politica della classe operaia e del sindacato di fabbrica, che riguarda tutti i paesi a capitalismo avanzato.
In Italia le rivendicazioni del movimento operaio, raggiungono il loro punto di massimo nell’autunno del 1969, essenzialmente su iniziativa dei primi gruppi autonomi di operai e in un atteggiamento di critica rispetto alla struttura organizzativa e alla linea politica dei sindacati istituzionali. Due furono le principali rivendicazioni del movimento operaio in questi anni: il controllo sul processo lavorativo e l’egualitarismo retributivo. Un ruolo centrale in questa fase viene svolto dal cosiddetto operaio-massa, generalmente giovane, meridionale, non specializzato, addetto al lavoro ripetitivo e alienante alla catena di montaggio fordista e, soprattutto, escluso dal sistema di rappresentanza sindacale. Fu all’opera in questi anni un importante processo di “formazione di una nuova identità collettiva” (2) da parte di masse di lavoratori prima esclusi dal sistema di rappresentanza che diede al movimento operaio una forza e radicalità tali da provocare una crisi di governabilità nel sistema delle grandi imprese italiane. In questi termini si esprime Valerio Castronovo a proposito della situazione in Fiat: “Alla Fiat le tabelle di marcia della produzione s’erano ridotte a pezzi di carta senza alcun valore. Non passava quasi giorno che fermate improvvise, scioperi isolati di piccoli gruppi, dispute sull’ambiente di lavoro, sulla mobilità o sugli straordinari, non bloccassero questo o quel segmento di Mirafiori o di Rivalta, ma anche di Cassino e di altri complessi decentrati (…)” (3).
A questo fattore di instabilità e di crisi per l’impresa, se ne aggiunge un altro: il mutamento della domanda di beni di consumo, che, a causa della crescita del reddito pro-capite e della saturazione dei mercati dei principali beni di consumo di massa, si fa più specializzata, diversificata e instabile. La crisi viene infine aggravata dallo shock petrolifero del 1973, con la conseguente caduta della domanda aggregata e il generale clima di incertezza circa i prezzi relativi e le prospettive di crescita.
La reazione del sistema delle imprese alla crisi segue due direzioni, entrambe rivolte al risparmio del fattore lavoro: il decentramento produttivo e l’avvio del processo di automazione, rispettivamente il secondo e il terzo processo considerati in questo articolo.
Il 1980 (l’anno della sconfitta degli operai della Fiat), come già detto, segna l’inizio del processo di deindustrializzazione, che passa attraverso la ristrutturazione della prima metà degli anni Ottanta, la crisi industriale dei primi anni Novanta e le profonde modifiche nelle caratteristiche quantitative e qualitative dell’occupazione che sono emerse a partire dalla seconda metà degli anni Novanta (4).
Tale processo ha avuto come esito prevalente la riduzione del lavoro operaio soprattutto nella grande industria e nei settori economici trainanti del sistema produttivo fordista. Il conseguente ridimensionamento politico e sociale della classe operaia si è così realizzato mediante l’erosione della “base strutturale” su cui si era fondata la crescita e la forza del movimento operaio.
Secondo l’indagine Istat sulle forze di lavoro (5), in Italia, nel 2002, gli operai erano 7.225.000, il 33,2% degli occupati, nel 1979 erano 9.465.000, il 46,7% degli occupati: l’entità del cambiamento è consistente, la marginalità politica e sociale di questi lavoratori notevolmente maggiore.
Il processo di ridimensionamento dell’impresa
In Italia l’importanza delle imprese di grandi dimensioni cresce fino alla fine degli anni Sessanta per poi decrescere stabilmente; viceversa l’importanza delle imprese minori diminuisce fino alla fine degli anni Sessanta per poi crescere stabilmente.
Attualmente, in Italia, le piccole imprese occupano almeno il 50% dei lavoratori dipendenti, una quota che non ha eguali nei paesi a capitalismo avanzato.
Il ridimensionamento dell’impresa taylor-fordista (la grande impresa verticalmente integrata della produzione di beni di massa standardizzati che sfrutta le economie statiche di scala) avviene mediate due fasi: la prima fase, che possiamo chiamare “snellimento organizzativo”, ha avuto come obiettivo la flessibilizzazione organizzativa dell’impresa fordista; la seconda fase, che possiamo chiamare “snellimento tecnologico”, tende al raggiungimento della flessibilità tecnologica attraverso una profonda trasformazione della struttura d’impresa e del processo produttivo. Entrambi questi processi realizzano una flessibilità crescente del sistema produttivo e nell’uso del fattore lavoro.
Lo snellimento organizzativo ha avuto luogo all’incirca nel decennio che va dal 1975 al 1985 e ha interessato esclusivamente le grandi imprese fordiste del triangolo industriale. È stato attuato mediante un processo di decentramento produttivo consistente in una rilevante esternalizzazione di attività per lo più secondarie del processo di produzione. La sua funzione è stata prevalentemente antisindacale, in risposta alle rivendicazioni e alla forza del movimento operaio. La flessibilità organizzativa viene ottenuta in due modi. Da un lato, l’impresa fordista può concentrarsi sulle attività “a maggior valore aggiunto” e scaricare sui suoi fornitori (e sui loro lavoratori) i costi della flessibilità: quando la domanda è alta il fornitore viene attivato, quando essa si contrae è il fornitore a subire una drastica riduzione delle sue attività. D’altro lato l’impresa fordista può beneficiare della riduzione della massa di lavoratori che avevano costituito il “contropotere operaio” e delle loro “resistenze”, conseguendo, in più, una notevole riduzione dei costi d’impiego della forza lavoro, grazie alle condizioni di lavoro contrassegnate da maggiore cooperazione, minore conflittualità e minori salari delle unità produttive di dimensioni minori.
Nella prima parte di questa fase, all’incirca fino alla fine degli anni Settanta, il ruolo della piccola impresa cresce in ragione dei processi di esternalizzazione, ma proprio per la loro origine, le piccole dimensioni assumono in genere caratteristiche di dipendenza dalle dimensioni maggiori: sono in gran maggioranza unità produttive dell’impresa verticalmente integrata fordista, formalmente autonome per raccogliere i vantaggi della decongestione sociale.
A partire dai primi anni Ottanta e fino al biennio 1985-86, le grandi imprese fordiste avviano la ristrutturazione tecnologica con l’introduzione nel processo produttivo delle tecnologie elettroniche e informatiche. In questi anni, parte della piccola impresa, in un contesto di ripiegamento e di ristrutturazione della grande impresa, assume un ruolo economicamente più rilevante e si organizza, in alcune aree del paese, nei distretti industriali, assumendo caratteristiche simili a quelle del “modello di specializzazione flessibile” (6).
Lo snellimento tecnologico prende avvio nella seconda metà degli anni Ottanta, come esito della ristrutturazione dei primi anni Ottanta, e realizza un profondo processo di trasformazione dell’assetto complessivo della grande impresa, che tende ad organizzarsi secondo una struttura a rete, in genere considerevolmente diffusa nello spazio produttivo globale. Mentre il decentramento della prima fase aveva ridotto massicciamente il grado di integrazione verticale dell’impresa fordista ma aveva lasciato sostanzialmente intatto il metodo e la tecnologia produttiva tayloristi, adesso risulta possibile, proprio in quanto mutano le tecnologie adottate nella produzione, un vero e proprio smembramento del processo produttivo di un dato bene in un sistema di imprese medio-piccole e fra loro molto differenziate, che fanno riferimento, a diversi livelli, a una casa madre di dimensioni tendenzialmente grandi, a seconda del settore.
Questo importante mutamento della struttura produttiva d’impresa di nuovo modifica il rapporto tra grande e piccola dimensione tendendo a ridurre i margini di autonomia delle piccole imprese e a ristabilire la vecchia gerarchia fordista.
Anche le conseguenze sul lavoro risultano di grande portata: si riduce fortemente il numero di lavoratori direttamente alle dipendenze della grande impresa e larga parte della gestione e dell’organizzazione della forza-lavoro è demandata alle imprese, di dimensioni variabili, facenti parte della filiera produttiva. Queste sono obbligate, nei confronti dell’impresa madre, a un dato risultato produttivo, in un dato periodo di tempo, e per ottenerlo possono avvalersi delle forme di lavoro più diversificate: dal lavoro nelle cooperative al lavoro nero, dai “lavoratori autonomi di seconda generazione” alle diverse forme di contratti atipici, in un contesto di crescente espansione della contrattazione individuale.
Il processo d’automazione
“Da quando è cominciato lo sviluppo industriale moderno, ossia da due secoli, abbiamo avuto periodi di poco più di mezzo secolo dominati, ciascuno, da una, due, al massimo tre grandi innovazioni” (7) scrive Paolo Sylos Labini, e attualmente staremmo vivendo la quarta rivoluzione industriale, trainata dal grappolo di innovazioni rappresentato dalle tecnologie elettroniche e informatiche. Come già accennato, in Italia tali tecnologie vengono applicate al processo produttivo delle imprese taylor-fordiste durante la ristrutturazione dei primi anni Ottanta, in conseguenza dei grandi mutamenti avvenuti nel sistema economico, sociale e politico durante gli anni Settanta.
Il processo di ristrutturazione, consistente, dal punto di vista strettamente tecnologico, nella sostituzione di componenti e parti a tecnologia meccanica e elettromeccanica con componenti a tecnologia elettronica, ha modificato profondamente il processo produttivo di tutte le attività industriali consentendo l’automazione di ampie fasi del processo produttivo (automazione flessibile) e la conseguente riduzione delle unità di lavoro richieste per la produzione delle stesse quantità di beni.
È opportuno ora prendere in considerazione, seppur sinteticamente, le trasformazioni che il processo d’automazione ha prodotto sul processo produttivo, sull’organizzazione del lavoro e sulle forme del comando e controllo sul lavoro.
“La produzione è tendenzialmente organizzata come un flusso che procede, a partire da un punto iniziale, per operazioni incrementali successive su ciascun pezzo (flusso monopezzo). Il flusso monopezzo è il risultato dell’azzeramento delle scorte interoperazionali, per cui esso riduce sia il costo delle giacenze sia il tempo di produzione di ciascun prodotto (tempo di attraversamento), dovuto all’annullamento degli spostamenti dei semilavorati da un luogo all’altro della fabbrica” (8).
Nel flusso, la linea ha un movimento prefissato, la cui velocità viene normalmente concordata con il sindacato, ma la quantità di pezzi che entrano sulla linea è variabile e dipende dalle chiamate della cellula produttiva successiva, secondo il principio organizzativo del just-in-time.
Sulle linee del flusso monopezzo sono distribuiti i lavoratori, organizzati secondo una nuova modalità, in generale sconosciuta alla fabbrica taylorista: il team di lavoro. Ogni team costituisce una cellula produttiva che ha come compito rifornire just-in-time (“esattamente al tempo designato”) la cellula a valle del processo produttivo dei componenti richiesti. Il kanban rappresenta lo strumento operativo di realizzazione del just-in-time. Kanban significa letteralmente “cartellino” ed è l’insieme delle informazioni su cosa e quanto produrre che ogni cellula produttiva fa pervenire alla cellula posta subito a monte nel processo produttivo. Interessante è quanto rileva Laura Fiocco a proposito del sistema kanban: “la sua applicazione produce un effetto di occultamento del potere, per cui funziona da dispositivo normalizzante e quindi da forza regolatrice dei rapporti sociali” (9).
L’effetto occultante sarebbe dato dal fatto che il sistema kanban veicola un ordine della direzione senza che questo appaia come tale, perché occultato nella forma di un ordine produttivo oggettivo e neutrale. Infatti, è vero che la produzione effettiva dipende da quanto “tirano” le cellule a valle, ma è la direzione che calcola il potenziale massimo possibile di produzione dato dalla produttività teorica degli operai effettivamente presenti in un turno, e su questa base viene fatta la programmazione operativa, per ogni turno, della quantità e del mix prodotto e vengono impartiti, ai vari livelli, gli ordini conseguenti. Questi ordini, tuttavia, appaiono ai lavoratori nella forma di “fatto oggettivo”, di “necessità” della cellula produttiva collocata a valle del processo produttivo e, in ultima analisi, di ordine d’acquisto del cliente finale, come se il piano della produzione fosse fornito da quest’ultimo. Il risultato è che l’imposizione dei ritmi di lavoro appare agli stessi lavoratori come un imperativo del flusso e non una decisione e un ordine della direzione aziendale.
Il nuovo modello produttivo, qui sinteticamente descritto, configura una forma diversa di controllo e di comando sul lavoro.
La “scienza del lavoro” di Taylor era stato un potente strumento di controllo della forza-lavoro: con essa si era spogliato il lavoratore del potere che poteva avere sul processo produttivo in quanto detentore di professionalità e lo si era forzato a erogare lavoro grezzo, semplice energia lavorativa, sotto il comando del nastro della catena di montaggio fordista che imponeva in ogni momento il gesto da compiere e il ritmo al quale eseguirlo. L’operaio era diventato l’appendice umana della macchina, il suo lavoro poteva essere svolto da uno scimpanzé ammaestrato.
Si era così ottenuta una produttività del lavoro che non aveva precedenti e si era riacquistato a pieno il controllo del processo produttivo e della forza-lavoro, sconfiggendo la resistenza degli operai al comando d’impresa e la loro “lentezza sistematica”.
Le vicende degli anni successivi, la graduale presa di coscienza dell’operaio, l’organizzazione e le rivendicazioni del movimento operaio, rendono la scienza del lavoro sempre più inadeguata: il lavoro sfugge al comando della catena di montaggio, con gli scioperi, la “lentezza sistematica”, l’assenteismo e non obbedisce più ai capi, la direzione aziendale perde il controllo sul processo produttivo e sulla forza-lavoro.
La fabbrica integrata invece cambia realmente la forma del comando e del controllo sul lavoro. L’erogazione di energia lavorativa sotto il comando e al ritmo della catena di montaggio viene sostituita dal sistema just-in-time: è la necessità di rifornire just-in-time la cellula a valle che impone alla cellula produttiva le quantità da produrre e i tempi di produzione.
La prestazione lavorativa adesso non si esaurisce più nella ripetizione di un gesto elementare e sempre uguale, ma affianca attività esecutive ad attività di controllo, richiede all’operaio di essere “polivalente” (viene meno il principio taylorista “un uomo, una mansione”), di lavorare su più macchine e, soprattutto, di “autoattivarsi” (di partecipare attivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, controllando che tutto proceda come previsto, risolvendo i problemi che possono presentarsi durante la produzione, recuperando l’eventuale scarto tra la produzione richiesta e quella effettiva).
Il nuovo modello produttivo muta anche l’organizzazione gerarchica della fabbrica, diminuendo il numero di livelli gerarchici, e il sistema di gestione del personale. Il primo aspetto – la riduzione del numero di livelli gerarchici e la conseguente diminuzione del numero di “capi” – in generale non ha comportato una riduzione della sorveglianza sui lavoratori: nella fabbrica snella la sorveglianza, per così dire visibile, dei “capi” fordisti può essere sostituita dalla strumentazione elettronica di sorveglianza e controllo sul lavoro che consente la monitorizzazione continua di tutto il processo produttivo. Il controllo della direzione, lungi dal diminuire, si fa più efficace e pervasivo, perché induce i lavoratori monitorati via computer a interiorizzare le norme di comportamento, imposte come se fossero normali regole di esistenza.
Relativamente al secondo aspetto, invece, abbiamo già visto come l’organizzazione in gruppi di lavoro sia uno degli aspetti più importanti del nuovo modello produttivo. Questo tipo di organizzazione ha delle conseguenze rilevanti, in termini di controllo sul lavoro: nella fabbrica integrata la cellula produttiva (gruppo di lavoro) costituisce la nuova dimensione del rapporto tra i lavoratori esecutivi e i loro capi. In questo contesto, di dimensioni variabili ma tendenzialmente modeste, il capo della cellula produttiva intrattiene con i lavoratori rapporti di tipo personale, invece che gerarchico-militare e gestisce le tensioni e le resistenze che possono nascere “nella forma di relazioni apparentemente discorsive e interpersonali”. “Tutta la logica di gestione delle tensioni è tesa a scongiurare il conflitto aperto, e ad escludere il sindacato dalla negoziazione”(10). La conseguenza è che i lavoratori negoziano individualmente le esigenze e i bisogni che emergono quotidianamente sul lavoro.
La richiesta di autoattivazione fatta all’operaio è in realtà la richiesta che questi condivida e faccia propri i fini dell’impresa in cui lavora, si faccia coinvolgere dalle difficoltà dell’azienda e interiorizzi un problema che invece risultava estraneo all’operaio fordista: il problema della competitività e della profittabilità dell’impresa. “E’ così condotto alle estreme conseguenze il principio della riduzione assoluta dei tempi di vita della forza-lavoro a tempi produttivi, che aveva costituito il reale obiettivo dello scientific management. E che aveva orientato la ricerca di Taylor” (11).
La fabbrica integrata usa il senso di appartenenza all’impresa come la fabbrica taylorista usava la costrizione; aspira all’egemonia, ad acquisire la fedeltà e la disponibilità del lavoro, come quella si fondava sul dispotismo. “Si tratta cioè di sussumere al capitale la dimensione esistenziale stessa della forza lavoro. Di identificare la soggettività del lavoro con la soggettività del capitale. Anzi di fare dell’appartenenza all’Impresa l’unica soggettività possibile” (12). La nuova forma di controllo sul lavoro passa, o dovrebbe passare, per una ideologia di questo tipo e si realizza attraverso i meccanismi descritti, ma, come suggerisce Laura Fiocco, ha dei forti fondamenti materiali, che, io credo, siano strettamente connessi all’assetto assunto complessivamente dal mercato del lavoro.
Il risultato dei processi economici presi in considerazione nelle righe precedenti può essere individuato nella destrutturazione della figura operaia tipica dell’organizzazione della produzione e del lavoro fordista – l’operaio della grande impresa a tecnologia meccanica regolata secondo i principi dell’organizzazione scientifica del lavoro – e, contemporaneamente, nella strutturazione di una nuova forza lavoro operaia.
Questa si presenta di dimensioni molto minori (13), dispersa in unità produttive di dimensioni variabili, ma tendenzialmente ridotte e molto diversificate quanto a livello tecnologico e organizzazione della produzione e del lavoro, inserita in un contesto di automazione crescente, seppure quasi mai compiutamente realizzato, e sottoposta a forme contrattuali differenziate, spesso precarie.
1. E. Pugliese, E. Rebeggiani, Occupazione e disoccupazione in Italia (1945-1995), Edizioni Lavoro, Roma, 1997
2. A. Pizzorno, E. Reyneri, M. Regini, I. Regalia, Lotte operaie e sindacato. Il ciclo 1968-1972 in Italia, Il Mulino, Bologna, 1978
3. V. Castronovo, Fiat 1899-1999 un secolo di storia italiana, Rizzoli, Milano, 1999
4. A partire dal 1996, in Italia e negli altri paesi Europei, l’occupazione cresce costantemente, ma tale aumento presenta caratteristiche di forte discontinuità rispetto al passato sia perché riguarda in modo massiccio le donne sia perché vede un importante mutamento delle forme del rapporto di lavoro: l’emergere e il consolidarsi di rapporti di lavoro cosiddetti atipici, che nel 2002 riguardavano ben il 22,7% degli occupati.
5. Istat, Forze di lavoro, 2003
6. F. Barca, M. Magnani, L’industria tra capitale e lavoro, Il Mulino, Bologna, 1989
7. P. Sylos Labini, Nuove tecnologie e disoccupazione, Laterza, Bari, 1989
8. L. Fiocco, Innovazione tecnologica e innovazione sociale, Rubbettino, Catanzaro, 1998
9. Ibidem
10. Ibidem
11. M. Revelli, Introduzione a T. Ohno, Lo spirito Toyota, Einaudi, Torino, 1993
12. Ibidem
13. Questa considerazione è relativa all’Italia, come tutto il ragionamento svolto fino a questo momento. Lo stesso può dirsi per tutti i paesi cosiddetti a capitalismo avanzato, ma non per i paesi in via di sviluppo, dove, al contrario, il lavoro operaio cresce in conseguenza dei vasti processi di delocalizzazione produttiva dei paesi occidentali.
14. V. Rieser, La fabbrica integrata “realizzata”, Finesecolo, 1996 e I lavoratori della fabbrica integrata continuità e mutamenti, Finesecolo, 1998
15. L. Gallino, Lavoro, Sociologia del, Dizionario di sociologia, Utet, Torino, 1993
16. V. Rieser, Nuovi lavori, nuovo sindacato, La rivista del manifesto, n. 20, 2001
In questo articolo si tenterà, molto sinteticamente, di prendere in considerazione le trasformazioni che hanno investito il lavoro operaio. A tal fine si procederà all’individuazione e alla discussione di alcuni processi economici tendenziali considerati rilevanti al fine di ricostruire un quadro generale dei mutamenti verificatisi. Successivamente mediante i dati relativi a un’inchiesta svolta dalla rivista Finesecolo sui lavoratori della Stata di Melfi si faranno alcune considerazioni relative alla nuova condizione lavorativa associata al lavoro operaio e ai problemi in termini di qualità del lavoro e di vita che essa solleva.
I processi economici considerati (il processo di deindustrializzazione, il processo di ridimensionamento dell’impresa, il processo d’automazione) prendono avvio tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta in risposta alla crisi economica e sociale determinatasi in quegli anni. Un elemento essenziale di tale risposta è svolto dal progresso tecnologico connesso all’ondata di innovazioni dell’elettronica e dell’informatica.
Il processo di deindustrializzazione
Il processo di deindustrializzazione, inteso come processo di riduzione dell’occupazione industriale, può essere colto dall’analisi dei dati che fotografano la struttura dell’occupazione. A partire dal 1960 e fino al 1980 l’occupazione nel settore dell’industria cresce costantemente, dopo questa data il trend si inverte e comincia a decrescere in modo lento ma persistente. Il declino del settore dell’industria è accompagnato dall’impennata occupazionale, soprattutto a partire dai primi anni Settanta, del terziario privato.
Si tratta di un cambiamento strutturale nella composizione dell’occupazione di grande portata, che per le sue implicazioni, anche in termini di struttura di classe e di organizzazione sociale del paese, è paragonabile solo al massiccio esodo agricolo che aveva avuto luogo tra la prima metà degli anni Cinquanta e la seconda metà degli anni Sessanta.
Nella prima parte del periodo, dal 1960 al 1980, all’aumento dell’occupazione industriale corrisponde l’affermarsi del modello economico e sociale di sviluppo fordista: si assiste alla forte crescita economica delle regioni del triangolo industriale, alla comparsa della grande impresa della produzione di massa nei settori più avanzati del sistema produttivo italiano, a una nuova forma di organizzazione del lavoro ispirata ai principi tayloristi e alle disperate migrazioni dal Mezzogiorno d’Italia per fornire braccia al Nord che si industrializza. “E’ difficile, per inciso, dire quanto sia legittimo parlare di modello di sviluppo fordista in Italia anche per quegli anni, dati la persistenza e il notevole peso della piccola e media impresa, che determinavano così un dualismo nella struttura industriale italiana”(1). Nonostante per l’Italia non si possa parlare di modello produttivo fordista compiuto, o meglio se ne possa parlare solo con riguardo a determinate aree del paese, la crescita del settore industriale in questi anni corrisponde a un processo di crescita numerica e politica della classe operaia e del sindacato di fabbrica, che riguarda tutti i paesi a capitalismo avanzato.
In Italia le rivendicazioni del movimento operaio, raggiungono il loro punto di massimo nell’autunno del 1969, essenzialmente su iniziativa dei primi gruppi autonomi di operai e in un atteggiamento di critica rispetto alla struttura organizzativa e alla linea politica dei sindacati istituzionali. Due furono le principali rivendicazioni del movimento operaio in questi anni: il controllo sul processo lavorativo e l’egualitarismo retributivo. Un ruolo centrale in questa fase viene svolto dal cosiddetto operaio-massa, generalmente giovane, meridionale, non specializzato, addetto al lavoro ripetitivo e alienante alla catena di montaggio fordista e, soprattutto, escluso dal sistema di rappresentanza sindacale. Fu all’opera in questi anni un importante processo di “formazione di una nuova identità collettiva” (2) da parte di masse di lavoratori prima esclusi dal sistema di rappresentanza che diede al movimento operaio una forza e radicalità tali da provocare una crisi di governabilità nel sistema delle grandi imprese italiane. In questi termini si esprime Valerio Castronovo a proposito della situazione in Fiat: “Alla Fiat le tabelle di marcia della produzione s’erano ridotte a pezzi di carta senza alcun valore. Non passava quasi giorno che fermate improvvise, scioperi isolati di piccoli gruppi, dispute sull’ambiente di lavoro, sulla mobilità o sugli straordinari, non bloccassero questo o quel segmento di Mirafiori o di Rivalta, ma anche di Cassino e di altri complessi decentrati (…)” (3).
A questo fattore di instabilità e di crisi per l’impresa, se ne aggiunge un altro: il mutamento della domanda di beni di consumo, che, a causa della crescita del reddito pro-capite e della saturazione dei mercati dei principali beni di consumo di massa, si fa più specializzata, diversificata e instabile. La crisi viene infine aggravata dallo shock petrolifero del 1973, con la conseguente caduta della domanda aggregata e il generale clima di incertezza circa i prezzi relativi e le prospettive di crescita.
La reazione del sistema delle imprese alla crisi segue due direzioni, entrambe rivolte al risparmio del fattore lavoro: il decentramento produttivo e l’avvio del processo di automazione, rispettivamente il secondo e il terzo processo considerati in questo articolo.
Il 1980 (l’anno della sconfitta degli operai della Fiat), come già detto, segna l’inizio del processo di deindustrializzazione, che passa attraverso la ristrutturazione della prima metà degli anni Ottanta, la crisi industriale dei primi anni Novanta e le profonde modifiche nelle caratteristiche quantitative e qualitative dell’occupazione che sono emerse a partire dalla seconda metà degli anni Novanta (4).
Tale processo ha avuto come esito prevalente la riduzione del lavoro operaio soprattutto nella grande industria e nei settori economici trainanti del sistema produttivo fordista. Il conseguente ridimensionamento politico e sociale della classe operaia si è così realizzato mediante l’erosione della “base strutturale” su cui si era fondata la crescita e la forza del movimento operaio.
Secondo l’indagine Istat sulle forze di lavoro (5), in Italia, nel 2002, gli operai erano 7.225.000, il 33,2% degli occupati, nel 1979 erano 9.465.000, il 46,7% degli occupati: l’entità del cambiamento è consistente, la marginalità politica e sociale di questi lavoratori notevolmente maggiore.
Il processo di ridimensionamento dell’impresa
In Italia l’importanza delle imprese di grandi dimensioni cresce fino alla fine degli anni Sessanta per poi decrescere stabilmente; viceversa l’importanza delle imprese minori diminuisce fino alla fine degli anni Sessanta per poi crescere stabilmente.
Attualmente, in Italia, le piccole imprese occupano almeno il 50% dei lavoratori dipendenti, una quota che non ha eguali nei paesi a capitalismo avanzato.
Il ridimensionamento dell’impresa taylor-fordista (la grande impresa verticalmente integrata della produzione di beni di massa standardizzati che sfrutta le economie statiche di scala) avviene mediate due fasi: la prima fase, che possiamo chiamare “snellimento organizzativo”, ha avuto come obiettivo la flessibilizzazione organizzativa dell’impresa fordista; la seconda fase, che possiamo chiamare “snellimento tecnologico”, tende al raggiungimento della flessibilità tecnologica attraverso una profonda trasformazione della struttura d’impresa e del processo produttivo. Entrambi questi processi realizzano una flessibilità crescente del sistema produttivo e nell’uso del fattore lavoro.
Lo snellimento organizzativo ha avuto luogo all’incirca nel decennio che va dal 1975 al 1985 e ha interessato esclusivamente le grandi imprese fordiste del triangolo industriale. È stato attuato mediante un processo di decentramento produttivo consistente in una rilevante esternalizzazione di attività per lo più secondarie del processo di produzione. La sua funzione è stata prevalentemente antisindacale, in risposta alle rivendicazioni e alla forza del movimento operaio. La flessibilità organizzativa viene ottenuta in due modi. Da un lato, l’impresa fordista può concentrarsi sulle attività “a maggior valore aggiunto” e scaricare sui suoi fornitori (e sui loro lavoratori) i costi della flessibilità: quando la domanda è alta il fornitore viene attivato, quando essa si contrae è il fornitore a subire una drastica riduzione delle sue attività. D’altro lato l’impresa fordista può beneficiare della riduzione della massa di lavoratori che avevano costituito il “contropotere operaio” e delle loro “resistenze”, conseguendo, in più, una notevole riduzione dei costi d’impiego della forza lavoro, grazie alle condizioni di lavoro contrassegnate da maggiore cooperazione, minore conflittualità e minori salari delle unità produttive di dimensioni minori.
Nella prima parte di questa fase, all’incirca fino alla fine degli anni Settanta, il ruolo della piccola impresa cresce in ragione dei processi di esternalizzazione, ma proprio per la loro origine, le piccole dimensioni assumono in genere caratteristiche di dipendenza dalle dimensioni maggiori: sono in gran maggioranza unità produttive dell’impresa verticalmente integrata fordista, formalmente autonome per raccogliere i vantaggi della decongestione sociale.
A partire dai primi anni Ottanta e fino al biennio 1985-86, le grandi imprese fordiste avviano la ristrutturazione tecnologica con l’introduzione nel processo produttivo delle tecnologie elettroniche e informatiche. In questi anni, parte della piccola impresa, in un contesto di ripiegamento e di ristrutturazione della grande impresa, assume un ruolo economicamente più rilevante e si organizza, in alcune aree del paese, nei distretti industriali, assumendo caratteristiche simili a quelle del “modello di specializzazione flessibile” (6).
Lo snellimento tecnologico prende avvio nella seconda metà degli anni Ottanta, come esito della ristrutturazione dei primi anni Ottanta, e realizza un profondo processo di trasformazione dell’assetto complessivo della grande impresa, che tende ad organizzarsi secondo una struttura a rete, in genere considerevolmente diffusa nello spazio produttivo globale. Mentre il decentramento della prima fase aveva ridotto massicciamente il grado di integrazione verticale dell’impresa fordista ma aveva lasciato sostanzialmente intatto il metodo e la tecnologia produttiva tayloristi, adesso risulta possibile, proprio in quanto mutano le tecnologie adottate nella produzione, un vero e proprio smembramento del processo produttivo di un dato bene in un sistema di imprese medio-piccole e fra loro molto differenziate, che fanno riferimento, a diversi livelli, a una casa madre di dimensioni tendenzialmente grandi, a seconda del settore.
Questo importante mutamento della struttura produttiva d’impresa di nuovo modifica il rapporto tra grande e piccola dimensione tendendo a ridurre i margini di autonomia delle piccole imprese e a ristabilire la vecchia gerarchia fordista.
Anche le conseguenze sul lavoro risultano di grande portata: si riduce fortemente il numero di lavoratori direttamente alle dipendenze della grande impresa e larga parte della gestione e dell’organizzazione della forza-lavoro è demandata alle imprese, di dimensioni variabili, facenti parte della filiera produttiva. Queste sono obbligate, nei confronti dell’impresa madre, a un dato risultato produttivo, in un dato periodo di tempo, e per ottenerlo possono avvalersi delle forme di lavoro più diversificate: dal lavoro nelle cooperative al lavoro nero, dai “lavoratori autonomi di seconda generazione” alle diverse forme di contratti atipici, in un contesto di crescente espansione della contrattazione individuale.
Il processo d’automazione
“Da quando è cominciato lo sviluppo industriale moderno, ossia da due secoli, abbiamo avuto periodi di poco più di mezzo secolo dominati, ciascuno, da una, due, al massimo tre grandi innovazioni” (7) scrive Paolo Sylos Labini, e attualmente staremmo vivendo la quarta rivoluzione industriale, trainata dal grappolo di innovazioni rappresentato dalle tecnologie elettroniche e informatiche. Come già accennato, in Italia tali tecnologie vengono applicate al processo produttivo delle imprese taylor-fordiste durante la ristrutturazione dei primi anni Ottanta, in conseguenza dei grandi mutamenti avvenuti nel sistema economico, sociale e politico durante gli anni Settanta.
Il processo di ristrutturazione, consistente, dal punto di vista strettamente tecnologico, nella sostituzione di componenti e parti a tecnologia meccanica e elettromeccanica con componenti a tecnologia elettronica, ha modificato profondamente il processo produttivo di tutte le attività industriali consentendo l’automazione di ampie fasi del processo produttivo (automazione flessibile) e la conseguente riduzione delle unità di lavoro richieste per la produzione delle stesse quantità di beni.
È opportuno ora prendere in considerazione, seppur sinteticamente, le trasformazioni che il processo d’automazione ha prodotto sul processo produttivo, sull’organizzazione del lavoro e sulle forme del comando e controllo sul lavoro.
“La produzione è tendenzialmente organizzata come un flusso che procede, a partire da un punto iniziale, per operazioni incrementali successive su ciascun pezzo (flusso monopezzo). Il flusso monopezzo è il risultato dell’azzeramento delle scorte interoperazionali, per cui esso riduce sia il costo delle giacenze sia il tempo di produzione di ciascun prodotto (tempo di attraversamento), dovuto all’annullamento degli spostamenti dei semilavorati da un luogo all’altro della fabbrica” (8).
Nel flusso, la linea ha un movimento prefissato, la cui velocità viene normalmente concordata con il sindacato, ma la quantità di pezzi che entrano sulla linea è variabile e dipende dalle chiamate della cellula produttiva successiva, secondo il principio organizzativo del just-in-time.
Sulle linee del flusso monopezzo sono distribuiti i lavoratori, organizzati secondo una nuova modalità, in generale sconosciuta alla fabbrica taylorista: il team di lavoro. Ogni team costituisce una cellula produttiva che ha come compito rifornire just-in-time (“esattamente al tempo designato”) la cellula a valle del processo produttivo dei componenti richiesti. Il kanban rappresenta lo strumento operativo di realizzazione del just-in-time. Kanban significa letteralmente “cartellino” ed è l’insieme delle informazioni su cosa e quanto produrre che ogni cellula produttiva fa pervenire alla cellula posta subito a monte nel processo produttivo. Interessante è quanto rileva Laura Fiocco a proposito del sistema kanban: “la sua applicazione produce un effetto di occultamento del potere, per cui funziona da dispositivo normalizzante e quindi da forza regolatrice dei rapporti sociali” (9).
L’effetto occultante sarebbe dato dal fatto che il sistema kanban veicola un ordine della direzione senza che questo appaia come tale, perché occultato nella forma di un ordine produttivo oggettivo e neutrale. Infatti, è vero che la produzione effettiva dipende da quanto “tirano” le cellule a valle, ma è la direzione che calcola il potenziale massimo possibile di produzione dato dalla produttività teorica degli operai effettivamente presenti in un turno, e su questa base viene fatta la programmazione operativa, per ogni turno, della quantità e del mix prodotto e vengono impartiti, ai vari livelli, gli ordini conseguenti. Questi ordini, tuttavia, appaiono ai lavoratori nella forma di “fatto oggettivo”, di “necessità” della cellula produttiva collocata a valle del processo produttivo e, in ultima analisi, di ordine d’acquisto del cliente finale, come se il piano della produzione fosse fornito da quest’ultimo. Il risultato è che l’imposizione dei ritmi di lavoro appare agli stessi lavoratori come un imperativo del flusso e non una decisione e un ordine della direzione aziendale.
Il nuovo modello produttivo, qui sinteticamente descritto, configura una forma diversa di controllo e di comando sul lavoro.
La “scienza del lavoro” di Taylor era stato un potente strumento di controllo della forza-lavoro: con essa si era spogliato il lavoratore del potere che poteva avere sul processo produttivo in quanto detentore di professionalità e lo si era forzato a erogare lavoro grezzo, semplice energia lavorativa, sotto il comando del nastro della catena di montaggio fordista che imponeva in ogni momento il gesto da compiere e il ritmo al quale eseguirlo. L’operaio era diventato l’appendice umana della macchina, il suo lavoro poteva essere svolto da uno scimpanzé ammaestrato.
Si era così ottenuta una produttività del lavoro che non aveva precedenti e si era riacquistato a pieno il controllo del processo produttivo e della forza-lavoro, sconfiggendo la resistenza degli operai al comando d’impresa e la loro “lentezza sistematica”.
Le vicende degli anni successivi, la graduale presa di coscienza dell’operaio, l’organizzazione e le rivendicazioni del movimento operaio, rendono la scienza del lavoro sempre più inadeguata: il lavoro sfugge al comando della catena di montaggio, con gli scioperi, la “lentezza sistematica”, l’assenteismo e non obbedisce più ai capi, la direzione aziendale perde il controllo sul processo produttivo e sulla forza-lavoro.
La fabbrica integrata invece cambia realmente la forma del comando e del controllo sul lavoro. L’erogazione di energia lavorativa sotto il comando e al ritmo della catena di montaggio viene sostituita dal sistema just-in-time: è la necessità di rifornire just-in-time la cellula a valle che impone alla cellula produttiva le quantità da produrre e i tempi di produzione.
La prestazione lavorativa adesso non si esaurisce più nella ripetizione di un gesto elementare e sempre uguale, ma affianca attività esecutive ad attività di controllo, richiede all’operaio di essere “polivalente” (viene meno il principio taylorista “un uomo, una mansione”), di lavorare su più macchine e, soprattutto, di “autoattivarsi” (di partecipare attivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, controllando che tutto proceda come previsto, risolvendo i problemi che possono presentarsi durante la produzione, recuperando l’eventuale scarto tra la produzione richiesta e quella effettiva).
Il nuovo modello produttivo muta anche l’organizzazione gerarchica della fabbrica, diminuendo il numero di livelli gerarchici, e il sistema di gestione del personale. Il primo aspetto – la riduzione del numero di livelli gerarchici e la conseguente diminuzione del numero di “capi” – in generale non ha comportato una riduzione della sorveglianza sui lavoratori: nella fabbrica snella la sorveglianza, per così dire visibile, dei “capi” fordisti può essere sostituita dalla strumentazione elettronica di sorveglianza e controllo sul lavoro che consente la monitorizzazione continua di tutto il processo produttivo. Il controllo della direzione, lungi dal diminuire, si fa più efficace e pervasivo, perché induce i lavoratori monitorati via computer a interiorizzare le norme di comportamento, imposte come se fossero normali regole di esistenza.
Relativamente al secondo aspetto, invece, abbiamo già visto come l’organizzazione in gruppi di lavoro sia uno degli aspetti più importanti del nuovo modello produttivo. Questo tipo di organizzazione ha delle conseguenze rilevanti, in termini di controllo sul lavoro: nella fabbrica integrata la cellula produttiva (gruppo di lavoro) costituisce la nuova dimensione del rapporto tra i lavoratori esecutivi e i loro capi. In questo contesto, di dimensioni variabili ma tendenzialmente modeste, il capo della cellula produttiva intrattiene con i lavoratori rapporti di tipo personale, invece che gerarchico-militare e gestisce le tensioni e le resistenze che possono nascere “nella forma di relazioni apparentemente discorsive e interpersonali”. “Tutta la logica di gestione delle tensioni è tesa a scongiurare il conflitto aperto, e ad escludere il sindacato dalla negoziazione”(10). La conseguenza è che i lavoratori negoziano individualmente le esigenze e i bisogni che emergono quotidianamente sul lavoro.
La richiesta di autoattivazione fatta all’operaio è in realtà la richiesta che questi condivida e faccia propri i fini dell’impresa in cui lavora, si faccia coinvolgere dalle difficoltà dell’azienda e interiorizzi un problema che invece risultava estraneo all’operaio fordista: il problema della competitività e della profittabilità dell’impresa. “E’ così condotto alle estreme conseguenze il principio della riduzione assoluta dei tempi di vita della forza-lavoro a tempi produttivi, che aveva costituito il reale obiettivo dello scientific management. E che aveva orientato la ricerca di Taylor” (11).
La fabbrica integrata usa il senso di appartenenza all’impresa come la fabbrica taylorista usava la costrizione; aspira all’egemonia, ad acquisire la fedeltà e la disponibilità del lavoro, come quella si fondava sul dispotismo. “Si tratta cioè di sussumere al capitale la dimensione esistenziale stessa della forza lavoro. Di identificare la soggettività del lavoro con la soggettività del capitale. Anzi di fare dell’appartenenza all’Impresa l’unica soggettività possibile” (12). La nuova forma di controllo sul lavoro passa, o dovrebbe passare, per una ideologia di questo tipo e si realizza attraverso i meccanismi descritti, ma, come suggerisce Laura Fiocco, ha dei forti fondamenti materiali, che, io credo, siano strettamente connessi all’assetto assunto complessivamente dal mercato del lavoro.
Il risultato dei processi economici presi in considerazione nelle righe precedenti può essere individuato nella destrutturazione della figura operaia tipica dell’organizzazione della produzione e del lavoro fordista – l’operaio della grande impresa a tecnologia meccanica regolata secondo i principi dell’organizzazione scientifica del lavoro – e, contemporaneamente, nella strutturazione di una nuova forza lavoro operaia.
Questa si presenta di dimensioni molto minori (13), dispersa in unità produttive di dimensioni variabili, ma tendenzialmente ridotte e molto diversificate quanto a livello tecnologico e organizzazione della produzione e del lavoro, inserita in un contesto di automazione crescente, seppure quasi mai compiutamente realizzato, e sottoposta a forme contrattuali differenziate, spesso precarie.
Il caso
Melfi
Nel 1996 e nel 1998 la rivista Finesecolo ha realizzato un’inchiesta
tra gli operai della Stata di Melfi: un punto di vista importante, seppure
necessariamente parziale, al fine di cogliere i diversi aspetti della
condizione lavorativa e i problemi in termini di qualità del
lavoro che essa solleva.
L’inchiesta, come elaborata in due contributi di Vittorio Rieser
(14) a cui si rimanda, analizza la condizione di lavoro, sulla base
di cinque dimensioni (rotazione tra mansioni, ritmi e tempi di lavoro,
orario e straordinario, nocività e infortuni, salario), e i rapporti
sociali aziendali (rapporti gerarchici, rapporti tra operai, sistema
di premi e punizioni).
Dalle parole degli intervistati emerge una condizione di lavoro, che,
da un lato, risente in modo pesante del nuovo modello organizzativo
“a flusso teso” (turni di lavoro con la cosiddetta “doppia
battuta”, fortissima pressione temporale in termini di ritmi di
lavoro e sovraccarico di compiti, cui sono associati stress, incidenti
di lavoro, situazioni di tensione tra i lavoratori) e, dall’altro,
si scontra ancora con situazioni “tradizionali” (come la noia
e la fatica del lavoro, i salari bassi e un sistema sociale aziendale,
in cui l’esigenza di controllo sociale “diretto” prevale
su quelle di integrazione e incentivazione) che trovano alimento, oggi
come ieri, nella diffusa disoccupazione dell’area (il cosiddetto
“effetto prato verde”).
Contrariamente a quanto previsto dal nuovo modello produttivo, non emergono
segnali di identificazione dei lavoratori con l’azienda. Questa,
in genere, viene percepita come un posto da cui, se possibile, scappare
o come un posto in cui si è costretti a rimanere. Questo elemento
può essere ricondotto alla natura “contraddittoria e non
assestata” dello stabilimento di Melfi e in particolare al sistema
di controllo sociale di tipo gerarchico-repressivo, denunciato dagli
operai di Melfi durante la loro recente mobilitazione. Il terreno dell’identificazione
viene allora spostato fuori dall’attività lavorativa, essendo
venuta meno la speranza di controllarla e “gestirla”, mentre
l’insoddisfazione rispetto al proprio lavoro è in generale
alta e si accompagna a sentimenti di marginalità sociale e di
insicurezza, legati al timore di licenziamento (e alle scarse prospettive
occupazionali alternative) o di “terziarizzazione” e all’assenza
di protezione sindacale e di rappresentanza politica.
I problemi in termini di qualità del lavoro che emergono da questa
realtà sono assolutamente importanti. Possiamo considerare, secondo
l’analisi di Luciano Gallino (15), la qualità del lavoro,
sulla base di quattro dimensioni: ergonomica, della complessità,
dell’autonomia e del controllo.
Sulla base di quanto emerso dall’inchiesta è possibile affermare
che mentre la dimensione ergonomica presenta una situazione molto critica,
a causa dei turni e dei ritmi di lavoro insostenibili imposti, le dimensioni
dell’autonomia e del controllo restano, oggi più di ieri,
completamente fuori dalla portata di questi lavoratori. Probabilmente,
invece, la dimensione della complessità ha subito una qualche
positiva evoluzione, anche se questa sembra essersi espressa piuttosto
in un aumento relativo di figure più qualificate in fabbrica
che in un aumento generalizzato del livello di qualificazione della
forza-lavoro.
Infine, come hanno mostrato le mobilitazioni degli operai di Melfi e
nonostante tali mobilitazioni, resta l’ineludibile problema dei
bassi salari e la più generale questione salariale, che si presenta
sotto certi aspetti in termini nuovi e molto più complessi che
in passato.
Si tratta, come sottolinea Vittorio Rieser, di ricostruire con la realtà
del lavoro, considerata nella sua totalità e complessità,
un nuovo rapporto conoscitivo e organizzativo, con uno sforzo sia in
termini di analisi sia in termini di elaborazione rivendicativa e di
proposte organizzative, di cui un bilancio autocritico da parte delle
organizzazioni sindacali è la necessaria premessa (16).
La capacità del sindacato di costruire le condizioni contrattuali
per accrescere il controllo dei lavoratori sulla prestazione lavorativa
passa per la capacità di dare ascolto alle nuove esigenze del
lavoro, ricostruendo un tessuto di rappresentanza sulla prestazione/condizione
di lavoro e coinvolgendo i lavoratori giovani, facendo loro vedere la
rappresentanza sindacale come uno strumento che funziona sui loro problemi
concreti. Tanto più che nelle realtà dove il sindacato
è riuscito a muoversi in questa direzione, i risultati sembrano
essere stati positivi. Uno sforzo difficile e da svolgere su più
fronti che abbisogna di tutto il sostegno e il lavoro delle forze politiche
e sociali, perché è anche da questo che dipende la forza
dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali.
1. E. Pugliese, E. Rebeggiani, Occupazione e disoccupazione in Italia (1945-1995), Edizioni Lavoro, Roma, 1997
2. A. Pizzorno, E. Reyneri, M. Regini, I. Regalia, Lotte operaie e sindacato. Il ciclo 1968-1972 in Italia, Il Mulino, Bologna, 1978
3. V. Castronovo, Fiat 1899-1999 un secolo di storia italiana, Rizzoli, Milano, 1999
4. A partire dal 1996, in Italia e negli altri paesi Europei, l’occupazione cresce costantemente, ma tale aumento presenta caratteristiche di forte discontinuità rispetto al passato sia perché riguarda in modo massiccio le donne sia perché vede un importante mutamento delle forme del rapporto di lavoro: l’emergere e il consolidarsi di rapporti di lavoro cosiddetti atipici, che nel 2002 riguardavano ben il 22,7% degli occupati.
5. Istat, Forze di lavoro, 2003
6. F. Barca, M. Magnani, L’industria tra capitale e lavoro, Il Mulino, Bologna, 1989
7. P. Sylos Labini, Nuove tecnologie e disoccupazione, Laterza, Bari, 1989
8. L. Fiocco, Innovazione tecnologica e innovazione sociale, Rubbettino, Catanzaro, 1998
9. Ibidem
10. Ibidem
11. M. Revelli, Introduzione a T. Ohno, Lo spirito Toyota, Einaudi, Torino, 1993
12. Ibidem
13. Questa considerazione è relativa all’Italia, come tutto il ragionamento svolto fino a questo momento. Lo stesso può dirsi per tutti i paesi cosiddetti a capitalismo avanzato, ma non per i paesi in via di sviluppo, dove, al contrario, il lavoro operaio cresce in conseguenza dei vasti processi di delocalizzazione produttiva dei paesi occidentali.
14. V. Rieser, La fabbrica integrata “realizzata”, Finesecolo, 1996 e I lavoratori della fabbrica integrata continuità e mutamenti, Finesecolo, 1998
15. L. Gallino, Lavoro, Sociologia del, Dizionario di sociologia, Utet, Torino, 1993
16. V. Rieser, Nuovi lavori, nuovo sindacato, La rivista del manifesto, n. 20, 2001
| |
|
settembre - dicembre 2004