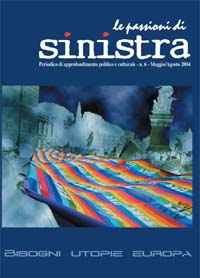Nella terra senza futuro |
Puglia, Italia, aprile 2003.
Sono a casa.
Sono a casa ed una perversa ed una indicibile sensazione di essere stato più fortunato di qualcun altro, mi attraversa il corpo percorrendomi vertiginosamente, dalla pelle fin dentro i gangli ed i centri nervosi, come un carrello impazzito alle montagne russe.
La tv mi vomita addosso le solite scene di violenza gratuita e scontatissima.
Ad un certo punto Rafah, Palestina, è sullo schermo.
Ne hanno fatto fuori un altro.
L’esercito israeliano ne ha fatto fuori un altro.
Si chiama Tom, 24 anni, pacifista inglese, arrivato in Palestina da meno di una settimana.
Gli hanno sparato mentre tentava di salvare dei bambini che erano sotto il fuoco dei cecchini.
Un colpo.
Un colpo solo, al collo.
Un dito che ha voluto mettere fine ad una vita, ed uno squarcio al giovane collo del pacifista.
È al collo che sparano i cecchini.
Al collo, oppure alla testa.
Tom, 24 anni, inglese, se n’è andato.
Non so se piangere o ridere, istericamente.
Mi sembra di aver perso un amico, un fratello, tra le strade puzzolenti e polverose di Rafah: meno di un mese fa ero lì per un reportage.
Jenin, Palestina, marzo 2003.
“We have no future, my friend”.
A parlare è Mouhammed, 18 anni, per i suoi amici palestinesi un partigiano e probabile futuro martire di una guerra infinita, terrorista per il resto del mondo occidentale.
Mouhammed fa parte della delegazione di Hammas venuta a prelevarmi.
Pensavano che io fossi una spia israeliana.
Una passeggiata per le strade di Jenin, il mio aspetto occidentale, la mia macchina fotografica sempre in azione, sono state un’autodenuncia.
I cosiddetti terroristi di Hammas, vengono da me, mi chiedono il passaporto, cercano di capire se io possa essere davvero una spia, un delatore, o un semplice curioso.
Ci mettono un po’ a capire che sono un giornalista.
Poi la tensione sparisce ed allora, i temibili terroristi di Hammas, iniziano a parlare.
“Noi non abbiamo futuro, amico mio”, continua Mouhammed, nel suo stentato inglese imparato un po’ navigando in internet, un po’ dai volontari, dai medici o dagli operatori internazionali che qui ci capitano forse per curiosità, forse per solidarietà, quasi sempre per assolvere ad una personalissima missione svolta nel nome della verità o ideali simili.
“Tu torni a casa. Tu ritrovi i tuoi amici, ritrovi la tua ragazza, i tuoi genitori, amico mio. Tu vai via di qui, continui la tua vita, continui il tuo lavoro. Tu vai in vacanza, giri, viaggi, sogni, ti realizzi. – Mi dice sorridendo - Noi restiamo qui, nell’inferno…”
Nessuna speranza, nessuna prospettiva di lavoro, nessuna possibilità di venirne fuori.
“E allora, amico mio, un bel giorno lo sai che faccio?”
La risposta non tarda ad arrivare.
Mouhammed, 18 anni, Jenin, Palestina, mi guarda e senza aggiungere altro, sorridendo come un ragazzo orgoglioso della prima azione veramente importante della sua vita, mima un gesto eloquente con le mani, accompagnandolo con un verso liberatore: “Buum!”.
Di ragazzi come Mouhammed ne ho conosciuti a decine.
Hanno tutte le età, i Mouhammed che ho incontrato, hanno tutti lo stesso sorriso, hanno tutti la stessa rabbia e tra le mani, tutti quanti un’invisibile carica di esplosivo, pronti ad immolarsi nel nome della libertà: quella stessa libertà che a qualche centinaio di chilometri ha il boato di un Tomahawk che esplode, ma che qui ha il colore di un orto coltivato dietro casa o il sapore di un sandwich con falafel al venerdì sera con gli amici senza rischiare di essere ammazzato.
Rafah, striscia di Gaza, confine con l’Egitto.
Una puntata di “Chi vuol esser milionario”, versione araba, condotta da un presentatore egiziano o giordano, regala opulenza a piene mani in un televisore mezzo squagliato dal calore di un’esplosione.
Una stanza dalle pareti rosa accoglie le chiacchiere di tarda serata del solito gruppo di amici.
A ricevermi è Ibrahim, attuale padrone di casa.
Davanti a me solita tazza fumante di caffè arabo.
Sorseggio il caffè, denso e corposo, e aspetto che si posi.
“Vedi amico mio, la mia storia non è molto diversa da quella di tanta gente che vive qui…”
Ed allora inizia a parlare.
Ex ingegnere, laureato in Arabia Saudita, progettava oleodotti.
All’inizio della seconda Intifada ha perso il lavoro.
Adesso passa il giorno ad aspettare, cosa non si sa. Nell’ultimo mese ha messo da parte qualcosa lavorando per tre giorni come fabbro. L’esercito israeliano gli ha distrutto la casa, allora Ibrahim ha preso sua moglie, i suoi genitori ed i suoi otto figli e si è trasferito nella casa in cui vive adesso.
Fuori la notte emette paurosi versi di tank israeliani che vanno avanti e dietro, elicotteri Apache disegnano fuochi artificiali dal sapore di morte con i propri lanciarazzi, M16 continuano a sparare in lontananza.
Ibrahim continua la sua storia.
Potrebbe essere mio padre.
“Nella mia vita non ho mai fatto male a nessuno, non ho mai dato uno schiaffo od un pugno, non ho mai fatto un torto ad alcuno, palestinese o israeliano. These hands are white – Mi dice nel suo inglese perfetto. - Le mie mani sono pulite.”
Dignità a quintali e la forza di un’onestà inattaccabile danno forza alle sue parole.
“Dimmi, amico mio, dimmi: perché?”
“Mi hanno distrutto la casa, i miei figli giocano sotto il tiro dei cecchini, viviamo nella violenza perenne di un’occupazione illegale, ho lavorato per tutta la vita per costruire una casa per me e per la mia famiglia. Adesso sono costretto ad abitare in una casa in cui nessuno ha il coraggio di vivere perché troppo vicina al campo d’azione dei soldati. Perché?”
“Why?”.
Potrebbe essere mio padre, ma mio padre è a casa, tranquillo o quasi: la sua famiglia non rischia la morte a causa di un’operazione di pulizia dal terrorismo.
Vado via dalla casa di Ibrahim, con il suo “Why?” che mi accompagna rimbombando nella mente e urtando la mia incredulità di occidentale da sempre bombardato da false notizie di mass media fin troppo attenti a non dire tutta la verità circa la questione palestinese.
Ricovero notturno: la casa di Abu Jamil.
I soldati continuano a sparare per tutta la notte.
Il loro scopo è spaventarci.
Dormo vestito, con la mia attrezzatura fotografica pronta ad una probabile fuga in caso di bombardamento o di un intervento dei soldati.
I bambini di Abu Jamil sono tranquilli, mentre i muri continuano a tremare e colpi di M60 a crivellare le stanze esterne dell’appartamento.
La casa di Abu Jamil sorge sul percorso del muro che gli israeliani stanno costruendo per dividere la striscia di Gaza dall’Egitto.
Come la casa di Ibrahim, e come tutte le case che sorgono a 100 metri dal muro, anche questa sarà distrutta, prima o poi. Scherziamo per non pensare al peggio e sperando che la presenza di un giornalista italiano li faccia desistere dal loro folle scopo.
Almeno per stanotte.
L’alloggio me l’hanno procurato i miei amici dell’ISM, l’International Solidarity Movement.
Tra di loro Rachel Corrie, 23 anni, americana.
Un bulldozer israeliano l’ha uccisa il giorno dopo che ho lasciato Rafah.
Da quando sono tornato in Italia ho una naturale repulsione per i telegiornali, leggiucchio i giornali e dubito di tutti gli improvvisati esperti di politica internazionale che si esibiscono nel grande e colorato Barnum che ogni giorno sfoggia il suo variopinto campionario di equilibristi, funamboli, culi e tette attraverso i tubi catodici casalinghi.
Guardo di sfuggita scene di soldati americani festosi che, gomma da masticare in dotazione perenne, sfoggiano i loro potenti arsenali dal valore di milioni di dollari, mentre continuo a pensare a tutte le bugie con cui siamo bombardati ogni giorno.
Il popolo della Palestina non ha vie d’uscita, la Palestina non ha più voce in capitolo, la gente della Palestina, evidentemente, agli occhi della comunità internazionale ha meno diritto alla libertà di altri popoli o forse, più semplicemente, non ha petrolio a sufficienza.
Di storie come quelle di Ibrahim, di Mouhammed o di Rachel e Tom, si potrebbero riempire dossier televisivi ed interi rotocalchi di cronaca, ma nessuno lo fa.
Per questo ho deciso di partire per la Palestina.
Avevo sentito parlare di storie raccapriccianti, di storie al limite della dignità umana, storie di ordinaria follia e quotidiana umiliazione di esseri umani, ed allora ho deciso di andare a vedere da vicino quello che accadeva.
Spesso le parole non sono sufficienti a descrivere quello che gli occhi vedono.
Troppo spesso le parole ti soffocano la bocca, le lacrime ti bruciano gli occhi, ed allora ti affidi al cuore.
Cerchi di capire, cerchi di conoscere, ti barcameni tra la freddezza della professione, ed il tuo sentire di uomo che non accetta.
Quello che ho visto è solo follia.
A volte ti sorprendi a dire a te stesso che quello che stai vedendo non può essere vero.
Ti giri e cerchi le impalcature di un grande set cinematografico, ma purtroppo non ci sono né operatori né registi, ma soltanto soldati, cecchini, mitra e colpi di cannone e bambini e gente innocente, gente con l’unica colpa di essere nata nella cosiddetta “Terra promessa” del popolo di Dio, del popolo Israeliano.
La striscia di Gaza non è solo un concetto geografico.
La Striscia di Gaza è una grande imbuto, è un immenso campo di prigionia, è un ciclopico tritacarne pronto a macinare innocenti e colpevoli, donne o bambini, soldati e pacifisti, indistintamente.
Ci sono famiglie, nella striscia di Gaza, che vivono in campi profughi da tre generazioni.
Quando si guarda la Tv e si sente parlare di campi profughi probabilmente non si pensa a quello che è il loro reale significato.
Si parla di campi profughi e si pensa a grandi accampamenti temporanei che gli eroi di turno, in una tumultuosa carica di infinita generosità presto trasformeranno in posti fatati.
Non è così.
I campi profughi sono delle fogne a cielo aperto.
I campi profughi non hanno strade, ma sentieri sabbiosi percorsi da piedi nudi di bambini, dalle zampe di topi grossi come gatti, pieni di perenni pozzanghere fangose dall’odore mefitico.
I campi profughi sono ammassi di lamiere e di immondizia lasciata agli angoli delle strade.
I campi profughi sono anticamere della dimenticanza, e tutto quello che ci sta dentro è solo ricordo in attesa di oblio.
Questi sono i campi profughi.
Ed in tutto questo una moltitudine di bambini che si rincorre giocando con avanzi di rifiuti, palloni di pezza ed aquiloni fatti con canne di bambù e sacchetti per la spesa.
I campi profughi della Palestina, poi, hanno un particolare privilegio: essere sotto il tiro dell’esercito 24 ore su 24.
Ci sono cecchini che da altissime torri controllano da soli intere strade.
Ho sentito la morte arrampicarsi su per il mio corpo, camminando per le strade di Rafah.
È una strana sensazione.
Sai di essere sotto il tiro di qualcuno.
Lo sai sempre, non solo a volte.
Senti uno strano brivido che ti sale dai piedi.
Sai che la tua carne è solo burro, e che in ogni momento il tuo collo, le tue tempie potrebbero esplodere.
Ma che fai? Non puoi correre, non puoi vivere cercando ripari definitivi.
Sai che da qualche parte un cecchino sta guardando attraverso un mirino il particolare del monile che porti appeso al collo.
Impari a conviverci, con questo perenne e continuo senso della morte.
Ed allora pensi “Insciallah”, sia fatta la volontà di Dio.
I campi profughi della Palestina sono poligoni di tiro, e non solo per i cecchini.
Immaginate un pilota di F16.
In Tv ce li fanno vedere come gloriosi ed impettiti ed inguaribili rubacuori.
Rayban sugli occhi e morte tra le dita.
Adesso immaginate i centri storici del nostro Sud.
Centrano qualcosa.
Centrano perché le strade dei campi profughi della Palestina sono larghe, nel 75 per cento dei casi, come le stradine dei nostri centri storici.
Ora immaginate questi cowboy del cielo.
Ho pensato a tutte le volte in cui in tv dicono che con “un’operazione chirurgica” è stata bombardata la sola casa del sedicente terrorista Mouahammed.
Impossibile.
Ognuna di quelle “operazioni chirurgiche” si porta via una famiglia intera, un vicinato, un quartiere, e non il solo singolo terrorista.
Immaginate le schermate verdi luminescenti della CNN che ci mostrano traccianti luminose contraeree: qui non c’è contraerea, non c’è nessuno a dar filo da torcere a quei temerari cowboy del cielo.
Ed allora l’imbarazzo della scelta pulsa sulle cloche di quei giocattoli da 100 milioni di dollari tanto, per loro, i campi profughi sono solo covi di terroristi.
Terroristi, terroristi di 10 anni che lanciano pericolosissimi ordigni anticonvenzionali, a frammentazione, ad esplosione ritardata, di fabbricazione artigianale, anzi, direi naturale: i sassi.
Spesso ho pensato che se solo avesse potuto, se solo non fossimo nell’era dell’informazione globale, Sharon trasformerebbe la Striscia di Gaza e la Cisgiordania in un grande campo di concentramento.
Non è un’iperbole.
L’occupazione della Striscia è illegale.
In Palestina, a volte ti sembra di trovarti in uno di quei film in cui la Gestapo semina terrore e morte senza ragione.
Non è un’iperbole.
La Palestina è l’unica parte del mondo dove si opera rappresaglia su civili.
Esplode una bomba a Tel Aviv?
Subito i tank si muovo e cannoneggiano i campi profughi.
Un kamikaze si fa esplodere a Netanya?
Arrivano gli F16 e gli Apache a bombardare i villaggi da cui si pensa possano essere partiti i terroristi.
Non è un’iperbole, è la realtà.
Questo è quello che accade, ogni sacrosanto giorno, in Palestina.
Questo è quello che ho visto.
Non voglio sapere chi ha ragione, non mi interessa discutere su chi possa avere diritto su questa terra, non è mia intenzione tirare in ballo le cause storiche o le motivazioni politiche.
Quello che ho visto mi basta.
Quello che ho visto mi è sufficiente per prendere posizione: io sto da parte degli esseri umani.
Ogni giorno noi occidentali siamo bombardati da una valanga di bugie, di parole, di false notizie o di storie manipolate.
Ogni giorno lo stato di Israele pratica una guerra di rappresaglia contro popolazioni civili.
Ogni giorno un cecchino israeliano decide di sparare su qualcuno, che sia un bambino che va a scuola o un pacifista inglese, non importa.
I palestinesi vivono nella terra che Dio ha promesso al popolo di Israele, e per questo vanno puniti.
Altro che diritto internazionale, altro che convenzione di Ginevra, altro che rispetto dell’umanità.
Certi concetti, in Palestina, sono solo maledizioni contro il mondo intero.
Essere palestinesi vuol dire soffrire in eterno.
Restare fermi ad un check point per cinque ore con i pantaloni abbassati, essere arrestati e torturati senza ragione, vedersi portare via un figlio di 14 anni e non rivederlo per sei mesi, vedersi bombardare casa senza ragione, vedere che hanno sparato a tuo figlio di 16 anni e vederlo morire dissanguato per quattro ore senza poterti avvicinare a lui, essere arrestato da un gruppo di soldati ubriachi e sorteggiare, coi bigliettini, se ti spezzeranno una gamba od un braccio, perdere il novanta percento della tua famiglia a causa della “operazione chirurgica” di un cowboy gonfiato di anfetamine ai comandi di un F16, vedere la tua vecchia madre in attesa ad un posto di blocco aspettare sotto la pioggia per due ore, non poter viaggiare, percorrere 15 chilometri in 6 ore e poi essere chiamato assassino terrorista dal mondo intero: questo vuol dire essere palestinese.
Non è un’iperbole.
Altro che Enduring Freedom, altro che Saddam o Bush o Blair o Bin Laden, altro che combattenti per la libertà, convenzioni internazionali, aiuti umanitari, bombardamenti preventivi, lotte contro la dittatura, Fondo Monetario Internazionale, globalizzazione, Nato e Nazioni Unite.
Tutte belle favole.
La realtà è un’altra.
| |
|
maggio - agosto 2004