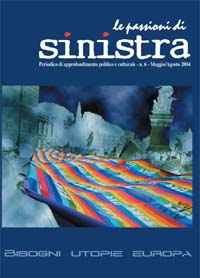Memoriale di un poeta civile |
Il 23 agosto 1994 Paolo Volponi si spegneva, all’età di settant’anni, ad Ancona, per infarto, dopo quasi cinque anni di seri disturbi cardiaci che lo avevano portato a un intervento chirurgico, nell’aprile del 1992, in seguito al quale alcune complicanze renali imposero allo scrittore di sottoporsi alla dialisi: un anno prima di morire aveva deciso di abbandonare per motivi di salute lo scranno senatoriale che occupava da dieci anni, esattamente dal luglio del 1983, quando fu eletto per il collegio di Urbino, come indipendente nelle liste del Partito comunista italiano. Figura di indubbio prestigio letterario nazionale, sin da quando aveva pubblicato le sue liriche giovanili (Il ramarro, 1948), poi parzialmente recuperate nel volume successivo (L’antica moneta, 1955(1)), passò poi a coltivare in parallelo la ‘primitiva’ scrittura in versi con quella narrativa in prosa, con un fecondo scambio fantastico e ideologico fra i due generi, complicato, altresì, dalla sovrapposizione cronologica delle stesure di più libri, com’è documentato dalla storia editoriale dei testi e dall’esame dei materiali preparatori, sparsi fra lo ‘Harry Ransom Humanities Research Center’ dell’Università di Austin, in Texas, il ‘Centro di ricerca sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei’ dell’Università di Pavia, l’‘Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti’ del Gabinetto Viesseux di Firenze, l’Archivio Einaudi e le due residenze private di Volponi, a Urbino e Milano. Di tutto questo materiale ha saputo giovarsi Emanuele Zinato, curatore delle Poesie 1946-1994 e degli ottimi tre volumi di Romanzi e prose, dotati, oltre che di introduzioni, cronologie e bibliografie esaustive, anche di apparati filologici ed esegetici(2).
Non solo, dunque, è possibile, e anzi indispensabile per comprendere appieno la poetica volponiana, trovare importanti riscontri d’immagini e di pensiero fra volumi di prosa e volumi di poesia coevi, come nei casi ‘maggiori’ di Memoriale e Le porte dell’Appennino, Corporale e Con testo a fronte, Le mosche del capitale e Nel silenzio campale, ma non è del tutto possibile districare dal groviglio della lunga gestazione creativa e collocare in un lineare percorso temporale alcuni romanzi, cominciando proprio da quel ‘primo’ che, progettato nella seconda metà degli anni Cinquanta, anche grazie all’esortazione di Pasolini, all’epoca della comune esperienza ‘officinesca’(3), col titolo di Repubblica borghese e iniziato nell’autunno del 1961, subito dopo la consegna all’editore di Memoriale, fu interrotto nel novembre del 1964 per la stesura d’impulso e quasi frenetica della Macchina mondiale e poi pubblicato, in verità con rari interventi, solo nel 1991, col titolo La strada per Roma(4), provocando un non piccolo spiazzamento nei lettori che vi ravvisano senza dubbio un’inversione di prospettiva storico-sociale e biografico-psicologica, nonché un ‘arretramento’ nell’uso della lingua e della forma romanzo, in questo caso debitore addirittura di una certa atmosfera neorealistica e pre-sperimentale. La rilettura, poi, di un certo numero di racconti, prose d’opinione e abbozzi di romanzi, nel tempo apparsi in rivista e ora parzialmente riproposti(5), rende di certo più fascinoso e periglioso l’accostamento a questo classico novecentesco. Il suo itinerario letterario procede di pari passo con la formazione di un pensiero politico, esemplare per nitore e autonomia, e soprattutto per il suo radicamento in un’esperienza diretta e ‘compromessa’ con la realtà sociale e civile di un’Italia che compiva il suo percorso dalla Liberazione, gloriosa e dolorosa, alla Repubblica della ricostruzione e della modernizzazione industriale, e dall’irrigidimento conservatore fino alle fibrillazioni degli anni di piombo e alla crisi delle Istituzioni. Lungo più stagioni caratterizzate da adesioni ambigue, immature, opportunistiche, sentimentali, semplificatrici alle fila del Partito che rappresentava la punta più avanzata in Occidente del movimento operaio e, insieme, una grande esperienza di convergenza e di dialogo fra le masse e gli intellettuali (ma s’intende che non tutte le adesioni che ho chiamato immature e sentimentali siano state opportunistiche e in malafede), la parabola di Volponi ha tracciato un arco non riconducibile allo schema dell’‘attrazione fatale’, bensì va a collocarsi quale maturazione graduale e faticosa di un convincimento sincero, passato al vaglio di una prassi professionale che si faceva sociale e infine politica, e, senza mai rinnegare gli stadi attraverso cui era passata la sua analisi, investiva nella conclusiva esperienza parlamentare un ‘capitale’ morale e memoriale (!) di prima grandezza.
Il principio di realtà intorno al quale ruota il pensiero di Volponi inizia a fondarsi, in effetti, in anni ben lontani da quelli della sua ‘conversione’ marxista, diciamo pure dal 1946, anno in cui comincia a scrivere le liriche del Ramarro, secondo modalità arcadico-pastorali di probabile mediazione dannunziana e pavesiana, rivelatrici di un bisogno di essenzialità naturale e biologica, ma anche di un autobiografismo ancora preponderante nell’esibizione del conflitto psicologico con la donna. Ma già nel 1950 l’assunzione da parte di Adriano Olivetti presso l’Unrra-Casas, il Comitato Amministrativo di Soccorso ai Senzatetto, messo in piedi con i finanziamenti americani per la ricostruzione, con il compito di condurre rilevamenti sociologici lungo la dorsale appenninica, dall’Abruzzo alla Calabria fino in Sicilia, e poi il passaggio, dal 1° ottobre 1956 alla direzione dei servizi sociali della grande azienda di Ivrea, determinano una decisiva evoluzione della scrittura di Volponi verso una vera e propria socializzazione del discorso, attraverso quel fondamentale processo di allegorizzazione, che consente di depurare il testo dagli elementi più angustamente riconducibili alla dimensione individuale e di esaltare quelli che, invece, contengono un’opportunità di riflessione sulle condizioni collettive. Quest’evoluzione è precisamente il motore di quel tormento selettivo che porterà il poeta a lasciar cadere un elevato numero di liriche giovanili, fino a comprenderne, nella definitiva edizione del 1980, Poesie e poemetti 1946-66, solo diciassette (su quarantadue) del Ramarro e trentatré (su quarantatré) dell’Antica moneta(6). Integrale, invece, sarà la riproposizione delle Porte dell’Appennino (1960(7)) la cui novità stava proprio nell’aver ipostatizzato nel soggetto lirico l’aspirazione di un’intera classe sociale – quella contadina e piccolo-borghese dell’Italia centro-meridionale – alla rottura dei legami più soffocanti con il paese e l’istituzione familiare, per abbracciare senza riserve l’utopia della modernizzazione metropolitana e capitalistica.
La tensione già embrionalmente storica e discorsiva si dimostra anche nel gusto per il poemetto dai molti spunti narrativi (si vedano in proposito La vita, Il giorno nove di Febbraio, Il cuore dei due fiumi e, soprattutto, i celebri poemi L’Appennino contadino e La paura) e inscrive queste liriche nella sfera delle proiezioni utopiche tracciate con slancio e originalità, in quegli anni, dall’imprenditore-filosofo Adriano Olivetti, teorizzatore, attraverso scritti quali L’ordine politico delle comunità, Società, Stato, Comunità. Per una economia e politica comunitaria e l’attività di riviste quali “Movimento di Comunità”, di un modello di fabbrica come cellula di una società nuova, struttura solidale e veicolo di emancipazione economica e morale del lavoratore, secondo un’inedita fusione di cristianesimo, socialismo e liberalismo, cui non erano certo estranee certe influenze dell’azionismo resistenziale e repubblicano(8). Il progetto della ‘comunità’ aziendale e sociale prevedeva la collaborazione di figure direttive reclutate fra i giovani intellettuali quali Franco Fortini (1917-1994), Geno Pampaloni (1918-2001), Ottiero Ottieri (1924-2002) e Giovanni Giudici (1924): la proposta non poteva non catturare anche Volponi, che vi attribuisce i connotati di un Rinascimento interrotto, la realizzazione di un’autentica città ideale ‘per tutti’, della quale lo splendido paradigma architettonico urbinate rappresentava solo il segno di un’anticipazione elitaria e fallimentare(9). Segno di quel fallimento, per Volponi, era anche la piccola industria marchigiana che importava nelle relazioni aziendali il modello familistico patriarcale e autoritario, come aveva potuto vedere direttamente nell’impresa paterna, una fornace di mattoni, espressione proprio di quell’incompiuta trasformazione della civiltà rurale e artigianale in una società tecnologica e progressista. Il tema, traguardato attraverso la lente antropologica e psico-sociale derivata dal magistero di Pasolini, che coglie nell’interruzione e nella disorganicità di queste evoluzioni la causa prima delle violenze culturali e dello sterminio delle identità, verrà più tardi meditato e articolato nel Lanciatore di giavellotto.
Ma la concreta esperienza dirigenziale e la scomparsa nel 1960 di Olivetti, all’età di cinquantanove anni, incrinano in Volponi la fiducia nell’utopia del capitalismo solidale e ‘comunitario’, avviando un percorso di ripensamento e di rigoroso riesame delle proprie ragioni professionali e intellettuali. Il primo segno di questa crisi è già in Memoriale, romanzo composto a partire dagli ultimi giorni del 1958, autobiografia stravolta di un ex contadino piemontese reduce di guerra che aspira a risolvere i propri “mali” attraverso l’inserimento nella “fabbrica grande più della stessa città”(10). Ma la sua aspirazione all’affermazione verrà tradita proprio dai meccanismi ingabbianti e brutali dell’industria, che porteranno Albino Saluggia a una visione paradossale e psicotica della realtà che lo circonda.
Il lettore, afferrato sin dalle prime pagine nella vorticosa rielaborazione memoriale del contadino espropriato divenuto operaio alienato, può però cogliere significative analisi della realtà, documenti del decorso nevrotico quasi inconsapevolmente trascritti dal protagonista. Il momento culminante è dato da quel sintomo di coazione a ripetere che è rappresentato dalle lunghe poesie senza senso che Albino compone nell’ultima parte del romanzo, originate soltanto dalla lunga catena delle rime e delle allitterazioni che gli scaturiscono spontaneamente, quasi a riprodurre i movimenti ripetitivi e definalizzati della macchina. Da ora in poi la rima, solo occasionalmente presente nei primi tre libri di liriche (dove semmai era sostituita da una certa predilezione per le assonanze e le consonanze), acquisirà un ruolo precisamente ‘retorico’, più che ritmico, sarà, cioè, nella sua ripetizione ossessiva e cacofonica, il segno ambivalente di una sofferenza comunicativa, scaturita da un senso di sconfitta, e di una scrittura che non vuole e non può ignorare la necessità etica di aderire alla natura e ai modi della produzione capitalistica, per denunciarne le aberrazioni e, infine, contestarne il sistema.
Ne sono testimonianza, sul piano della lirica, Foglia mortale (1974(11)), plaquette composta entro il 1966, e quel suo compimento maturo e contiguo alle avanguardie che è Con testo a fronte, titolo polisemico, del quale non deve certo sfuggire la possibilità di lettura come ‘contesto a fronte’, rivelatore di una scrittura che intende porsi dinanzi alla realtà storica, per divenirne, più che specchio, traduzione interpretante e glossa analitica. Dal primo dei due libri furono esclusi nell’edizione 1974 due poemetti, La durata della nuvola e Canzonetta con rime e rimorsi, contenenti chiare dichiarazioni di autocritica che il dirigente aziendale sente di dover comunicare e, insieme, riflessioni sul ripudio dell’“indulgenza” e sul legittimo uso della “violenza”. Ne La durata della nuvola il poeta ripercorrendo le fasi della sua carriera professionale – “L’Abruzzo, Roma, Ivrea” – si chiede se “furono soltanto l’idea / di un’affermazione personale” oppure le fasi successive di una “reale” azione nel mondo: la risposta è data più avanti dalla confessione di essere anche lui prigioniero, talvolta colpevolmente appagato, di “quel laccio-giardino eporediese” che fagocita e inibisce, tradendo le sue origini ‘umanistiche’, le ragioni letterarie, classificandole “tra l’inutilità / d’ogni ricerca che non sia harvardiana, / data nel progetto del capitale”. Nella Canzonetta, poi, esortando il suo interlocutore a riconoscere la propria inibizione individuale “dentro la più grande figura / della paura sociale”, tuona contro “l’indulgenza”, come relazione addomesticata e narcosi dell’antagonismo di classe, e indica la via di una “violenza” usata “con la sapienza / di capovolgere la norma della divinità / e di ogni conseguente, umana utilità”. È l’invito a reagire all’inglobamento di tutto (“L’orto e la poesia, la fabbrica e la campagna / la città e i viaggi, la casa e gli incontri, / l’ansia e la cura, la lingua e la parola, / il cazzo e la fica, i pensieri e la morte […]”) nel “capitale”: “e ciascuno nasce, lavora, canta e muore / lungo la catena della pena / per crescere e saldarsi nel / capitale del capitale. / Nella divisione del lavoro internazionale / ha il suo tratto assegnato anche la tua pena”. Quanto pericolose, ardite e sconvenienti risultassero queste affermazioni, se non acquisite nella loro corretta interpretazione metaforica, negli anni più aspri della lotta armata, è facilmente arguibile, mentre si spiega che Volponi abbia ritenuto di poter rendere pubblici i due testi nel su menzionato volume ricompositivo del 1980, quando ormai molte cose erano cambiate: a cominciare dalla soluzione dei “rimorsi” etici data dalla rottura con la professione industriale, dapprima per la non condivisione dei piani aziendali di Ivrea (1971, in piena gestione Visentini), e poi per la compiuta trasformazione del suo comunitarismo olivettiano in comunismo libertario, esplicitato dalla dichiarazione di voto in favore del Pci per le amministrative del 1975, cosa che gli costò le dimissioni dalla Fiat, dove nel frattempo aveva svolto attività di consulenza sociologica.
L’accantonamento dello slancio utopico, del quale era ancora debitore un romanzo come La macchina mondiale, si registra nel più sperimentale dei romanzi di Volponi, quel Corporale (1974(12)) che scardina la struttura del romanzo tradizionale, addirittura alternando la prima e la terza persona nelle diverse sezioni dell’opera e agglutinando materiali narrativi e generi letterari diversi, tanto da suscitare la vistosa perplessità di Pasolini, solitamente ostile agli estremismi avanguardistici: il dato centrale che emerge dal libro è la ‘resistenza’ della corporeità come unico baluardo dopo il tradimento delle speranze e l’esplosione dei sistemi filosofici e scientifici, ma vi si avverte già, con una certa precocità, la crisi della partecipazione politica classica, nella connotazione del protagonista, Gerolamo Aspri, come intellettuale in crisi, fuoruscito dal Partito comunista.
Egli è, infatti, un’ulteriore incarnazione della follia da disorganicità ed emarginazione, è l’espressione esasperata di una inadattabilità alla società borghese che sfocia nell’ennesima variazione sul tema della fuga, figura costante e cruciale di tutta l’opera di Volponi, questa volta, però, con una geniale soluzione allegorico-narrativa ‘rovesciata’: l’autoesclusione dal mondo di Gerolamo si consuma nello spazio chiuso e ossessivo di un rifugio-tana, sintomaticamente collocato nella campagna urbinate, nel quale trovare scampo da un’imminente esplosione atomica. Corporale è l’anti-romanzo di un anti-eroe, fallimentare perché disperato, isolato perché tragicamente scisso, ma è anche l’epopea dell’irriducibilità della vita umana al processo di reificazione messo in campo dalla società dei consumi.
Su questa base Volponi traccerà tutto il suo itinerario politico, narrativo e lirico degli anni a venire, dall’apostolato marxista alla dura requisitoria contro il sistema industriale delle Mosche del capitale, dall’accostamento al Pci (e poi al Partito della Rifondazione Comunista) ai toni più compostamente melanconici delle liriche di Nel silenzio campale, libro dalla vocazione politica esplicitata fino al punto da ridurre al minimo la stessa sperimentazione formale. Se le prove narrative intermedie (Il sipario ducale, 1975; Il pianeta irritabile, 1978; Il lanciatore di giavellotto, 1981), pur nella diversità dei sottogeneri (che per semplicità potrei definire, rispettivamente, ‘storico’, ‘fantastico’ e ‘psicologico’), ruotano intorno al nucleo tematico della pericolosità del rifiuto della storia, quando urga la scelta della partecipazione politica, della solidarietà sociale e del coraggio di affrontare la realtà, Le mosche del capitale (1989), romanzo dedicato ad “Adriano Olivetti, maestro dell’industria mondiale”, rappresenta il culmine della sua critica al sistema neo-capitalistico, attraverso la vicenda ‘trasparente’ di un dirigente industriale illuminato, Bruto Saraccini, dalle idee politicamente libertarie e produttivamente rivoluzionarie(13). Egli resterà stritolato dal cinismo dei padroni e dall’impraticabilità di una democratizzazione interna e dall’alto della fabbrica. Memorabili le pagine di apertura del romanzo, con quella liricissima e umoristica rappresentazione della città industriale sprofondata in un sonno avvolgente e tranquillizzante, in una “notte di febbraio senza luna, tre ore prima dell’alba”: la costruzione, perlopiù paratattica, segnata dall’anafora ossessiva del verbo ‘dormire’, realizza la metafora di una ‘disattenzione’, di un’‘indifferenza’ che coinvolge tutti, uomini e cose, natura e macchine, “sotto l’effetto del Valium, del Tavor e del Roipnol […] come ulteriore dato e calcolo delle compatibilità favorevoli al capitale”. Infatti, “mentre tutti dormono il valore aumenta, si accumula secondo per secondo all’aperto o dentro gli edifici”.
Se il sonno, dunque, è il segno della soggezione ipnotica alla civiltà della tecnica e del plusvalore, con i suoi corollari ideologici dell’efficientismo e del riformismo, l’insonnia, cui sono dedicati alcuni testi di Con testo a fronte (che raccoglie versi composti fra il 1967 e il 1985), trascende il dato meramente autobiografico, per divenire figura di un atteggiamento, al contrario, vigile e analitico-riflessivo, che consente al poeta, per esempio, di riflettere sull’alienazione dell’operaio anche in termini di presa di coscienza e di scoperta di un’opportunità creativa(14). Si pensi a questi versi di Insonnia inverno 1971 (introdotta da un eloquente esergo di Puskin: “Non risponderete per me, / Potete dormire sonni tranquilli”), che contengono uno sviluppo engagé dell’ossessione di cui era affetto Albino Saluggia: “L’operaio dentro e fuori la fabbrica / anche se non gli è cara / è costretto spesso a ricorrere alla mente, / ridotto dalla ripetizione a pensare / con il solito incantamento sopra una rima / rima lima ritornello martello nastro astro / libertà con ciò che si fa / ciò che si fa con libertà / con ciò che non si fa / un’altra libertà”. Peraltro, gli studi di sociologia del lavoro e di economia aziendale divengono fonte di versi aspri e polemici come quelli de La deviazione operaia, in cui la riduzione dell’operaio a una funzione algebrica si spiega alla luce della necessità di calcolare quanto la ‘diversità’ di comportamento rispetto agli standard di produzione programmata incida sul profitto.
Il poeta prende di mira la “determinazione” neo-capitalistica del tempo e degli stili di vita, in numerose altre liriche di Con testo a fronte, ma è con Nel silenzio campale (1990) – raccolta tutta maturata all’interno del travaglio politico che attraversa il Partito dopo la morte di Enrico Berlinguer (avvenuta l’11 giugno 1984) e la risacca liberal che interessa il gruppo dirigente – che Paolo Volponi rende espliciti i riferimenti al dibattito ideologico in corso(15). Il volume, anzi, precipita nella figura tragica di Mao, opportunamente accostata da Luperini all’ascendenza pascoliana di Alexandros, colta nella sua fissità irrisolta ed enigmatica(16). Il poeta non si sottrae al giudizio storico di una condanna, qui elaborata attraverso la figura dell’ironia e del rovesciamento comico: “Quando Mao capì che il suo governo / angelico e perfetto non giovava / che a qualche giovanetto di buona ispirazione / […] / si tuffò nel grande fiume”, che è il “[…] fiume del mondo e della brutta gente, / degli egoisti e dei pavidi, dell’occidente, / dei soggetti al feudale dominio del capitale, / delle repubbliche socialiste in difetto / teorico e culturale, del comunismo / della burocrazia […]”.
In questi versi si compie un ragionamento iniziato tempestivamente con gli articoli sulle pagine di “Alfabeta”, a partire dal 1979, intorno all’inevitabile, lenta omologazione al capitalismo dei regimi totalitari, con particolare riferimento proprio alla Cina post-maoista, quando al comunismo sia venuto a mancare lo slancio utopico-progettuale e libertario-popolare, per intraprendere la via senza ritorno della conservazione poliziesca del potere. L’esclamazione perplessa in cui Volponi coglie l’anziano presidente cinese (“Boh!”) – suggestionata dall’espressione sarcastica con cui Pasolini gli aveva sintetizzato la risposta evasiva che Mao avrebbe reso a un giornalista inglese che gli chiedeva “Dove sta andando l’umanità?” – è il segno dell’esaurimento, nel cosiddetto socialismo reale, della filosofia della praxis, della capacità, cioè, di leggere e interpretare nei movimenti della storia le istanze reali delle masse; eppure acquista, nella sua trascrizione del giugno 1989, quando appunto Volponi scrive Le cose di Mao, il valore di un azzeramento storico dal quale può ripartire la “partecipazione” e la “speranza”(17). Da parte sua, peraltro, lo scrittore, proprio in virtù di quell’“insonnia” che è solerte vigilanza, instancabile analisi materialistica, inquieta preoccupazione, insinuava nel profetico intervento Deve stare molto attenta la sinistra, apparso su “Alfabeta” (n. 6) nel lontanissimo 1979, una considerazione di stringente attualità: “Il regime golpista non ha necessariamente il viso di un gendarme chiodato, ma può anche avere, e non diminuito nella portata storico-sociale, quello dei diagrammi di un piano di razionalizzazione capitalistica”.
Nella piena e diretta partecipazione politica, che non rinuncia e anzi rilancia il cimento dell’arte, Volponi vede compiersi quel processo di collettivizzazione della parola poetica e delle idee, cui aveva mirato sin dai tempi di “Officina”, attraverso la distillazione di dolori, anche privatissimi, posti a servizio di un ragionamento e di un confronto aperto. La consapevolezza del risultato raggiunto è consegnata alle parole di quella sorta di testamento anticipato che è Per questi versi (da Nel silenzio campale): “Se qualcosa di me ancora vale / debbono tale cosa prenderla gli altri, / impiegarla e trarne profitto presente e reale”.
1) Il ramarro, pref. di Carlo Bo, Istituto d’Arte, Urbino 1948; L’antica moneta, Vallecchi, Firenze 1955.
2) Poesie 1946-1994, Einaudi, Torino 2001; Romanzi e prose, 3 voll., stesso luogo, 2002.
3) Pasolini rappresentò per Volponi, di appena due anni più giovane, un vero e proprio maestro, come testimoniò, tra l’altro in Pasolini maestro e amico, in AA.VV., Perché Pasolini, Guaraldi, Firenze 1978; ora in Romanzi e prose cit., vol. II, pp. 649-663. Il sodale bolognese viene evocato più volte nelle poesie di Volponi: cfr. La paura (in Le porte dell’Appennino), Canzonetta con rime e rimorsi (in Foglia mortale), Pasolini da cinque anni è morto (in Con testo a fronte, dov’è ricordata l’esortazione a intraprendere la strada della narrativa) e Il cavallo di Atene (in Nel silenzio campale). Altri articoli su Pasolini sono raccolti in P. Volponi, Scritti dal margine, a cura di Emanuele Zinato, Manni, Lecce 1994. L’esperienza di “Officina” viene ricordata, invece, in Officina prima dell’industria, pubblicato in “Belfagor”, XXX, 6, novembre 1975; ora in Romanzi e prose cit., vol. I, pp. 1064-1069.
4) La strada per Roma, Einaudi, Torino 1991 (premio Strega).
5) Non solo nei poderosi volumi einaudiani, ma anche in pubblicazioni più ‘appartate’, come La pestilenza (Via del Vento, Pistoia 2002), titolo non d’autore con cui sono stati riediti due racconti usciti sulle pagine di “Marka”, maggio-luglio 1984.
6) Poesie e poemetti 1946-66, nota di Gualtiero De Santi, Einaudi, Torino 1980. Sui problemi della storia editoriale e variantistica della lirica volponiana cfr. E. Marongiu, La storia dei testi poetici di Volponi, in Letteratura italiana e utopia, “FM 1995”, II, Annali del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, pp. 251-265. Della stessa autrice si veda ora anche l’Intervista a Paolo Volponi, pref. di Ernesto Ferrero, Archinto, Milano 2003.
7) Le porte dell’Appennino, Feltrinelli, Milano 1960 (premio Viareggio).
8) A. Olivetti, L’ordine politico delle comunità, Nuove Edizioni, Ivrea 1945; Id., Società, Stato, Comunità. Per una economia e politica comunitaria, Comunità, Milano 1952. Paolo Volponi tracciò un ricordo di Olivetti in Adriano, un eretico del capitalismo, pubblicato in “Corriere della Sera”, 18 dicembre 1976; ora in Romanzi e prose cit., vol. II, pp. 645-648.
9) È l’assunto dal quale parte il ritratto di G.C. Ferretti, Paolo Volponi politico, in “Belfagor”, LI, 306, 30 novembre 1996, pp. 675-690; poi, col titolo Un ideale anticentralistico, in M. Raffaeli (a cura di), Paolo Volponi. Il coraggio dell’utopia, Atti del convegno di Urbino, 24 maggio 1996, Transeuropa, Ancona 1997, pp. 39 sgg.
10) Memoriale, Garzanti, Milano 1962. Utile, ancorché caratterizzato da un eccessivo ricorso alle risultanze della ricerca linguistico-computazionale, il saggio di G. Gigliozzi, Memoriale di Paolo Volponi, in A. Asor Rosa (a cura di), Letteratura italiana. Le opere, vol. IV, 2: Il Novecento. La ricerca letteraria, Einaudi, Torino 1996, pp. 729-769.
11) Foglia mortale, Bucciarelli, Ancona 1974.
12) La macchina mondiale, Garzanti, Milano 1965 (premio Strega); Corporale, Einaudi, Torino 1974. Sulla valenza politica della scrittura volponiana, con particolare riferimento allo snodo rappresentato da Foglia mortale, nell’ambito lirico, e da Corporale, nell’ambito romanzesco, cfr. il tributo monografico Volponi ovvero la forza dell’utopia, proposto da “Critica marxista”, n.s., IV, 4-5, luglio-ottobre 1995, pp. 74-108.
13) Il sipario ducale, Garzanti, Milano 1975; Il pianeta irritabile, Einaudi, Torino 1978; Il lanciatore di giavellotto, Einaudi, Torino 1981; Le mosche del capitale, Einaudi, Torino 1989. Un’analisi accurata di quest’ultimo titolo è quella di M. Romani, Saraccini nei gironi del capitale. Lettura del romanzo post-industriale di Paolo Volponi, in “Avanguardia”, VIII, 24, dicembre 2003, pp. 127-178.
14) Con testo a fronte, nota di Guido Santato, Einaudi, Torino 1986.
15) Nel silenzio campale, introd. di Filippo Bettini, Manni, Lecce 1990.
16) Romano Luperini individua nella lirica Le cose di Mao l’ipotesto pascoliano, rispondendo all’intervista Attualità di Volponi, in “L’immaginazione”, VII, 83-84, novembre-dicembre 1990, p. 12.
17) Giusta l’autocommento dell’autore in P. Volponi, F. Leonetti, Il leone e la volpe. Dialogo nell’inverno 1994, Einaudi, Torino 1995, p. 131. Sulla partecipazione di Volponi ad “Alfabeta” cfr. M.C. Papini, L’impegno politico di Volponi: gli interventi su “Alfabeta”, in “L’immaginazione”, XIV, 143, dicembre 1997, pp. 30-31. Della stessa autrice si consulti senz’altro Paolo Volponi. Il potere, la storia, il linguaggio, Le Lettere, Firenze 1997.
| |
|
maggio - agosto 2004