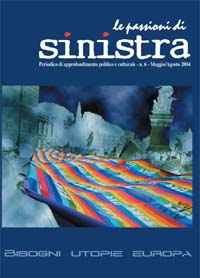Lo sguardo negato |
“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facilmente a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare di sapere riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”.
Italo Calvino
“Una volta lanciato nella sua frenesia, occorre all’attore per trattenersi dal commettere un delitto una virtù infinitamente maggiore del coraggio necessario a un assassino per poter mandare ad effetto il proprio, ed è per questo che, nella sua gratuità, l’azione di un sentimento a teatro appare infinitivamente più valida di quella di un sentimento effettivamente concretato.
In confronto al furore dell’assassino che si scarica, quello dell’attore tragico rimane in un cerchio puro e completo. Il furore dell’assassino, compiendo l’atto, si esaurisce e perde il contatto con la forza che lo ispira, ma che cesserà ormai di alimentarlo. Quello dell’attore ha assunto una forma che nega se stessa man mano che si libera, e si fonde nell’universalità.”
Antonin Artaud
Queste considerazioni di Calvino mi hanno fatto strada in uno strano viaggio che ormai dura da più di un anno. Un viaggio in un mondo particolare che non finirò di conoscere mai abbastanza: il carcere. Storicamente fin dai tempi del XVIII secolo, età in cui fu introdotto il carcere come punizione nella maggior parte degli Stati europei, molti giuristi riformatori si opposero a questa “novità” affermando che il carcere fosse incapace di rispondere alla specificità dei delitti principalmente perché sprovvisto di effetti sul pubblico…
Il pubblico è un elemento che mi interessa dato che sono entrato in carcere insieme ad Enza Depalma per gestire un laboratorio teatrale con i detenuti della sezione di alta sicurezza del super-carcere di Trani, e il teatro per esistere ha bisogno di un pubblico e della sua partecipazione. Una partecipazione che con l’introduzione del carcere si è persa completamente, poiché con la detenzione si è cominciato a punire in modo uniforme e di nascosto dal pubblico. Quest’ultimo viene lasciato di proposito all’esterno di ogni procedimento punitivo, come un testimone scomodo, togliendogli il ruolo di garante della pena. Ciò anche a causa della grande difficoltà di prevedere la sua reazione di fronte ad una punizione (all’epoca delle grandi esecuzioni pubbliche infatti il popolo era intervenuto non di rado a favore del condannato, liberandolo e massacrando le guardie). Chissà perché mi viene in mente il grande regista Jerzy Grotowski e la sua scelta, in questo caso libera, di operare in assenza di pubblico in quel di Pontedera negli ultimi anni della sua ricerca teatrale…che avesse paura di un testimone scomodo?
Ritornando a noi…
Il carcere sostituiva con il “buio” della prigionia la “rappresentazione pubblica” del castigo evolvendosi sempre più come uno strumento di controllo sociale in mano alla classe dominante, attorno al quale i media hanno saputo costruire un’ottima rete di consenso, parlando quotidianamente e in maniera ossessiva di criminalità, pericoli, emergenze, arrivando a creare così un artificiale clima d’insicurezza che ha come unico fine quello di giustificare agli occhi delle masse le carceri, le pene, le “misure di sicurezza”, adottate in realtà per proteggere e consolidare la supremazia delle classi dominanti appunto. Il pubblico non è più completamente “fuori” ma viene supportato da altri occhi, da altre forme di rappresentazione pubblica, potremmo dire di “stato”, parafrasando il buon Carmelo Bene.
Il pubblico, la rappresentazione e Carmelo Bene… già il teatro, o quello che ne rimane!
Tutto questo è stato il cavallo di Troia che mi ha permesso di entrare in questo inferno che di letterario non ha nulla, se non echi in forma di storiche rivolte… adesso anche il teatro gli fanno fare?
Un posto invisibile all’esterno in cui però all’interno tutto deve essere visibile, sorvegliato… anch’io che sono un civile normo-dotato…
Michel Foucault descrive in Sorvegliare e punire le conseguenze del panoptismo e il suo complessivo significato storico: quello di indurre all’interno del carcere uno stato di consapevole e permanente visibilità che assicura la funzione automatica del potere.
Il Panopticon teorizzato da J. Bentham è la figura architettonica che meglio rappresenta lo schema disciplinare per sorvegliare e controllare, il cui effetto è quello di indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicuri il funzionamento automatico del potere. Per Bentham quindi il potere doveva essere visibile e inverificabile: di continuo il detenuto avrà davanti agli occhi l’alta sagoma della torre centrale da dove è spiato e non deve mai sapere quando è guardato.
Questo l’ho visto frequentemente negli occhi dei detenuti, occhi che vagano spesso fuori dal contesto laboratoriale, non per l’imbarazzo di certi esercizi teatrali, ma perché hanno sempre la sensazione di essere osservati. A volte è stato molto difficile per me, che ho come principali obiettivi la rimozione di blocchi prettamente teatrali (il non saper recitare o il non essere creativi) e, soprattutto, psicologici (la paura e l’insicurezza), “denudare” uno che è gia nudo. In questo modo non si crea la particolare differenza di potenziale che consente all’allievo di “far saltare il ponte”, come direbbe Henry Miller.
Poi ho pensato che l’attore è sempre osservato, giudicato, nudo quando è sulla scena… e allora?
Questi continui incroci di visibilità che si annullano a vicenda potrebbero de-realizzare la realtà ma anche potenziarla, rivoltarla contro lo stesso sistema “ottico”, o panottico come in questo caso…
Mi viene in soccorso Foucault e mi dice che lo schema panoptico è un metodo applicabile ai più svariati campi della società: dalle scuole alle fabbriche, dagli ospedali alle situazioni domestiche e di vita comune. A questo punto mi sono chiesto se lo schema panoptico e il ragionamento di Foucault si potessero ben applicare anche al teatro…ma come?
Con lo sgomento e la necessità che mi accompagnano sempre durante ogni esperienza laboratoriale, mi sono ritrovato ad analizzare delle priorità, quindi a pensare soprattutto in termini di visibilità “altra”…del vedere oltre, dell’essere guardati anche quando si è soli, del vedere insieme quello che si riesce a vedere ma soprattutto quello che non si riesce a vedere…
Il mio scopo è stato quello di “sovvertire” le abitudini visive dello spazio dove facevamo teatro. Sovvertire in maniera spaziale le abitudini di quel luogo. Dimenticare il rumoroso palco, consapevole che la sua indiscussa centralità avrebbe creato quella permanente visibilità che volevamo mettere in discussione. È stato difficile convincere i miei “allievi” poiché la normalizzazione tocca anche loro, e il palco è sacro e non si tocca…
Tramite l’attività “subdola” del pedagogo sono poi riuscito a far passare questa nuova consapevolezza, più o meno…nel carcere tutti gli spazi sono stretti, e i piccoli passi sono inevitabili…
Come inevitabile è stato “mettere in scena” l’Amleto…
La parola ripetuta più spesso in quest’opera è “sorvegliare”. Qui sono sorvegliati tutti, senza eccezione, e in continuazione. Nel castello di Elsinore dietro ogni tenda si cela qualcuno.
Amleto tuttavia è l’unico che sa d’essere spiato…
E poi c’è la scena della recita, una geniale forma di teatro nel teatro in cui le direttive visive si perdono continuamente in forma di contraddizione. L’assassino-Claudio vede il suo doppio-attore compiere l’omicidio di cui è l’artefice, come dire il senso in platea e il significante sulla scena…ma anche il significante è senso di per sé stesso per la purezza unica e irripetibile del suo agire.
È proprio per questa intuizione artaudiana che questi corpi invisibili non potevano reclamare un ritorno alla semplice possibilità di rappresentare, ma la più giusta recriminazione sarebbe stata quella della visibilità dell’irappresentabile.
Corpi senza organi che cercavano una forma anatomica da invasati, “protetti” solo dalle loro necessità di vivere. La “figurazione” di un testo come l’Amleto non ha allontanato, anzi…
Mai una cosa così lontana è diventato una tanto vicina possibilità. Attraverso quest’opera si è riuscito a dar voce alle voci di ognuno, a veder emergere dal personaggio chi lo interpreta, ad assaporare la delicatezza che salta fuori dagli spiragli della recitazione e apre squarci di verità, di dolore, di gioia…di necessità. Il linguaggio di Shakespeare come codificazione poetica dei nostri pensieri, che cavalca questi attori-individui-detenuti per essere diretto dove vogliono loro, sempre con riverenza e rispetto, sia chiaro, ma con la convinzione di creare una forma di teatro che si fa per chi lo fa, che non sia autoreferenziale e che porti, come diceva Giovanni Testori, un pezzo di carne palpitante sulla scena a pronunciare quello che non si riuscirà mai a dire.
Ecco l’irrapresentabile in scena di questi corpi dis-umani perché il “testo” non può più essere re-citato da questi attori, ma continuamente messo in discussione per rispettarlo alla lettera. Un superbo ossimoro che incrociando i dubbi di Shakespeare (Essere o non essere…) con i propri (ancora Essere o non essere lì, in quel posto buio, in quell’essere continuamente irrappresentabili), dice con le parole del poeta di una delicata ribellione ai ruoli assegnati per essere vivi e “provvisoriamente”liberi, come direbbe Fulvio con la sua proverbiale auto-ironia…
Penso inevitabilmente a Nicola che parla di quel posto buio come “ il territorio dal cui confine non torna indietro mai nessun viaggiatore” e non perché cita alla lettera Shakespeare, ma perché è vero che il suo fine pena è mai…
Il panottico diviene così parallelo teatrale. Teatron di una strana architettura di visioni, punti di vista, focali o “vie di fuga”. Andare oltre la struttura. Un teatro dove non si riesce a capire più la differenza tra scena e platea, e non perché si è “infranta” la quarta parete, ma perché “qui e ora” ci sono gli sguardi che cadono continuamente in contraddizione, nessun riconoscimento… solo conoscere…
Chi guarda può “pensare” ed essere “normalmente” sensibile.
Qui non funziona, poiché si è continuamente guardati da tutti. Detenuti, agenti, educatori, direttori… non c’è più nulla da vedere.
Per questo trovo che il momento più forte del nostro Amleto sia stato il momento della scena della recita. I detenuti-attori non hanno fatto nessuna pantomima, come da drammaturgia, ma shakespearianamente sono diventati loro stessi osservatori passando tre minuti ad osservare il pubblico, ribaltando la prospettiva e liberandosi della rappresentazione per donare il proprio sguardo, il proprio “vedere”…
Una atipica poesia che muove sensazioni, sollecita in-comprensioni, invece di tramutarsi in trattati di filosofia o peggio ancora girare intorno alla comunicazione.
Il teatro in carcere ha bisogno solo di con-divisione con il coraggio del ridicolo, poiché non sono semplici attori, ma di più… Del linguaggio loro non sanno che farsene, se non per disfarlo… La poesia dei loro corpi senza organi ha solo questa possibilità, questi suicidati dal sistema hanno dis-fatto il teatro perché hanno dis-fatto il testo e la sua dittatura. Loro affrontano poi il pubblico con una vera e propria vergogna di mancare perché dovranno pur esserci, pur non essendoci, in scena.
| |
|
maggio - agosto 2004