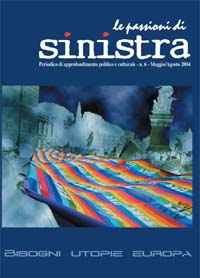Libertà provvisoria |
L’incontro col teatro “scatena”, per certi aspetti, le stesse emozioni di quando si incontra una persona che, sin dal primo momento, capisci che può cambiarti la vita.
Il rapporto con il teatro è quello di un amore. Un amore che non annulla niente di te, anzi aggiunge!
Se questo avviene in un luogo che, per sua indole, è teso ad annullare l’uomo e i suoi spazi naturali, qual è il carcere, allora il teatro diventa importante, quasi indispensabile. In carcere molto probabilmente i suoi benefici non si avvertono in toto. Infatti i preparativi di uno spettacolo avvengono all’interno di un sistema e di una struttura poco incline ai rapporti sociali “normali”. Un attore lavora col proprio corpo. In carcere però cose naturali, come un semplice contatto fisico o un abbraccio, vengono percepite come una sorta di infrazione. Le distanze fra esseri umani sono regola. Per non parlare dei problemi che sorgerebbero se una messinscena prevedesse una presenza femminile. In carcere non è ammesso alcun tipo di socialità col sesso opposto (già questo basta a far capire la civiltà della pena). Per cui, bisognerebbe affrontare un primo, grosso problema: farsi “prestare” dalla società esterna una attrice.
Se si riuscisse a risolvere il primo problema, bisognerebbe affrontarne un altro: evitare, durante la preparazione dello spettacolo e al momento della rappresentazione, qualsiasi tipo di contatto fisico con la propria compagna di lavoro. Ovviamente non mi riferisco ad abbracci d’amore o baci passionali, che durante la messinscena sono impensabili.
È come se in carcere coabitassero persone nate in cattività, che devono muoversi, parlare e agire (sin nei gesti più quotidiani e semplici) facendo i conti con pesanti limitazioni.
Tuttavia, la preparazione di uno spettacolo è vitale, perché rende possibile vivere insieme momenti importanti; scrivere e recitare pezzi di vita ti consente di dire delle verità che senza il mezzo-teatro non “dovresti” mai dire. Due verbi apparentemente inconciliabili, come dovere e desiderare, col teatro possono abbracciarsi.
Poi arriva il giorno della rappresentazione e le distanze, in quelle due ore, si annullano. Comunichi liberamente con i tuoi compagni e col pubblico.
Il pubblico interagisce con te con i gesti e gli sguardi, e i suoi assensi o dissensi perfezionano la terapia per guarire da quell’atroce patologia chiamata solitudine vergognosa.
Io e il mio amico Nicola, unitamente ad altri compagni, chiamiamo quelle due ore “libertà provvisoria”. Quelle due ore, per noi, sono paragonabili ad un anno di vita fuori da queste mura. Sono vissute pienamente, e questo, da parte di persone che spesso calpestano ciò che hanno perché egoisticamente vogliono ciò che non possono avere, non è poco.
Il mio motto è: guarda con amore ciò che hai, fallo con gli stessi occhi di ciò che vorresti.
Questo è il teatro in carcere per me.
P.S.: Il nostro gruppo si chiama “La-ghetto pensatore”, il trattino messo non senza provocazione si motiva col fatto che nel ghetto c’è chi pensa e vorrebbe un giorno sedersi metaforicamente attorno ad un laghetto per dialogare con la società e dare un contributo avvalendosi dei nuovi valori interiorizzati.
| |
|
maggio - agosto 2004