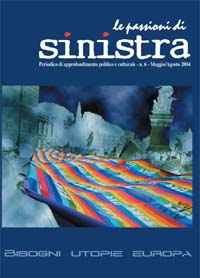Le pensioni, il lavoro, il risparmio... e poi la verità |
Appare opportuno ritornare sul tema della previdenza, oggetto della cosiddetta riforma delle pensioni predisposta dal governo di centro-destra, anche per tener conto delle osservazioni di quanti hanno ritenuto l’intervento apparso sul precedente numero di questa stessa rivista eccessivamente sintetico ed oscuro in taluni passaggi. Alcuni, infatti, hanno considerato l’articolo “criptico” o “ellittico”, in particolare laddove si è trattato del passaggio dal sistema a contribuzione a quello a ripartizione nella determinazione dei trattamenti pensionistici.
Nel testo citato si rammentava, al riguardo, come già con la legge 218 del 1952 si fossero poste le premesse per un tale mutamento nel metodo di calcolo delle pensioni. Si rimarcava, inoltre, come fin da allora, tramite l’uso di una terminologia subdolamente ingannevole, si tendesse ad indurre nei lavoratori e nei pensionati l’erronea convinzione che le modifiche via via apportate fossero per essi vantaggiose o comunque nel loro interesse, anche quando peggiorative del trattamento previdenziale. In tale ultimo caso, infatti, si sosteneva invariabilmente che le modifiche al sistema pensionistico consentissero di salvare il salvabile o di estendere e migliorare la tutela previdenziale di talune categorie o di garantire la stabilità, il rafforzamento e la perpetuazione della previdenza pubblica o cose simili.
Vale la pena di mettere in luce la catena di capziose definizioni dei concetti chiave e di attribuzioni di significati impropri ai termini impiegati, tramite cui storicamente, nel caso della previdenza pubblica in Italia, è potuto accadere che la sostituzione del sistema a capitalizzazione con quello cosiddetto retributivo sia stata sempre falsamente prospettata come vantaggiosa per gli assicurati.
Va innanzitutto sottolineato, in proposito, che, propriamente, la pensione è una rendita e, quindi, un reddito di capitale e non un reddito da lavoro. Beninteso, nel caso dei lavoratori dipendenti, il capitale o montante di loro spettanza, cioè di loro proprietà, è stato accantonato tramite versamenti di contributi da parte dei datori di lavoro e trattenute sulla busta paga. Tuttavia, se certamente all’origine del processo di accumulazione c’è un rapporto di lavoro, il processo in sé per sé consiste nell’accantonamento di un capitale e di una proprietà di spettanza dell’assicurato. In altri termini, la previdenza è una forma di assicurazione, ne ha i caratteri contrattuali e come tale funziona. Essa è sempre e non può che consistere in un processo di capitalizzazione, messo in atto tramite l’accantonamento di risorse, nella forma di contributi, che nel caso della previdenza pubblica null’altro sono, in fin dei conti, che una imposizione, un risparmio forzoso, cui vengono assoggettati i datori di lavoro ed i lavoratori. Occorre non dimenticare, infatti, che la previdenza pubblica ed il sistema pensionistico italiano hanno natura obbligatoria e sono stati imposti ai cittadini in forza di legge (la sigla AGO, con cui la previdenza pubblica viene complessivamente indicata, sta non a caso a significare Assicurazione Generale Obbligatoria).
I motivi per cui storicamente, nel caso italiano, si sia affermato un sistema previdenziale pubblico, generale ed obbligatorio, invece che forme di gestione a carattere privato, individuale e facoltativo, sono ovviamente complessi e meriterebbero un esame ben più approfondito di quello consentito dal presente articolo, che del resto non si propone una tale finalità. Va comunque considerato che una gestione obbligatoria ed a carattere generale consente, in astratto o, come dicono gli economisti, a parità di ogni altra condizione, quantomeno la possibilità di sottrarre le sorti dei lavoratori divenuti anziani e delle persone e famiglie da essi dipendenti per i mezzi di sussistenza, dalle conseguenze negative dei comportamenti degli stessi assicurati e dall’eventuale funesto accanimento del caso. Più problematico appare il giudizio circa il confronto fra privato e pubblico, anche se va in ogni caso considerato che un sistema a carattere generale – l’unico, che per le ragioni esposte, possa considerarsi efficiente e funzionale in materia di assicurazioni, in virtù della legge dei grandi numeri – ha necessariamente carattere collettivo e normalmente anche pubblico in senso stretto e, come tale, quantomeno sarà regolato a norma di legge.
Per tornare al tema iniziale, si rammenta che la legge 153 del 1969, con l’aggancio delle pensioni ai salari, sancì il passaggio definitivo al sistema a ripartizione, in tal modo stabilendo per legge una stretta connessione fra le pensioni e l’ammontare delle retribuzioni dei lavoratori in attività. È appena il caso di sottolineare come contestualmente e implicitamente le pensioni furono trasformate, in forza di legge, da reddito di capitale in reddito da lavoro e il metodo di calcolo delle pensioni fu definito retributivo.
Tale sistema di calcolo si basa su due elementi: il numero degli anni di contribuzione e la media delle retribuzioni percepite nell’ultimo periodo di attività, rivalutate tenendo conto dell’inflazione. L’ammontare della pensione, in base alla normativa tuttora vigente, è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione. Con 25 anni di contribuzione si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino al massimo di 40 anni e dell’80%. La retribuzione presa a base per il calcolo della pensione è costituita dalla media annua delle retribuzioni percepite nell’ultimo decennio di lavoro. Va sottolineato, a questo riguardo, che la c.d. riforma Amato (Legge 503 del 1992) ha gradualmente elevato da cinque a dieci il numero degli anni da considerare per il calcolo della retribuzione media. Il requisito dei dieci anni è pienamente in vigore dal 1° maggio 2001. Più esattamente, per effetto della predetta legge, il calcolo della pensione è stato scisso in due quote (A + B): la prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dal 1° gennaio 1993 in poi. La quota A viene determinata in base alla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di lavoro; la quota B è calcolata in base alla media degli ultimi 10 anni. Come già accennato, le retribuzioni utilizzate per il calcolo della media non sono quelle effettivamente percepite, ma quelle rivalutate tenendo conto dell’inflazione. In pratica, la rivalutazione viene effettuata moltiplicando le retribuzioni effettive per un coefficiente rilevato dalla tabella annualmente aggiornata dall’Istat. Poiché dalla rivalutazione sono esclusi l’anno di decorrenza della pensione e quello precedente, risulta in genere conveniente presentare la domanda di pensione nel mese di dicembre con decorrenza dal gennaio successivo, onde inserire nel calcolo della media un anno pieno di retribuzione rivalutata in più.
La legge Amato, oltre a quanto esposto circa le modalità di calcolo delle pensioni, ha elevato gradualmente l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (entro il 2000, da 60 a 65 anni per gli uomini, da 55 a 60 anni per le donne) ed il requisito minimo per il pensionamento (da 15 a 20 anni di contributi entro il 2001), ha avviato la perequazione dei trattamenti fra dipendenti pubblici e privati ed ha introdotto le prime restrizioni per le pensioni di anzianità. È il caso di rimarcare, per coloro ai quali tale particolare fosse sfuggito, che il passaggio dalla retribuzione media di cinque anni a quella calcolata su dieci anni non è che una pura e semplice riduzione delle pensioni, tanto più rilevante quanto più accentuato è l’incremento delle retribuzioni nel decennio considerato per il calcolo della media.
La successiva c.d. riforma Dini (legge 335 del 1995) ha pure inciso in misura rilevante sul sistema pensionistico, in particolare introducendo il calcolo contributivo, anziché retributivo, per coloro che sono entrati nel sistema assicurativo previdenziale dopo il 31 dicembre 1995. Il calcolo contributivo viene collegato ad un’età di pensionamento flessibile con riferimento a 65 anni, con incentivi e disincentivi a seconda dell’età effettiva dell’assicurato. Nel regime contributivo, la pensione è strettamente collegata alla contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa e non alle retribuzioni percepite nell’ultimo periodo di lavoro, come accade con il sistema retributivo. Il sistema contributivo, come concepito dalla legge Dini, comporta che il lavoratore dipendente, in concorso con il proprio datore di lavoro, accantoni annualmente il 33% della retribuzione. Le somme versate producono una sorta di interesse composto, ad un tasso legato alla dinamica quinquennale del prodotto interno lordo e all’inflazione. Alla data del pensionamento, al montante contributivo, ossia alla somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione, che cresce con l’aumentare dell’età. Il coefficiente, ad esempio è pari al 4,72% per chi sceglie di chiedere la rendita pensionistica a 57 anni (oppure ha raggiunto i 40 anni di attività), sale al 5,514% per chi continua fino a 62 anni e al 6,136% se si decide di lavorare fino a 65 anni.
Con la legge finanziaria 1998 varata dal governo Prodi (articolo 59 della legge n. 449 del 1997), si è realizzato un completamento della c.d. riforma Dini: per le pensioni di anzianità è stato accelerato il percorso che porta l’età minima a 57 anni per i lavoratori dipendenti ed a 58 anni per i lavoratori autonomi.
Le modifiche del sistema previdenziale pubblico attuate negli anni novanta con le leggi Amato, Dini e Prodi lo hanno trasformato in maniera sostanziale, abbassandone progressivamente il grado di copertura. Si è calcolato che, per effetto dei provvedimenti legislativi citati, nel 2020, con 40 anni di contributi, il cosiddetto tasso di sostituzione, cioè il rapporto tra la pensione e l’ultimo stipendio su cui sono stati versati i contributi previdenziali, si abbasserà al di sotto del 50%.
Va rimarcato come in materia di pensioni si faccia un uso ambiguo ed ingannevole delle espressioni “a capitalizzazione”, “contributivo”, “retributivo” e “a ripartizione”. In pratica, il sistema a capitalizzazione viene capziosamente presentato come equivalente o addirittura sinonimo di sistema contributivo. In realtà, ciò che la legge Dini ha definito sistema contributivo ha poco o nulla a che vedere con il sistema a capitalizzazione. Come già precisato, il “sistema Dini” fa dipendere l’ammontare delle pensioni da grandezze del tutto estranee ai rapporti fra l’assicurato e l’istituto di previdenza: il prodotto interno lordo (PIL) e l’inflazione. Va sottolineato, in proposito, un aspetto che a taluni sembra essere sfuggito: se il PIL o il livello dei prezzi o entrambi si riducono, in forza del marchingegno creato dal governo Dini, si devono ridurre anche le pensioni. Peraltro, i due riferimenti introdotti dalla legge Dini hanno già manifestato, in passato, tendenze anche pronunciate al ristagno ed alla flessione, con conseguenze traumatiche sui sistemi socioeconomici. Del resto, anche all’attualità, il ripetersi di questo genere di fenomeni non è affatto da escludersi e, anzi, non parrebbe esagerato affermare che sia già in atto in alcuni paesi, compresa l’Italia, una incipiente flessione del PIL, mentre per altri paesi, come gli Usa e, quindi, necessariamente anche a livello globale, appare innegabile che la dinamica di questo indicatore sia drogata, ossia fortemente influenzata da guerre e spese militari.
Altrettanto surrettiziamente, il sistema retributivo è stato presentato come equivalente al sistema a ripartizione, diffondendo in maniera subdola nell’opinione pubblica la convinzione che le pensioni pagate dal sistema previdenziale abbiano la loro fonte e ragion d’essere unicamente nei contributi versati dai lavoratori attivi nello stesso periodo. Questo implicitamente comporta che le fonti medesime siano da intendersi come rigidamente identificate e limitate e, quindi, non possano superare l’ammontare dei contributi versati annualmente.
In realtà, le cose stanno in maniera profondamente diversa. Il sistema a capitalizzazione, inteso nella sua accezione corretta, implica che i contributi versati dai lavoratori e dai loro datori di lavoro vengano affidati ad un ente, che provvede a gestirli, con la prudenza del buon padre di famiglia, nell’interesse degli assicurati. In altri termini, l’ente assicuratore, ossia, nel caso italiano, l’istituto di previdenza, ha l’incarico di salvaguardare e far fruttare i fondi in tal modo incamerati, impiegandoli in investimenti al più alto livello di sicurezza e, in tale ambito, al migliore tasso di rendimento. Ciò che spetta, ossia è di proprietà degli assicurati, in virtù delle regole alla base dei contratti di assicurazione, nonché della matematica finanziaria ed attuariale, è il montante di capitale e rendimenti composti prodotti da questo processo di accantonamento ed investimento, al netto delle spese di gestione dell’ente previdenziale. Ciò che accade - e che è storicamente accaduto anche in Italia – è che una parte considerevole della ricchezza annualmente prodotta dalla nazione viene risparmiata, ossia sottratta al consumo e messa da parte, a disposizione degli assicurati per il momento in cui vanno in pensione. Finché il sistema previdenziale pubblico è stato gestito in maniera sufficientemente corretta, ha consentito non solo - ovviamente - di pagare agli assicurati le pensioni di loro spettanza, ma anche l’acquisizione di un formidabile patrimonio immobiliare e partecipativo da parte degli istituti previdenziali.
Nel precedente intervento si è sottolineato come la gestione della previdenza secondo il principio della capitalizzazione - l’unico veramente corretto e giustificato in materia assicurativa - avrebbe consentito, ai tassi di rendimento correnti in tempi ancora recenti (anni settanta ed ottanta), quando la maggior parte dei lavoratori attualmente alle soglie della pensione era già in attività, il raddoppio in pochi anni – cinque, quattro o anche tre – dell’intero montante assicurato.
Invece, i governi e le forze politiche e sindacali dell’Italia repubblicana hanno ritenuto più utile, almeno ai loro fini, non rispettare le regole delle assicurazioni previdenziali, né quelle della matematica e della lingua, né, tantomeno, la norma costituzionale posta a tutela del risparmio. In pratica, la ricchezza messa da parte per assicurare i mezzi di sostentamento ai lavoratori una volta cessata la loro attività è stata sottratta ai legittimi proprietari e destinata ad altre finalità, per lo più di ordine dichiaratamente o sostanzialmente assistenziale, di cui è stato fatto carico di volta in volta agli istituti previdenziali, senza dotarli delle risorse necessarie, in violazione del dettato costituzionale che impone l’individuazione delle fonti di finanziamento delle spese pubbliche.
La cosa più inammissibile non è tanto questa sistematica sottrazione di ricchezza, ma il fatto che non sia stato affatto rispettato l’obbligo di reintegrare gli assicurati nei loro diritti, ossia nelle loro proprietà. In altre parole, il diritto proprietà, ritenuto sacro in ogni altro contesto, è stato in questo caso bellamente violato, senza tanti problemi.
Contro tali argomenti, in alcun modo oppugnabili da nessun economista o tecnico della previdenza di qualunque tendenza politica, purché onesto e in buona fede, si oppone talora che i soldi distratti per altri fini vengono prima o poi restituiti alla gestione previdenziale. Ovviamente è proprio nel “prima o poi” la chiave dell’imbroglio. Innanzitutto, il fatto che in ogni momento gli istituti previdenziali pubblici destinino parte rilevante delle loro risorse a fini in senso lato assistenziali, sta chiaramente ad indicare che in realtà quelle somme non vengono restituite ma sostituite e semmai incrementate. Va poi sottolineato che, nei numerosi decenni in cui questo andazzo è durato e ancora perdura, ai capitali sottratti alla gestione previdenziale non è stato garantito né il rendimento ricavabile da investimenti prudenziali a rischio nullo, né, tantomeno, quello, normalmente più elevato, ricavabile dal collocamento delle stesse somme sul mercato creditizio.
Alla fin fine, ciò che è in effetti accaduto è che i lavoratori assicurati presso la previdenza pubblica non solo sono stati defraudati, ossia derubati, della loro ricchezza, cioè della loro proprietà, ma si sono visti, come per magia, trasformati in assistiti e mantenuti dalla società. Per effetto di illusionismi ed acrobazie linguistiche, in cui i politicanti italiani di ogni asserita tendenza politica da sempre si sono mostrati maestri, coloro che in svariati decenni di lavoro hanno faticato e si sono assicurati presso l’ente di previdenza, tramite pagamenti diretti o effettuati dai datori di lavoro, le risorse necessarie per la sopravvivenza propria e della propria famiglia, devono sentirsi dire che stanno campando a spese o in danno delle giovani generazioni, le quali, peraltro, non per loro colpa, per lo più non hanno avuto ancora modo di produrre granché.
Va rimarcato, per quanto la cosa debba considerarsi superflua, che un sistema previdenziale efficiente contribuisce in misura decisiva a fare la differenza fra civiltà e barbarie. Va analogamente chiarito che, se il sistema socioeconomico italiano è sopravvissuto, nonostante le ruberie e gli imbrogli, lo si deve principalmente e in massima parte alle risorse prodotte e accantonate dai lavoratori e dai loro datori di lavoro, ancorché saccheggiate dai politicanti e dagli uomini d’affari.
Né più né meno, ai lavoratori assicurati presso gli istituti previdenziali è stato in molti casi tolto il diritto, ampiamente maturato e pagato, a diventare legittimamente ricchi, con le risorse messe da parte da loro e dai loro datori di lavoro. Tale diritto e le corrispondenti proprietà sono stati trasferiti ad altri e, in fin dei conti, ad avvantaggiarsi di tali trasferimenti, direttamente o indirettamente, sono stati gli uomini d’affari.
Le modifiche varate dal governo di centro-destra diminuiscono ulteriormente il grado di copertura delle pensioni rispetto alle retribuzioni, riducendo contestualmente l’onere contributivo a carico dei datori di lavoro, e tendono ad accrescere lo squilibrio finanziario degli istituti previdenziali pubblici ed a favorire la previdenza privata. Si afferma, al riguardo, che l’ulteriore sottrazione di ricchezza ai danni dei lavoratori e dei pensionati, favorendo gli uomini d’affari ed il profitto, tornerebbe a vantaggio delle giovani generazioni, in quanto consentirebbe di liberare risorse che le imprese impiegherebbero nello sviluppo delle attività produttive e dell’occupazione.
Chi afferma queste panzane, qualora lo faccia in buona fede, dimostra di vivere in un mondo totalmente diverso da quello reale. Nel mondo reale, le imprese e gli uomini d’affari che le controllano sono occupati a far soldi, ossia ad ottenere una differenza positiva fra ciò che incassano e ciò che pagano. Oltre che nel significato traslato, ancorché plebeo, di acquisire ricchezza, l’espressione “far soldi” va intesa anche in senso stretto, come trasformazione degli investimenti materiali in denaro, ossia in attività finanziarie. A questo denaro, gli uomini d’affari fanno fare tutti i possibili giri del mondo nelle isole dei pirati o in altri paradisi fiscali, per lucrare rendite e plusvalenze e rifilare fregature a dritta e a manca. Si tratta del formidabile fenomeno della finanziarizzazione delle economie, di cui, si direbbe, gli economisti dovrebbero pur aver sentito parlare. Produrre beni e servizi, creare occupazione, soddisfare bisogni non sono obiettivi, ma solo incombenze che le circostanze hanno storicamente imposto agli uomini d’affari e che nel mondo attuale appaiono manifestamente ridimensionate rispetto alla cosiddetta economia di carta. Peraltro, l’interesse degli uomini d’affari a far soldi, come dimostrano ampiamente le cronache finanziarie, possono essere in patente contrasto con la stessa sopravvivenza delle imprese da loro controllate.
In parole povere, gli uomini d’affari, di per sé e tramite le imprese che controllano, tendono ad accaparrare ed accumulare ricchezza e non fanno cose utili per la società, a meno che non vi siano costretti. Se i soldi già ce li hanno o se vengono loro graziosamente regalati dalla collettività, non devono fare nulla per guadagnarseli e meritarseli e, quindi, viene fuori in pieno la natura parassitaria, speculativa, ma anche fraudolenta e violenta delle attività affaristiche e delle istituzioni finanziarie che le supportano.
Per tornare all’argomento previdenza, si può comprendere, alla luce delle argomentazioni svolte, come solo se i soldi restano o tornano saldamente nelle mani dei legittimi proprietari, ossia dei lavoratori assicurati e dei pensionati, serviranno effettivamente a soddisfare bisogni e ad acquistare beni e servizi utili. D’altro canto, solo se riterranno vantaggiosa la vendita di questi beni e servizi, anziché le alchimie e frodi finanziarie e le spese militari, le imprese e gli uomini d’affari si decideranno ad incrementare la produzione di beni e servizi e l’occupazione. Viceversa, se la gente comune perde, oltre alle proprie risorse, anche la fiducia e la speranza in un futuro migliore, non solo non supporterà le attività produttive con la propria spesa per consumi, ma neanche sarà più in grado di svolgere efficacemente il prezioso ruolo di supporto e formazione delle nuove generazioni. E queste ultime si ritroveranno ancor più povere ed impotenti, così come l’intera società.
A mo’ di conclusione, è il caso di soffermarsi a considerare lo spauracchio strumentalmente agitato dai partiti del centro-destra, ma in tempi non lontani anche da quelli del centro-sinistra, per giustificare gli interventi sulla previdenza. Va chiarito, al riguardo, che qualora in un futuro prossimo o remoto dovesse effettivamente manifestarsi un qualche squilibrio fra entrate ed uscite annue degli istituti previdenziali, ammesso pure che un tale pericolo non sia stato ingigantito e drammatizzato ad arte, c’è tutto il tempo per premunirsi, procacciandosi risorse tramite la lotta all’evasione contributiva ed il recupero dei crediti previdenziali. Oltretutto, nella peggiore delle ipotesi, non ci sarebbe nulla di male se, una volta tanto, per consentire il superamento di eventuali momentanee crisi di liquidità, fosse lo stato a fare credito agli enti previdenziali e non viceversa, come fin qui è invariabilmente accaduto. La presunta e temuta cosiddetta gobba contributiva viene, infatti, da tutti descritta come un fenomeno transitorio, per cui risulta alla fin fine incomprensibile come e qualmente abbia potuto sollevare tanto allarme.
| |
|
maggio - agosto 2004