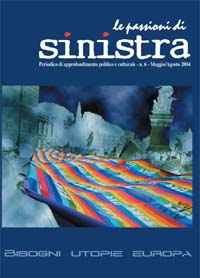Il teatrino barocco della settima figlia di Jacopo |
Scelse la fine di un secolo classico il barocco per svelare l’artificio di luce e di ombra ravvicinate, dove spesso la baraonda e la moltitudine di rappresentazioni indussero ad esaltare una cognizione nuova di bellezza tra angeli festanti di gesso bianco e madonne portate nell’aria da spiegazzanti veli azzurri e rosa.
E scelse l’irregolarità e l’abbondanza, il contrasto e l’allucinazione, nelle chiese e nei palazzi, nei teatri e nelle piazze, cosicché permise incredibilmente a taluni, se pur di spirito e indole non barocca, di toccare la pietra e di scolpirla con tale mestiere e tanta arte come se fosse cera tiepida o argilla tenera nelle loro mani, al contrario del cuore che in Jacopo Salvemini per esempio, maestro scalpellino, invocato tra i migliori ed apprezzato tra i più abili, era rimasto invece così com’era classico e severo, duro come la ruvidezza di una lastra pietrosa.
Per una storiella che capita chissà a quanti nella propria esistenza, e che nel caso di Jacopo Salvemini invece si concluse con la morte per pazzia, era arrivato addirittura ad imporre alla sua famiglia alcune modifiche all’aritmetica e all’alfabeto e addirittura altre regole quotidiane. E ditemi se tutto questo non è invece profondamente barocco. E irriverente.
Dopo l’uno, il due, il tre, il quattro, il cinque, il sei veniva l’otto, poi il nove, il dieci e tutto il resto; dopo la f veniva la h, la i, la l, la m fino alla z; forse per la stessa ragione dopo il sabato, nonostante il timore per il Buon Dio, sembrava venisse sempre un giorno qualunque, d’altra parte di riposo proprio non se ne parlava, figuriamoci poi se poteva esserci qualcuno che portava il conto dei giorni della settimana.
L’aritmetica e le lettere dell’alfabeto nella casa di Jacopo Salvemini non erano consuete, ma un po’ tutti, sebbene limitata ai rudimenti, ne avevano una certa conoscenza.
La verità è che a un certo punto quel santo uomo, abbandonato dalla ragione e dalle sue madonne con gli angeli, stabilì che tutto ciò che avesse a che fare con il numero sette dovesse essere cancellato.
Ma come si poteva riuscire in un’impresa simile? In che modo si poteva spiegare ai figli una decisione del genere? Già non v’era mai stato nessuno che a loro avesse raccontato storie; l’istruzione dei nove sopravvissuti di Caterina e Jacopo – i nati erano stati in tutto ventidue – consisteva nel saper scrivere a malapena il proprio nome e a contare fino alla decina. E tutto questo lo avevano appreso grazie allo spirito della madre.
Invece da quell’uomo con la barba bianca, sempre in silenzio, con le lunghe dita deformi e angolose proprio come scaglie di pietra, dove nelle pieghe più remote e nelle rughe talvolta sanguinanti si era infiltrato il biancore incancellabile dei suoi colpi di martello e scalpello, nessuno aveva imparato proprio niente.
D’altronde che cosa avrebbero potuto imparare da uno che aveva l’aspetto di essere misterioso e antico, ma nello stesso tempo che tutti ritenevano invincibile e profondo tale da rendere la sua fama inavvicinabile e irreprensibile come un dio greco?
Sembrava al primo impatto privo di qualunque sentimento o affetto, proprio come una pietra, al punto che gli otto figli in diversa misura provavano un senso di ritrosia nei suoi confronti, ma in realtà non era proprio così.
Allora i figli di Jacopo e Caterina erano otto o nove?
In realtà stava proprio nella incongruità tra questi numeri lo stato che indusse Jacopo Salvemini alla pazzia.
Mentre si diceva da una parte all’altra della strada che il padre di quei ragazzi era un individuo strano, di modi bruschi e severi e che nessuno capiva come riuscisse a realizzare quelle mirabolanti scene di gloria e di perfezione intorno alle colonne delle chiese e degli altari, di Caterina tutti dicevano che il suo aspetto gentile e remissivo era corrispondente a ciò che il cuore le dettava. Era brava e buona con i figli, passava tutto il tempo a lavare e cucinare e si diceva inoltre che anticipasse, come tutti del resto, addirittura l’alba, mettendosi in movimento alla fioca luce di lucerne ad olio o al chiarore del fuoco del camino.
Qualcuno diceva che possedeva una bella voce e che l’aveva sentita cantare. Era lei che nei giorni di messa cantata, all’oscuro di Jacopo, portava i figli nella piazzetta dove per uno o due giorni sostavano venditori di volatili e spezie piccanti provenienti dall’oriente, musicanti, attricette, illusionisti e mangiafuoco, gente capace di portare un po’ di divertimento in quella parte della terra, gente che conosce mille trucchi e invenzioni per attrarre gli umili e gli analfabeti. Qualcuno di loro recitava addirittura anche dei versi.
Capitan Fracassa era il capocomico, poi vi erano gli altri che o suonavano o recitavano; vi era anche uno enorme e possente come un gigante che si dimenava con tutte le forze fino a quando riusciva a spezzare catene e serrature che sembravano inviolabili.
Con capigliature cespugliose ed esagerate più simili a ispidi nidi di rondine, le donne provavano a muovere alcuni passi di danza, benché il risultato coreografico fosse oltremodo sgraziato. Apparivano letteralmente imbustate nei loro vestiti rassomiglianti a voliere ricoperte di passamanerie, ricami e stracci coloratissimi. Le loro guance erano coperte da spessi strati di cipria che le rendevano più improbabili delle bambole di pezza che Caterina cuciva per i figli mentre gli occhi, grandi come fiori di mandorlo, erano ripassati con i fondi dei tappi di sughero anneriti dal fuoco.
Cantavano oppure recitavano versi accompagnate dalle musiche melodiose di scalcinati liutisti e flautisti che sembravano però lì per lì usciti da un libro di favole arabe. Un tamburellista poi girava intorno al palco richiamando l’attenzione degli spettatori con qualche rude colpo che aveva l’effetto di far indietreggiare i più piccoli per lo spavento.
Non vi era niente di più divertente, diciamolo pure, e a quegli appuntamenti Caterina portava Giuseppe, Maria Giuseppa, Elisa, Susanna, Rosina, Onofrio, Pasqualina, Corrado e Modesto. A Maria Giuseppa spettava l’obbligo di sorvegliare i più piccoli e impedire che si avvicinassero troppo al palco.
Tutti rimanevano incantati da quella fiera di meraviglie, di luci e di musica, di magie e salti: chissà in quel momento che cosa passava nelle loro testoline; soltanto Pasqualina, la settima, era sempre lei, non riusciva a starsene ferma ed era sempre lei ad abbandonare il gruppo per avvicinarsi agli attori. – “Pasqualina torna immediatamente indietro.”, gridava Maria Giuseppa. – “Vado un po’ più avanti; non preoccuparti. Starò attenta a non perdermi.”, rispondeva Pasqualina allontanandosi di più, senza nemmeno voltarsi verso la sorella.
I ricami d’oro e di porpora delle attrici, il bel canto, per modo di dire, i movimenti veloci delle dita dei musicisti sulle corde dei loro strumenti, capaci di concertare canzoni e melodie così struggenti che raccontavano sempre le stesse storie di gioie e di dolori d’amore, per Pasqualina erano come un soffio per ravvivare dei fiori.
Intendiamoci, nulla di sconveniente, anzi, la curiosità e la sensazione per quel piccolo mondo che appariva libero e poetico sulle quattro travi incrociate del palcoscenico erano per tutti talmente forti da richiamare anche i più resistenti, meno [Jacopo naturalmente] che pareva avere nella testa soltanto angeli e madonne.
Ebbene, durante la giornata capitava che Caterina canticchiasse alle sue creature le melodie che aveva sentito da quelle attricette. E capitava poi che un po’ tutti si univano alla madre atteggiandosi a fare l’attrice o il poeta. Ma per una di loro quelle melodie erano più di un gioco.
Con il tempo molto probabilmente Pasqualina cominciò a costruire nella mente un suo piccolo teatro, con attrici e poeti, musicisti e saltimbanchi, maghi e illusionisti simili a quelli che aveva visto nelle fiere e che sul palcoscenico sembravano vivere soltanto di poesia e di gentilezze.
Mentre i fratelli e le sorelle giocavano con palle di stracci sudici avvolti nello spago e qualche rozzo giocattolo di legno, lei si rifugiava in un angolo della casa recitando dei versi che con mille fatiche cercava di trascrivere su pezzi di tessuto chiaro che riusciva a sottrarre alla madre.
Con chissà quali stenti, era riuscita a imparare a scrivere e a leggere da sola. Non vi è dubbio che era diversa dalle sorelle e dai fratelli. Appariva vagamente più distinta e nei modi si scorgeva una sensibilità interiore che la induceva a preferire la riflessione e la conoscenza.
Un giorno Caterina la scovò con il viso imbellettato come una di quelle attrici. Non mancò naturalmente di far rilevare con la giusta severità alla figlia che quello che aveva fatto era una pazzia. – “Non farti vedere da nessuno in quel modo. Ti scambierebbero per una pazza e chissà cos’altro. Se poi ti vedesse tuo padre. Pulisciti e torna a giocare con i tuoi fratelli.”
Pasqualina era proprio quello che non voleva fare: giocare con i suoi fratelli. Il suo mondo si era formato e coincideva con la vita che secondo lei conducevano le compagnie teatrali.
In quegli attimi di più intensa malinconia, come se soavemente venisse rapita dalla sua immaginazione, terminava i suoi sogni davanti alle fiamme del camino.
Nessuno, e come poteva essere diversamente, si accorse che Pasqualina stava anch’ella allontanandosi dalla famiglia e si stava rifugiando in un mondo costituito all’esterno dal silenzio e dall’irascibilità. Come Jacopo d’altronde.
Nel caso di Pasqualina avvenne che durante l’ultimo giorno della fiera di un anno, come sempre, s’era allontanata dai fratelli e poi nessuno l’aveva più vista in giro.
La piazza, i vicoli, la chiesa grande barocca, la sagrestia e i palazzi, i giardini, il torrione, le cisterne dell’acqua, furono messi sotto sopra fino all’alba e oltre. Furono rincorse le carrozze degli attori, ma Pasqualina non fu ritrovata. Fu soltanto rinvenuto sotto il letto della poverina un biglietto dov’era scritto in maniera veloce e frammentaria che era fuggita con un poeta di cui si era perdutamente innamorata e che intendeva seguirlo in giro per il mondo nuovo che stava per venire.
Si seppe che Caterina per questo si ammalò e che il silenzio di Jacopo si trasformò presto in pazzia e non vi fu modo per riportare in quella casa pace e serenità.
In preda all’oscurità causata dalla malattia giunse al punto di imporre a tutta la famiglia di cancellare il sette essendo Pasqualina la sua settima figlia nata, quella figlia segretamente prediletta perchè come lui era incline al silenzio e alla poesia, ma che ad un certo punto aveva scelto l’evasione e le voci frastornanti di un teatro barocco.
| |
|
maggio - agosto 2004