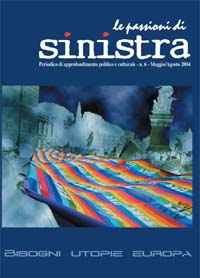I laboratori della scienza |
È il testo della “laudatio”, espressa il 24 marzo scorso a Potenza, in occasione del conferimento della laurea ‘honoris causa’ a Gino Strada in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio, nell’università della Basilicata. In un’aula affollatissima e commossa, si è celebrata una cerimonia viva e per niente rituale, proseguita con la lettura della ‘rogatio’, che è riportata in fondo a questo scritto, e successivamente con un’appassionata ‘lectio doctoralis’ da parte di Gino, conclusasi infine con la proclamazione da parte del rettore dell’università.
Ho iniziato a lavorare alla laudatio in onore del dottor Strada, quando ero in Angola, alcuni mesi fa, con il CUAMM di Padova, un’organizzazione sanitaria non governativa impegnata nella riapertura e nel sostegno ai servizi medici in un paese devastato e indebolito da più di trent’anni di guerra.
È stato là, durante una delle rare pause della mia personale difesa dall’anofele della malaria, è stato a Uige e a Damba, che ho maturato l’idea di scrivere sui laboratori della scienza, una via non rituale da percorrere per descrivere l’opera di costruttore di pace svolta da Gino Strada, chirurgo d’urgenza al Policlinico di Milano e fondatore di Emergency, e non rischiare di scadere nella vacua retorica elogiando una persona nota al grande esercito dei volontari e al numeroso pubblico degli onesti e dei non violenti, un uomo lontano dagli stereotipi cari alla comunicazione di massa. E non è retorico riferire che con difficoltà l’università ha potuto sottrarre per qualche giorno Gino Strada al suo silenzioso lavoro in Iraq, in Sudan e in Afghanistan, impegnato nei tanti teatri della guerra infinita ad operare per salvare vittime innocenti della follia umana e costruire, con indispensabili strutture ospedaliere, anche nuovi scenari di pace, veri laboratori di scienza e di umanità.
Qualche anno fa Marco Beretta, in un bel libro sulla Storia materiale della scienza, ha ripercorso i tentativi della scienza di inseguire la sua funzione strategica e, insieme, la sua propria neutralità, ed io intendo qui proporre un tracciato di lettura per attraversare il ruolo che i laboratori hanno avuto nella storia.
Il significato quattrocentesco di laboratorio, nel suo termine derivato dal latino rinascimentale, in origine coincideva con “officina”, ma pian piano si è trasformato in luogo, e via via in sistema, di sperimentazione scientifica ed elaborazione concettuale. È questa la sua funzione più piena, quella che davvero si manifesta utile alla liberazione dei popoli della terra dai pregiudizi e dai conflitti.
Non studiolo ristretto, né museo ammuffito, non accademia di eletti e neppure soltanto angusto edificio universitario, oggi il laboratorio non è certamente più lo spazio degli umanisti bisognosi nell’antichità di istituzionalizzare la ricerca filologica, per legittimare l’autorità dei testi, ma neppure più è il laboratorio rinascimentale della sperimentazione empirica e descrittiva. Non museo naturalistico della scienza osservativa, né bottega in cui si sperimentava la lavorazione di metalli, marmi e argille, non è più soltanto lo spazio in cui si realizzano le condizioni materiali per la replica artificiale e controllata dei fenomeni naturali.
Importante e insostituibile, oggi, nella pratica di quasi tutte le scienze, il laboratorio però non risale, in origine, alle generalizzazioni teoriche del meccanicismo e del razionalismo cartesiano né dell’empirismo baconiano, su cui si basavano le accademie scientifiche. Nasce, dalla pratica delle scienze occulte, il laboratorio degli alchimisti, che costituì l’alternativa al modo tradizionale di praticare la scienza, non più mediato dai libri e dalle lezioni accademiche. Fu qui che lo studioso non si piegava più all’autorità degli auctores e dei loro libri; fu qui che si crearono le condizioni perchè la natura si rivelasse senza mediazione nè ricorso al complesso apparato di categorie della filosofia aristotelica; fu qui, ne Il laboratorio dei medici, che Paracelso, invitando al superamento della cultura libresca, proclamava nel sedicesimo secolo la superiorità della conoscenza diretta della natura.
Oggi, non è più laboratorio di storte e di vetri, laboratorio di strumenti che assomiglia più a una “cucina” che a un sito moderno di ricerca sperimentale, secondo l’immagine che ci è stata tramandata dagli storici della scienza. Non è più laboratorio di bilance, aerometri, termometri, barometri, macchine elettriche, “bottiglie di Leida”, modelli meccanici ed altri congegni utili ad approfondire la natura dei fenomeni fisici, il laboratorio in cui venivano svelati i misteri che avvolgevano fenomeni comuni ma oscuri, come l’elettricità e il magnetismo, la fotosintesi e la generazione delle specie, la dinamica e la statica dei corpi.
Fu Lavoisier che organizzò, già dal diciottesimo secolo, un modello di ricerca che non prevedeva soltanto la condivisione delle strutture di sperimentazione, ma anche il confronto delle idee. Con lui la ricerca sperimentale cessò di essere attività di volenterosi dilettanti e innocui autodidatti per diventare un’attività molto costosa, che richiedeva apparecchi di altissima precisione e di grande complessità, strumenti di misura, attrezzature e campioni chimici, un equipaggiamento eccezionale per l’epoca, che anticipò quanto sarebbe avvenuto nel secolo successivo, quando la ricerca scientifica ebbe bisogno di laboratori sempre più attrezzati.
Non più tradizionali anfiteatri delle scuole universitarie, in cui l’insegnamento veniva impartito dalla cattedra, ma spazio orizzontale, dove i ricercatori erano chiamati a partecipare e svolgere un ruolo attivo: Lavoisier introdusse l’abitudine di incoraggiare gli assistenti a pubblicare e firmare i loro contributi con il proprio nome, una prassi che poi venne ripresa con successo agli inizi del diciannovesimo secolo, da Gay-Lussac al politecnico di Parigi e da Liebig alle università di Giessen e di Monaco. Il laboratorio divenne per la fisica e la chimica lo spazio privilegiato della ricerca, il luogo dell’apprendistato scientifico e dell’attività collettiva, l’ambiente in cui la partecipazione e il confronto stimolavano la ricerca e il raggiungimento di risultati originali.
Man mano che questa tendenza si andava accentuando, al tempo stesso l’esigenza di dotare i laboratori di macchine e strumenti sempre più costosi e di disporre di un numero sempre maggiore di ricercatori ha reso necessario, a partire dalla fine del diciannovesimo secolo, un coinvolgimento sempre più diretto dell’industria. E soprattutto un rapporto sempre più stretto tra i laboratori della scienza e l’industria bellica.
Noi oggi assistiamo, comodamente seduti davanti alla televisione, ai bombardamenti della guerra preventiva, guardiamo l’orrore in diretta e poco ci scandalizziamo davanti alla distruzione di città millenarie e al massacro di civili incolpevoli, ma furono le armi da fuoco a segnare un passaggio decisivo della storia europea, e piuttosto che l’impiego delle grandi armate, fu sufficiente l’uso dell’archibugio e del cannone ad annientare civiltà ben organizzate, come quella dei Maya e degli Incas.
Ed è stato nei laboratori della scienza e della guerra che invenzioni, come quella della polvere da sparo, si sono via via integrate a teorizzazioni scientifiche, come quella del moto dei proiettili; la produzione industriale di metalli, come il bronzo e il ferro, per creare armi da fuoco e armature, ha fatto seguito al progresso di macchine militari per opera di Leonardo e degli ingegneri; i progressi della metallurgia e della chimica, da cui nacquero armi che accrebbero la dimensione dello sterminio, si sono avvicendati ai trattati di balistica, in cui era la matematica a farsi fondamento delle applicazioni strategico-militari; la costruzione di macchine e congegni militari si è aggiunta a trattati, come quello di Galileo sulle fortificazioni e sull’architettura militare; e l’uso militare dei palloni aerostatici ha lasciato il passo allo sviluppo di sistemi di comunicazione innovativi, come il telegrafo ottico, che si rivelò decisivo per il coordinamento degli spostamenti delle armate.
Passo dopo passo, si giunse al disegno di Napoleone di inseguire un’alleanza sempre più stretta e feconda tra l’espansionismo militare e i progressi della scienza: scienza e guerra presero a viaggiare insieme, un viaggio da cui scaturì un’alleanza che negli anni successivi avrebbe dato ancora molti risultati, micidiali.
Ne è risultata quella che non ha torto Gino Strada a definire “la più grande vergogna della specie umana”, una specie talmente poco sviluppata da non riuscire ancora oggi ad incentivare, dopo millenni di storia, laboratori di scienza che non siano quelli dell’autodistruzione.
Come si poteva pretendere che la funzione emancipatrice della scienza e della tecnologia mitigasse, e in un certo qual modo giustificasse, la brutalità della conquista militare e della guerra?
Andò modificandosi il rapporto tra scienza e potere. Mentre la scienza ufficiale rivelava la sua indispensabilità per il potere politico, furono le circostanze storiche, politiche e soprattutto militari, ad offrire l’occasione favorevole allo stabilirsi di una saldatura fra scienza e politica. Ma fu anche la fine della neutralità della scienza.
Forse questa non è mai stata neutrale, e non mi riferisco all’uso della scienza, che ovviamente dipende da coloro che, controllando le risorse, hanno il potere. Mi riferisco alla scienza stessa, alle sue direttrici di ricerca, ai suoi paradigmi, ai suoi stessi progressi. Dico, con Marcello Cini, che la scienza non è capace di percorsi inequivocabili, lineari, unidirezionali, in quanto essa è storicamente determinata, influenzata com’è dal contesto economico, politico, culturale.
E, infatti, furono le guerre, insieme alle scoperte geografiche e innumerevoli altri elementi esterni e circostanze storiche, a spingere stati e nazioni a servirsi dei saperi tecnici e, poi, anche di quelli scientifici.
Fidandosi più degli scienziati e dei tecnocrati che degli “ideologi”, Napoleone ridimensionò l’egemonia culturale esercitata fino allora dalla teologia, dalla giurisprudenza e dalla filosofia; pienamente consapevole del valore strategico delle scoperte scientifiche e delle loro applicazioni, volle una riforma dell’ordinamento delle scuole militari - con l’école polytecnique in testa - per rispondere alle rinnovate esigenze dell’Impero e delle sue guerre di conquista.
Una volta accreditata, dunque, la funzione strategica della scienza, venne anche la sua perdita di autonomia e i laboratori contribuirono a sottrarle neutralità.
Venne la grande guerra del ventesimo secolo, il primo conflitto armato in cui l’applicazione dell’innovazione scientifica e tecnologica sul campo di battaglia si rivelò decisiva. I laboratori della scienza si trasferirono sui campi di battaglia e la guerra diventò un laboratorio di verifica delle acquisizioni scientifiche più avanzate.
Questo sono stati i laboratori della scienza. Non lo dico soltanto pensando all’uso del sottomarino per la conquista dei mari o dello Zeppelin per la conquista del cielo, ma anche all’impiego dei gas asfissianti nella guerra di terra. Tra i risultati delle nuove applicazioni della ricerca, la più spettacolare, e tragica, fu senza dubbio l’introduzione delle tecniche di guerra chimica: per sviluppare nuove armi e nuovi esplosivi, molti chimici tedeschi furono ingaggiati dagli alti comandi dell’armata, già dal 1914. Furono chimici industriali e chimici teorici che proposero di riempire i proiettili da mortaio di una miscela di gas asfissianti, l’arma venefica usata ad Ypres, sul fronte belga, nel 1915.
Non fu scienza al servizio dell’uomo! In virtù della supposta neutralità della scienza, gli scienziati ormai risolvevano qualunque problema strategico fosse sottoposto dai comandi militari. La scienza appartiene “all’umanità in tempo di pace, ma alla patria in tempo di guerra”, fu l’opinione aberrante del chimico teorico Fritz Haber, ma l’atteggiamento era largamente condiviso dagli scienziati, e non solo tedeschi, se il rettore dell’università di Harvard, James Bryant Conant, un chimico americano, si impegnò dal 1917 a svolgere per il governo ricerche militari sull’uso dei gas tossici nei campi di battaglia.
Dopo la prima guerra mondiale, scienza e tecnologia trovarono nei governi un sostegno più deciso, la crescita degli investimenti in ricerche molto costose si fece esponenziale e non fu più possibile frenare la perdita progressiva di autonomia e di neutralità per la scienza.
Se non ci fosse stato, nella storia del ventesimo secolo, un tale colossale dispendio di risorse, anche finanziarie, quante tragedie sarebbero state risparmiate all’umanità, quante sofferenze come quelle patite dai popoli africani! Tribù e organizzazioni di guerriglieri non sarebbero state foraggiate in armi dai paesi ricchi. La storia postcoloniale dell’Angola e di molti altri paesi sulla terra è esemplare: armi in cambio di diamanti, armi in cambio di petrolio, armi in cambio della destabilizzazione dell’area. Quante crisi di miseria, fame, sete, malattie si sarebbe evitate!
La tendenza alla crescita degli investimenti e all’aumento delle spese militari si realizzò pienamente negli Stati Uniti, negli anni precedenti la seconda guerra mondiale. L’university of California radiation laboratory fu creato a Berkeley nel 1930 dal fisico americano Ernest Orlando Lawrence, finalizzato alla realizzazione del ciclotrone, per il bombardamento dei nuclei atomici, i cui principali beneficiari dovevano essere la cura del cancro, la produzione di energia e l’industria chimica. Diventò la palestra di una delle migliori scuole di fisica atomica e fu preso come modello dai laboratori di ricerca nucleare istituiti durante la mobilitazione generale che seguì il bombardamento di Pearl Harbour nel 1941.
Oggi sappiamo che lo scoppio della seconda guerra mondiale non trovò impreparata la comunità scientifica: diversi laboratori erano da tempo impegnati a risolvere problemi direttamente o indirettamente connessi alle strategie militari. Non potrebbero spiegarsi altrimenti le realizzazioni tanto di macchine sofisticate, il radar o la macchina di Turing per la decifrazione dei linguaggi cifrati, quanto di aerei da bombardamento, razzi ed altri ordigni. Ma fu dopo l’attacco dei giapponesi a Pearl Harbour che la sempre più stretta collaborazione tra scienziati e militari cancellò ogni residuo di credibilità alla tradizionale immagine di neutralità che aveva caratterizzato la scienza e che, almeno dal diciassettesimo secolo, s’era rivelata falsa.
La costruzione della bomba atomica costituì il passaggio cruciale, oltre il quale la scienza acquisì un’importanza politica e strategica quale mai aveva avuto in precedenza. Era stata la scoperta della radioattività nei primi anni trenta a dare l’avvio, in Europa e in prestigiosi laboratori degli Stati Uniti, a ricerche sperimentali intensissime sullo studio della struttura atomica di alcune sostanze, rendendo concreta la possibilità di utilizzare grandi quantità di energia atomica derivate dall’uranio e costruire un ordigno il cui potenziale distruttivo sarebbe stato molto superiore a qualsiasi esplosivo conosciuto.
Tutti reclutati, Fermi e gli scienziati, impegnati nei vari segmenti della ricerca sulla radioattività, furono messi a lavorare nel laboratorio segreto di Los Alamos, nel New Messico, a quella che, dopo il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, la Casa Bianca definì “la più grande realizzazione della scienza organizzata della storia”. Con Robert Oppenheimer gli scienziati ammisero che con la bomba essi “avevano conosciuto il peccato” e frantumato in poco meno di mezza giornata la millenaria immagine della scienza intesa come sapere neutrale e idealmente impegnato nella ricerca della verità. E soprattutto si è rivelata nel ventesimo secolo l’utilità della scienza nel favorire la doppia natura del militarismo: la sua funzione aggressiva, da un lato, che tende alla vittoria e all’annientamento del nemico, e la sua funzione economica, dall’altro, che con la spesa pubblica militare mira a sostenere la produzione e il prodotto interno lordo dei gendarmi della terra e a fronteggiare le ricorrenti crisi di sovrapproduzione del capitalismo. Nei loro saggi scientifici, gli economisti e i ricercatori universitari americani hanno cominciato da tempo a quantificare la crescita - e con effetto duraturo - del prodotto interno lordo, determinata dai dollari dati al Pentagono ad incrementare le spese per la difesa militare.
La maschera è caduta!
In una spirale senza fine, la guerra genera altra guerra. Scriveva Mao Tse Tung: “Siamo per l’abolizione della guerra, non vogliamo la guerra. Ma la guerra può essere abolita solo con la guerra. Perché non vi siano più fucili, bisogna impugnare il fucile”.
Nel ventunesimo secolo le guerre si combattono su più fronti. Ci sono quelle provocate dal brutale modello economico proposto dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, un vero laboratorio dove si sperimentano forme inusuali di guerra: è guerra, perché le privatizzazioni e le deregolamentazioni uccidono spingendo in alto i prezzi dei beni di prima necessità, l’acqua e le medicine, e in basso i prezzi dei prodotti primari dell’agricoltura ed anche quelli del caffé, e mettendo in grave difficoltà i popoli poveri del mondo; guerra, perché chi resiste e si rifiuta di scomparire viene arrestato, picchiato e ucciso; guerra, perché è quella dichiarata che ha inizio quando questa repressione a bassa intensità non riesce a spianare la strada alla liberalizzazione delle multinazionali.
E, prima dei bombardamenti, c’è sempre l’embargo che strangola popolazioni inermi. L’Iraq era un paese colto ed evoluto, non era così povero, nonostante l’oppressione di Saddam. A Baghdad, scrive il dottor Strada, si facevano complicate operazioni di chirurgia cardiaca, e ancor oggi c’è una preziosa società civile che l’occupazione militare annichilisce.
Poi, ancora altre forme sotterranee di distruzione intervengono a completare l’opera delle guerre, le mine antiuomo, le mine giocattolo, studiate per mutilare: un lungo strascico di sangue dopo la fine ufficiale dei conflitti, quando bambini e donne, pastori e contadini, vengono dilaniati dalle mine disseminate a milioni nei luoghi di vita e lungo le rotte della transumanza. Questo accade in Afghanistan e nell’Iraq, questo ho visto in Angola. Non è difficile immaginare – sapendo che è tutto maledettamente vero – un ingegnere efficiente e creativo, seduto alla scrivania a fare bozzetti, a disegnare la forma dei pappagalli verdi, scrive Gino Strada. E poi, un chimico, a decidere i dettagli tecnici del meccanismo esplosivo, e infine un generale compiaciuto del progetto, e un politico che lo approva, e operai in un’officina che ne producono a migliaia, ogni giorno mine di fabbricazione anche italiana.
È vero, non si può non essere d’accordo con Beretta, che oggi, strumenti, macchine, calcolatori, laboratori sempre più complessi costituiscono i prerequisiti di qualsiasi ricerca scientifica d’avanguardia, costringendo così lo scienziato ad interagire con il mondo della tecnologia, e soprattutto dell’industria. La realizzazione del progetto Genoma ha messo in luce la massiccia presenza dell’industria privata nella ricerca. I principali istituti mondiali nella ricerca spaziale o nelle biotecnologie avanzate sono enormi sistemi tecnologici dove lavorano migliaia di ricercatori specializzati e dove si realizzano esperimenti di enorme complessità tecnica. Sono laboratori necessari al progresso della scienza.
Ma contribuiscono a renderla autonoma?
Altri laboratori possono liberare scienza e tecnologia dalla dipendenza strategica dagli ingenti capitali e dallo sviluppo del commercio nel mondo globalizzato. Sono i laboratori della pace e della cooperazione internazionale, quelli della solidarietà e degli interventi umanitari per salvare le vite di popolazioni deboli e precarie, quelli della lotta alla malaria, all’aids, alla tubercolosi. Vi lavorano i costruttori di pace, per sanare i conflitti, por fine alle tante guerre civili, vincere carestie ed epidemie, combattere la malnutrizione e la sete. Sono i laboratori per il diritto all’acqua, come bene finito e bene comune, per lo sviluppo sostenibile e per la tutela dell’ambiente, i laboratori per lo sminamento di immensi territori devastati dalla stupidità dell’uomo globalizzato. Sono i laboratori dell’emigrazione e dell’accoglienza, del pensiero meridiano, delle università mediterranee che sperimentano nuove forme di convivenza e di scambio, ricercano nuovi modelli economici. Sono i laboratori della complessità, che non è l’opposto della semplicità, ma la straordinaria interdipendenza tra le parti di un sistema, e l’irriducibilità dei livelli superiori di aggregazione alle proprietà dei livelli inferiori. In questi laboratori si sperimentano intuizioni e pratiche, che oggi vengono sistematizzate in nuove teorie, culture capaci sia di contestare l’egemonia positivista, che afferma la scienza come verità univoca e metastorica, sia di contrastare la tendenza a rifiutare il progresso scientifico e tecnologico in nome di un umanesimo superstizioso e antimoderno. Qui, dove i bisogni sono più acuti, occorrono amore disinteressato per la scienza, grande curiosità intellettuale, gusto per l’avventura umana, tutto ciò che ancora può animare scienziati disinteressati e ricercatori entusiasti.
Con questi laboratori, la scienza non può più far paura: sono i diversi fondamentalismi ad avere paura della scienza. Le società, i popoli hanno invece un grande bisogno della scienza, sempre più necessità degli altri laboratori della scienza. Sono i laboratori della riattivazione di ospedali in situazioni estreme, sono gli ospedali di guerra e le strutture di salute, dove bisogna essere rudi, di poche parole e molti fatti. In quei luoghi umani violati e negati, sono loro che costruiscono quella che Moni Ovadia definisce l’umanità possibile del futuro, l’unica possibile: e lo fanno impazienti di trovare, nel Rwanda ferito a morte, un posto dove iniziare a operare i tanti feriti che aspettano; affannandosi a risolvere problemi pratici in condizioni estreme, a trovare dove dormire, procurare cibo, acqua e tutto il resto, e poi a rimettere in funzione ospedali abbandonati, riparare gli ampi squarci nel soffitto del blocco operatorio; e, per questo, recuperare travi di legno e tegole da altri edifici crollati, e ancora scavare due buche nel giardino davanti alla corsia chirurgica perché facciano da inceneritori; chiedersi se è davvero impensabile mettersi a costruire un ospedale sotto i bombardamenti, in una città fantasma, esposta ai razzi talebani; e, mentre si lavora a costruire un ospedale, attrezzare dei rifugi che mettano al riparo da attentati; e passare mesi a organizzare il reparto di chirurgia in Perù, a costruire l’ospedale di Emergency nel Kurdistan iracheno, a decidere, mentre infuria la guerra, dove mettere le prese elettriche, dove ci vogliono i ventilatori, come riparare le autoclavi e come schermare la sala di radiologia per evitare le radiazioni; in situazioni estreme, quando non ci sono mezzi per riparare le strade o per fornire l’elettricità, né cherosene per riscaldare scuole e ospedali, trovare una soluzione per smaltire i rifiuti e impedire che il sistema idrico vada compromesso; scegliere un grande prato dove c’è la pista in disuso dell’aeroporto, per aprire un ospedale da campo; garantirsi che non vi siano mine intorno, spianare, costruire latrine, portare acqua ed elettricità, piantare tende, organizzare la farmacia e la cucina, l’inceneritore per i materiali contaminati, recintare il campo; e poi, organizzare il personale di pulizia, le guardie, i medici e gli infermieri, un sistema di trasporto degli ammalati; abituare i bambini ad usare le stampelle; mettere su una tenda davanti all’ingresso dell’ospedale della Croce rossa internazionale, per curare i feriti lievi e sgravare il pronto soccorso da decine di casi ogni giorno; lavorare diciassette ore al giorno e non dirsi mai stanchi. Salire fino a cinquemila metri per tentare di passare in Afghanistan, quando tutti si preparano ad evacuare, e abbandonano il campo persino l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, il Programma alimentare mondiale, l’Organizzazione mondiale della sanità, il Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia, l’Ufficio delle Nazioni unite per il coordinamento delle attività umanitarie.
Da più di dieci anni, l’ECHO, l’Ufficio per gli aiuti umanitari della Commissione europea, è impegnato a intervenire in vari paesi del mondo, per rispondere all’urgenza delle crisi umanitarie, conseguenze di conflitti armati o di catastrofi naturali. C’è bisogno qui della ricerca rigorosa e dell’impegno della cultura scientifica. Qui c’è bisogno di investimenti, nei laboratori del sapere scientifico e delle esperienze di base, del sapere vissuto e del pensiero critico; nei laboratori dove si sperimenta un altro sistema di pensiero, per lavorare in maniera efficace nel mondo reale. E chiedersi dove siano finiti i laboratori di “ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine”, previsti dalla legge n. 106 del 1999 sulla messa al bando delle mine antipersona, e come si incrementi l’impegno dichiarato dal parlamento italiano a costruire i “laboratori di produzione di informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari”.
Piuttosto che continuare a barattare qualche punto del Pil dei paesi ricchi con la distruzione di interi paesi nel mondo, occorre investire risorse finanziarie per sostenere i laboratori che diffondono il diritto alla salute, e insieme la solidarietà, il rispetto, la giustizia. È qui l’impegno ad aiutarli a superare le loro attuali difficoltà: sono i laboratori europei del sostegno agli sfollati e ai rifugiati, in Afghanistan; quelli della riattivazione urgente delle infrastrutture idriche, in Burundi; dell’assistenza a centri ospedalieri, in Uganda; del soccorso di emergenza delle vittime di condizioni climatiche estreme, nel Tibet; di aiuto alle vittime delle guerre civili, in Sudan; dell’accesso all’acqua corrente, in Eritrea; di riapertura di centri sanitari e di accesso alle cure mediche, nella Serbia e nel Montenegro; di aiuto alle vittime di un interminabile conflitto interno, in Columbia; di accesso all’acqua potabile per evitare epidemie e malnutrizioni, in Tadjikistan; di accesso alle strutture sanitarie e cure mediche, nella Repubblica democratica del Congo; di aiuti di emergenza alla struttura sanitaria rurale, nello Yemen; di aiuto all’educazione di gruppi sociali vulnerabili, in Albania; di riparo per le vittime di catastrofi naturali, in India; di lotta contro la penuria d’acqua, nei territori palestinesi; di aiuto alimentare, nell’ex repubblica jugoslava di Macedonia; di intervento di emergenza per il sostegno alle attività agricole, nello Sri Lanka; di aiuto sanitario d’emergenza per la maternità, in Algeria; di riapertura e sostegno ai servizi medici, in Angola.
Li ho visti al lavoro con i miei occhi, i volontari che provano a “viverci in mezzo”, come loro stessi dicono, nel lavoro diretto sul territorio, rendendosi utili nella ricerca di mezzi per migliorare le condizioni igieniche di reparti provvisori e precari, potenziare il servizio idrico-sanitario, con una riservatezza che sconfina nell’ossessione di non apparire. In Angola ho visto con i miei occhi che aveva ragione John Fitzgerald Kennedy a dire che “la guerra contro la fame è in realtà una guerra di liberazione dell’umanità intera” e va combattuta senza armi e solo con le nostre mani e i nostri corpi, a costruire laboratori di pace.
È questo il momento di riempire di umanità il lavoro dell’ingegneria. Proprio come fanno, insieme a Gino Strada ed Emergency, le tante altre organizzazioni non governative esistenti al mondo, presenti nei tanti paesi in cui non cessano i conflitti armati, dove vale quel che disse Bertrand Russell: “i vantaggi della guerra, se ce n’è qualcuno, sono solo per i potenti della nazione vincente; gli svantaggi ricadono sulla povera gente.”
Magnifico rettore, chiarissimi colleghi, permettetemi di rinnovare un antico rito delle università medievali e di richiedere formalmente per il dottor Gino Strada, chirurgo d’urgenza e personalità ricca d’ingegno e di capacità creative, il conferimento della Laurea Honoris Causa in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio.
| |
|
maggio - agosto 2004