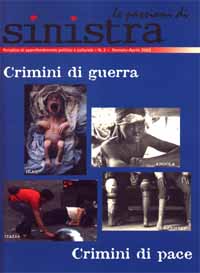I molti volti della battaglia euro-atlantica |
Nel corso dell'orazione ufficiale dedicata a tutti i caduti della battaglia di El Alamein, il presidente Ciampi ha solennemente affermato: "mai più la guerra fra noi".
Si tratta di una dichiarazione in piena sintonia con l'operazione di ricostruzione d'una sorta di "orgoglio nazionale", nel più ampio contesto di quella promozione ideologica dell'europeismo che con intensità crescente accompagna i tempi e le dinamiche della formazione dell'insieme continentale imperialistico europeo.
L'auspicio, però, al di là della traboccante retorica e del non certo minor contenuto utopistico, porta già in sé un inquietante interrogativo. Perché, anche ammesso possa valere per "noi", gli europei, nulla assicura riguardo al rapporto con gli "altri".
Il fatto che le potenze del Vecchio Continente uniscano le loro forze nell'Uníone Europea non è la fine della violenza dello Stato-nazione, ma ne è la moltiplicazione secondo la gigantesca scala continentale. Anche se certamente, in quel complesso e dinamico campo di forza che è l'imperialismo unitario, la dinamica del duopolio euroatlantico, la capacità d'azione comune e quella di influenza reciproca tra USA ed Europa, sono decisive per il complesso delle relazioni globali. Come in ogni grande battaglia, sarà coinvolta una molteplicità di fronti, sui quali già oggi maturano evidenti gli elementi di confronto e di contrasto.
Nell'esaminare i contenuti della Dottrina Bush emergono due aspetti. In primo luogo, è evidente che con la fine della "guerra fredda" gli Stati Uniti si impongono come prima potenza, priva di sfidanti strategici e con una forza militare senza precedenti e senza paragoni. Tuttavia, e questo sarebbe il secondo aspetto, la dimensione militare della forza strategica viene considerata distintamente dagli altri attributi della potenza nazionale, rispetto ai quali la condizione americana è collocata su di un gradino inferiore: quello di una grande influenza economica e politica, anziché di un primato incontrastato.
Come esiste un ineguale sviluppo economico, esiste anche un ineguale sviluppo politico e militare. Come la storia ci ha più volte dimostrato possono coesistere, anche per periodi di tempo non necessariamente brevi, condizioni di forza economica cui non corrispondono analoghi livelli di potenza politico militare. Abbiamo visto la presenza di "giganti economici" a lungo costretti al rango di "nani politici". Cosi come ci è capitato di assistere per decenni - è il caso dell'ex URSS - ad una sovraestensione sul piano militare non fondata su un corrispondente potenziale economico.
Sul piano dei rapporti internazionali è indubbio che la fase in corso rifletta emblematicamente questa condizione di non corrispondenza.
Per quanto storicamente declinante la potenza statunitense può contare su un dispositivo militare che rimarrà a lungo ineguagliato. Più ancora, l'obiettivo del mantenimento, se non addirittura del consolidamento di tale indiscussa superiorità, è una risposta al crescente multipolarisrno, come reazione all'emergere delle vecchie e delle nuove potenze sull'arena della contesa internazionale.
Oggi quell'intento è reso manifesto.
Sul "New York Times" la dottrina Bush è cosi commentata: "Il Presidente non ha alcuna intenzione di consentire a qualunque potenza straniera di recuperare l'enorme vantaggio conquistato dagli Stati Uniti con la caduta dell'URSS più di un decennio fa. Le nostre forze armate saranno forti abbastanza da dissuadere i potenziali avversari dal perseguire una politica di riarmo che speri di sorpassare o di eguagliare la potenza degli Stati Uniti".
Gli Stati Uniti reagiscono oggi alla dinamica generata da Cina ed Europa, ossia al medesimo processo multipolare cui risposero negli anni Ottanta, alzando la posta strategica con un riarmo che sull'Atlantico mira a contrattare da posizioni di forza la trasformazione dell'alleanza con l'Europa e sul Pacifico intende condizionare, indirizzare o utilizzare l'ascesa della Cína.
Se si guardano i numeri, la non corrispondenza, l'asimmetria esistente tra i pesi economici e quelli militari appare in tutta la sua evidenza.
Secondo il piano di rilancio della spessa bellica, presentato per il 2003 dal presidente Bush al Congresso, il divario oggi esistente sarebbe destinato a crescere. Si prevedono, infatti, 48 miliardi di dollari di aumento della spesa militare, con uno stanzíamento totale di 379 miliardi di dollari, attorno ai livelli del 1984. Per i prossimi cinque anni, è pianificato un aumento di altri 72 miliardi, con una soglia fínale di 451 miliardi. Si tratterebbe del più alto livello assoluto mai toccato nel dopoguerra, superiore cioè - in dollari del 2002 - alle tre punte toccate dopo la Guerra di Corea (442 milíardí), durante la Guerra del Víetnam (449 miliardí) e con il riarmo di Ronald Reagan (428 míliardí).
Nel 2000, Washington aveva circa il 22% dei prodotto mondiale e il 36% della spesa bellica. Con il nuovo stanziamento si avvicinerebbe al 45%, ossia ad una incidenza doppia del dispositivo bellico rispetto alla forza economica.
Sino al 2000, nella ripartizione della forza economica e della spesa militare, se gli Stati Uniti avevano meno di un quarto del prodotto mondiale e più di un terzo della spesa, l'Europa aveva all'ingrosso il 20% del prodotto e il 19% della spesa, dispersa però in quindici forze separate.
La non corrispondenza tra il potenziale economico e quello militare è dunque evidente. In questa stessa sfasatura è contenuto il più che prevedibile corso degli anni a venire.
Tanto nel Vecchio Continente come nell'epicentro asiatico ci sono dei potenziali inespressi, che alla lunga non potranno che manifestarsi, anche se con tempi e modi che allo stato non è semplice prevedere.
In Asia vi era il maggiore squilibrio: il Giappone aveva rispettivamente il 7,3% del prodotto mondiale e il 5,5%, della spesa bellica; la Cina l'11,6% contro il 5%; l'India il 4,6% contro l'l,7%. Mentre Mosca rimane ancora oggi sovraesposta, con un peso economico mondiale del 2,5% e una spesa del 7,3%.
I due processi cruciali sono il potenziale oggettivo per il riarmo in Asia e la centralizzazione delle forze in Europa.
Se Washíngton alza la posta della contesa, sino a ipotecare più di due quinti della spesa bellica mondiale, è per anticipare o condizionare l'Europa e le potenze dell'Asia.
La contesa politica sui bilanci militari ha lo stesso segno della "guerra preventiva" nel Golfo.
Bastano e avanzano questi numeri per cogliere chiaramente il senso delle continue e crescenti pressioni che, da ogni parte d'Europa, si levano ad invocare una pronta e decisa azione per recuperare il ritardo. Basti pensare, per esempio, al Progetto Galileo nel campo delle comunicazioni satellitari. Sicuramente uno dei tantissimi passi che saranno richiesti da un "cammino di pace" che è appena agli inizi.
Naturalmente gli sponsor socialimperialisti non mancano.
Con il solito zelo da "più realista del re", Marco Minniti, ex sottosegretario alla difesa nel governo D'Alema, sul "Foglio" del 25 ottobre, mentre richiama al realismo i sostenitori del "pacifismo integrale", bacchetta la linea del governo Berlusconi per la sua "piccineria" sul piano della difesa: "Se si vuol contrastare l'unitateralismo americano… (serve) ... una Maastricht della difesa: dopo l'11 settembre gli USA hanno aumentato il budget della difesa di 70 mila miliardi di vecchie lire, che è la cifra di tutto il budget dell'intera Europa. E I'ltalia è pure ultima. C'è in questo un elemento di piccineria. ... la politica di bilancio delle forze armate è al limite del collasso. Un bilancio del genere non l'avrebbe fatto nemmeno un monocolore di Rifondazione".
Il volto militare della battaglia euroatlantica non riflette certo quello del confronto economico finanziario tra le due sponde dell'Oceano.
Scriveva Arrigo Cervetto, nel novembre dei 1990, a poche settimane dalla riunificazione tedesca e alla vigilia della guerra combattuta dagli USA nel Golfo, anche per rispondere al multipolarismo incalzante: "Secondo l'economista Paul Samuelson, gli Stati Uniti, ai quali oggi va attribuito il 20% della produzione mondiale, semplicemente non possono pretendere di esercitare nel mondo lo stesso ruolo dominante che esercitarono dopo la seconda guerra mondiale, quando da essi proveniva il 40% della produzíone mondiale. Continuiamo a mantenere una vasta capacità militare in angoli lontani del mondo, ma Paut Kennedy, lo storico che dello studio dell'ascesa e della decadenza degli imperi ha fatto la sua specialità accademica, ipotizza che, cosi facendo, cadremo vittime della classica sindrome di "iperespansione imperiale" che ha condannato alla rovina grandi potenze in tutto il corso della storia".
Che quella battaglia sia in corso è impossibile negarlo. Altro è dire quale sarà l'esito, e quali saranno i tempi di questo confronto, con tutti i suoi corollari strategici. A partire, in primo luogo, dal passaggio dai tempi del contenimento e della deterrenza a quelli della guerra preventiva.
Soffermiamoci sul mutamento che, nel corso di questi decenni, con un'accelerazione via via crescente, ha trasformato nel profondo il potenziale economico tra le due rive dell'Atlantico.
Il campo dell'esportazione di capitali, un contrassegno tipico dell'imperialismo, risulta al riguardo estremamente indicativo.
Assieme ai molti tratti che concorrono a fare dell'attuale congiuntura internazionale un momento di definizione per la bilancia globale, lo sgonfiamento della "bolla" americana e gli effetti a catena che ha prodotto anche sull'andamento del ciclo (sui cui esiti permane più che mai sovrana l'incertezza) avvengono all'interno di un quadro internazionale per molti versi inedito.
Per la prima volta una crisi di grandi proporzioni vede una moneta a stazza continentale, l'euro, fronteggiare gli Stati Uniti sui mercati mondiali. Washington pagherà a prezzo più caro tutte le debolezze, avendo meno gioco a scaricarle all'esterno grazie al dollaro nel ruolo di unica moneta intemazionale.
La recessione ha aperto un dibattito sull'ultimo decennio dell'economia americana.
Martin Wolf, editorialista del "Financial Times", delinea un bilancio del ciclo americano concentrandosi sull'aspetto particolare dei conti economici internazionali degli Stati Uniti.
La tesi di Wolf è che l'investimento internazionale netto americano, che nel 2000 ha raggiunto il deficit di 2.187 miliardi di dollari, è insostenibile e nello stesso tempo destinato a crescere a causa della persistente insufficienza del risparmio delle famiglie americane e della tendenza al sovrainvestimento, favorito dalla politica monetaria della Federal Reserve (FED). Wolf ipotizza una via d'uscita svalutazionistica per il dollaro, perché riesca a riequilibrare la sua bilancia commerciale, pur non escludendo una resistenza di anni della condizione attuale. Il deficit americano denunciato da Wolf quantifica la differenza fra tutte le attività possedute all'estero dagli americani (7.190 miliardi di dollari nel 2000) e tutte le attività possedute negli Stati Uniti dal resto del mondo (9.377 miliardi).
Un'altra fonte - Wolf ha attinto ai dati forniti dal Dipartimento del Commercio statunitense - quella della FED, calcola le attività americane nel mondo, nel 2000, in 5.286 miliardi di dollari e quelle estere negli USA in 7.369 miliardi, con un deficit di 2.083.
Per quanto riguarda i dati del 2001, la FED rileva che le attività estere degli USA salgono a 5.571 miliardi, quelle straniere negli USA a 8.191, con un saldo negativo di 2.620. In un solo anno la posizione debitoria degli USA è peggiorata del 25%, passando da un quinto a un quarto dei PIL americano.
Un rapporto che nel tempo ha finito con il capovolgersi, come certificano gli stessi dati di lungo periodo della FED.
Le serie storiche della FED dei flussi dei capitali e delle consistenze finanziarie estere nette permettono di ricostruirne la dinamica. In trentasei anni, dal 1946 al 1981, il flusso dell'investimento estero netto americano è stato di segno positivo, salvo che in sei anni. Nei venti anni successivi, dal 1982 al 2001, la serie diventa tutta negativa (eccetto il 1991), con un'accelerazione vertiginosa nell'ultimo periodo. Nei sedici anni, dal 1982 al 1997, l'investimento estero netto americano ha cumulato un deficit di 1.218 miliardi di dollari; il raddoppio a 2.545 miliardi di dollari ha richiesto appena quattro anni (1998-2001).
Nel quarantennio 1961-2000, gli assets (attività negli USA da parte del resto del mondo) sono cresciuti di 189 volte ad un tasso medio annuo de 14%, mentre gli assets americani all'estero si sono moltiplicato di 78 volte, con un ritmo annuo dell'11,5%. I redditi delle attività estere negli USA si sono moltiplicati di 300 volte ad un tasso di crescita annuo del 15,3%, mentre i redditi degli americani dai loro assets esteri si sono moltiplicati per 76 volte, ad un tasso medio annuo dell'11,4%.
Ciò significa certamente che il riarmo statunitense è stato finanziato dal capitale internazionale. Cosa del tutto in linea con la logica della ricerca dei profitto, sempre largamente indifferente al modo in cui questo realizza.
Quei capitali, affluiti copiosamente negli USA per anni, non vi si sono riversati certo per beneficenza, ma perché attratti dai più alti tassi di interesse praticati dalla FED e dalle politiche di tax cut e di deregulation che ne favorivano l'impiego in terra americana.
Più ancora, la realtà che si è affermata ha finito con il demolire senza appello la falsa rappresentazione del rapporto tra "impero" e "colonie".
Se si concentra l'attenzione sul rapporto USA/UE, infatti, l'accelerazione della penetrazione europea è persino sorprendente
Il Dipartimento dei Commercio pubblica, per gli anni '90, i dati degli investimenti diretti annuali negli USA provenienti dall'Unione Europea e dei loro relativi redditi, solo negli ultimi otto anni la quota europea passa da metà a 4/5 degli investimenti diritti totali negli Stati Uniti. Praticamente gli investimenti europei si moltiplicano per sei volte, mentre i redditi triplicano. E per di più, questa crescente penetrazione si è verificata prima della discesa in campo fisica della moneta unica europea. Tanto che è indubitabile il mutamento dei rapporti relativi attraverso l'Atlantico ed il Pacifico.
Proseguendo lo studio, tra il 1980 e il 2000, il rapporto tra gli investimenti diretti dei mondo negli USA e di quelli USA nel mondo è passato da 1/4 alla parità.
Per l'Europa, in particolare, il salto è stato ancora più marcato: vent'anni fa aveva in USA la metà degli investimenti americani nel Vecchio Continente; nel 2000 il rapporto si era invertito: l'UE accoglie il 46% degli investimenti diretti americani nel mondo, ma rappresenta il 65% degli investimenti diretti che da tutto il mondo si sono collocati negli Stati Uniti.
Ciò avviene in un quadro di rafforzamento poderoso degli investimenti diretti mondiali cumulativi della Unione Europea che, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, nel ventennio considerato crescono da 213 miliardi di dollari a 3.111, mentre gli Stati Uniti passano dai 220 dei 1980 ai 1.245 niliardi di dollari del 2000.
L'UE cresce di 15 volte, gli USA di 6.
Il senso è sin troppo chiaro. Semmai, per sovrappiù, si può aggiungere che parallelamente si è assistito ad un costante e continuo processo di penetrazione dei capitale bancario europeo in terra statunitense; tanto che, nel 2001, le banche estere, che ancora nel 1973, non superavano il 13% di tutte le attività della piazza di New York, erano arrivate al 54% ( 910 miliardi di dollari su 1693 complessivi). In questo scenario la componente europea ha costituito il motore dell'"avanzata straniera". Nei sei anni 1995/2001 le attività bancarie negli USA dell'Unione Europea sono cresciute da 403 a 791 miliardi di dollari, la loro quota sugli assets totali delle banche commerciali negli USA è salita dall'8,9 all'11,7% e dal 40 al 60,5% degli assets totali bancari stranieri negli Stati Uniti.
Tra il 1950 e il 2001 le attività finanziarie americane sono passate da 1.294 a 90.580 miliardi di dollari, moltiplicandosi per 70 volte. Nello stesso periodo, le attività acquisite dal resto del mondo negli Stati Uniti sono aumentate di 470 volte, passando da 17 a 8.192 milirdi.
L'evoluzione del rapporto tra le due grandezze è eloquente.
Questo è certo solo un aspetto dell'ineguale sviluppo in atto tra i grandi insiemi continentali; ma non certo secondario. È forse un aspetto peculiare della fase imperialistica, utile a mettere in evidenza il mutamento profondo tra potenziali economici destinato alla lunga a riflettersi anche sul terreno politico e militare.
Vale al riguardo, anche per le grandi entità sopranazionali in formazione, ciò che caratterizzava la dialettica conflittuale tra gli Stati nazionali nell'analisi sull'imperialismo condotta da Lenin: ."Non si può dividere se non "secondo la forza". E la forza cambia nel corso dello sviluppo economíco. Dopo il 1871 la Germania si è rafforzata tre o quattro volte più rapidamente dell'Inghílterra e della Francía e il Giappone dieci volte più rapidamente della Russia. Per mettere a prova la forza reale di uno Stato capitalistico non c'è altro mezzo che la guerra.
La guerra non è in contraddizione con le basi della proprietà privata ma è il risultato diretto e inevitabile dello sviluppo di queste basi. In regime capitalistico non è possibile un ritmo uniforme dello sviluppo economico né delle singole aziende, né dei singoli Stati.
In regime capitalistico non sono possibili altri mezzi per ristabilire di tanto in tanto l'equilibrio spezzato, all'infuori della crisi nell'industría e della guerra nella politica." (N. LENIN, Sulla parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa, 1915)
Quando, nella sua denuncia della politica imperialistica britannica, J.A. Hobson deve spiegare il motivo della mancata comprensione di una realtà tanto evidente, comincia con il dire: "Come mai l'imperialismo riesce a mascherarsi agli occhi di tutti? Ogni nazione, quando guarda dall'esterno l'imperialismo dei suoi vicini, non s'inganna; gli interessi egoistíci delle classi politiche e commerciali si mostrano chiaramente sovrani, ma nessuna nazione vede i propri difetti".
È sempre così: gli imperialisti sono sempre gli altri. Ieri, per i francesi e i tedeschi, erano gli inglesi. Oggi, nella mistificazione corrente, sono solo gli americani.
Per questo è prima di tutto fondamentale un'opposizione internazionalista all'imperialismo europeo.
* Militante del circolo operaio di Bari / Nella stesura del presente articolo sono stati diffusamente utilizzati gli interventi di Guido La Barbera, pubblicati sul mensile "Lotta Comunista" nel periodo luglio-ottobre 2002.
| |
||
gennaio - aprile 2003