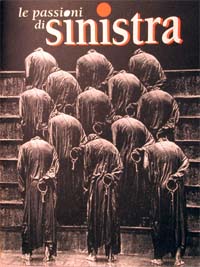Raccontar cantando |
Nei quartieri popolari di Napoli, osserva Daniele Sepe, non si sentono tammurriate, ma musica commerciale, house e dance.
È giustissimo, ma qui vorrei prescindere dalla discussione, pur utile, su cosa debba intendersi oggi per “musica popolare”, per focalizzare l’attenzione sulla canzone tradizionale delle classi popolari del sud Italia. Questo genere nasce in stretta relazione con l’ambiente lavorativo dei suoi autori; autori il più delle volte anonimi, le cui personalità si confondono con la comunità in cui vivono e cantano.
Un verso, una battuta, un movimento della danza, nuovi, hanno sempre, chiaramente, un inventore. Ma questo individuo-autore, che compie il primo passo verso la novità, facendosi portavoce delle istanze del gruppo, resta anonimo; una novità espressiva viene accettata dalla comunità solo se funzionale. L’individuo-creatore resta anonimo, perché culturalmente non è diverso dal resto del gruppo: è, semplicemente, uno che per primo ha colto fermenti nuovi che sono entrati a far parte della vita del gruppo.
Posso fare alcuni esempi. Le pizziche salentine, che sono parte del fenomeno culturale del tarantismo, complesso di musica, canto, danza, lamento e preghiera, rappresentano la risposta della civiltà contadina ai momenti di pericolo, di smarrimento, di “perdita della storia”. Sono un tentativo di esorcizzare le paure tipiche del mondo contadino: la scarsità del raccolto, la precarietà, la dipendenza dai fattori atmosferici, le veglie nei campi, l’insicurezza, i monstra (tarante, serpenti, scorpioni), ecc.
La pizzica è un grido contro la miseria, lo sfruttamento, gli abusi sul luogo di lavoro: Fimmene fimmene ca sciati a lu tabaccu, ne sciati a ddoi e ne turnati a quattu. Ma questa forma culturale, tipica della Puglia meridionale, non si esaurisce nell’ambito contadino. I protagonisti-autori di questi canti e musiche, gli esecutori di queste danze raccontano il malessere della vita ai margini del mondo sviluppato, alla periferia dell’occidente opulento, in una terra emarginata come il Salento. Spesso i protagonisti sono emigranti, giovani che hanno fallito nelle loro speranze, donne depresse per le costrizioni di una società patriarcale, che cercano sollievo in danze frenetiche, sensuali, spesso scomposte e oscene, quasi in un sabba di significato liberatorio.
Similmente, la tammurriata, la tarantella, la villanella sono nel ritmo della vita delle campagne campane e nella venerazione delle loro innumerevoli Madonne, di Napoli e dei suoi santi. Un gruppo storico della canzone popolare napoletana, E Zezi, racconta su ritmi e melodie tradizionali le storie del mondo operaio campano, gli incidenti sul lavoro per mancanza di sicurezza, gli episodi di sfruttamento in quelle cattedrali nel deserto che sono i grandi complessi industriali a Napoli, Pomigliano d’Arco, Solofra, la condanna comune a tante regioni del mezzogiorno italiano, il freno allo sviluppo delle sue risorse naturali, le ferite inferte al suo territorio dai processi di urbanizzazione selvaggia, i danni programmati e taciuti al suo ambiente.
La canzone popolare della Terra di Bari, le tarantelle e le nenie nate nei suoi centri medievali, raccontano storie di artigiani e mercanti, recitano aneddoti di prostitute, vedove e zitelle combattive, narrano di viaggi di marinai su pescherecci e di fatti miracolosi di cui essi sono frequentemente spettatori e beneficiari, descrivono la fatica quotidiana dei contadini alle prese con la produzione e il raccolto, in scenari di ulivi e alberi da frutta, campi di grano e pascoli.
Lo sfondo socio-culturale ha caratteri simili a quello del materano, del foggiano, del molisano e dell’Abruzzo della pastorizia e dei viaggi della transumanza. Sono spesso uno specchio della storia nazionale, che arriva anche in quei paesi.
E arriva anche nei nostri. In una canzone molfettese si ricorda l’arrivo dell’illuminazione elettrica pubblica come un fatto ancora raro e contemporaneamente, con salto temporale di qualche decennio, anche l’uso delle sigarette: a lu pendone d cas stè la lush elettrek, avà passà mmio bbene c l sigarette.
Un’altra racconta di Zì Catarine e della sua disperata ricerca di un marito tra gli artigiani del paese. Spesso protagonisti sono commercianti arricchiti, di cui ironicamente si descrive il contrasto tra l’umile origine sociale e i comportamenti delle classi elevate che essi scimmiottano: u berbend du veccir meng e veve da cavallire; u scarpar … s’ha pust u scollin; la figghie du nghiappachen ten la valisce.
Una canzone diffusa dall’Abruzzo alla Terra di Bari parla delle fatiche dei raccoglitori di grano, pezzing e vespr sott o sol, la schena doele ma la scernat ava passà. Ma il tema della raccolta nei campi non può mancare nelle canzoni molfettesi, e in particolare quella delle olive, data la loro importanza nell’economia cittadina: Uè cummà Uelin, com s’accogghien l’aliv? S’accogghien ad un ad un.
La prostituzione come unico modo per sbarcare il lunario per la moglie di un contadino è il tema di alcune canzoni diffuse a Molfetta e Terra di Bari: Meritem alla pugghie e ì a lu liette, vedimm ci guadegn cchiù denere; nen fasce nudd marit mì ca sì chernut, abbast ca meng e viv e vè vestut. Numerose sono anche le serenate, spesso sarcastiche nei confronti di donne dai tratti non proprio angelici: Metalen ce tin mbitt, nen zò menn me so saìtt; sott o arv d r vermcocc Metalen avì la bott.
Il referente è dunque il popolo umile e basso, il proletariato operaio, contadino e marittimo, il sottoproletariato urbano: quella popolazione dell’Italia meridionale che non è mai stata protagonista di una propria storia comune, succube come è stata del feudalesimo nelle sue forme medievali e moderne, la mafia e il caporalato, vittima del sottosviluppo voluto dal fascismo prima e del paternalismo democristiano poi.
Un abbozzo di identità nazionale contadina sembrò il fenomeno del brigantaggio; infatti storie e inni dei briganti sono frequenti nella canzone popolare meridionale, specie nelle regioni montane di Campania, Lucania e Calabria. Per quanto ingenua, disorganica, a tratti passionale e violenta, facilmente strumentalizzabile, l’esperienza storica dei briganti segnò forse il primo momento in cui i contadini meridionali tentarono una via di “autodeterminazione” e si rivoltarono contro quello Stato che vedevano lontano, estraneo, ostile perché incapace di parlare la loro stessa lingua, che non li comprendeva e che era loro incomprensibile, quello Stato che i contadini di Carlo Levi dicevano si era fermato con Cristo a Eboli. Il brigantaggio insegnò a molti ad alzare la testa, a molti che fino allora avevano concepito il lamento come unica forma possibile di reazione.
È un’esigenza di espressione delle comunità l’atto fondativo della canzone popolare, espressione della propria cultura, del proprio vissuto, tramite i propri mezzi e le proprie regole comunemente accettate. La poesia stessa è espressione popolare. Nasce dal basso, a differenza della filosofia, dell’oratoria, della letteratura politica. Poeti popolari elaborano così un proprio stile, che attinge temi e immagini a legami sociali, rapporti di vita, vicende liete e tristi che si vivono tutti i giorni. I testi sono affidati a cantori e musicisti che li adattano alle loro musiche e li tramandano oralmente di generazione in generazione.
Poeti contadini sono molti degli eroi dell’emancipazione della gente del sud Italia, come Rocco Scotellaro, Salvatore Carnevale e Ignazio Silone, uomini che conquistarono la fiducia dei contadini perché seppero parlare la loro lingua e che pagarono con la vita il loro impegno rivoluzionario contro il padronato, i baroni, la loro lotta contro la mafia, la loro denuncia contro le connivenze col potere politico.
Ma la musica viva è anche contaminazione. La pratica della contaminazione musicale, tipica degli ultimi decenni, ha coinvolto oggi anche il genere della musica popolare. I Mau Mau hanno piegato il dialetto piemontese ai suoni caraibici di cui un’eco è sempre giunta dai porti liguri e d’oltralpe. Qui, da noi, si ripetono appuntamenti importanti come il festival di Melpignano, in cui ormai da anni convengono musicisti popolari salentini con grandi nomi del jazz e della fusion internazionali. E sono spesso ben riusciti i tentativi di sposare la musica elettronica con la pizzica, come quelli esperiti dai salentini Nidi d’Arac e Mascarimirì o dal molfettese Stramonium, al secolo Lillino Salvemini. Le contaminazioni più felici e di successo sono state quelle che hanno unito le nostre musiche “basse” con le musiche popolari di altre regioni del mondo con cui gli autori hanno scoperto dei legami storico-sociali.
A Napoli la 99 Posse e una miriade di altri musicisti attivi intorno ai centri sociali partenopei hanno operato una sintesi tra testi che raccontano l’esperienza sociale del proletariato napoletano, vittima di disoccupazione, sfruttamento, esclusione sociale, e il ragamuffin, la musica che le periferie metropolitane di tutto il mondo hanno mutuato dal reggae giamaicano. Prima ancora Pino Daniele aveva sottolineato il rapporto che lega Napoli agli Stati Uniti tramite gli scambi marittimi tra capitali portuali, cantando in un misto tra dialetto partenopeo e inglese, tra melodie napoletane e blues, la musica dei bassifondi americani, nata tra gli schiavi neri rapiti e importati dall’Africa.
Alla stessa maniera, gli Agricantus hanno mescolato le musiche popolari siciliane con quelle dei popoli del vicinissimo deserto del Sahara, primi fra tutti i Tuareg. E sono significativi anche il folk barese-irlandese di alcune composizioni dei Folkabbestia, il folk barese-rom-slavo degli Ziringaglia, il reggae della barlettana/molfettese Chop Chop Band e dei baresi Suoni Mudù.
Ma la più importante esperienza del reggae italiano appare oggi il Sud Sound System, storica band che esprime, in dialetto salentino, il legame con un’altra terra di miseria e ribellione, la Giamaica, patria della cultura rasta e dell’incredibile propulsore di idee, sogni, speranze che è la musica reggae. Nei testi del Sud Sound System si parla di emarginazione e di disoccupazione: pe trovi la fatìa tocca te sbatti; ogni tantu me chiedu ma ce cazzu so nato a fari; si canta di tossicodipendenza, t’à sciuta bona osce, ma crai? Ma è anche tradizione, festa e speranza, all’inno di lu reggae a nui ni brucia specie se parla de realtà e cultura.
E, ancora una volta, non si rinuncia a Molfetta ad esperimenti simili, come i tentativi fatti negli ultimi tempi dalla posse South Love Vibration, che ha prodotto, col suo brillante leader Zio Pino, una sintesi interessante tra dialetto molfettese e ragamuffin.
Oppure a qualcuno queste sintesi, questi esempi di contaminazione, questi riferimenti dei nostri autori alla cultura internazionale, possono sembrare irriverenti? Discutiamone.
È giustissimo, ma qui vorrei prescindere dalla discussione, pur utile, su cosa debba intendersi oggi per “musica popolare”, per focalizzare l’attenzione sulla canzone tradizionale delle classi popolari del sud Italia. Questo genere nasce in stretta relazione con l’ambiente lavorativo dei suoi autori; autori il più delle volte anonimi, le cui personalità si confondono con la comunità in cui vivono e cantano.
Un verso, una battuta, un movimento della danza, nuovi, hanno sempre, chiaramente, un inventore. Ma questo individuo-autore, che compie il primo passo verso la novità, facendosi portavoce delle istanze del gruppo, resta anonimo; una novità espressiva viene accettata dalla comunità solo se funzionale. L’individuo-creatore resta anonimo, perché culturalmente non è diverso dal resto del gruppo: è, semplicemente, uno che per primo ha colto fermenti nuovi che sono entrati a far parte della vita del gruppo.
Posso fare alcuni esempi. Le pizziche salentine, che sono parte del fenomeno culturale del tarantismo, complesso di musica, canto, danza, lamento e preghiera, rappresentano la risposta della civiltà contadina ai momenti di pericolo, di smarrimento, di “perdita della storia”. Sono un tentativo di esorcizzare le paure tipiche del mondo contadino: la scarsità del raccolto, la precarietà, la dipendenza dai fattori atmosferici, le veglie nei campi, l’insicurezza, i monstra (tarante, serpenti, scorpioni), ecc.
La pizzica è un grido contro la miseria, lo sfruttamento, gli abusi sul luogo di lavoro: Fimmene fimmene ca sciati a lu tabaccu, ne sciati a ddoi e ne turnati a quattu. Ma questa forma culturale, tipica della Puglia meridionale, non si esaurisce nell’ambito contadino. I protagonisti-autori di questi canti e musiche, gli esecutori di queste danze raccontano il malessere della vita ai margini del mondo sviluppato, alla periferia dell’occidente opulento, in una terra emarginata come il Salento. Spesso i protagonisti sono emigranti, giovani che hanno fallito nelle loro speranze, donne depresse per le costrizioni di una società patriarcale, che cercano sollievo in danze frenetiche, sensuali, spesso scomposte e oscene, quasi in un sabba di significato liberatorio.
Similmente, la tammurriata, la tarantella, la villanella sono nel ritmo della vita delle campagne campane e nella venerazione delle loro innumerevoli Madonne, di Napoli e dei suoi santi. Un gruppo storico della canzone popolare napoletana, E Zezi, racconta su ritmi e melodie tradizionali le storie del mondo operaio campano, gli incidenti sul lavoro per mancanza di sicurezza, gli episodi di sfruttamento in quelle cattedrali nel deserto che sono i grandi complessi industriali a Napoli, Pomigliano d’Arco, Solofra, la condanna comune a tante regioni del mezzogiorno italiano, il freno allo sviluppo delle sue risorse naturali, le ferite inferte al suo territorio dai processi di urbanizzazione selvaggia, i danni programmati e taciuti al suo ambiente.
La canzone popolare della Terra di Bari, le tarantelle e le nenie nate nei suoi centri medievali, raccontano storie di artigiani e mercanti, recitano aneddoti di prostitute, vedove e zitelle combattive, narrano di viaggi di marinai su pescherecci e di fatti miracolosi di cui essi sono frequentemente spettatori e beneficiari, descrivono la fatica quotidiana dei contadini alle prese con la produzione e il raccolto, in scenari di ulivi e alberi da frutta, campi di grano e pascoli.
Lo sfondo socio-culturale ha caratteri simili a quello del materano, del foggiano, del molisano e dell’Abruzzo della pastorizia e dei viaggi della transumanza. Sono spesso uno specchio della storia nazionale, che arriva anche in quei paesi.
E arriva anche nei nostri. In una canzone molfettese si ricorda l’arrivo dell’illuminazione elettrica pubblica come un fatto ancora raro e contemporaneamente, con salto temporale di qualche decennio, anche l’uso delle sigarette: a lu pendone d cas stè la lush elettrek, avà passà mmio bbene c l sigarette.
Un’altra racconta di Zì Catarine e della sua disperata ricerca di un marito tra gli artigiani del paese. Spesso protagonisti sono commercianti arricchiti, di cui ironicamente si descrive il contrasto tra l’umile origine sociale e i comportamenti delle classi elevate che essi scimmiottano: u berbend du veccir meng e veve da cavallire; u scarpar … s’ha pust u scollin; la figghie du nghiappachen ten la valisce.
Una canzone diffusa dall’Abruzzo alla Terra di Bari parla delle fatiche dei raccoglitori di grano, pezzing e vespr sott o sol, la schena doele ma la scernat ava passà. Ma il tema della raccolta nei campi non può mancare nelle canzoni molfettesi, e in particolare quella delle olive, data la loro importanza nell’economia cittadina: Uè cummà Uelin, com s’accogghien l’aliv? S’accogghien ad un ad un.
La prostituzione come unico modo per sbarcare il lunario per la moglie di un contadino è il tema di alcune canzoni diffuse a Molfetta e Terra di Bari: Meritem alla pugghie e ì a lu liette, vedimm ci guadegn cchiù denere; nen fasce nudd marit mì ca sì chernut, abbast ca meng e viv e vè vestut. Numerose sono anche le serenate, spesso sarcastiche nei confronti di donne dai tratti non proprio angelici: Metalen ce tin mbitt, nen zò menn me so saìtt; sott o arv d r vermcocc Metalen avì la bott.
Il referente è dunque il popolo umile e basso, il proletariato operaio, contadino e marittimo, il sottoproletariato urbano: quella popolazione dell’Italia meridionale che non è mai stata protagonista di una propria storia comune, succube come è stata del feudalesimo nelle sue forme medievali e moderne, la mafia e il caporalato, vittima del sottosviluppo voluto dal fascismo prima e del paternalismo democristiano poi.
Un abbozzo di identità nazionale contadina sembrò il fenomeno del brigantaggio; infatti storie e inni dei briganti sono frequenti nella canzone popolare meridionale, specie nelle regioni montane di Campania, Lucania e Calabria. Per quanto ingenua, disorganica, a tratti passionale e violenta, facilmente strumentalizzabile, l’esperienza storica dei briganti segnò forse il primo momento in cui i contadini meridionali tentarono una via di “autodeterminazione” e si rivoltarono contro quello Stato che vedevano lontano, estraneo, ostile perché incapace di parlare la loro stessa lingua, che non li comprendeva e che era loro incomprensibile, quello Stato che i contadini di Carlo Levi dicevano si era fermato con Cristo a Eboli. Il brigantaggio insegnò a molti ad alzare la testa, a molti che fino allora avevano concepito il lamento come unica forma possibile di reazione.
È un’esigenza di espressione delle comunità l’atto fondativo della canzone popolare, espressione della propria cultura, del proprio vissuto, tramite i propri mezzi e le proprie regole comunemente accettate. La poesia stessa è espressione popolare. Nasce dal basso, a differenza della filosofia, dell’oratoria, della letteratura politica. Poeti popolari elaborano così un proprio stile, che attinge temi e immagini a legami sociali, rapporti di vita, vicende liete e tristi che si vivono tutti i giorni. I testi sono affidati a cantori e musicisti che li adattano alle loro musiche e li tramandano oralmente di generazione in generazione.
Poeti contadini sono molti degli eroi dell’emancipazione della gente del sud Italia, come Rocco Scotellaro, Salvatore Carnevale e Ignazio Silone, uomini che conquistarono la fiducia dei contadini perché seppero parlare la loro lingua e che pagarono con la vita il loro impegno rivoluzionario contro il padronato, i baroni, la loro lotta contro la mafia, la loro denuncia contro le connivenze col potere politico.
Ma la musica viva è anche contaminazione. La pratica della contaminazione musicale, tipica degli ultimi decenni, ha coinvolto oggi anche il genere della musica popolare. I Mau Mau hanno piegato il dialetto piemontese ai suoni caraibici di cui un’eco è sempre giunta dai porti liguri e d’oltralpe. Qui, da noi, si ripetono appuntamenti importanti come il festival di Melpignano, in cui ormai da anni convengono musicisti popolari salentini con grandi nomi del jazz e della fusion internazionali. E sono spesso ben riusciti i tentativi di sposare la musica elettronica con la pizzica, come quelli esperiti dai salentini Nidi d’Arac e Mascarimirì o dal molfettese Stramonium, al secolo Lillino Salvemini. Le contaminazioni più felici e di successo sono state quelle che hanno unito le nostre musiche “basse” con le musiche popolari di altre regioni del mondo con cui gli autori hanno scoperto dei legami storico-sociali.
A Napoli la 99 Posse e una miriade di altri musicisti attivi intorno ai centri sociali partenopei hanno operato una sintesi tra testi che raccontano l’esperienza sociale del proletariato napoletano, vittima di disoccupazione, sfruttamento, esclusione sociale, e il ragamuffin, la musica che le periferie metropolitane di tutto il mondo hanno mutuato dal reggae giamaicano. Prima ancora Pino Daniele aveva sottolineato il rapporto che lega Napoli agli Stati Uniti tramite gli scambi marittimi tra capitali portuali, cantando in un misto tra dialetto partenopeo e inglese, tra melodie napoletane e blues, la musica dei bassifondi americani, nata tra gli schiavi neri rapiti e importati dall’Africa.
Alla stessa maniera, gli Agricantus hanno mescolato le musiche popolari siciliane con quelle dei popoli del vicinissimo deserto del Sahara, primi fra tutti i Tuareg. E sono significativi anche il folk barese-irlandese di alcune composizioni dei Folkabbestia, il folk barese-rom-slavo degli Ziringaglia, il reggae della barlettana/molfettese Chop Chop Band e dei baresi Suoni Mudù.
Ma la più importante esperienza del reggae italiano appare oggi il Sud Sound System, storica band che esprime, in dialetto salentino, il legame con un’altra terra di miseria e ribellione, la Giamaica, patria della cultura rasta e dell’incredibile propulsore di idee, sogni, speranze che è la musica reggae. Nei testi del Sud Sound System si parla di emarginazione e di disoccupazione: pe trovi la fatìa tocca te sbatti; ogni tantu me chiedu ma ce cazzu so nato a fari; si canta di tossicodipendenza, t’à sciuta bona osce, ma crai? Ma è anche tradizione, festa e speranza, all’inno di lu reggae a nui ni brucia specie se parla de realtà e cultura.
E, ancora una volta, non si rinuncia a Molfetta ad esperimenti simili, come i tentativi fatti negli ultimi tempi dalla posse South Love Vibration, che ha prodotto, col suo brillante leader Zio Pino, una sintesi interessante tra dialetto molfettese e ragamuffin.
Oppure a qualcuno queste sintesi, questi esempi di contaminazione, questi riferimenti dei nostri autori alla cultura internazionale, possono sembrare irriverenti? Discutiamone.
| |
||
settembre - dicembre 2001