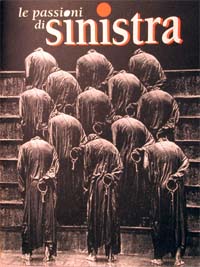La globalizzazione al tempo dell’impero |
“Non bisogna dimenticare che al di fuori delle minoranze che fanno politica militante ci sono quaranta milioni di ottimi Italiani i quali lavorano, si riproducono, perpetuano gli strati profondi della razza, chiedono e hanno il diritto di non essere gettati nel disordine cronico, preludio sicuro della generale rovina.”
Benito Mussolini, 16 novembre 1922
[primo discorso tenuto alla Camera come Presidente del Consiglio per ottenere il voto di fiducia]
“L’Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Noi, questa tranquillità gliela daremo con l’amore, se è possibile, e con la forza, se sarà necessaria.”
Benito Mussolini, 3 gennaio 1925
[discorso alla Camera dopo le polemiche scoppiate in seguito al delitto Matteotti]
“Vogliamo fare una politica estera di pace, ma nel contempo di dignità e di fermezza: e la faremo.”
Benito Mussolini, 16 novembre 1922
[vd. sopra]
“[…] vogliamo cambiare l’Italia. […]
Lo faremo nell’ottimismo, che non c’è mai mancato, nello spirito di fiducia e di collaborazione con tutti coloro che mostrano buona volontà e anche in un clima sereno, ma lo faremo […]”
Silvio Berlusconi, 18 giugno 2001
(discorso per la fiducia tenuto al Senato)
Uno degli ambiti di ricerca maggiormente indagati, all’interno della riflessione generale sul fenomeno della globalizzazione, riguarda lo spazio di azione politica riservato allo stato-nazione rispetto alla creazione e allo sviluppo di un unico megaspazio produttivo, commerciale e sociale.
L’autorità dello stato-nazione, essenzialmente connessa alla concentrazione della capacità amministrativa e dell’apparato militare, e definita efficacemente nei termini del “monopolio dei legittimi mezzi di violenza”, sembra aver subito una profonda modificazione.
Il cambiamento può essere letto, come sostiene Negri, in uno “slittamento” della sovranità degli Stati verso l’Impero: «Il mercato è globale, l’ordine politico del mercato sta costruendosi. […] L’ordine politico è universale, quanto lo è quello economico. Ci sono organismi imperiali che dominano la moneta, la comunicazione e, se non si è d’accordo sul modo nel quale l’imperatore concepisce le due, essi possiedono la facoltà di fare guerra e/o pulizia. L’ordine è davvero universale, trasversale. Si può morire di fame, ma questo vale nell’ultimo buco di culo del mondo, in Burkina-Faso o nelle foreste andine, quanto – sempre per malnutrizione, lavoro o feroce oppressione – nei ghetti di Los Angeles o nelle banlieus parigine. Non c’è più Terzo Mondo: meglio, c’è dappertutto così come, dappertutto, c’è la presenza del comando imperiale. L’Impero non sta in America né a Wall Street, né alla Casa Bianca, né a Washington né a New York: l’Impero è dappertutto, è in rete, si forma e si riproduce nell’ordine globale. Rispetto a una volta ciò che è crollata, è l’illusione che la sovranità nazionale (delle grandi nazioni come delle piccole) possa in qualche maniera agire fuori della logica imperiale»(1).
Questa ricollocazione della sovranità, che ha ormai ridotto i blocchi regionali dell’impero, come l’Unione Europea, a semplici “fornitori locali di servizi” (vedi la guerra in Kosovo) e ha reso i governi sempre più somiglianti alle “municipalità dei centri urbani”(2); anche se le ha inglobate all’interno di processi di mercato mondiale aperto, non ha, tuttavia, cancellato le politiche nazionali.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il trasferimento dei poteri decisionali a favore dei mercati finanziari, la distruzione dello stato sociale, la violazione dei diritti dei lavoratori sono obiettivi che si conseguono e sedimentano in leggi approvate dagli apparati dello stato-nazione (è indifferente se a guida socialdemocratica o liberale), ma soprattutto non deve sfuggirci che allo stato-nazione è affidata l’elaborazione di quella specifica “cultura antipolitica”, che fino a oggi ha reso possibile la realizzazione dei principali obiettivi della globalizzazione capitalistica.
Lo strumento più efficace per consolidare pratiche di antipolitica o di spoliticizzazione resta sempre quello di attirare l’attenzione dei cittadini su bersagli fittizi. Bourdieu, che ha dedicato a questo tema la sua riflessione più recente, utilizza come esempio illuminante di questa attività di spoliticizzazione, gestita dallo stato-nazione, un tema classico: le politiche sull’immigrazione. A livello nazionale e locale ciò su cui viene richiamata l’attenzione dei soggetti sono i fattori terminali, che vengono largamente disciplinati dall’attività governativa, con normative sui permessi di soggiorno, sulla immigrazione irregolare, sulla criminalità dei migranti, ecc.. Ciò che viene rigorosamente taciuto, in questo caso, riguarda le politiche di “aggiustamento strutturale”, dettate dalle istituzioni del neoliberismo (FMI, BM, WTO), la cui realizzazione produce sistematicamente crisi economiche e con esse quei licenziamenti di massa che determinano le grandi ondate migratorie e la crescita di un “esercito mondiale di riserva” che si scarica, soprattutto nelle forme dell’immigrazione clandestina, sulla manodopera nazionale, aggravandone la situazione di precarietà.
Di fronte al ruolo spoliticizzante giocato dallo stato-nazione attraverso l’occultamento delle cause autentiche di un fenomeno, diventa necessario avviare processi di ripoliticizzazione.
Per Bourdieu, non a caso, una delle questioni da sempre ineludibili riguarda l’individuazione del livello (locale, nazionale, europeo, mondiale) a cui deve essere portata l’azione politica. E se, come assunto metodologico, resta valida l’indicazione di risalire dal particolare alle cause generali, è decisivo riconoscere che il luogo in cui oggi riposano quelle cause è mondiale e che è a quel livello che deve portarsi l’azione politica: «Contro la politica di spoliticizzazione – scrive Bourdieu – dobbiamo restaurare la politica, cioè rimettere in campo il pensare e il fare politico, trovando per quest’ultimo il giusto punto di presa, situato ormai oltre lo Stato nazionale, e i suoi mezzi specifici, non più riducibili ai conflitti politici e sindacali ristretti entro i confini degli Stati nazionali»(3).
Non discuteremo, in questa circostanza, la critica mossa dallo stesso Bourdieu al “popolo di Seattle”, la cui azione, diretta al livello più alto, cioè mondiale, viene ritenuta “effimera” e meno efficace di una azione concertata a livello europeo. E, in ogni caso, ci sembra che al “popolo di Seattle”, se non si vuole riconoscere la capacità di aver fermato uno dei più significativi passaggi formali di strutturazione della costituzione politica dell’Impero come forma di sovranità adeguata al governo della globalizzazione, si deve almeno riconoscere il merito di aver «denudato i processi di decision making, iscritto all’ordine del giorno della politica dei movimenti la questione del potere, […] messo in discussione natura, titolarità, legittimità del potere»(4).
Ciò che, invece, ci interessa evidenziare del discorso di Bourdieu riguarda le strategie di ripoliticizzazione: «Quanto all’azione politica se non vuole crearsi illusioni o alibi con gesti senza efficacia, deve risalire anch’essa alle vere cause, luogo dell’efficacia reale»(5).
L’argomentazione di Bourdieu ci consente, oggi, di tentare una discussione di alcuni aspetti della globalizzazione capitalista e di farlo dalla periferia di una provincia imperiale, da una “regione di frontiera”, per stare alle espressioni coniate dai funzionari provinciali che hanno il compito di occultare l’onnipervasività dell’Impero, giocando ancora sulla dialettica dentro/fuori, regolare/clandestino, ecc..
Ebbene, se anche da questa marca dell’Impero, senza provare inibenti sensazioni di smarrimento di fronte alla considerevole mole di studi fino a oggi prodotti, ci accingiamo a parlare di globalizzazione è soprattutto per ri-creare spazio politico.
«Viviamo nell’Impero: non c’è più politica, c’è solo amministrazione»(6). Questa affermazione di Negri la comprendiamo in tutta la sua densità. La comprendiamo come cittadini della provincia imperiale, che ha visto funzionari che vantavano (o millantavano?) una cultura di sinistra prendere decisioni all’interno del comando imperiale; la comprendiamo come residenti della periferia a cui tocca subire, giustificata dalla logica dell’“amministratore di condominio” (una logica esemplarmente spoliticizzante), una amministrazione di centrodestra guidata da chi vantava (o millantava?) ascendenze salveminiane, socialiste e, maturate in verità per un breve, ma denso, periodo di tempo, finanche democratiche-di-sinistra.
Benito Mussolini, 16 novembre 1922
[primo discorso tenuto alla Camera come Presidente del Consiglio per ottenere il voto di fiducia]
“L’Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Noi, questa tranquillità gliela daremo con l’amore, se è possibile, e con la forza, se sarà necessaria.”
Benito Mussolini, 3 gennaio 1925
[discorso alla Camera dopo le polemiche scoppiate in seguito al delitto Matteotti]
“Vogliamo fare una politica estera di pace, ma nel contempo di dignità e di fermezza: e la faremo.”
Benito Mussolini, 16 novembre 1922
[vd. sopra]
“[…] vogliamo cambiare l’Italia. […]
Lo faremo nell’ottimismo, che non c’è mai mancato, nello spirito di fiducia e di collaborazione con tutti coloro che mostrano buona volontà e anche in un clima sereno, ma lo faremo […]”
Silvio Berlusconi, 18 giugno 2001
(discorso per la fiducia tenuto al Senato)
Uno degli ambiti di ricerca maggiormente indagati, all’interno della riflessione generale sul fenomeno della globalizzazione, riguarda lo spazio di azione politica riservato allo stato-nazione rispetto alla creazione e allo sviluppo di un unico megaspazio produttivo, commerciale e sociale.
L’autorità dello stato-nazione, essenzialmente connessa alla concentrazione della capacità amministrativa e dell’apparato militare, e definita efficacemente nei termini del “monopolio dei legittimi mezzi di violenza”, sembra aver subito una profonda modificazione.
Il cambiamento può essere letto, come sostiene Negri, in uno “slittamento” della sovranità degli Stati verso l’Impero: «Il mercato è globale, l’ordine politico del mercato sta costruendosi. […] L’ordine politico è universale, quanto lo è quello economico. Ci sono organismi imperiali che dominano la moneta, la comunicazione e, se non si è d’accordo sul modo nel quale l’imperatore concepisce le due, essi possiedono la facoltà di fare guerra e/o pulizia. L’ordine è davvero universale, trasversale. Si può morire di fame, ma questo vale nell’ultimo buco di culo del mondo, in Burkina-Faso o nelle foreste andine, quanto – sempre per malnutrizione, lavoro o feroce oppressione – nei ghetti di Los Angeles o nelle banlieus parigine. Non c’è più Terzo Mondo: meglio, c’è dappertutto così come, dappertutto, c’è la presenza del comando imperiale. L’Impero non sta in America né a Wall Street, né alla Casa Bianca, né a Washington né a New York: l’Impero è dappertutto, è in rete, si forma e si riproduce nell’ordine globale. Rispetto a una volta ciò che è crollata, è l’illusione che la sovranità nazionale (delle grandi nazioni come delle piccole) possa in qualche maniera agire fuori della logica imperiale»(1).
Questa ricollocazione della sovranità, che ha ormai ridotto i blocchi regionali dell’impero, come l’Unione Europea, a semplici “fornitori locali di servizi” (vedi la guerra in Kosovo) e ha reso i governi sempre più somiglianti alle “municipalità dei centri urbani”(2); anche se le ha inglobate all’interno di processi di mercato mondiale aperto, non ha, tuttavia, cancellato le politiche nazionali.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il trasferimento dei poteri decisionali a favore dei mercati finanziari, la distruzione dello stato sociale, la violazione dei diritti dei lavoratori sono obiettivi che si conseguono e sedimentano in leggi approvate dagli apparati dello stato-nazione (è indifferente se a guida socialdemocratica o liberale), ma soprattutto non deve sfuggirci che allo stato-nazione è affidata l’elaborazione di quella specifica “cultura antipolitica”, che fino a oggi ha reso possibile la realizzazione dei principali obiettivi della globalizzazione capitalistica.
Lo strumento più efficace per consolidare pratiche di antipolitica o di spoliticizzazione resta sempre quello di attirare l’attenzione dei cittadini su bersagli fittizi. Bourdieu, che ha dedicato a questo tema la sua riflessione più recente, utilizza come esempio illuminante di questa attività di spoliticizzazione, gestita dallo stato-nazione, un tema classico: le politiche sull’immigrazione. A livello nazionale e locale ciò su cui viene richiamata l’attenzione dei soggetti sono i fattori terminali, che vengono largamente disciplinati dall’attività governativa, con normative sui permessi di soggiorno, sulla immigrazione irregolare, sulla criminalità dei migranti, ecc.. Ciò che viene rigorosamente taciuto, in questo caso, riguarda le politiche di “aggiustamento strutturale”, dettate dalle istituzioni del neoliberismo (FMI, BM, WTO), la cui realizzazione produce sistematicamente crisi economiche e con esse quei licenziamenti di massa che determinano le grandi ondate migratorie e la crescita di un “esercito mondiale di riserva” che si scarica, soprattutto nelle forme dell’immigrazione clandestina, sulla manodopera nazionale, aggravandone la situazione di precarietà.
Di fronte al ruolo spoliticizzante giocato dallo stato-nazione attraverso l’occultamento delle cause autentiche di un fenomeno, diventa necessario avviare processi di ripoliticizzazione.
Per Bourdieu, non a caso, una delle questioni da sempre ineludibili riguarda l’individuazione del livello (locale, nazionale, europeo, mondiale) a cui deve essere portata l’azione politica. E se, come assunto metodologico, resta valida l’indicazione di risalire dal particolare alle cause generali, è decisivo riconoscere che il luogo in cui oggi riposano quelle cause è mondiale e che è a quel livello che deve portarsi l’azione politica: «Contro la politica di spoliticizzazione – scrive Bourdieu – dobbiamo restaurare la politica, cioè rimettere in campo il pensare e il fare politico, trovando per quest’ultimo il giusto punto di presa, situato ormai oltre lo Stato nazionale, e i suoi mezzi specifici, non più riducibili ai conflitti politici e sindacali ristretti entro i confini degli Stati nazionali»(3).
Non discuteremo, in questa circostanza, la critica mossa dallo stesso Bourdieu al “popolo di Seattle”, la cui azione, diretta al livello più alto, cioè mondiale, viene ritenuta “effimera” e meno efficace di una azione concertata a livello europeo. E, in ogni caso, ci sembra che al “popolo di Seattle”, se non si vuole riconoscere la capacità di aver fermato uno dei più significativi passaggi formali di strutturazione della costituzione politica dell’Impero come forma di sovranità adeguata al governo della globalizzazione, si deve almeno riconoscere il merito di aver «denudato i processi di decision making, iscritto all’ordine del giorno della politica dei movimenti la questione del potere, […] messo in discussione natura, titolarità, legittimità del potere»(4).
Ciò che, invece, ci interessa evidenziare del discorso di Bourdieu riguarda le strategie di ripoliticizzazione: «Quanto all’azione politica se non vuole crearsi illusioni o alibi con gesti senza efficacia, deve risalire anch’essa alle vere cause, luogo dell’efficacia reale»(5).
L’argomentazione di Bourdieu ci consente, oggi, di tentare una discussione di alcuni aspetti della globalizzazione capitalista e di farlo dalla periferia di una provincia imperiale, da una “regione di frontiera”, per stare alle espressioni coniate dai funzionari provinciali che hanno il compito di occultare l’onnipervasività dell’Impero, giocando ancora sulla dialettica dentro/fuori, regolare/clandestino, ecc..
Ebbene, se anche da questa marca dell’Impero, senza provare inibenti sensazioni di smarrimento di fronte alla considerevole mole di studi fino a oggi prodotti, ci accingiamo a parlare di globalizzazione è soprattutto per ri-creare spazio politico.
«Viviamo nell’Impero: non c’è più politica, c’è solo amministrazione»(6). Questa affermazione di Negri la comprendiamo in tutta la sua densità. La comprendiamo come cittadini della provincia imperiale, che ha visto funzionari che vantavano (o millantavano?) una cultura di sinistra prendere decisioni all’interno del comando imperiale; la comprendiamo come residenti della periferia a cui tocca subire, giustificata dalla logica dell’“amministratore di condominio” (una logica esemplarmente spoliticizzante), una amministrazione di centrodestra guidata da chi vantava (o millantava?) ascendenze salveminiane, socialiste e, maturate in verità per un breve, ma denso, periodo di tempo, finanche democratiche-di-sinistra.
Un punto fermo, delle analisi sviluppabili “a sinistra”, concerne l’interpretazione della fase contemporanea della globalizzazione capitalistica come figura della crisi capitalistica in atto.
Molto opportunamente, concludendo i lavori del seminario di studi La mondializzazione capitalistica nell’epoca presente, organizzato a Firenze nel novembre del 1995 dal Gruppo confederale europeo Gue/Ngl e dal Partito della Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti invitava a non dimenticare che l’attuale processo di globalizzazione si realizza «all’interno di una fase di sviluppo rallentato dell’economia capitalistica e che costituisce una risposta difensiva. Gli apologeti ci descrivono la mondializzazione (a prescindere dai disastri sociali che essa produce) come apportatrice di meraviglie, di tecnologie che pervadono tutto, di grandissime cose. Si tratta invece del prodotto di una crisi del capitalismo e di una replica anche affannosa alla crisi […]»(7).
Le considerazioni del segretario del Prc si fondavano, in modo particolare, sulle analisi prodotte da Samir Amin nello studio La sfida della mondializzazione(8), e sulla distinzione da questi operata tra le due forme di mondializzazione tipiche della seconda metà del Novecento.
La “mondializzazione di tipo controllato e coerente”, che si è affermata nel secondo dopoguerra, è stata sostenuta da una espansione dei mercati, che raggiungeva anche i paesi socialisti, e, nello stesso tempo, è stata favorita da una logica d’insieme che connetteva i progetti sociali dell’Occidente capitalista, dell’Est socialista e del Sud sottosviluppato.
I tre pilastri che, secondo Amin, hanno retto questa forma della mondializzazione sono stati il Welfare State nei paesi del capitalismo sviluppato, il sovietismo come progetto di capitalismo senza capitalisti, la costruzione dello Stato e dell’economia interdipendente nei paesi del Terzo Mondo. Nonostante le differenze, si trattava di progetti di società nazionali, che organizzavano una interdipendenza tra nazioni: «Un concetto di mondializzazione che implicava soprattutto il rafforzamento delle strutture nazionali e della loro interdipendenza – uguale o ineguale – ma sempre negoziata. Questo concetto e questa pratica della mondializzazione, sovrapposta al rafforzamento della costruzione nazionale, non è stata in contraddizione né con l’egemonia degli Stati Uniti sull’insieme del mondo capitalista, né con l’equilibrio Est-Ovest (socialismo-capitalismo), né con il rapporto Nord-Sud»(9).
La fase contemporanea della globalizzazione, in questa analisi di Amin, inizia con il 1968, cioè con la rimessa in discussione, da parte del capitalismo, della legittimità del modello di Welfare State affermatosi in Occidente.
All’interno di una interpretazione concorde nel ritenere la globalizzazione come una situazione nella quale il potere capitalista si riforma, di fronte all’impossibilità di sopravvivere con le vecchie forme, anche Negri vede nel ’68 un momento nodale del Novecento: «Un momento nel quale lo Stato-nazione è stato attaccato sia nel suo ruolo regolatore della produzione capitalista all’interno di ogni paese, che nella sua funzione imperialista. La grande differenza che esiste tra “impero” e “imperialismo” è che il secondo era la continuazione, l’estensione del raggio di azione dello Stato-nazione al di fuori delle proprie frontiere; era un tentativo di espandere le proprie frontiere, di occupare degli spazi, di accerchiarli, di allargare la propria cultura. A metà del XX secolo, intorno al ’68, è esplosa questa doppia realtà: non è stato più possibile controllare la classe operaia all’interno dello spazio nazionale, e non è stato più possibile controllare l’impulso riformista che emergeva tanto al centro del capitalismo, con il ’68, quanto in Vietnam»(10).
La grande espansione del commercio e della produzione mondiale degli anni Cinquanta e Sessanta si trasformava nell’espansione finanziaria degli anni Settanta e Ottanta(11), confermando l’andamento alterno dell’economia capitalistica, caratterizzato da fasi di espansione materiale, che consentivano l’investimento di notevoli capitali monetari nel commercio e nella produzione, e da fasi di espansione finanziaria, segnate dalla ritrasformazione del capitale in liquidità, alimentante prestiti, crediti e speculazione. È importante ricordare che la fase di finanziarizzazione del sistema veniva inaugurata, il ferragosto del 1971, dalla decisione di Nixon di sganciare il valore del dollaro dall’oro. In questo modo, trent’anni fa, l’amministrazione americana, trasformando il dollaro nell’unica moneta di riferimento internazionale, sarebbe riuscita a finanziare il proprio debito per decenni, tanto che, come ricorda Giovanna Ricoveri, «gli USA primo debitore mondiale verso l’estero (oggi 1,5 trilioni di dollari, 20% del Pil USA) sono riusciti – anche grazie all’ondata di liberalizzazioni succedutesi negli anni ’80 e ’90 – a raccogliere il risparmio dei paesi di nuova industrializzazione e di quelli emergenti». In questa prospettiva, il WTO diventa per gli USA uno strumento necessario per protrarre nel tempo quello che Frédéric Clairmont definisce un “privilegio imperiale” e cioè la possibilità di «sottrarsi al doppio cappio del debito estero e dell’indebitamento interno di famiglie e imprese, attraverso l’aumento di esportazioni e investimenti esteri, mantenendo il proprio potere egemonico nei confronti del mondo, soprattutto del Sud»(12).
La questione, a partire da Seattle, si configura, quindi, nella resistenza alle strategie del WTO. Ma cosa deve significare resistere al WTO? In che modo questa resistenza potrà evitare del tutto le forme della “resistenza passiva” per diventare rivoluzionaria?
Tenteremo di articolare alcune considerazioni, sfruttando un breve intervento, pubblicato, all’inizio di agosto, sul «manifesto» con il titolo Provocazione al popolo di Seattle. Ma Carlo Marx non sarebbe d’accordo con voi(13), nel quale Luigi Cavallaro richiama il testo marxiano Discorso sulla questione del libero scambio. Apparso come opuscolo all’inizio di febbraio 1848, lo scritto costituisce la rielaborazione di un discorso preparato da Marx per il congresso liberoscambista tenutosi a Bruxelles nel settembre del 1847, ma che gli fu impedito di tenere(14). Sebbene si trattasse di un intervento circoscritto storicamente alla approvazione, nel giugno del 1846, da parte del parlamento inglese di una legge, fortemente voluta dalla borghesia industriale, che aboliva i dazi sul grano, introdotti nell’interesse dei grandi proprietari fondiari inglesi, il discorso di Marx circolò diffusamente nella seconda metà dell’Ottocento. Scritto in francese, ebbe una edizione tedesca nello stesso 1848, una russa nel 1885, una americana nel 1889, e in Italia venne tradotto con il titolo Libero scambio e socialismo nel 1894 sulla rivista «Critica sociale».
Presentato, oggi, come una “provocazione al popolo di Seattle”, il testo di Marx era in origine una “provocazione ai liberoscambisti”. In queste pagine, infatti, il sostegno dato alla legge in favore dell’abolizione dei dazi doganali non comporta nessuna forma di sostegno alle politiche del capitalismo industriale. Marx, infatti, ironizza sulla filantropia degli industriali che mirano a una riduzione del prezzo del pane, mentre resistono alla riduzione a dieci ore della giornata lavorativa. Gli operai inglesi sanno bene, egli afferma, che quella riduzione è cercata in vista della diminuzione del salario e, allo stesso tempo, sono perfettamente consapevoli di essere in presenza di una battaglia condotta per l’aumento del profitto industriale a spese della rendita agraria.
Ciò che a Marx interessa esaltare è il carattere “distruttivo” del libero scambio: «Esso dissolve le antiche nazionalità e spinge all’estremo l’antagonismo fra la borghesia e il proletariato. In una parola, il sistema della libertà di commercio affretta la rivoluzione sociale. È solamente in questo senso rivoluzionario, signori, che io voto in favore del libero scambio»(15). Nel resoconto che del discorso di Marx fornisce Engels, le contraddizioni globali innescate dal liberoscambismo sono ancora più fortemente esplicitate: «Noi siamo per il libero scambio perché mediante il libero scambio tutte le leggi economiche, con le loro più sorprendenti contraddizioni, agiranno su più vasta scala, su un territorio più esteso, su tutta la terra, e perché dall’unione di tutte queste contraddizioni in un solo gruppo in cui esse si fronteggeranno direttamente scaturirà la lotta che finirà con l’emancipazione del proletariato»(16).
Le “contraddizioni globali del capitalismo” diventano particolarmente evidenti se rivolgiamo lo sguardo al cuore dell’Impero, gli USA, e, in modo particolare, se valutiamo gli effetti prodotti dai meccanismi di finanziarizzazione, adottati per far fronte al sovradimensionamento degli investimenti realizzati nelle infrastrutture, nelle telecomunicazioni, nel mercato dell’auto, nei beni di consumo.
La crisi di reddittività dell’economia reale, determinata da una sovraccapacità produttiva, ha favorito l’ascesa egemonica di un capitalismo finanziario che si è sempre più diretto verso la speculazione finanziaria connessa alla new economy (la combinazione Wall Street-Silicon Valley): «Quando la sovrapproduzione ha tolto reddittività alla cosiddetta old-economy, il furbo capitale speculativo è emigrato sui titoli azionari dell’alta tecnologia; qui ha preso piede un capitalismo virtuale basato sull’aspettativa di futuri profitti più che su profitti reali. La new-economy era in sostanza una bolla speculativa, e tutti sapevano che sarebbe prima o poi scoppiata, come poi è successo»(17). Ciò significa anche che, dopo essere cresciuto, fra il 1982 e gli inizi del 2000, di ben 30 volte, oggi il Nasdaq perde dall’inizio dell’anno il 30% e sprofonda al 66% della vetta raggiunta il 10 marzo del 2000 e si determina una significativa contraddizione per quanto riguarda il regime dei consumi privati, che, alimentati negli anni Ottanta e Novanta dal credito tratto su valori virtuali, rappresentano ormai i due terzi del Pil USA, oltre che una forma incredibile di indebitamento privato: «L’egemonia mondiale Usa – scrive James O’Connor – azzera dunque il funzionamento della legge della domanda e dell’offerta del dollaro sul mercato globale. In qualsiasi altro paese con surplus di importazioni tanto elevati, la moneta avrebbe subito un forte deprezzamento, riducendo la capacità di quel paese a importare beni e servizi, e innescando la tendenza all’aumento delle esportazioni. Ne sarebbe derivata una forte tendenza alla riduzione o scomparsa del surplus da importazioni. Ma gli Usa non sono “un qualsiasi altro paese”, sono il paese che detiene la più importante riserva monetaria esistente – il dollaro. La maggior parte degli investimenti esteri e del commercio estero si realizza in dollari, e ciò significa che i grandi protagonisti della economia mondiale sono interessati a difendere il valore del dollaro sul mercato del cambio»(18).
Da questa contraddizione gli USA, a Seattle, pensavano di venir fuori attraverso strategie di liberalizzazione del commercio estero volte ad avvantaggiare le proprie esportazioni e i propri investimenti all’estero e, quindi, a impedire pressioni sul dollaro, ad avviare un processo di crescita interna in grado di ridurre l’indebitamento, a evitare crisi di liquidità. Naturalmente questi obiettivi non sono risultati facilmente compatibili con quelli dei blocchi regionali dell’Impero, l’Unione Europea e l’Asia, che mirano a strutturare e a potenziare percorsi autonomi di sviluppo economico su aree regionali. In Asia, il già citato O’Connor ricorda che ciò può accadere grazie al sistema produttivo giapponese, all’enorme bacino di forza lavoro a bassissimo costo disponibile in Cina e, naturalmente, grazie a un enorme mercato interno potenziale(19). Mentre, per quanto riguarda l’Unione Europea, a dover essere letti come una ricerca di un percorso autonomo di sviluppo sono i tentativi di penetrazione nei Balcani, nell’Europa Orientale e nella Russia di Putin.
I tre centri di crescita dell’economia globalizzata, America, Europa, Asia orientale, come sostiene Guido La Barbera, «sebbene interdipendenti sono rivali per l’influenza globale»(20).
Anche se non l’hanno avvertito consapevolmente, occorre dire che il “carattere distruttivo” del libero scambio, di cui parlava Marx, i blocchi regionali dell’Impero hanno cominciato a praticarlo nella forma di “strategie multipolari globali” foriere di notevole instabilità.
Tuttavia, se a Seattle questa forma di instabilità, che cominciava ad apparire in tutta la sua contraddittorietà, non è stata colta come una chance rivoluzionaria, la colpa non è da attribuire ai governi dei paesi capitalisti e ai loro apparati repressivi, ma alla mancanza di rivendicazioni unitarie da parte del proletariato mondiale. Una mancanza che, in questo circostanza, chiama in causa le responsabilità della Confederazione sindacale Afl-Cio, il cui presidente, John Sweeney, un mese prima di Seattle, sottoscriveva insieme a un gruppo di grandi industriali una lettera di appoggio all’agenda commerciale di Clinton per i negoziati del WTO(21).
A Seattle, la Afl-Cio ha avuto un comportamento ambiguo dal momento che ha chiesto al WTO, da un lato, l’approvazione e la determinazione puntuale di standard internazionali per il lavoro, e, dall’altro, di impedire l’ingresso della Cina: «Ma che senso ha – si chiede efficacemente James O’Connor – lasciare fuori dal WTO la Cina, che è un enorme paese dove gli standard sul lavoro sono meno rispettati»(22). Per quanto riguarda l’ingresso della Cina è opportuno ricordare, e purtroppo ci tocca affrontare incidentalmente un tema che meriterebbe un’ampia trattazione, che la Afl-Cio ha accolto nelle sue dimostrazioni anche rappresentanti della destra sciovinista e populista americana come Pat Buchanan, legatosi nell’occasione al sindacato degli autotrasportatori (Teamsters). Il “popolo di Seattle” non deve ignorare, infatti, che è in atto un significativo attacco portato dalle destre al FMI e alla BM, ritenuti ingombranti concorrenti degli istituti finanziari privati(23).
Il comportamento ambiguo del sindacato statunitense si è ulteriormente manifestato con la decisione di non partecipare al Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre: «Rispetto a Seattle – scrive Luciana Castellina – Porto Alegre ha tuttavia subito una perdita secca e non di poco conto: gli operai del Nord, in particolare il sindacato statunitense, la cui presenza nel raduno sulla costa del Pacifico aveva costituito la novità più rilevante. Aveva acceso la speranza che si stesse per costruire l’alleanza fra sfruttati che, invece, permane fragilissima, ostacolata da pesanti contraddizioni negli immediati interessi di coloro che lavorano al Nord e coloro che lavorano al Sud e che la diffidenza di entrambi verso il processo di globalizzazione non basta ancora a far superare. In compenso si è estesa la presenza e l’assunzione di responsabilità dei sindacati del Sud: la grande Cut brasiliana, la Kctu della Corea del Sud, la Cta argentina, il Cosatu sudafricano. È il Sud del mondo, a Seattle ancora marginale, ad avere qui preso la testa, una rottura con la dipendenza dal Nord che si è tradizionalmente riflessa anche nel militantismo»(24).
La marginalità del Sud a Seattle è stata avvertita, innanzi tutto, dai delegati del Terzo Mondo che nella volontà di fissare standard lavorativi e ambientali più alti, prospettata dall’alleanza fra governo USA e gruppi sindacali, hanno visto un tentativo per mettere fuori gioco i prodotti dei paesi in via di sviluppo, o almeno per livellare le differenze attraverso l’aumento dei costi di produzione(25).
In ogni caso, la marginalità del Sud è destinata a essere fissata stabilmente dal regime dei “diritti di proprietà intellettuale” (Trips), che, come scrive Walden Bello, costituiscono la “chiave di volta del WTO”. Dal momento, infatti, che il potere economico attualmente è determinato dall’innovazione nei settori industriali ad alta intensità di conoscenza (software e hardware elettronico, biotecnologie, laser, optoelettronica, ecc.), è evidente che «quando qualsiasi azienda in Asia o altrove cerca di innovare vuoi nel disegno di chips o nel software, è costretta a incorporare parecchi processi e prodotti coperti da brevetto, di solito proprietà di giganti come Microsoft, Intel o Texas Instruments. Le molteplici ed esorbitanti royalities da pagare alla “mafia high tech” americana mantengono bassi i profitti bassi e riducono gli incentivi all’innovazione locale. Le aziende asiatiche, in questo settore, seguiranno la via delle aziende a bassa tecnologia del tessile e dell’abbigliamento: lavoreranno sotto appalto per le varie Sun, Apple, Intel. I Trips permettono al leader tecnologico, in questo caso gli USA, di influenzare, di determinare, il ritmo dello sviluppo tecnologico e industriale nei paesi industrializzati rivali, nei paesi di “nuova industrializzazione”, e in quelli in via di sviluppo»(26). E il lavoro in appalto, è bene ricordarlo, nelle zone a bassi costi di produzione, è retribuito con salari fissati dai governi e non dalla competizione liberista o dalla concertazione sindacale. Su questa straordinaria combinazione di dirigismo economico statale e di liberismo si fonda un efficace e perverso accordo delle corporations multinazionali del Nord e delle élites governative del Terzo Mondo.
Non sappiamo con certezza se a Seattle, come afferma Luigi Vinci, sia sceso in campo “un grande schieramento planetario di classe”, ma è chiaro che l’assedio del vertice del WTO ha riattivato una potente riflessione sulle contraddizioni attuali del capitalismo. Con Vinci siamo d’accordo, invece, sulla duplice necessità che si impone al “popolo di Seattle”. La necessità, da un lato, di superare una fiducia “ingenua” nella possibilità di liberare spazi di cooperazione democratica e solidale, accanto ai processi sociali capitalistici, e, dall’altro, di «tentare di praticare l’unità delle classi subalterne e, più in generale, di chiunque sia sfruttato e calpestato dal capitalismo, in quanto non solo necessaria alla costruzione di un percorso di lotta di classe che porti al rovesciamento del capitalismo, ma anche alla difesa degli stessi “spazi” liberati»(27).
Siamo, così, giunti a un punto inaggirabile dell’attuale discussione politica sulla globalizzazione. Si tratta di verificare, infatti, la tenuta dell’assunto tipico della tradizione marxista che lega la lotta al capitalismo alla maturazione di una coscienza di classe rivoluzionaria.
Rispetto alla rivendicazione, avanzata da parte del “movimento dei movimenti”, della struttura “reticolare” come di un progresso rispetto alle tradizionali forme dell’agire politico (vd. partiti e sindacati), Luigi Cavallaro, nel succitato intervento, ha proposto una argomentazione fortemente provocatoria. A suo parere, l’orgoglio con cui viene rivendicata la costruzione di un reticolo relazionale “privo di nessi organizzativi che non siano di tipo orizzontale”, impedisce di accorgersi che, in fondo, il modello di un “luogo “orizzontale” in cui si incontrano decisioni di produrre, di scambiare e di consumare […]” è rinvenibile proprio nel mercato. In sostanza, coloro che muovono una forte critica al mercato cadono nella “contraddizione” di “organizzarsi” secondo la forma tipica del mercato.
Questa provocazione ha il merito di sollevare, indirettamente, una serie notevole di questioni, relative, per esempio, alle modalità con cui i partiti della sinistra antagonista potranno e dovranno relazionarsi con le pratiche di opposizione al dominio capitalistico, che possono essere efficacemente definite con la formula di “antagonismo sociale”(28). È evidente, infatti, che se questi partiti non riusciranno a giustificare il proprio ruolo all’interno della fase attuale di ricostituzione dell’antagonismo anticapitalistico, non potranno far altro nei prossimi anni che registrare continue contrazioni della propria base elettorale(29).
Tali questioni diventano sempre più urgenti, dal momento che anche il capitale e il suo apparato istituzionale cercano di relazionarsi con le forze antagoniste, come è dimostrato dal singolare fenomeno di ONG sempre più armonizzate con i bisogni del sistema capitalistico(30).
Particolarmente istruttivi ci appaiono, a questo proposito, una serie di articoli apparsi nel mese di luglio, prima e dopo il vertice di Genova, sul «Sole 24Ore», e cioè su uno dei più importanti organi di stampa del padronato italiano.
All’inizio di luglio, il nobel per l’economia Amartya Sen viene ingaggiato per spiegare, innanzi tutto, che i movimenti di protesta, nonostante siano spesso “goffi, rabbiosi, semplicistici, dissennati” e nonostante partano da premesse e propongano rimedi “raffazzonati e confusi”, sono portatori di “fecondi dubbi creativi”. In secondo luogo, a Sen tocca chiarire ai manifestanti, che criticano la globalizzazione, che “le loro proteste sono fra gli eventi più globali che ci siano” e che «la globalizzazione dei rapporti non è certo quello che intendono fermare, altrimenti dovrebbero cominciare col fermare se stessi». Dopo queste premesse, della cui esplicitazione il movimento non può che essere devotamente grato, l’oggetto del contendere viene individuato nelle «diseguaglianze inter e intra-nazionali di ricchezza, nelle notevoli asimmetrie del potere politico, sociale ed economico, e quindi nella condivisione dei potenziali benefici della globalizzazione tra i paesi ricchi e poveri e tra diversi gruppi all’interno di uno stesso paese». I difensori della globalizzazione, secondo Sen, non possono, nelle attuali circostanze, sottrarsi all’impegno di una profonda riforma istituzionale: «C’è bisogno di riflettere […] sulla necessità concreta di mettere le istituzioni internazionali al servizio del mondo e di estendere il ruolo delle istituzioni sociali di ogni paese. È importante tenere conto della complementarietà tra istituzioni diverse, tra cui il mercato e i sistemi democratici, le opportunità sociali, le libertà politiche e altri elementi istituzionali, vecchi e nuovi»(31). Secondo la più tipica linea riformista, a Sen non riesce nemmeno di dubitare che sistemi formalmente democratici (modello Westminster) possano trovare diffusione in strutture sociali fondate sulla diseguaglianza.
L’impianto riformista di Sen, dopo le giornate di Genova, cede il passo ad interventi più decisi. Esemplare ci sembra il numero del 29 luglio, allorché a essere ingaggiati dal quotidiano padronale sono Sebastiano Maffettone e Stefano Silvestri.
Nell’analisi di Maffettone, dedicata a Popper per l’anniversario della nascita (28 luglio 1902), l’elemento che ha accomunato le proteste ecologiche spontanee alla politica dei movimenti antiglobalizzazione viene colto nel “primitivismo romantico”, che ha come suo precedente storico e intellettuale l’ecologismo profondo, nato nella seconda metà degli anni Sessanta. Ma lega più esplicitamente l’atteggiamento anti-scientifico e anti-tecnologico dei verdi tradizionali a una critica del capitalismo e della burocrazia internazionali.
Il movimento di protesta “goffo, rabbioso, semplicistico, dissennato, raffazzonato e confuso” scopre, così, di essere anche “primitivista-romantico”. Ma scopre, anche, che Maffettone non lo ignora, anzi lo studia con interesse per «cercare di vedere qual è la natura delle pretese del movimento politico antagonistico, magari per contrapporgli una risposta adeguata alle esigenze della cultura liberaldemocratica».
La soluzione viene prospettata nei termini di una cultura politica che «deve diffondere trasparenza e democrazia nei processi decisionali. I processi decisionali, soprattutto quando nuove tecnologie sono massicciamente prodotte e distribuite dal grande capitale, come avviene nel caso degli OGM, creano un senso popolare di disagio cui i movimenti radicali rispondono alla loro maniera»(32). Un surplus di informazioni, tuttavia, non riteniamo possa risolvere il grosso problema connesso alla questione degli OGM, per stare al significativo caso citato, consistente soprattutto nella ventennale protezione generalizzata dei brevetti garantita dal già discusso regime dei Trips.
Accanto alle soluzioni riformista-istituzionale di Sen e liberaldemocratica di Maffettone, compare quella di Stefano Silvestri, preoccupato dal fatto che le violenze di Genova e la conseguente confusione politica possano costituire «per gruppi terroristici e per settori della criminalità organizzata un segnale e una opportunità da sfruttare». Dopo aver messo in guardia nei confronti delle “analisi vetero-marxiste o movimentiste”, che rischiano di proliferare in un Paese diviso, nel quale i gruppi terroristici più “politicizzati” possono coltivare «la speranza di ritrovare un collegamento con le “masse operaie” o in loro assenza, almeno con alcuni settori del mondo politico e con la nuova realtà della contestazione anti-globalista», Silvestri prospetta la sua soluzione. In questo caso, si tratta di un rimedio adeguato a un “paese di frontiera”, che rischia continuamente di essere colpito sul versante balcanico e del mediterraneo orientale e meridionale: «queste situazioni – sostiene Silvestri – si combattono in primo luogo con una buona rete informativa, che tuttavia ha bisogno della maggior cooperazione possibile da parte degli alleati».(33)
Al di là della soluzione legata al rafforzamento di attività di intelligence cogestite con gli alleati, ciò che ci appare interessante notare è lo slittamento semantico che, in questi tre articoli, ha riguardato il movimento di protesta che, da “goffo, rabbioso, semplicistico, dissennato, raffazzonato, confuso, primitivista-romantico”, comincia ora ad essere prospettato come il terreno di coltura del “terrorismo” nazionale e internazionale.
Joseph Halevi, di fronte alla sempre più diffusa tendenza a omologare il movimento a nuove forme di terrorismo, ha significativamente fatto notare che questa operazione di criminalizzazione è stata avviata, ma al contempo bloccata, a Seattle a causa della partecipazione del sindacato Afl-Cio, assolutamente necessario all’amministrazione democratica USA in vista delle elezioni presidenziali, e ha potuto essere ripresa con il trasferimento delle azioni di protesta in Europa.
Associare le azioni di protesta a fenomeni terroristici è, secondo Halevi, un modo per consentire al sistema statale il dispiegamento del low intensity warfare (guerra di bassa intensità) sperimentato già nell’america reaganiana in Nicaragua (finanziamento dei “contras” e “Irangate”), Salvador e Guatemala, e per reprimere movimenti sociali “pericolosi” o le proteste delle popolazioni “escluse”, le rivolte dei ghetti neri per esempio. L’unificazione degli interventi imperialistici e delle azioni repressive interne, su cui si fonda la strategia del low intensity warfare, non poteva non investire il movimento no-global, dal momento che «è considerato un serio pericolo perché può costituire un ponte tra le vittime delle ormai permanenti ristrutturazioni economiche nel mondo capitalistico e quelle dei paesi poveri soggetti all’imperialismo»(34).
Nel 1977, in uno di quelli che vent’anni dopo avrebbe efficacemente chiamato i “libri del rogo”, Antonio Negri definì “infame” il riformismo, argomentando in questi termini: «La sua infamia risiede nella posizione strutturale che la forma-Stato gli affida. Centro della mistificazione, centro e motore della organizzazione del consenso, quindi della repressione contro l’opposizione, reale e possibile»(35).
Oggi, senza entrare nel merito del duro giudizio di Negri, dobbiamo forse essere pronti a riconoscere che una dialettica riformista non può giocare alcun ruolo nella globalizzazione capitalistica, dal momento che non esiste un soggetto negoziale nel capitalismo globale.
Lasciamo, dunque, “l’attualità del riformismo” ai redivivi e rancorosi intellettuali di «MondOperaio»(36) e ritorniamo a riflettere sullo stato del conflitto sociale.
Alla vigilia del tragico 20 luglio genovese, Alberto Burgio e Claudio Grassi, sulle pagine del «manifesto», vedevano nello sciopero di giugno dei metalmeccanici e nel movimento anti-G8 una potente messa in discussione delle teorizzazioni della “fine del conflitto”. Il fulcro della loro analisi era costituito dalla convinzione che senza una rigorosa critica del capitalismo si rischia di lasciare spazio alle pratiche della sinistra moderata.
In questa prospettiva, soltanto una analisi critica del capitalismo renderebbe possibile il superamento di “letture a-classiste” del G-8 e interpretazioni generiche dei processi di globalizzazione, al fine di consentirci di cogliere l’insopportabile comando imperialistico esercitato dagli stati capitalistici più potenti, a cominciare dagli USA, attraverso i principali organismi sovranazionali (BM, FMI, WTO, OCSE, NATO, Tribunale dell’Aja).
Nell’analisi di Burgio e Grassi, questa critica del capitalismo non può e non deve: 1) trascurare le connessioni tra dominio economico e dominio politico-militare, 2) perdere di vista la centralità dello sfruttamento del lavoro vivo, vera chiave di volta di una mondializzazione che scarica su migranti e nuovi schiavi il peso della generale deregolamentazione dei rapporti di lavoro, 3) sganciare la discussione sugli effetti generalmente regressivi e distruttivi prodotti dalla mondializzazione capitalistica sull’ambiente e sulla riproduzione delle forme viventi dalle cause specificamente di classe che informano di sé questo modello di sviluppo e gli attuali rapporti di forza internazionali.
Soltanto l’assunzione di una prospettiva di classe può preservare i movimenti dall’adesione a quelle rivendicazioni meramente compatibiliste che, puntando alla realizzazione di un capitalismo “equo e solidale”, “sostenibile” e “dal volto umano”, finiscono con il divergere totalmente dal movimento di classe che mette al centro il tema del lavoro. Rivendicazioni che trovano espressione nelle parole delle gerarchie cattoliche, per esempio nel discorso con il quale il cardinale Tettamanzi invoca «una globalizzazione umana e umanizzante, […] una globalizzazione per l’uomo e non un uomo per la globalizzazione». Parole che hanno certamente un valore straordinario nel contesto in cui vengono pronunciate, in questo caso il raduno genovese delle associazioni cattoliche tenutosi all’inizio del luglio, ma che, nella sostanza, appaiono soltanto una versione aggiornata della “giusta mercede” teorizzata nella Rerum Novarum.
«O si lavora, sulla base di una rigorosa critica del capitalismo, per fare emergere e divenire coscienza comune la sostanziale unità delle ragioni del movimento di classe, sia che si scenda in piazza contro il G-8, sia che ci si muova contro il padronato italiano, da anni rassegnato alla perdita della propria autonomia produttiva per svolgere funzioni di complemento nei confronti dei sistemi produttivi di altri paesi; o, in caso contrario, si rischia di avallare, a dispetto delle parole d’ordine altisonanti, la ultradecennale deriva moderata della sinistra, il suo diligente allinearsi allo stato di cose dato appagandosi di apporre trascurabili correzioni o attenuazioni alla tendenza principale»(37).
Non sappiamo se l’ex ministro del commercio con l’estero, Piero Fassino, sarà il futuro segretario dei DS e se sarà vincente la sua linea di “riformismo radicale”, espressa in questa definizione del proprio programma: «Non esiste un’altra società, diversa da questa, in cui viviamo e operiamo: tutti i tentativi di farla sono falliti, o finiti in tragedia. Penso a Pol Pot o a Ceausescu. Naturalmente questo non significa affatto che la nostra società vada bene così com’è. Tutt’altro è piena di ingiustizie, di iniquità e noi siamo qui per lottare e cambiarla e dobbiamo fare la battaglia quotidiana per cambiare quello che riusciamo a cambiare, per fare cessare a esempio lo sfruttamento dei bambini, la morte per fame, la morte per Aids, per dare regole e vincoli al processo di globalizzazione. Questo non è moderatismo, è riformismo. E può anche essere radicale»(38).
Non sappiamo, nemmeno, se il 4 luglio [accordo bi-partisan raggiunto sul G-8 con il governo di centrodestra, attraverso mozioni parallele e astensioni incrociate], il 20 luglio [decisione, dopo la morte di Giuliani, di non partecipare alle manifestazioni genovesi], il 26 luglio [D’Alema in Parlamento definisce “fasciste” le violenze della polizia a Genova], le esternazioni agostane di Violante su accordi bipartisan nei confronti di azioni terroristiche tutte da decifrare, costituiscano recenti articolazioni della tattica del “riformismo radicale” che ha in mente Fassino e buona parte della dirigenza DS.
Tuttavia, ciò che sappiamo e che vogliamo ricordare a chi, come Fassino, esibisce orgoglioso le opere di Eduard Bernstein come fondamento di una identità “riformista”, è il giudizio formulato da Lenin, usando il termine “revisionismo”: «Il fine è nulla, il movimento è tutto, queste parole alate di Bernstein esprimono meglio di lunghe dissertazioni l’essenza del revisionismo. Determinare la propria condotta caso per caso; adattarsi agli avvenimenti del giorno, alle svolte provocate dai piccoli fatti politici; dimenticare gli interessi vitali del proletariato e i tratti fondamentali di tutto il regime capitalista, di tutta l’evoluzione del capitalismo; sacrificare questi interessi vitali a un vantaggio reale o supposto del momento, tale è la pratica revisionista»(39).
Una sinistra autenticamente rivoluzionaria, progressista e democratica non può restare subalterna alle logiche dell’espansione capitalistica, né può pensare, con l’ipocrisia degli accordi bipartisan, di costruire l’avvento di forme caritatevoli di liberismo. Per evitare tutto questo, alla sinistra “basta” «non dimenticare i tratti fondamentali di tutto il regime capitalista, di tutta l’evoluzione del capitalismo».
1) A. NEGRI, Italy/Europe, in “POSSE. Politica, filosofia, moltitudini”, a.1, n.1, aprile 2000, p.91.
2) P.Q. HIRST, Globalisation is fashionable but is it a myth?, in “Guardian”, 22.03.1993, p. 11.
3) P. BOURDIEU, Contro la politica dell’antipolitica, in “La rivista del Manifesto”, n. 16, aprile 2001, p. 46.
4) B. CACCIA, Che cosa significa fare come a Seattle, in “POSSE. Politica, filosofia, moltitudini”, a. 1, n. 1, aprile 2000, p. 76.
5) P. BOURDIEU. op. cit., p. 46.
6) A. NEGRI, Italy/Europe, cit., p. 91.
7) F. BERTINOTTI, Conclusioni, in AA.VV., La mondializzazione capitalistica nell’epoca presente, edizioni punto rosso, Milano 1996, p. 78.
8) S. AMIN, La sfida della mondializzazione, edizioni punto rosso, Milano 1995.
9) S. AMIN, I caratteri della mondializzazione capitalistica, in AA.VV., La mondializzazione capitalistica nell’epoca presente, cit. pp. 8-9.
10) A. NEGRI, Empire, intervista rilasciata a L. H. Navarro, “La Jornada”, 12 luglio 2001, trad. it. in “Carta”, a. III, n. 5, luglio-agosto 2001, p. 63.
11) Una rassegna significativa degli studi di Beverly J. Silver e Giovanni Arrighi è contenuta nella nota bibliografica del saggio B. J. SILVER – G. ARRIGHI, The Global Working Class at the Millennium, conferenza tenuta nel gennaio 2000 alla York University di Toronto; trad. it. di S. Liberti, Lavoratori del Nord e del Sud, in “la rivista del Manifesto”, n. 19, luglio-agosto 2001, pp. 18-24.
12) G. RICOVERI, La lezione di Seattle, in “La rivista del Manifesto”, n. 9, settembre 2000, p. 30.
13) Come repliche allo scritto di Cavallaro, risalente al 4 agosto, “Il Manifesto” ha ospitato, fino al momento in cui scriviamo, gli interventi di A. Calafati (7 agosto), P. Costantini (8 agosto), E. Brancaccio (10 agosto), A. Cozzo (10 agosto), M. De Angelis (11 agosto), F. Gesualdi (11 agosto), C. Perugini e F. Musotti (14 agosto), R. Bosio (14 agosto), V. Faranda (15 agosto), S. Saruis (15 agosto), M. Magni (18 agosto).
14) Cfr. F. ENGELS, Il congresso liberoscambista di Bruxelles (1847), in K. MARX – F. ENGELS, Opere, vol. VI, Editori Riuniti, Roma 1973, pp. 299-308.
15) K. MARX, Discorso sulla questione del libero scambio, in K. MARX – F. ENGELS, Opere, vol. VI, cit., p. 482.
16) F. ENGELS, op. cit., p. 308.
17) W. BELLO, I padroni del profitto High Tech, in “Il Manifesto”, 14.06.2001. Cfr. anche M. J. MANDEL, Internet Depression, Fazi, Lecce 2001.
18) J. O’CONNOR, Dopo Seattle negli USA. Non basta internet, in “La rivista del Manifesto”, n. 4, marzo 2000, p. 35.
19) Per quanto riguarda le relazioni “imperiali” fra USA e Asia rinviamo al breve, ma efficace, saggio di E. LUTTWAK, Usa – Giappone – Cina, la strana geometria, in “Limes”(Asia Maior), n. 1, 1999, pp. 149-152.
20) G. LA BARBERA, Schieramenti inediti nella lotta per il fondo monetario, in “Lotta comunista”, n. 355, marzo 2000, p. 15. In questo articolo vengono indagati, in modo particolare, gli schieramenti internazionali che si sono prodotti in relazione all’elezione di Horst Kohler a direttore del Fmi.
21) K. MOODY, On the Eve of Seattle Trade Protests, Sweeney Endorses Clinton’s Trade Agenda, in “Labor Notes” (Detroit), 249, dicembre 1999.
22) J. O’CONNOR, op. cit., p. 36.
23) Cfr. S. FINARDI, L’attacco da destra a Imf e Banca Mondiale, in “ALTERNATIVE europa”, n. 22, giugno-settembre 2000, pp. 19-20
24) L. CASTELLINA, Da Seattle a Porto Alegre. Un passo indietro e due avanti, in “La rivista del Manifesto”, n. 15, marzo 2001, p. 8.
25) D. SANGER, The Shipwreck in Seattle, in “New York Times”, 5.12.1999, p. 14.
26) W. BELLO, I padroni del profitto High Tech, cit..
27) L. VINCI, Seattle, e cioè l’inizio della lotta di classe al governo imperialista dell’economia mondiale, in “ALTERNATIVE europa”, n. 21, maggio 2000, p. 36.
28) D. PALANO, Le talpe della globalizzazione, in “ALTERNATIVE europa”, n. 22, giugno-settembre 2000, pp. 11-13. In questo articolo viene proposta una interessante distinzione fra “movimenti antagonisti” e “antagonismo sociale”.
29) Cfr. B. CACCIA, I linguaggi e le pratiche del conflitto, in op.cit., pp. 72-73. Cfr. anche L. VINCI, op. cit., pp. 39-40.
30) Cfr. L. SPINOLA, I collaborazionisti: quando Ong e business scoprono di amarsi, in “Limes – I popoli di Seattle”, n. 3, 2001, pp. 181- 189.
31) A. K. SEN, Globalmente rassegnati, trad. it. di S. Coyaud, in “Il Sole 24 0re”, 8.07.2001.
32) S. MAFFETTONE, I black blocs, luddisti del 2000, in “Il sole 24Ore”, 29.07.2001, pp. 1-2.
33) S. SILVESTRI, L’Italia esposta a nuove minacce, in “Il Sole 24Ore”, 29.07.2001, pp. 1-2.
34) J. HALEVI, No global e imperialismo, in “Il Manifesto”, 3.08.2001.
35) A. NEGRI, Il dominio e il sabotaggio – Sul metodo marxista della trasformazione sociale, ripubblicato in A. NEGRI, I libri del rogo, DeriveApprodi, Roma 1997, p. 282.
36) Sul numero di “MondOperaio” dedicato in buona parte alla sconfitta elettorale e ai processi di mondializzazione (n. 4/5, n.s. a. 6, luglio-ottobre 2001), nell’editoriale scritto da Luciano Pellicani, dopo una celebrazione della sinistra riformista (“Fortunatamente c’è una sinistra – quella dei Macaluso e dei Colajanni, dei Cafagna e degli Amato – che, sebbene minoritaria, lavora per dare all’Italia un partito socialdemocratico lib-lab e un programma riformatore e al tempo stesso concreto e realistico, il solo che possa sconfiggere la destra.”), è istruttivo ritrovare una dura reprimenda relativa ai vantaggi di cui il Pds avrebbe goduto a causa delle inchieste giudiziarie che, all’inizio degli anni Novanta, colpirono il Psi: “E’ accaduto che le inchieste sulla corruzione politica hanno distrutto il Psi e, contemporaneamente, hanno offerto al Pds la possibilità di candidarsi alla direzione del Paese senza compiere il doveroso e indispensabile lavacro ideologico”.
37) A. BURGIO – C. GRASSI, Radiografia del conflitto sociale, in “Il Manifesto”, 19 luglio 2001
38) P. FASSINO, Il riformismo secondo me, intervista rilasciata a Rina Gagliardi, in “Liberazione”, 30.06.2001, p. 9.
39) V. I. LENIN, Marxismo e revisionismo (1908), in V. I. LENIN, Opere scelte, edizioni “Progress”, Mosca, p. 24.
| |
||
settembre - dicembre 2001