12.12.1998
©1998
- Patrick Boylan – patrick![]() boylan.it
boylan.it
www.boylan.it – Return to Publications Page or Home Page
. In: P. Pierini (Ed.), L'atto del Tradurre, Roma, Bulzoni, 1999, pp. 129-151.
|
12.12.1998
©1998
- Patrick Boylan – patrick |
www.boylan.it – Return to Publications Page or Home Page |
|
. In: P. Pierini (Ed.), L'atto del Tradurre, Roma, Bulzoni, 1999, pp. 129-151. |
|
LA TRADUZIONE IN UN CORSO DI LAUREA IN LINGUE:
BASI SCIENTIFICHE ED IMPLICAZIONI DIDATTICHE
Patrick Boylan
Introduzione
Questo intervento esaminerà le basi scientifiche della traduzione — ovvero della produzione di testi omologhi in codice diverso — alla luce di un modello dell’atto traduttivo incentrato sul sapere prelinguistico del traduttore. Da questo modello deriveranno precise implicazioni didattiche per la formazione dei traduttori nelle Facoltà universitarie di lingue e letterature straniere.
Può destare sorpresa la scelta di incentrare la discussione sulle Facoltà: non hanno indirizzi quadriennali per traduttori e, di regola, le lezioni di traduzione avvengono saltuariamente all’interno delle esercitazioni di lingua o dei corsi di letteratura straniera. Ma proprio per questo motivo può essere utile descrivere un possibile programma universitario, scientificamente fondato e didatticamente efficace. Il ruolo di primo piano che l’Italia è tornata ad occupare sulla scena internazionale ha infatti provocato una pressante domanda di laureati in lingue che sappiano mediare tra culture. Le traduzioni approssimative non sono più tollerate in quei settori dove conta la qualità delle intese.
Questo articolo procederà a ritroso, partendo dalle conclusioni: così si può valutare subito la portata della riflessione teorica che verrà poi svolta.
1.1 Tradurre non è, di per sé, un'arte
La prima conclusione cui giungeremo in questo intervento è che tradurre non è, di per sé, un'arte. Anzi, se i testi da tradurre sono familiari, non è nemmeno un'attività intellettuale particolarmente impegnativa. Non è altro, infatti, che l'atto di proclamare una congruenza tra due ordini di significati, attività che noi pratichiamo quotidianamente senza rifletterci. Ad esempio quando, durante una conferenza, qualcuno ci chiede ciò che il relatore ha appena detto, l'operazione che compiamo d'istinto è in qualche modo una "traduzione": riportiamo parole altrui con parole nostre. E anche se ripetiamo testualmente le parole del relatore, le diciamo in modo diverso: ad esempio con voce bassa ed uniforme per non disturbare. In sostanza, cerchiamo di rendere ciò che secondo noi il relatore ha detto, riportandolo però alla nuova situazione comunicativa. Quest'operazione è, essenzialmente, ciò che io chiamo "tradurre".
Come si vede, è un'attività che, di per sé, non comporta particolari capacità artistiche. Comporta invece — e su questo punto insisterò nel mio intervento — una precisa conoscenza dei connotati linguistico-culturali delle due situazioni comunicative messe in relazione. Anzi, sosterrò che la capacità di individuare analogie tra situazioni comunicative, attraverso l'accurata indagine dei loro connotati linguistico-culturali, è la capacità specifica del traduttore (v. anche Snell-Hornby, 1988:39-63).
Ma è poi vero che le traduzioni non sono mai operazioni artistiche? Chiaramente non è arte la "traduzione" appena descritta, quella di un ipotetico uditore che ridice sottovoce le parole di un conferenziere, riadattandole ai codici del "parlare sottovoce". Ma si potrebbe obiettare che in altri casi, la produzione di un testo omologo in codice diverso è invece un'operazione artistica vera e propria. Pensiamo, ad esempio, alla bellissima traduzione del romanzo di Süskind Il Profumo fatta da Giovanna Agabio: per rendere il linguaggio illuminista dell'originale la traduttrice ha praticamente creato per l'occasione un italiano illuminista; in tal modo è riuscita a far assaggiare al lettore italiano quel modo di discorrere elegante ma asciutto ed incisivo che dà il tono al romanzo come, del resto, dava il tono al Settecento in tutta l'Europa del nord. In una parola, la traduttrice è stata un'artista. La nostra prima conclusione potrebbe dunque apparire a priori del tutto insensata.
Ma qui bisogna distinguere tra lo specifico dell'atto di "tradurre" — ossia la ricerca di omologie tra due sistemi linguistico-culturali in base all'omologia percepita tra due stati esistenziali — dall'atto di "scrivere un testo", ossia l’individuazione di una rappresentazione verbale atta a rievocare un determinato stato esistenziale. Sono cose diverse.
Uno studente di traduzione può essere molto bravo, poniamo, nel trovare equivalenze tra vissuti di sapore francese e gli equivalenti vissuti di sapore italiano: per esempio, può saper mettere in relazione correttamente la distanza interpersonale che intercorre abitualmente tra studenti universitari in Francia e che si manifesta nell'uso prevalente del "Vous", con la corrispondente distanza interpersonale riscontrabile tra studenti in Italia, che si manifesta con l’uso del "Lei" in qualche ambiente ma normalmente con l’uso del "Tu" e il nome dell’interlocutore (oppure, per essere più formale, "Tu" e il cognome). In altre parole, come comparativista di lingue e culture gallo-italiche, il nostro aspirante traduttore può essere abbastanza esperto. Ma è del tutto possibile che, ciò nonostante, egli risulti molto meno bravo come scrittore. Può non trovare con facilità, né in francese e nemmeno in italiano, l'adeguata rappresentazione verbale per gli stati esistenziali che vuole esprimere. Per esempio, nel tradurre un dialogo tra studenti in un romanzo francese, egli può esitare tra l'uso del "Tu" o del "Lei" per rendere il "Vous" nell'originale, proprio perché nella sua vita reale ha forse la stessa difficoltà: facendo la fila, poniamo, alla Segreteria studenti, esita tra l'uso del "Tu" o del "Lei" per rivolgersi alla studentessa trentenne vestita con eleganza che sta dietro a lui; la parola giusta non gli viene spontaneamente; è come se mancassero i circuiti per connettere lo stato in cui intuitivamente egli sente di trovarsi rispetto a quella persona, con l'inventario di parole che intuitivamente sente di avere a disposizione. Per riprendere la distinzione di Saussure (1922), egli è esperto in langue ma gli manca la parole.
Difatti, i docenti che si occupano della traduzione nei corsi di laurea in lingue dicono spesso che i loro studenti hanno soprattutto problemi con l'italiano, non con le lingue straniere. Preciso che, formulata così, l’accusa è, a mio parere, vera ma fuorviante: la carenza non è in italiano ma in educazione linguistica, ossia in "educazione alla parole" (Boylan, 1981). Ciò significa che il rimedio al problema non consiste nel far fare più corsi di grammatica o di letteratura italiana, come qualcuno propone, ma nel sostituire una parte degli insegnamenti tradizionali d’italianistica con corsi di scrittura creativa, di elocuzione e via discorrendo. Comunque, anche se posso dissentire sui rimedi proposti, trovo la diagnosi che si fa abbastanza giusta: le carenze "artistiche" di un testo tradotto sono soprattutto imputabili a carenze — nel traduttore — di capacità espressive nella sua lingua madre.
Pertanto, posta la questione in questi termini, forse non è affatto insensato ipotizzare che l'atto traduttivo in sé sia più scienza che arte. Certo, esso può richiedere capacità artistiche quando il testo tradotto deve avere qualità artistiche, come può richiedere un sesto senso politico se il testo da tradurre è un discorso politico, acume filosofico se il testo finale deve rendere un pensiero filosofico, una visione sistemica dei fenomeni se il testo è un manuale tecnico, ecc. Ma tali capacità sono tutte accessorie. La capacità propria del traduttore, a prescindere dal tipo di testo su cui egli lavora di volta in volta, è un'altra: è, cioè, la capacità ragionata di omologare stati esistenziali e quindi sistemi linguistico-culturali diversi. Questa capacità non si acquista in un programma di formazione per traduttori, coltivando una "sensibilità da scrittore" o l'"acume filosofico" o qualche altra "arte". Essa è di natura scientifica.
Chi dice dunque, senza qualificazione, che tradurre un'opera letteraria è un'arte, dice una mezza verità; di conseguenza dice, per metà, anche una bugia. Nasconde a se stesso (e a chi decide i programmi di formazione in traduzione) che il traduttore, anche di testi letterari, svolge un compito specifico che è soprattutto scientifico, non artistico: l’omologazione di stati esistenziali. Se egli non svolge correttamente quel compito, i testi che produrrà saranno forse artistici (se egli ha doti di scrittore) ma in ogni caso fasulli. Cioè, tutto concentrato sulla propria creatività, egli produrrà testi che svelano il suo mondo interiore più che quello dell'autore dell’originale. Sarà un falsario.
Ritengo altresì che il termine di "traduzione letteraria" sia del tutto improprio e per gli stessi motivi. Una traduzione può essere semantica, comunicativa, letterale o altra; ma è improprio parlare di una "traduzione letteraria" come sarebbe improprio parlare di una "traduzione statistica" o di una "traduzione filosofica", semplicemente perché il testo da tradurre usa le modalità espressive tipiche dell'analisi statistica o della filosofia. La modalità espressiva dei testi non definisce il genere di traduzione da effettuare: questo viene determinato dalla funzione che i testi tradotti dovranno svolgere presso il pubblico destinatario. Se il testo tradotto deve far capire, non il senso del testo originale, ma i meccanismi linguistici della lingua in cui il testo è stato scritto, perché il pubblico destinatario vuole capire come funziona quella lingua, la traduzione sarà letterale; se invece il testo tradotto deve documentare l'espressività e i referenti culturali del testo originale nella loro alterità, perché il pubblico destinatario non vuole o non ha bisogno di intermediazioni da parte del traduttore, la traduzione sarà semantica; se il testo tradotto deve provocare su un pubblico di destinatari generici un effetto reattivo analogo a quello provocato dal testo originale sul pubblico che ha decretato il suo valore, la traduzione sarà comunicativa (Chang 1996) — e via discorrendo. Ognuno di questi generi di traduzione presuppone precise e diverse competenze linguistico-culturali da parte del traduttore, competenze che prescindono dall'ambito e dal linguaggio del testo originale: politico, letterario, sportivo, commerciale, ecc.
I traduttori che insistono sull'uso del termine "traduzione letteraria" tendono a rifiutare distinzioni del genere. Ascoltano con insofferenza — questo, posso testimoniarlo per esperienza diretta — ogni richiamo alla base scientifica dell'attività traduttiva. Negano con sdegno che la traduzione richieda acume più che "ispirazione" e che costituisca un'operazione relativamente semplice una volta individuate e definite le omologie tra i due sistemi linguistico-culturale-esistenziali (la vera fatica del traduttore). Vogliono credere che il processo traduttivo sia squisitamente "artistico" e quindi misterioso; ciò nobilita il loro lavoro e, nel contempo, li dispensa dalla fatica di dissezionare metodicamente la materia prima (linguistica) del testo, sporcandosi le mani. Sposta sull'attività scrittoria — la quale può effettivamente essere artistica a seconda del testo — l'attività propria del traduttore. Anzi, si ha a volte il sospetto che ciò che interessa traduttori di questo genere è esprimere i propri stati d'animo, proiettati anche gratuitamente sul testo da rendere, il quale non viene indagato a fondo nella sua alterità. "Intanto — dicono — mi ci riconosco" ed è proprio questo il guaio: traducono solo ciò che somiglia (o sembra somigliare) a loro.
Concludiamo quindi ribadendo la prima conclusione cui giungeremo: in sé, la traduzione non è arte. Non è nemmeno un'attività riservata a persone con particolari meriti artistico-letterari, salvo se il testo da produrre deve averne. E anche in questo caso, l'atto traduttivo in sé procede anzitutto dall'indagine scientifica, pena la non corrispondenza dei testi: l'invenzione artistica è soltanto una compagna di strada (v. anche Neubert-Shreve, 1992:43).
Se tutto ciò è vero — e dobbiamo ancora dimostrarlo facendo appello ad un modello psicolinguisticamente e gnoseologicamente attendibile dell'atto traduttivo — possiamo sì considerare la traduzione, in fin dei conti, un'attività alla portata di chiunque sappia comunicare. Basta acquisire una specifica preparazione scientifica nonché una padronanza, nella propria madrelingua, dell'ambito e del linguaggio in cui bisogna esprimersi (politico, filosofico, sportivo, romanzesco...). Certo, l'attività di confrontare sistemi linguistico-culturali, come tutte le attività intellettive, presuppone una certa dose d'ingegno e d'immaginazione per cogliere le omologie non sempre evidenti tra stati esistenziali e sistemi espressivi nelle due culture. Ma non è un’operazione misteriosa; non vengono richieste doti riservate ad un'élite. Se questa affermazione può sorprendere, è solo perché siamo tutti un poco come il Monsieur Jourdain di Molière: ignoriamo che l’atto che compiamo automaticamente nella nostra lingua madre riportando un discorso dette in altre circostanze e quindi equiparando de facto due ordini diversi di significato, si chiama, in senso lato, tradurre.
1.2 Scopo di un programma di formazione alla traduzione
La seconda conclusione cui giungerò è che, proprio perché ignoriamo quali sono i meccanismi che mettiamo automaticamente in atto ogni volta che comunichiamo o traduciamo, spesso comunichiamo e traduciamo male. Proprio perché quei meccanismi sono inconsci, non riusciamo a perfezionarli. Pertanto, scopo di un programma di formazione alla traduzione — e, più in generale, di un corso di laurea in lingue — dovrebbe essere quello di dare agli studenti una presa più consapevole sui meccanismi che già utilizzano d’istinto. Ciò comporta, di conseguenza, dare loro anche una presa più consapevole sui sistemi linguistici ed esperienziali che, nel tradurre, metteranno a confronto.
Un'analogia con la fisiologia viene subito in mente: camminare è una complessa e, per certi versi, sofisticata operazione neuromuscolare che tuttavia ognuno di noi pratica adeguatamente senza rifletterci. Ma un professionista del cammino — un maratoneta, per esempio — deve capire a fondo l'operazione del suo sistema nervoso e le relazioni tra i suoi muscoli; deve saper controllare quest'ultimi selettivamente attraverso appositi esercizi. Solo dopo aver acquisito il pieno possesso cognitivo ed esperienziale del suo corpo, egli può dare libero corso al suo ingegno e alla sua immaginazione, nella speranza di trovare l'assetto e i ritmi più idonei per la corsa.
Anche chi si accinge a fare una traduzione ha bisogno del pieno possesso cognitivo ed esperienziale degli strumenti che adopererà, prima di lasciar volare la sua immaginazione. Egli deve avere, cioè, una sicura presa su:
la scienza traduttologica come riflessione e come prassi,
i due sistemi linguistico-culturali da mettere a confronto, nonché
gli ambiti ed i linguaggi specifici del testo da tradurre.
Come dovrebbe essere dunque, per raggiungere queste finalità, un programma di formazione alla traduzione in una Facoltà di lingue? Anzi, per allargare il discorso, come dovrebbe essere articolato un Corso di Laurea in Lingue se questo pretende di formare laureati che siano (anche) capaci di tradurre?
Prendiamo, per cominciare, la terza delle tre competenze appena elencate: la "sicura presa sugli ambiti e sui linguaggi specifici del testo da tradurre". Secondo le associazioni di categoria, di tutte le traduzioni che vengono effettuate ogni anno in Italia, solo il 2% riguarda le opere letterarie, generalmente contemporanee. Se diamo uno sguardo, invece, agli attuali programmi statutari delle Facoltà di lingue, constatiamo che, in linea di massima, essi preparano lo studente soprattutto a commentare opere letterarie, specie di altre epoche. La conclusione non sfugge. Se la terza competenza elencata è davvero un requisito indispensabile, i laureati formati attualmente dalle Facoltà di lingue vanno considerati incompetenti a tradurre il 98% dei testi proposti dal mondo del lavoro. Chiaramente, un programma di formazione alla traduzione in una Facoltà di lingue deve trovare il modo di porre rimedio a questo squilibrio.
Sia ben chiaro: con questo dato statistico non sto affatto proponendo che le Facoltà di lingue diventino professionalizzanti. Non c’è bisogno: lo sono già. Il problema è che preparano con professionalità un’unica figura: quella del commentatore di opere letterarie di altre epoche. Il laureato medio, cioè, sa solo documentare storicamente un brano letterario. Non sa tradurre le lingue con professionalità (donde le proposte di creare appositi indirizzi o corsi di specializzazione), come non sa insegnare le lingue con professionalità o partecipare ad una riunione internazionale usando le lingue con professionalità. Ma lo studente medio di oggi non è più, come una volta, figlio delle classi agiate senz’alcun bisogno di competenze tecniche nella vita se non quelle del filologo (per continuare gli studi letterari dopo la laurea) e di parlatore colto (per frequentare i salotti bene). Egli ha bisogno di una formazione davvero "polivalente" e quindi applicabile a più domini. Nel caso della traduzione, egli ha bisogno cioè di una formazione in tutte e tre le competenze di cui sopra.
Si potrebbe obiettare, naturalmente, che la terza competenza elencata (la padronanza di ambiti e linguaggi) è meno importante della prima (la capacità di indagare scientificamente sui sistemi linguistico-culturali da mettere a confronto). Si potrebbe aggiungere, poi, che se l'Università dà le prime due competenze, non ha bisogno di darne anche la terza: gli studenti potranno sempre imparare in futuro, per conto loro, gli ambiti e linguaggi di cui avranno bisogno.
Ma gli attuali programmi statutari dei corsi di laurea in lingue danno davvero le prime due competenze? Basta consultare le tabelle ministeriali per constatare che le scienze del linguaggio, le scienze antropologico-culturali, le scienze della comunicazione, le scienze interpretative e soprattutto la traduttologia non sono affatto il cardine degli odierni programmi. Nelle Facoltà di lingue questi insegnamenti sono sotto rappresentati o addirittura assenti. Il cardine rimane il commento (e la traduzione semantica) di testi letterari. Il confronto interlinguistico/interculturale viene condotto solo episodicamente e intuitivamente dai professori di letteratura, senza l'appoggio della gamma di scienze appena elencate. Per quanto riguarda quelle scienze che vengono effettivamente insegnate, le lezioni si svolgono purtroppo in un'ottica spesso solo descrittivo-sistematica; sono cioè finalizzate alla langue più che alla parole. Al termine del corso di studio lo studente si trova pertanto con una manciata di sistematizzazioni linguistico-comunicative che non sembrano riferirsi a nulla di concreto, da aggiungere alle nozioni non sistematiche acquisite dallo studio, nei corsi letterari, di opere letterarie concrete. Lo studente non riesce pertanto a crearsi una visione sistematica dell'atto traduttivo, esemplificata dalla pratica.
Non solo, ma la terza competenza che abbiamo elencato — competenza che l'università quasi si picca di non impartire — comprende anche, come abbiamo affermato all'inizio, la capacità di scrivere creativamente nella propria madre lingua, usando le modalità discorsive del testo originale. Nel caso di un'opera letteraria, ciò significa la capacità di scrivere letterariamente. Ma pochi programmi universitari offrono corsi di scrittura creativa in italiano e nessuno offre corsi sulle tecniche per acquisire familiarità con un nuovo ambito e linguaggio settoriale. Con quali risultati, poi? La risposta è facile ad immaginare. Solo gli studenti in lingue che appartengono ad una fortunata minoranza (coloro che hanno "doti naturali" di scrittore) si laureano sapendo tradurre testi — per lo più letterari — in un italiano scorrevole. Gli altri studenti (che sono la maggioranza) si trovano doppiamente esclusi dal mondo del lavoro: sono impreparati per i vari settori non-letterari (da cui provengono il 98% delle richieste di collaborazione) e sono anche impreparati per il settore letterario.
Ciò non significa che questi laureati non fanno mai traduzioni. Ahimè, saltuariamente ne fanno — e anche qui, sappiamo con quali conseguenze dannose. Sappiamo, per esempio, quanto i manuali d’istruzione per apparecchi tecnologici sono di regola mal tradotti e poco adattati al pubblico destinatario — e non solo in Italia: v. Ulijn - Strother 1995 — donde la sotto utilizzazione (o uso erroneo) di questi apparecchi da buona parte del pubblico. Ma il danno non si limita al settore tecnologico. Il professor Dardano di quest'università ha documentato (1998) come la faciloneria dei traduttori della paraletteratura (come le telenovelas americane Dallas e Beautiful o i romanzi rosa americani della Harmony) ha contribuito a cambiare notevolmente la lingua italiana negli ultimi 25 anni, sul piano sintattico e non solo su quello lessicale: una colonizzazione linguistico-culturale svolta, non da stranieri, ma da traduttori italiani usciti da Facoltà italiane di lingue. Ma forse la conseguenza più dannosa perché più insidiosa sono le traduzioni di opere letterarie di qualità, fatte dai laureati in lingue con doti di scrittore: fuorviano senza che il lettore se ne accorga. Le case editrici, poi, raramente esercitano un controllo: riconfermano il traduttore se i suoi testi risultano scorrevoli e quindi contribuiscono al successo delle vendite. Intanto, quello che c'era veramente nell'originale, nessuno lo saprà.
Abbiamo detto, fin qui, che la terza delle tre competenze elencate — la sicura presa sugli ambiti ed i linguaggi specifici del testo da tradurre — richiede una "educazione alla parole" nella lingua madre del traduttore. Ma richiede anche una "educazione alla parole" nelle lingue straniere che il traduttore dovrà adoperare. Quest'affermazione potrebbe sorprendere. Si potrebbe pensare, per esempio, che un traduttore ha bisogno solo di una conoscenza "ricettiva" delle lingue straniere, cioè la capacità di leggerle, non di parlarle creativamente. Ma la glottodidattica insegna che non è così. L'abitudine ad esprimere emotività e volizione — e non soltanto concetti — in una lingua straniera, parlandola in situazioni (o simulazioni) affettivamente connotate, è necessaria per consentire al traduttore, quando legge un testo in lingua, di provare istintivamente l'effetto delle parole che riscontra.
Arriviamo, quindi, al nodo dolente che rischia di condannare alla sconfitta qualsiasi tentativo di formare alla traduzione nelle Facoltà di lingue, almeno in Italia. A differenza di quello che succede negli altri paesi europei, gli attuali programmi universitari italiani, con poche eccezioni, non offrono agli studenti corsi ufficiali di lingua intesa come "lingua viva". I corsi ufficiali riguardano quasi esclusivamente la "grammatica", in senso lato, o la "letteratura" — cioè lo stesso binomio usato da secoli per l'insegnamento delle lingue morte.
Imparare una lingua viva in quanto lingua viva, invece, vorrebbe dire interiorizzarla come microcosmo culturale, diventare cioè capace di esprimersi usando non solo una diversa grammatica ma anche una diversa gamma di valori culturali, la quale colora diversamente l'affettività e la volizione e pertanto la composizione di un discorso. E dal momento che il traduttore deve saper esplicitare le divergenze tra i due sistemi linguistico-culturali che mette a confronto, l'interiorizzazione deve essere non solo esperienziale ma anche consapevole. Questo traguardo va ben al di là del tipo di apprendimento che lo studente può procurarsi viaggiando oppure frequentando una scuola commerciale di lingue o un Centro Linguistico di Ateneo. Ma è un traguardo che un aspirante traduttore, futuro mediatore linguistico tra culture diverse, deve porsi.
Come può un traduttore, infatti, paragonare lingue e culture di cui non è padrone? (Intendiamo sul piano dei valori trasmessi e non solo sul piano della grammatica normativa.) Come può cogliere la specificità dei linguaggi e delle modalità discorsive che connotano un testo, quando non sente il distacco dal linguaggio comune? Come può reagire ad un testo in modo analogo ai destinatari originali se non ha interiorizzato il substrato linguistico-culturale di cui il testo è fatto, espressione di una Weltanschauung? Non c’è dubbio, con anni di studi pazienti di "grammatica" e di "letteratura" un traduttore può sperare di reagire emotivamente — e autenticamente — alla specificità culturale di un testo in lingua, senza avere mai parlato quella lingua creativamente. Così hanno fatto per secoli, del resto, i filologi delle lingue morte. Ma gli studenti universitari oggi non hanno la vocazione filologica e soprattutto non hanno tempo. Bisogna quindi dare loro una conoscenza "sentita" delle lingue vive con metodi antropologici (etnometodologici), che consentono di cogliere, verificare ed interiorizzare dal vivo, sperimentalmente, il senso delle parole e dei discorsi.
Corsi universitari del genere sono possibili: alcuni sono stati sperimentati con successo da decadi (Boylan 1980). Ma tali insegnamenti non hanno quasi mai acquisito lo status di corso ufficiale. Del resto, con poche eccezioni, nessun corso di lingua viva ha mai avuto lo status di "corso ufficiale" nelle Facoltà italiane di lingue (e in ciò sta l’anomalia del Caso Italia). Insisto sul termine "corso ufficiale" perché contano poco i seminari "sperimentali" o le lezioni di lingua svolte da "collaboratori" senza lo status di docente. Gli studenti onorano ciò che l'università onora e si dedicano allo studio in proporzione.
Tiriamo le somme. La seconda conclusione cui giungeremo in questo intervento riguarda dunque il sapere che deve possedere un buon traduttore (e che un valido programma di formazione alla traduzione deve cercare di dare). Tale sapere, abbiamo detto, non è altro che una presa ragionata sui meccanismi di omologazione di senso che ognuno di noi utilizza inconsapevolmente, accompagnata da una presa ragionata su una lingua/cultura straniera e su un ambito/linguaggio settoriale, padroneggiati espressivamente. Vediamo ora come si articola questo sapere in termini disciplinari.
1.3 Linee di un programma universitario di formazione alla traduzione
La terza conclusione cui giungeremo è che, per essere efficace, un programma di formazione per traduttori nelle Facoltà di lingue deve costituire un indirizzo a sé stante del corso di laurea in lingue: non va impostato come specializzazione per laureandi o come titolo post-laurea. Va cioè visto come formazione culturale di largo respiro in cui tecnica ragionata, riflessione analitica ed acume deliberativo si congiungono per formare un laureato completo.
Chiunque abbia insegnato materie linguistiche in un corso di specializzazione post-laurea o in un corso di aggiornamento per insegnanti di lingue della Scuola, sa quanto sia difficile spostare i partecipanti, da una visione statica e normativa delle lingue (visione fondamentalmente idealista), ad una visione dinamica e sperimentale (fondamentalmente materialista). Eppure oggi come oggi un traduttore professionale o un insegnante di lingue può esercitare adeguatamente la propria professione solo se ha fatto suo il secondo modo di vedere le lingue. E’ tramontata, infatti, l’epoca in cui la traduzione veniva praticata soprattutto come ermeneutica di testi "sacri" (e quindi statici); oggi al traduttore vengono richieste, sempre di più, traduzioni comunicative "a geometria variabile" (cioè, adattate alle circostanze di ricezione). Nella stessa maniera, oggi all’insegnante della scuola vengono richieste competenze diverse rispetto al passato: data la globalizzazione dell’economia, un corso di lingua correttamente impostato deve consentire agli allievi di adattarsi non ad una sola norma (ad esempio, l'inglese della Regina), ma alle diverse norme che esistono (l'inglese australiano, l'inglese dell'India, l'inglese "lingua franca" dei congressi internazionali); gli allievi, cioè, devono saper cogliere e vagliare sperimentalmente gli specifici usi linguistici che incontrano per poi crearsi norme ad hoc.
Se tutto ciò è vero, come mai succede allora che, nei corsi di specializzazione per traduttori oppure nei corsi di aggiornamento per insegnanti di lingue, le persone che oppongono maggiore resistenza all'acquisizione di una visione dinamica e sperimentale dei fenomeni linguistici, sono proprio i laureati in lingue? Escludo che si possa considerare queste persone particolarmente ritrose o culturalmente arretrate. La risposta è senz’altro da ricercarsi in una "deformazione professionale" da loro subita. E’ dovuta, cioè, ad un’abitudine — inculcata per otto anni a scuola e per l’intera durata dei loro studi universitari — a concepire i discorsi che produciamo, quando interagiamo, come "testi", cioè come qualcosa di fisso su carta, d’incorniciato tra quattro margini bianchi, qualcosa da contemplare ma non da riscrivere. La rigidità dei laureati in lingue dimostra, cioè, quanto la loro formazione non sia stata "polivalente", come si pretende, bensì estremamente focalizzata sulle sole capacità filologiche. L’unilateralità della formazione consentita dagli attuali Statuti dei corsi di laurea in lingue si manifesta palesemente nello svolgimento degli esami (quelli che contano: gli orali di Lingue e Letterature Straniere): i docenti ufficiali esigono dagli studenti due competenze soltanto, quella di saper commentare in italiano un’opera letteraria scritta in lingua (prendendo spunto da ciò che i critici letterari hanno detto a riguardo) e quella di saper tradurre — semanticamente — un brano tratto dall’opera stessa, considerata quindi un "testo sacro" (Newmark 1988). La forma mentis così acquisita segnerà poi questi laureati nel loro futuro lavoro come traduttori o insegnanti di lingue nella scuola; difficilmente essi riusciranno ad abbandonarla nei corsi post-laurea di aggiornamento o di specializzazione — donde la rigidità che di solito essi manifestano.
Pertanto, se un programma universitario mira a formare traduttori di testi contemporanei — vale a dire traduttori con una visione dinamica e sperimentale delle lingue e della comunicazione — urge offrire un percorso totalmente alternativo a quello statutario e ciò sin dal primo anno del corso di laurea. Il percorso può essere articolato in cinque filoni principali:
I. Corsi quadriennali delle singole lingue (insegnate per essere interiorizzate antropologicamente come microcosmi culturali), svolti da docenti ufficiali;
II. Corsi di educazione alla parole nella madre lingua degli studenti: Scrittura creativa, Elocuzione pubblica, Editing, Stilistica dei generi, Linguaggi settoriali (il che comprende anche un'introduzione agli ambiti trattati — economico, politico, cinematografico... — nonché l’acquisizione delle tecniche per imparare rapidamente altri linguaggi settoriali), ecc.;
III. Corsi a moduli in cui ciascuna lingua viene studiata con gli strumenti delle:
scienze del linguaggio: Linguistica descrittiva, Sociolinguistica, Storia della lingua per area linguistica, ecc.;
scienze antropologico-culturali: Etnologia, Antropologia filosofica, Culture comparate (ivi comprese le letterature) per area linguistica, ecc.;
scienze della comunicazione: Pragmatica, Retorica, Comunicazione interculturale, ecc.;
scienze interpretative: Ermeneutica, Critica letteraria, Semiologia, ecc.
Queste discipline non verranno insegnate in quanto tali ma in quanto sostegni dell’atto traduttivo. Per esempio, la linguistica descrittiva tratterà soprattutto temi come la Textlinguistik (Dressler 1972) o la teoria degli attanti.
IV. Corsi di traduttologia, raggruppati sotto due capi:
Linguistica applicata: Modellazione del processo traduttivo, Risoluzione dei problemi traduttivi per tipo, Epistemologia dell'atto traduttivo, ecc.;
pratiche lavorative: Ricerca delle fonti documentali, Indagine del mercato librario e profilo del pubblico destinatario, Editoria cartacea ed audiovisiva, Traduzione assistita dal computer, Adattamento per il doppiaggio, Deontologia professionale, ecc.
V. Corsi sulle pratiche traduttive, per area linguistico-culturale, finalità traduttiva e modalità discorsiva, con relative esercitazioni: questi corsi rappresentano una continua sintesi, durante l'anno, di quanto viene insegnato nei filoni precedenti. Vanno pertanto affidati a docenti ufficiali.
Questa descrizione del contenuto di un ipotetico programma vuole dare concretezza alla nostra prima affermazione: tradurre, di per sé, non è un’arte; richiede l’impiego di un'accurata preparazione scientifica per indirizzare correttamente l'ingegno alla ricerca di accostamenti indovinati. Nell’atto traduttivo l'uso dell'ingegno e dell'immaginazione è simile alla creatività del chimico che scopre relazioni tra le sostanze fino ad allora sconosciute: più che arte, è una creatività che si può chiamare "acume deliberativo".
I programmi universitari di traduzione che circolano oggi in forma di bozza non offrono neanche lontanamente il ventaglio ricco di discipline di sostegno che abbiamo appena illustrato. Il pilastro di questi programmi rimane la metodologia tradizionale dell'"apprendimento attraverso l'esempio". In questo tipo di insegnamento, gli allievi svolgono a casa la traduzione di testi discussi tematicamente in aula; le traduzioni vengono poi "corrette" collettivamente in classe, parola dopo parola, riga dopo riga, paragrafo dopo paragrafo, da professori che proclamano la versione "migliore" (generalmente la loro) su basi di solito impressionistiche. Ogni tanto vengono fatte analisi sistematiche interculturali di carattere grammaticale o pragmatico o sociolinguistico, ma raramente legate tra di loro. Gli studenti più intuitivi vanno avanti proprio perché intuitivi: colgono ciò che non viene esplicitato. Gli altri studenti — solitamente la maggioranza — soccombono perché sorretti dal nulla. Davanti al conseguente livellamento verso il basso della classe, i professori si disperano. Poi alzano le spalle e proclamano che non c'è rimedio, intanto la traduzione è un'arte accessibile solo a pochi eletti. Dopo quattro e più anni di non-insegnamento di questo genere, le Facoltà di lingue sfornano alcuni bravi laureati e molti ciarlatani, proprio come facevano le Facoltà di medicina secoli fa, quando insegnavano la loro disciplina soltanto tramite l'esempio, col pretesto che la medicina è un'arte.
Abbiamo illustrato in dettaglio un possibile programma universitario di formazione alla traduzione anche — e soprattutto — per rendere concreta la terza conclusione di questo intervento: è effettivamente possibile creare un indirizzo di traduzione che abbia lo stesso valore formativo degli altri indirizzi del corso di laurea in lingue, sia per quanto riguarda la ricchezza del patrimonio culturale che rappresenta, sia per quanto riguarda la preparazione critica che consente agli studenti di acquisire. Ciò legittima la proposta che avanziamo qui di offrire una formazione alla traduzione comunicativa sin dal primo anno degli studi universitari, come alternativo agli attuali indirizzi statutari.
Certo, se i professori di oggi, nelle Facoltà di lingue, avessero studenti come quelli di qualche generazione fa — come Antonino Pagliaro, per fare un nome (De Mauro - Formigari, 1994) — sarebbe meno urgente progettare percorsi alternativi. Infatti, con studenti così motivati, sarebbe facile impostare un corso di filologia o di letteratura straniera in senso autenticamente umanistico: cioè come indagine aperta sul senso delle parole di un testo (il quale viene visto, poi, sia come indizio sia come espressione di una cultura in movimento). Anzi, un insegnamento filologico impostato in questi termini, pur riguardando le lingue morte, consentirebbe senz’altro agli studenti di cogliere il senso dinamico e sperimentale delle lingue vive. Studenti così formati potrebbero sicuramente cimentarsi in traduzioni di testi contemporanei di qualsiasi genere, poiché sarebbero in grado di dotarsi autonomamente dei mezzi necessari.
Ma gli studenti di oggi non sono degli Antonino Pagliaro e tanto meno degli Angelo Poliziano: non per carenze loro, ma semplicemente perché sono espressione di una società che ha mutato la natura del sapere che intende privilegiare e coltivare. Davanti ad una platea di studenti di cui solo una minoranza s'interessa sinceramente di studi filologico-letterari, i docenti di lingue hanno dovuto annacquare col tempo i loro insegnamenti: sono giunti oggi ad insegnare non più la filologia ma soltanto la storia della filologia. Cioè, un ornamento culturale, non la disciplina formatrice voluta da Poliziano.
Riteniamo di poter affermare, dunque, che — fatta eccezione per quegli studenti che abbiano autentici interessi filologici e che pertanto sappiano ricavare dagli studi letterari ciò che tali studi una volta offrivano a tutti — l'attuale orientamento delle Facoltà di lingue, all’epoca dell’istruzione universitaria di massa, ostacola la corretta formazione di traduttori "comunicativi", persino di traduttori comunicativi di testi letterari. Il programma appena illustrato vuole suggerire un possibile percorso di studio alternativo, di pari valore culturale ma orientato allo studio dei fenomeni linguistici in divenire.
1.4 Anche l’ingegno è, in buona parte, suscettibile di apprendimento
La quarta conclusione cui giungeremo in questo intervento è che la capacità che abbiamo chiamato fin qui "ingegno" — capacità sorretta ed indirizzata da un’accurata preparazione scientifica — può, almeno in parte, essere appreso anch'esso. Si tratta, infatti, di un "acume deliberativo", quindi di un sapere non esclusivamente intuitivo. Nella classificazione aristotelica (Etica nicomachea, VI, 1140a), questo genere di sapere viene chiamato phronesis e si distingue sia dal sapere denominato techne (il saper fare strumentale), sia dal sapere denominato episteme (il sapere ragionato e dimostrabile), sia infine dal sapere denominato comunemente intuizione (la percezione immediata).
Ma perché questa capacità venga effettivamente insegnata nei programmi universitari di lingue, occorre che le Facoltà allarghino la loro visione di ciò che costituisce un sapere e quindi di ciò che può costituire una lezione. Ad esempio, non è possibile insegnare l’"acume deliberativo" dall'alto di una cattedra; né è possibile farlo attraverso la mera pratica. Occorre portare gli studenti ad acquisirlo attraverso le sperimentazioni controllate e guidate.
Un esempio renderà subito chiare queste distinzioni. Se, in un corso universitario di chimica, proponiamo di trasmettere agli studenti soltanto una descrizione delle proprietà delle sostanze visibili, le lezioni possono benissimo svolgersi ex cathedra. Al termine di un corso del genere, il sapere impartito sarà in parte nozionistico (cioè, un pre-sapere) e in parte epistemico (cioè, un sapere ragionato): i buoni studenti sapranno recitare a memoria le tavole periodiche e dimostrare, in sede di esame, la coerenza di una formula. Ma sicuramente non sapranno impostare una ricerca per verificare le nozioni assimilate a parole né tanto meno indagare sugli elementi per conto proprio in laboratorio. Oppure, invece della lezione ex cathedra, possiamo proporre agli studenti un insegnamento tutto basato su esercitazioni pratiche di laboratorio. Ma è probabile che, al termine del corso, gli studenti sapranno sì maneggiare provette e strumenti di misurazione, ma non sapranno usare questo saper fare tecnico per impostare una ricerca o per indagare sugli elementi in maniera originale.
Invece una terza via — sicuramente la migliore — consisterebbe nel guidare gli studenti (dapprima in aula e poi in laboratorio) mentre impostano e poi conducono ricerche sperimentali, miranti a definire le proprietà delle sostanze o a verificare la validità degli strumenti di misura. Un insegnamento di questo tipo, oltre a far acquisire le stesse nozioni assimilate con il primo metodo, nonché le tecniche acquisite con il secondo metodo, consentirebbe agli studenti di interiorizzare la chimica come "atteggiamento verso la natura", cioè come predisposizione a porre le domande giuste e a saper scegliere i procedimenti idonei per venire a capo delle domande. Ovviamente non si tratta di far ri-inventare la chimica attraverso infinite sperimentazioni. Occorre prevedere anche momenti di studio mnemonico, quando cioè gli studenti avranno costruito reti associative esperienziali in cui riescono a situare le nuove nozioni. Questa rete costituisce il sapere che abbiamo denominato phronesis o "acume deliberativo" — sapere cardine che, purtroppo, viene generalmente trascurato nei corsi di laurea, con i noti risultati (laureati con un buon bagaglio di nozioni e di tecniche ma che non sanno utilizzare).
Nell'insegnamento della traduzione, l’uso di tecniche come il problem solving i case-based studies, le simulazioni — tutte quante tecniche indirizzate all'acquisizione di un "acume deliberativo" — potrebbe risvegliare le doti d'ingegno e d'immaginazione latenti in molti studenti. Sia ben chiaro: non si pretende di fare miracoli; è ovvio che, quand’anche tutti gli studenti possano imparare a tradurre decorosamente, non tutti saranno dei traduttori raffinati. Ma se accettiamo di eliminare il dominio dell’insegnamento epistemico (che, del resto, è solo pseudo-epistemico nelle scienze umane) per alternarlo con momenti d’insegnamento incentrati sulla phronesis e sulla techne, daremo a tutti gli studenti un’effettiva possibilità di coltivare tutto l'ingegno che hanno. Anche il filone III è idoneo ad un’insegnamento del genere.
2. Un modello del processo traduttivo
Le quattro conclusioni appena illustrate, che chiamano in causa la maniera tradizionale di vedere e d’insegnare la traduzione, possono provocare sdegno, destare perplessità o suscitare interesse, a seconda del rapporto che si ha, appunto, con le tradizioni. Sarebbe ingiusto, tuttavia, scartarle — o approvarle — sulla base di quanto esposto finora. Infatti, la modalità espressiva usata fin qui si è volutamente basata su entimemi e appelli all'affettività, come la retorica classica consiglia di fare inizialmente davanti ad un pubblico incerto. Ora però possiamo procedere alla dimostrazione di quanto affermato. Intendiamo elaborare un modello del processo traduttivo, giustificarlo in termini psicolinguistici e gnoseologici e poi trarne le conclusioni pedagogiche — quelle appena presentate — per un futuro programma universitario di formazione alla traduzione.
[La seconda parte dell'intervento verrà pubblicata in altra sede. Per avere un’idea delle argomentazioni usate, presentiamo di seguito i lucidi e il handout usati nell’intervento svolto al Simposio sulla Traduzione il 12.3.98.]
LUCIDO 1. PASSAGGI "TRADUTTIVI"

A U T O R E L E T T O R I
.............................¯...........................................................¯...................................
* STATO ---------1------------->
ESPRESSIONE ---------2----------->
STATO
X
X
X’
3
3
3
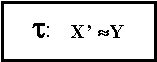
3
3
3
**STATO------------4---------->ESPRESSIONE----------5------------->STATO
Y
Y
Y’
*Matrice linguistico-culturale in cui nasce il testo originale ® lingua di partenza (LP)
**Matrice linguistico-culturale nella quale nasce il testo tradotto ® lingua di arrivo (LA)
1. L’autore "traduce" lo stato esistenziale X con l’espressione X (proclamando che X = X)
2. I lettori "traducono" l’espressione X in stato esistenziale X’ (danno un loro senso a X)
3. Il traduttore (uno dei lettori) traduce lo stato X’ nello stato analogo Y (X’ » Y).
Qui avviene il vero atto traduttivo t . Infatti, le altre "traduzioni" sono in realtà transcodifiche. La traduzione, come equiparazione di valori, è pragmatico/esistenziale, non linguistico. Sembra linguistico poiché stati X’ e Y si afferrano solo attraverso le loro espressioni.
4. Il traduttore (ora diventato il sosia dell’autore, ossia uno scrittore con il diritto e il dovere di plagiare l’opera dell’autore) "traduce" lo stato Y in espressione Y (proclama "Y=Y").
5. I lettori "traducono" l’espressione Y in stato esistenziale Y’ (danno un loro senso a Y).
Se l’autore fornisce il traduttore con un testo scritto male (cioè, non è vero che X=X come lui proclama: è il caso di molte lettere commerciali e persino di molte relazioni congressuali), il traduttore ha interesse a riscrivere il testo per chiarire il pensiero dell’autore. Deve cioè fare lo editing — ripercorrendo la fase 1 — possibilmente dopo aver intervistato l’autore per cogliere lo STATO X. In ogni caso, il traduttore prende sempre a testimonianza del senso dell’ESPRESSIONE X un lettore modello della cultura di partenza (anche immaginario), che non sia l’autore e che sia il più vicino possibile al pubblico destinatario della traduzione nella cultura di arrivo. Fase 2 è quindi una ricostruzione del senso, ma non filologica in quanto la costituzione del lettore modello determina la percezione del testo e quindi l’assegnazione del senso (il valore X’ non sarà mai uguale a X che rimane un ignoto). Fase 3 è già stato commentato. Fase 4 è la fase della scrittura creativa, la quale però viene condizionato dall’anticipazione del fase 5. Infatti, il traduttore, nel raffigurare le attese e il livello di preparazione del pubblico destinatario, costruisce un destinatario modello che "detta" le scelte espressive da operare nel fase 4. Nell’anticipare 5 il traduttore fa una "indagine del mercato", a meno che il committente non abbia già definito il lettore target.
Il presente schema si basa su recenti ricerche in psicologia cognitiva tendente a dimostrare la natura affettiva e volitiva della conoscenza. Vedi ad esempio Wermus (1997).
LUCIDO 2. GENERI DI SAPERE
saper scegliere = PHRONESIS = ©
saper costruire = TECHNE = ª
saper dimostrare = EPISTEME = ¨
Materia ¬ scienze della natura ª +¨ ma in realtà: © poi ª +¨
Volontà ¬ scienze morali*: ª +© [tendenza moderna: © +¨]
*o "scienze umane", dominio dell’ermeneutica
Sapere Traduttivo:
indagare discorsi = ª +© [¨ ], tradurre = © , creare discorsi = ª oppure ª +©
Le distinzioni illustrate nel LUCIDO 2 mirano ad accreditare la "scientificità" dell’atto traduttivo. Si basano sulla lettura di Aristotele in Gadamer (1966). Gadamer non solo ridimensiona il carattere epistemico delle scienze della natura (il loro sapere è epistemico solo in modo ancillare) ma fonda il sapere proprio delle scienze morali (da mos/moralis, costumi) nella phronesis. La traduttologia ha un triplo status epistemologico.
[I lucidi illustrano le giustificazioni psicolinguistiche e gnoseologiche del modello traduttivo presentato qui. Tuttavia, la validità (o meglio, il "senso") di queste giustificazioni dipende in prima istanza da come noi definiamo gli oggetti del nostro discorso traduttologico, nonché da ciò che premettiamo al riguardo. Vengono pertanto esplicitate qui di seguito definizioni e premesse.]
HANDOUT
GLI
OGGETTI DEL DISCORSO
(e le nostre PREMESSE)
(SIGLE: LA, CA = lingua, cultura di arrivo LP, CP = lingua, cultura di partenza)
Def. 1 Per "testo" s'intende un macro-enunciato (insieme coerente di sintagmi predicativi) che proclama una intenzionalità comunicativa unificatrice. V. Dressler [1974:9]: un "testo" è qualsiasi "enunciato conchiuso"; ma id. p.25. Il singolo enunciato, se è testo, è comunque doppio poiché dialogico: il contesto costituisce un "enunciato tematizzante". Esempio: cartello stradale "STOP" ® tema = l’incrocio; rema = l’ingiunzione a fermarsi lì.
Def. 2 Per "opera" s'intende un testo in quanto macro-segno (insieme coerente di figure o procedimenti espressivi) che riveste un significato tipico (un genere discorsivo ed un quadro unitario referenziale-esistenziale) e un senso proprio (una specifica attualizzazione delle potenzialità espressive del significato, che rende manifesta l'intenzionalità comunicativa). (In seguito: ~ "congruente", » "simile", = "uguale", º "identico")
Testo » Opera (ogni parlare è poiesi).
Opera º testo canonicamente formalizzato (v. il concetto di genres)
Esempi di testi: preghiere; diari; conversazioni...
Esempi di opere: preghiere liturgiche, diari letterari, conversazioni radiofoniche...
E' l'intenzionalità comunicativa che fa percepire il genre (Aristotele, Poetica). E' l'effetto reattivo (catartica, epistemica o volitiva, a secondo del tipo di testo: espressivo, rappresentativo o appellativo; v. Bühler 1934) che fa ravvisare l'intenzionalità comunicativa.
Le definizioni 1 e 2 danno i seguenti postulati ®
I. Condizione necessaria e sufficiente perché una traduzione si chiami tale:
* omologia dell'intenzionalità comunicativa.
* quindi, omologia dell'effetto reattivo provocato dal testo.
II. Ordine di priorità decrescente, nel tradurre:
(1) intento comunicativo Testo A ~ Testo B se (1) in A = (1) in B.
(2) Weltanschauung Testo A » Testo B se (1, 2) in A = (1, 2) in B.
(3) testualità Testo A = Testo B se (1, 2, 3) in A = (1, 2 ,3) in B.
(4) enunciazione Testo A º Testo B se (1, 2, 3, 4) in A = (1, 2, 3, 4 ) in B.
Def. 3 Per "intenzionalità comunicativa" s'intende il principio organizzatore della finalizzazione dei messaggi evidenziato dalla reazione suscitata dal testo nei "lettori di riferimento" del traduttore, reazione che egli fa sua.
Nota: L'intenzionalità comunicativa è la creazione del fruitore. NON corrisponde necessariamente all'intenzionalità comunicativa proclamata dall'autore (per Kafka la Metamorfosi era comica; una lettera commerciale contraddittoria è limpida per il manager che l’ha scritta). Né presuppone l'esistenza di un "autore" (l’Iliade; le poesie automatiche). Vedi Sechehaye (Amacker 1985): è l'ascoltatore, non il parlante, a "inventare" il neologismo. Cf. anche la visione goethiana dell'artista, "inconsapevole sonnambulo", in Gadamer 1989:123.
Def. 4a Per finalizzazione (nel senso di "causa finale apparente") s'intende, con Aristotele, la ragione primaria di un'attivazione di mezzi oppure, per uscire dalla tautologia fine/mezzi: ciò verso il quale tende un'entità in divenire per il suo compimento, vale a dire, per potersi chiamare come tale. Implicita in questa impostazione ®
* impossibilità di discorrere su "ciò che è" (conoscibile in "ciò che appare")
* limitazione dei discorsi scientifici: elaborazioni di "ciò che si dice" di "ciò che sembra manifestarsi" — v. l'Aristotele di Weil (1990: 110).
Perciò la "finalizzazione" di un testo è solo ciò che un soggetto (tramite i suoi "lettori di riferimento", anzitutto interni, e all'intero di uno schema percettivo culturalmente determinato) percepisce reattivamente come funzione catartica/epistemica/volitiva e che attribuisce ad un ipotetico "disegno" (all'"intenzionalità comunicativa" di un presunto "autore").
Compito primario del traduttore: alterare la propria determinazione culturale. Dal momento che egli riprodurrà nel testo LA la finalizzazione che egli stesso attribuisce al testo LP, sulla scorta dell'effetto reattivo percepito, egli deve dapprima introiettare il sistema di valori di un "lettorato di riferimento" LP, scelto per congruenza con i destinatari del testo LA.
Def. 4b Per finalizzazione (nel senso di "traguardo perseguito") s'intende lo scopo per il quale un'opera viene soggettivamente realizzata; nel caso del traduttore eterocentrico, gli scopi comunicativi che egli persegue nel dare forma al testo LA, vengono determinati dai bisogni (conoscitivi/emotivi/volitivi) dei suoi destinatari reali o presunti. Questi bisogni stabiliranno anche il tipo di traduzione da svolgere. Ne seguono i quattro generi principali.
Def. 4c La "traduzione comunicativa" è la produzione di un testo in LA pragmaticamente omologo ad un originale in LP; è illocutoriamente e perlocutoriamente omologo all'originale sul piano degli enunciati e comunque, sul piano del macro-enunciato (cioè, del testo), omologo nella finalizzazione dei messaggi. E’ il genere più richiesto oggi.
Def. 4d La "traduzione d'autore", caso limite della traduzione comunicativa, è la riscrittura di un'opera LP nella LA, aggiungendo agli enunciati e alle figure originali una plusvalenza catartica/epistemica/volitiva tesa a salvaguardare o ad accrescere l'effetto reattivo provato dal destinatario modello (che di norma è l'alter ego LA del traduttore stesso). In pratica, il traduttore viene pagato per scrivere per sé. (In realtà, scrive a sua insaputa per destinatari ben precisi, individuati dall’Editore che l’ha scelto come traduttore.)
Def. 4e La "traduzione semantica" è la restituzione del testo originale come semplice "documento" in LA, ossia come testo pragmaticamente autoreferente. Così tradotto, il testo in LA può servire da "reperto linguistico-culturale", consentendo a chi non conosce la LP di avvicinarsi alla materialità dell'espressione e alla specificità dei richiami culturali nell'originale. La traduzione semantica tratta ogni opera come "testo sacro".
Def. 4f Un "testo sacro" è una Parola autorevole che va mantenuta nella sua alterità per consentire future esegesi. Vanno lasciate volutamente ambigue le ambiguità denotative del testo originale e, sul piano connotativo, vanno lasciate aperte a molteplici soluzioni la finalizzazione (catartica, epistemica, volitiva) del testo nonché la finalizzazione (illocutoria, perlocutoria) dei singoli enunciati. Il testo sacro esige la traduzione semantica.
Def. 4g La "traduzione letterale" è la ricerca di corrispondenze morfosemantiche biunivoche tra i testi LP e LA, vincolata solo dagli asservimenti lessico-sintattici (servitudes grammaticales) intrinseci alle due lingue. La traduzione semantica non è affatto una traduzione letterale: esclude l'adattamento ma ammette la trasposizione, l'equivalenza e la modulazione. La traduzione letterale invece esclude tutti e quattro i procedimenti. Produce il "nonsenso grammaticalizzato" utile solo per analisi metalinguistiche.
Def. 5a Per "lettori di riferimento" s'intendono quei lettori LP/CP (reali o potenziali) del testo originale i quali, per le loro conoscenze linguistico-enciclopediche e per le loro attese cognitive/emotive/volitive, più si avvicinano ai destinatari LA della traduzione.
I lettori di riferimento sono, nella CP, i sosia dei destinatari nella CA. Il traduttore italiano sceglierà, quindi, come lettori di riferimento per tradurre dal tedesco le fiabe dei fratelli Grimm, bambini tedeschi di oggi (non bambini dell’800 e non adulti) se i destinatari del testo tradotto saranno dei bambini italiani di oggi; oppure bambini tedeschi dell’800 se il testo deve essere letto in uno spettacolo per le scuole sul Zeitgeist romantico tedesco; o ancora studiosi tedeschi di folklore se il testo tradotto è destinato a studiosi italiani del folklore: leggerà cioè le fiabe con gli occhi di quei soggetti tedeschi che più gli consentono di cogliere nelle fiabe ciò che gli specifici destinatari italiani coglierebbero se sapessero il tedesco e se avessero il retaggio culturale di quel lettorato di riferimento.
Corollario: Non esiste né l'autore né il testo: esiste solo un-testo-letto-da-qualcuno, cioè da qualcuno che asserisce di vedervi una "intenzionalità soggettiva" (l'autore-nel-testo). Il traduttore coglie l’intenzionalità soggettiva attraverso l’effetto che il testo produce in lui.
Def. 5b Il "Coro di voci interiori" del traduttore (quale lettore) è più che le voci dei lettori di riferimento; è l'insieme delle voci dinamizzate dalle parole del testo e che conferiscono al testo il suo colorito. Le voci del coro provengono dalla
Def. 5c * "Cultura di Partenza" ("CP", la cultura in cui è nato il testo), che il traduttore ha sentito in situazioni CP reali e poi "risentito" leggendo testi CP, nonché dalla
Def. 5d * "Cultura di Arrivo" ("CA", la cultura dei destinatari e, di norma, anche del traduttore), ossia la voce dei "delegati CP" nella CA.
Coro ¹ associazionismo (alla Hume). Coro = linguaggio voluto. Capire fino in fondo un testo è capire, in fin dei conti, perché lo si vuole leggere; nel caso della lettura/traduzione, è capire perché determinati destinatari CA (e quindi i loro sosia CP) vorrebbero leggerlo.
Conclusione ® Ogni lettura è largamente arbitraria poiché
fondata su una scelta arbitraria di "lettori di riferimento", determinata dai profili/bisogni di destinatari casualmente offertisi come committenza;
effettuata con l'ausilio di referenti semantici casualmente reclutati negli anni (o reclutati per l’occasione), ossia con l’ausilio di un Coro di voci interiori arbitrarie, tra cui bisogna scegliere i solisti. Il traduttore è, volente o nolente, l'uomo libero degli esistenzialisti.
Def. 6a Per "destinatari prefigurati" s'intendono gli utenti (reali o presunti) per i quali la traduzione viene svolta, i quali costituiscono il referente primario per le scelte espressive del traduttore; in virtù di ciò, determinano anche la scelta dei "lettori di riferimento" del testo originale, tra tutti i possibili referenti semantici convenuti dal testo.
Def. 6b Il "destinatario prefigurato CA" spurio è una figura funzionalmente equivalente a quella legittima ma che compromette la resa qualitativa della traduzione in quanto insufficientemente precisata o attendibile sul piano linguistico-culturale CA:
insufficientemente precisata = il traduttore naïf che scrive per "chiunque";
inattendibile = l'autore o il committente naïf che s’impone come pseudo-destinatario LA, obbligando il traduttore a scrivere per lui (dal momento che non sa la LA, chiede al traduttore di fare una traduzione in senso inverso per simulare la lettura del testo tradotto).
Def. 7 Per "traduzione egocentrica", perciò, s'intende la definizione dei contenuti del testo LP e dei criteri per la loro trasposizione in un testo LA, da parte di chi non si è dislocato psicologicamente in un "lettore di riferimento LP" e in un "destinatario prefigurato CA" ben definiti e autentici. (V. egocentrismo in Piaget/Vygotsky, 1984).
Il traduttore scrive sempre per un "destinatario prefigurato" CA. Se non è reale o comunque presunto, è spurio. Il traduttore dilettante scrive per il proprio alter ego CA indistinto; l'autore ingenuo fa tradurre per il proprio ego, onnisciente e pseudo-bilingue. La traduzione egocentrica, rivolta ad un destinatario spurio, è quella più diffusa in Italia oggi.
Def. 8 Tradurre un testo comunicativamente, invece, è l'atto di omologare il suo "senso" intenzionale ed il suo valore espressivo, socialmente ratificati in prima istanza da un lettorato che funge da "referente semantico", presso un lettorato di diversa lingua e cultura, detto il "destinatario", che funge da "referente espressivo". E' anzitutto phronesis poiché il traduttore deve operare una doppia immedesimazione culturale:
(1) nell'"autore", cioè, nell'intenzionalità comunicativa dell'opera originale (attestata dai "lettori di riferimento" scelti per similitudine ai destinatari prefigurati, tra tutti i "referenti semantici" a disposizione del traduttore); così, il traduttore diventa capace di generare a sua volta un testo con finalizzazione omologa a quella del testo originale;
(2) poi nei destinatari — cioè, nei "referenti espressivi" prefigurati dal traduttore su indicazione del committente della traduzione, in base a congetture sul presunto lettorato, o come sdoppiamento di se stesso — così da trovare un linguaggio ed un impianto discorsivo per la versione tradotta che abbiano un'efficacia pragmatica omologa a quella originale.
_____
BIBLIOGRAFIA
Amacker R. (1985), "Créativité de l'auditeur selon Albert Sechehaye", in: AA.VV., Bollettino della SLI, 30-35.
Boylan P. (1981), "La nozione di 'educazione linguistica' come base della didattica sia dell'italiano che delle lingue straniere" in: M. Castelli - F. Lorenzi (a cura di), Plurilinguismo e Scuola, Firenze, Nardini, 202-227.
----- (1998), "Learning Languages as 'Culture' with CALL" in: L. Calvi (a cura di), CALL, Culture and the Language Curriculum, London, Springer , 60-72.
Bühler K. (1934), Sprachtheorie, Jena, Verlag von Gustav Fischer.
Chang N.F. (1996), "Towards a Better General Theory of Equivalent Effect", Babel 42:1, 1-17.
Dardano M. - Frenguelli G. - Perna S. (1998), "L’italiano di fronte all’inglese alle soglie del terzo millennio", (manoscritto).
De Mauro T. - Formigari L. (1994) Italian Studies in Linguistic Historiography, Münster, Nodus Publikationen.
Dressler W.(1972), Einführung in die Textlinguistik, Tübingen, Niemeyer.
Gadamer H.G. (1960), Warheit und Metode, Tübingen, Mohr (Paul Siebeck).
Neubert A. - Shreve G. (1992), Translation as Text. Kent (Ohio), Kent State Univesity Press.
Piaget J. (1984): "Commenti alle osservazioni critiche di Vygotsky", Appendice in: L.S.Vygotsky Pensiero e linguaggio, Firenze, Giunti Barbèra.
Saussure F. de (1922), Cours de linguistique générale, Paris, Payot.
Snell-Hornby M. (1988), Translation Studies. An Integrated Approach, Amsterdam. John Benjamins.
Süskind P. (1988), Il profumo, traduzione di Giovanna Agabio, Milano, Tea (originale: Das Parfum, Zürich, Diogenes Verlag,1985).
Weil E. (1970): Aristotelica, in: Essais et conférences, Paris, Plon.
Wermus H. (1997), "Representations, beliefs and hindrances in understanding", Cognitive systems, 5/1, 1-16.
Cliccare per
andare in su /
Click to go to top>![]()