|
DA BERSAGLIERE AD
ARDITO
Nascita, vita e
vicende del XXIII reparto d'assalto

Ludovico Lommi
edizioni Itinera
Progetti Bassano del Grappa
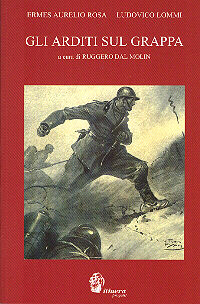
|
|
Dalla prefazione di Paolo Volpato
Nell’iconografia della prima guerra mondiale, la figura
dell’ardito, il soldato impiegato nei reparti d’assalto del Regio Esercito
italiano, rappresenta qualcosa di più di un semplice combattente. Senza
entrare in considerazioni più ampie che, fatalmente, portano questa figura
a sconfinare dall’ambito prettamente militare a quello più complesso della
politica, è indubbio che i reparti d’assalto italiani si guadagnarono la
loro fama già durante le battaglie del 1917 e del 1918. …. fin da subito,
gli arditi furono qualcosa di più e assunsero dei caratteri specifici, la
cui peculiarità non ebbe riscontri nei reparti simili organizzati in altri
eserciti europei. L’idealizzazione di un soldato che amava la guerra, che
cercava la morte in battaglia, che usava armi primitive, che combatteva
fuori le norme e anche contro le norme, serviva ai comandi italiani per
far tornare, attraverso lo spirito di emulazione, la volontà di resistere,
combattere e vincere ad un esercito che aveva subito il disastro della
rotta seguente allo sfondamento a Caporetto. Gli arditi, soldati che
comunque facevano una scelta dettata più dal cuore che dagli ordini,
autoalimentarono il loro mito, attraverso gli scritti certamente, ma
soprattutto con il loro atteggiamento nelle retrovie e con il loro
comportamento nei combattimenti, tanto che ben presto la fama travalicò i
confini e si diffuse prima nell’esercito avversario e, in seguito, anche
tra gli eserciti alleati. Nacque il mito dell’ardito, soldato senza paura
e con qualche macchia, che fece della morte una religione, della guerra il
suo credo, della battaglia la sua vita. In questa opera di ricostruzione e
di affermazione del mito, si insinua felicemente il volume di Lommi,
ufficiale del XXIII Reparto d’Assalto, protagonista delle grandi battaglie
da giugno a ottobre del 1918. ..
 Il 16 giugno 1918 il Cap. Lommi viene gravemente ferito ed è costretto
a lasciare il campo, meritando la seconda medaglia d’argento, a pochi
giorni da quella ricevuta per l’attacco di Capo Sile, la cui motivazione
oltretutto illustra l’azione: Il 16 giugno 1918 il Cap. Lommi viene gravemente ferito ed è costretto
a lasciare il campo, meritando la seconda medaglia d’argento, a pochi
giorni da quella ricevuta per l’attacco di Capo Sile, la cui motivazione
oltretutto illustra l’azione:
“Sempre in testa alla sua compagnia si
slanciava contro il nemico che tanto odiava; ferito una prima volta,
continuava a combattere, sempre trascinando gli uomini col suo fulgido
esempio, finché la mitragliatrice nemica, lo colpiva una seconda volta
gravemente — Canale Fossetta, 16 giugno 1918”.
Il Lommi combatteva assieme
al fratello, a sua volta ferito nel fatto d’arme di Capo Sile. Peraltro,
anche le perdite austriache sono rilevanti e nei giorni successivi
inevitabile parte il contrattacco italiano. Il 19 giugno (1918) il XXIII Reparto
d’Assalto concorre nell’azione volta a riprendere il terreno fino al Piave
Vecchio. La lotta è ancora asprissima tra canali e fossati, gli arditi si
battono casolare per casolare, con i pugnali forano le mura per far uscire
le canne dei fucili, ufficiali mutilati incitano alla lotta, a ondate
escono nei ripetuti assalti, assieme ai fanti della Sassari, fino a che
gli austriaci sono costretti a ritirarsi difendendo con valore le
artiglierie portate oltre il fiume. Non mancano del resto episodi di cruda
violenza che, spesso, travalicano anche la pur necessaria volontà di
annientamento che anima i soldati in combattimento.
Ricorda nelle sue
memorie l’On.le Luigi Gasparotto: “A Meolo sono a riposo gli arditi del
maggiore Allegretti, entusiasta delle sue fiamme. “Gli austriaci, dice
il maggiore, venivano avanti colle mani alzate per proteggere le
squadre che sparavano a tradimento “. il cappellano, che si è battuto
anche lui, dice: “La nostra prima ondata sembrava un volo di rondini “.
Fra i primi a morire fu il tenente Meneghini, al grido: “Viva l’Italia”. il
tenente Leonarduzzi, milanese, che, scappato dal deposito, era corso
dall‘Allegretti a pregarlo di lasciarlo battersi con gli arditi, ferito
cinque volte, è rimasto per quattro ore nel terreno conteso fra noi e
loro. Dato oramai per morto, nella notte si trascinò nella nostra linea.
il nemico si è battuto alla beduina, sgusciando a piccoli gruppi fra
siepi, da case, da fossati. Era invisibile”. Ma anche per gli arditi
vi era l’ordine di non fare prigionieri: il Cap. Antonio Zane, del XXIII
Reparto d’Assalto, cattura con un lanciafiamme un gruppo di austriaci
nascosti in una cantina di una casa, ma due altri arditi, avendo trovato
impiccati dietro la casa quattro Granatieri italiani e due Arditi,
uccidono i prigionieri con le bombe e i pugnali. |
|


immagine tratta dal libro
Il mito dell' ardito ritorna in
queste pagine
permettendoci però (per buona parte del libro) di osservare dietro le quinte la complessa macchina militare
fatta di trincee, riposi, trasferimenti, cameratismo e affetti. Il libro,
come dice Volpato, trasuda di retorica, enfasi, misticismo e passione,
trasmigrata poi nel reducismo e nelle ben note vicende per quella vittoria
mutilata che aveva
"cambiato tutto per non cambiare niente".
Senza entrare nel complesso mondo degli arditi
(costituiti alla Vigilia di Caporetto,
ma inefficaci se confrontati con quelli del nemico, di Rommel per intenderci), mi preme confutare alcune facili visioni che la propaganda
tendeva a dare di questi uomini attraverso una pubblicistica mirata e resa
popolare dalla stampa (vedi sotto anche intervento di F.T. Marinetti) e che, a merito di Lommi, non viene confermata dal
racconto. Buoni alloggi, soprassoldo, donne, divertimenti, eccessi, tutte cose che non
traspaiono neanche minimamente dal racconto e dalle immagini di cui è corredato il
libro. Al massimo gli si concede un buon bagno, un pasto caldo regolare,
una branda senza pidocchi, una bicchierata e la morte in faccia ad ogni assalto. Ma questo per il
fante di trincea era pane di tutti i giorni (!! pur non essendo ardito) come nessuna delle cose
precedenti (vino escluso). Il maestro Lommi, figlio
della sua cultura e classe sociale, sempre alla vigilia di Caporetto,
va in licenza e cerca in Emilia, la sua terra, un patriottismo assente da
anni, avversato da un socialismo che non condivide nulla delle intenzioni del
conflitto. Lommi, riporta "vidi troppo divertimento, troppo lusso,
troppo disamore per i combattenti, per la morale, per tutto".
Nulla di più falso se lo si vede solo con
gli occhi divenuti estranei, in zone dove anche la miseria in tempo di
guerra la faceva da padrona e dove ogni regola, anche "morale"
saltava per puro spirito di conservazione. Come si facevano
fortune improvvise con le commesse militari, altrettante se ne facevano
con la borsa nera.
A..W.
Qualcun'altro aggiungeva
rincarando la dose.
Il gen.
Segato dirà "la responsabilità della
rotta di Caporetto non si limita a capi militari ed a uomini di governo:
essa coinvolge tutti coloro che col disfattismo attivo o passivo
esercitarono influenza deprimente sullo spirito del soldato: essa
coinvolge coloro che, riusciti ad imboscarsi, dell'imboscamento si valsero
per trarre dalla guerra il maggior profitto possibile, poco curando se con
ciò venivano a danneggiare coloro che nella trincea soffrivano e morivano;
essa coinvolge coloro che non avevano rossore d'offrire al soldato che per
licenza o per servizio, rientrava temporaneamente dal fronte, un nauseante
spettacolo di vita fatta di godimento e di spreco, guardando i reduci dal
fronte con un sorriso di compassione, quando non era sorriso di scherno".
Della
esperienza di Lommi riporto a fianco il brano della prima ferita (Luglio
'15) quando era ancora al L btg del 15°
per il valore della testimonianza diretta senza nulla togliere agli scontri che
vedranno il XXIII reparto sacrificarsi da protagonista sul Piave per l'orgoglio
nazionale. A.W.
 |
|
Dal libro - La Ferita - 28 luglio '15 - Il trincerone (Sagrado) -
... Non volli mandare avanti il plotone; andai io stesso prima a esplorare
il terreno. Tutto solo mi avventurai in quell’inferno, sostando qua e là,
saltando ora in una buca, ora dietro un sasso. Dalle feritoie della
trincea nemica fui certamente scorto, e mi si tirò addosso con furia:
delle pallottole mi fischiarono rabbiose alle orecchie, una mi lacerò il
piumetto, un’altra mi attraversò la manica sinistra, senza per fortuna
ferirmi. Con la coscienza netta del pericolo, strisciai cautamente dietro
un masso, sostandovi qualche minuto. Proseguendo incontrai l’eroico Sten.
Cenci, di Rimini, carissimo amico, ferito a una mano e a una gamba che,
con in pugno la sua pistola, guardava attentamente intorno a sé,
strisciava, saltava da un riparo all’altro, retrocedendo per recarsi al
posto di medicazione. Mi gridò: …. “Dove vai, disgraziato? Non lo vedi lì
il Trincerone? Torna indietro, se non vuoi farti ammazzare come un cane!
Quanti poveri bersaglieri sono già morti! E quanti feriti sono qui intorno
e giù in trincea!” . Furono le ultime parole che sentii dalle sue labbra, povero Cenci. Intanto
potei vedere la nostra prima linea e osservare il terreno; poi di sasso in
sasso, di buca in buca, con l’occhio attento e la pistola impugnata feci
ritorno. Diedi rapidamente istruzioni ed ordini, poi con un: “Avanti,
bersaglieri!” avanzai. Precedendo il plotone, mi voltavo a incoraggiare e
a fare raccomandazioni. Ricorderò sempre i due bersaglieri che più
dappresso mi seguivano: il bravo caporalmaggiore Ghermandi e il
bersagliere Banzola, quest’ultimo prese subito una fucilata in bocca e fu
portato via.
Giunto a pochi passi dai nostri, tutto raggiante, mi alzai gridando:
“Signor maggiore, siamo qui! “ Ma voltandomi per accennare ai mio plotone,
che mi seguiva di corsa, mi sentii colpire come da una violentissima,
tremenda bastonata al cuore. Feci due o tre ruzzoloni e gridai: “Ah,
vigliacchi! mi hanno ammazzato! Vendicatemi, fratelli! E avanti, per la
Patria! Viva l’Italia!” Credo seguisse un momento di costernazione
tragica. “Sì, sì!” urlarono quei bravi bersaglieri. “Andate a prenderlo!” Gridò il maggiore.
Subito mi sentii afferrare da molte mani e trascinare di corsa sotto il
riparo; intanto che alcuni bersaglieri mi liberavano dalle giberne e mi
stracciavano giubba, camicia e maglia, già orribilmente insanguinate, per
mettermi allo scoperto la ferita, il tenente Bompiani mi chiedeva
affettuosamente “Dove sei ferito, povero amico, dove sei ferito?” Il
respiro mi mancava, il sangue usciva a fiotti, non potevo parlare. Cacciai
con un rantolo due parole: “Al cuore....” che tale era la mia impressione.
E con l’immagine di mia madre dolorante, mi apparve impetuosamente
l’immagine della mia fanciulla dal più profondo dell’animo, e su di esse
lo spirito trafitto si posò rassegnato al sacrificio.

Il maggiore mi disse forte: “Bravo! Lei ha fatto più del suo dovere ed io
sono lieto di proporla per la medaglia al valore. Coraggio!” Nessuno
più parlò ed io compresi, anche troppo bene compresi e, aspettando la
morte, pensai alla mia ricompensa che in un giorno non lontano avrebbe
reso meno straziante alla mia famiglia il sacrificio.
Accennai con un gesto a una scatola di fialette di tintura di iodio che
tenevo in una tasca; me la diedero, ebbi la forza di levarne due, di
spezzarne le punte di vetro e di cacciarmi i due tubetti, uno dopo
l’altro, nella ferita e schizzarvi il liquido con l’apposita peretta di
gomma: il dolore fu atroce, ma la speranza di poter guarire, mi fece
forte.
Mi diedero da bere, fui coperto colla mia mantellina e lasciato li. Il
rude giaciglio era scomodo, dolorosissimo: sentivo alla spina dorsale un
dolore irresistibile e pensavo che il piombo, dopo aver attraversato il
polmone sinistro, si fosse fissato in una vertebra.
Persi i sensi? Mi addormentai? Delirai? Non ricordo. Ma ricordo che il
sole, quel tremendo sole d’estate che mi batteva in faccia e mi soffocava,
era un ben duro supplizio. Lentamente venne la sera: gli austriaci
battevano sempre la nostra posizione, tagliando qualsiasi comunicazione
con le nostre linee retrostanti mentre noi avevamo fame, avevamo sete,
avevamo bisogno di soccorrere i feriti. Molti feriti giacevano sul terreno
già da qualche ora e le loro grida, i loro lamenti erano strazianti:
“Aiutatemi, portatemi via! Un po’ d’ acqua, per carità, un po’ d’acqua!”
Alcuni invocavano la madre, la sposa, i figlioletti. Il mio tenente, con
le lacrime agli occhi, diceva: “Ma è una maledizione, questa!” . Ora la
fucileria nemica era spaventosa.
“Zanchetta - disse il tenente a un caporale veneto che il giorno dopo
doveva essere il mio salvatore - ti farò sergente sul campo: vola a
prendere dell’acqua; bada di non farti scorgere!” L’attendemmo lunghe ore;
finalmente, verso l’alba Io vidi affacciarsi dai ripari con una squadra di
bersaglieri. Si precipitarono avanti, una raffica rabbiosa di fucileria li
investì, qualcuno cadde colpito, gli altri si gettarono a terra e
continuarono ad avanzare, strisciando da un riparo all’altro; alla fine si
gettarono nella trincea. Un bravo bersagliere, un certo Spini Massimo, mi
cadde ai piedi fulminato da una palla in fronte. Il valoroso caporale Zanchetta aveva portato quello che aveva potuto: una ghirba d’acqua, tante
borracce quante ne stavano intorno al cinturone e due fiaschi di vino. Fu
consumato tutto in un attimo.
Poco dopo, la nostra artiglieria cominciò un fuoco infernale sulle trincee
nemiche alla nostra destra: preparava l’assalto a un battaglione di
fanteria. Erano scoppi e schianti tremendi. Rinacque in me una speranza...
non ero ancora morto... essere soccorso in tempo, ad azione finita... Ora
il pensiero di sopravvivere mi trasfigurava: respiravo convulsamente, il
cuore mi batteva forte... ascoltavo. Si sentì un immenso grido: “Savoia!
Savoia!” Svenni ancora una volta e non sentii più nulla.
Quando riaprii gli occhi tutto era silenzio; deliravo per la febbre, ogni
tanto aprivo gli occhi e vedevo ora a destra ora a sinistra quel povero
Spini, lungo disteso, immobile. Come era possibile?
Verso sera, ero circondato da morti e feriti; pioveva. Mi sentivo il
sangue raggrumato in gola. Mi prese lo spasimo di bere, di bere, di bere!
Mi pareva di impazzire. Un piccolo filo d’acqua scendeva da un sasso
sull’orlo superiore del riparo e mi cadeva sul petto: avessi potuto
muovermi e accoglierlo fra le mie labbra assetate! Provai: fu una
maledizione, perdetti altro sangue dalla ferita riapertasi, allora presi
il mio cappello inzuppato d’acqua e per parecchie volte mi cacciai in
bocca le penne per toglierne le poche stille. Dopo di che sentii le forze
abbandonarmi e per quanto con la volontà cercassi di sopraffare quel
mancamento, ne fui vinto. Mi pare che ripresi presto i sensi e ricordo che
mi trovai tutto coperto dalla testa ai piedi con una mantellina. Era stato
il mio maggiore, mi raccontarono un giorno. Vedendo che non davo più segni
di vita, egli aveva detto : “Ha finito di soffrire, povero ragazzo. Copritegli la faccia e il petto!”
La notte calò presto, torbida e minacciosa. Erano ormai più di 36 ore che
ero stato ferito, e già cominciava a mancarmi quella resistenza al dolore
fisico di cui avevo dato fino allora prova. Con un supremo appello alle
mie forze, misi la pistola in posizione di sparo e me la puntai alla
tempia, in una disperata rinunzia ai miei affetti, alla mia vita... “Disgraziato che fai!” mi gridò il maggiore e mi strappò l’arma
convulsamente. Poi mi disse tante buone parole ed io non rispondevo perché
non potevo parlare, ma nella mia mente mormoravo un’implorazione: “Mi
lasci terminare questo martirio, divento pazzo e tanto non guarirei più
ugualmente! La scongiuro, signor Maggiore mi ammazzi lei, una buona volta,
che non resisto più...”
A un tratto le vedette diedero l’allarme: “Gli Austriaci vengono avanti!”
. Il tenente Bompiani si alzò con impeto e disse: “Su bersaglieri! Chi si
sente di impugnare un fucile, per i nostri feriti, per la vita di tutti,
si alzi!” . Si alzarono tutti. “Sparate con calma! Puntate con calma!”
Cominciò una scarica rabbiosa da parte dei nostri: in piedi, le penne al
vento, sprezzanti del pericolo, Zanchetta e Galli, i migliori caporali
della compagnia, sparavano senza interruzione, incitando i compagni a gran
voce. “Il nemico si ritira! si ritira!” si gridò da tutte le parti. Senza
perdere tempo allora il tenente disse: “Ragazzi, restare qui ancora è un
sacrificio inutile, cercate di raggiungere coi feriti la seconda linea.”

Vidi molte ombre dileguarsi, provai ad alzarmi: ricaddi dolorosamente. Fu
allora che mi rassegnai a morire. Pensai a mia madre, a mio padre, ai miei
fratelli, alla mia fanciulla lontana e ignara del mio martirio e piansi,
poi. parendomi il piangere viltà, mi calmai. Due ombre si avvicinarono:
erano Zanchetta e il bersagliere Garagnani. “Coraggio, signor tenente la
portiamo via noi.”
Provarono a sorreggermi ma non potevo abbracciarmi al loro collo per
l’atroce dolore che mi dava la ferita ad ogni piccolo movimento; provarono
a mettermi nella mia mantellina e portarmi via così: era ancora peggio. Mi
scoraggiai: “Ragazzi - dissi loro - è inutile che perdiate del tempo
prezioso, cercate di ritirarvi presto tanto io sento che non arriverei...”
Rimasero muti e addolorati. Ma subito, un lampo nella mente, una fede
nuova nel cuore, una forza strana nelle dissanguate membra mi pervase;
l’istinto della conservazione disperatamente mi si attaccò all’ anima,
vinse il dolore e mi guidò alla salvezza: “Prendetemi come prima, succeda quel che succeda!”
I due bravi giovani mi sollevarono sorreggendomi colle loro forti braccia;
mi attaccai ai loro colli vigorosi e via! Un po’ curvi, essi volarono,
miracolosamente incolumi, sotto il fuoco nemico che era ricominciato, fino
al riparo e quando vi giunsero, meravigliati anch’essi del loro ardimento
e della loro fortuna, piansero di gioia. Anche io piangevo li abbracciavo
e li baciavo; se avessi posseduto un tesoro, lo avrei regalato loro senza
rimpianto. Ero dunque salvo. Salvo! Non ho mai dato, come in quel momento,
un significato più profondo alla parola vita. Portarono una barella
insanguinata: mi adagiarono con cura, misero a mo’ di guanciale una
mantellina e mi portarono al posto di medicazione. Trovai i due ufficiali
medici del battaglione e molti bersaglieri feriti, tutti erano
dolorosamente stupiti, tutti mi strinsero la mano, molti mi baciarono. Fui
portato subito, attraverso il bosco di Sagrato, alla 19 Sezione di sanità;
qui, steso sulla barella, passai le ultime ore della notte era tardissimo
sempre assistito da quella perla di caporale. Un’autolettiga mi accolse
con altri feriti gravi e mi portò a Cassegliano. Le strade orribili davano
alla vettura degli scossoni violenti; era, per noi poveri disgraziati, un
supplizio orribile.
Finalmente giungemmo all’ospedale. Fui spogliato degli ultimi indumenti
inzuppati d’acqua e di sangue e adagiato. per l’esame della ferita, sulla
tavola anatomica. Stentatamente, feci capire che desideravo essere
sottoposto all’esame radioscopico, avendo la persuasione che il proiettile
si fosse conficcato nella spina dorsale. Mi si promise tutto ma intanto
che il tenente medico mi ripuliva la schiena dal sangue e dal fango, forse
con dell’ alcool, a un certo punto ebbi l’impressione di una trafittura
dolorosissima il dottore riscontrò un secondo foro: il foro d’uscita del
proiettile! La pallottola era entrata a sinistra, mezzo centimetro dietro
il cuore, fra la quarta e la quinta costola, ed era uscita dalla regione
dorsale destra fra l’ottava e la nona costola, dopo avere attraversato il
polmone sinistro. Il medico impallidì e non seppe dissimulare il suo
turbamento. Gli feci capire che desideravo sapere se il mio stato era
molto grave; mi rispose: “Vedo che hai molto coraggio e perciò ti dico
tutta la verità. Non ti nascondo che la tua ferita è grave. Non c’è che
tentare una cura, e tu stesso devi provvedervi le tue medicine sono
queste: immobilità assoluta, digiuno, calma e fiducia di guarire.”

Fui medicato, fasciato e messo a letto. Il buon caporale riordinò le mie
povere cose, piegò la mia giubba insanguinata e lacera (che
successivamente portai a mia madre) mi fece i suoi auguri affettuosi e
partì.
“lo - mi scrisse un giorno - la salutai persuaso che fosse l’ultima volta
che la vedevo, il dottore mi aveva detto che non aveva più di 24 ore di
vita.” All’ospedale attesi con pazienza e coraggio. I dottori
venivano spesso a visitare i feriti; le loro cure e le loro buone parole
davano un grande conforto all’anima. Il medico che mi aveva medicato per
primo mi stringeva affettuosamente la mano, sorridendo, e mi diceva:
“Bravo, bravo, vedo che stai meglio, che vai sempre migliorando. Fra
qualche giorno ti manderò a casa.” Allora mi si inondava di gioia e di
speranza il cuore.
Non mi dilungherò a descrivere le scene di dolore che si svolsero sotto i
miei occhi durante i pochi giorni in cui rimasi in quell’ospedale. Una
mattina il bersagliere Vinti - il mio attendente - si presentò tutto
commosso; al primo vedermi delle lacrime gli solcarono le guance. Non
potevo parlare, gli feci solo cenno che ero in collera con lui; perché non
era stato con me quel giorno?
Mi raccontò piangendo le sue vicissitudini: mi aveva perso di vista e
aveva finito con il perdere l’orientamento, aveva così combattuto con
un’altra compagnia; si era trovato in un inferno, non sapeva come si
trovasse ancora al mondo. Aveva girato in tutti i paesi vicini per
cercarmi negli ospedali da campo, ora m’aveva ritrovato ed era contento.
“Signor tenente, si diceva che lei era morto!”
Mi... disarmò, gli chiesi di darmi qualche notizia.
Brutte notizie: il nostro tenente aveva ricevuto di nuovo l’ordine di
avanzare ad ogni costo e, dopo aver invano esposte le gravi difficoltà
nell’attaccare il Trincerone, era andato a morire con pochi votati alla
morte: Chiodini, Garagnani... Garagnani uno dei miei salvatori! Il cuore
mi sanguinò. Piansi, per te e per la tua povera mamma, piansi tutta quella
sera e durante tutta quella notte insonne. Sentì l’angoscia della mia
ferita che mi inchiodava al letto, che mi impediva di correre, correre su,
volare sulla roccia insanguinata in cerca del tuo cadavere per strappano
al barbaro, per morire anch’io su di esso.
Vinti pianamente continuava il racconto, confondendo le parole nei
singhiozzi ..... |

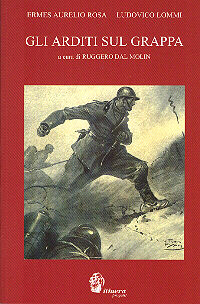
 Il 16 giugno 1918 il Cap. Lommi viene gravemente ferito ed è costretto
a lasciare il campo, meritando la seconda medaglia d’argento, a pochi
giorni da quella ricevuta per l’attacco di Capo Sile, la cui motivazione
oltretutto illustra l’azione:
Il 16 giugno 1918 il Cap. Lommi viene gravemente ferito ed è costretto
a lasciare il campo, meritando la seconda medaglia d’argento, a pochi
giorni da quella ricevuta per l’attacco di Capo Sile, la cui motivazione
oltretutto illustra l’azione: 





