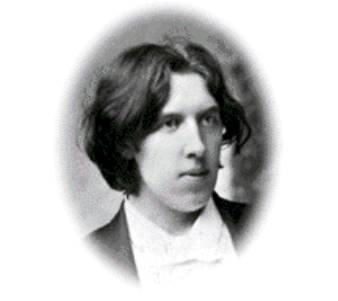DECADENTISMO
|
|||
|
|
PRECEDENTE
|
HOME PAGE
|
SUCCESSIVA
|
|
Decadentismo La parola Decadentismo
deriva da décadent, termine usato
in Francia con significato dispregiativo nella seconda metà dell'800, contro
i "poeti maledetti", che con la novità della loro arte e la loro
vita irregolare e disordinata, apparivano alla gente comune dei
"decadenti", cioè corrotti e dissoluti. Ma loro non si offesero e
usarono questo appellativo come vessillo di battaglia nella loro rivista
"Le Décadent" uscita nel
1886. Oggi il termine Decadentismo non ha alcun significato dispregiativo:
infatti la parola serve ad indicare sul piano storico-culturale la civiltà
sorta dalla crisi del Positivismo. In Italia la parola ha finito per indicare
tutta la letteratura del '900. Il
Decadentismo penetra e si sviluppa in Italia molto lentamente, con il ritardo
di circa un quarantennio rispetto alle più significative manifestazioni del
Decadentismo europeo. Affiora confusamente nelle prime esperienze innovatrici
degli Scapigliati, fra il 1860 e i11880; lo troviamo più o meno mescolato ad
elementi culturali tradizionali nelle opere di Pascoli e D'Annunzio; si avverte più chiaramente in
Pirandello, nei crepuscolari, nei futuristi e, in modo più deciso, nei poeti
ermetici fioriti tra le due guerre mondiali. Inoltre esso assume aspetti
diversi in rapporto alla personalità di ciascun artista. Nel Pascoli, assume
l'aspetto simbolistico e vittimistico; in D'Annunzio l'aspetto estetizzante, superomistico e
sensualistico; in Pirandello l'aspetto dialettico, polemico, demolitore delle
ipocrisie e dei luoghi comuni; in Italo Svevo l'aspetto apatico e
rinunciatario; nei poeti crepuscolari l'aspetto smarrito ed estenuato; nei
poeti futuristi l'aspetto vitalistico ed attivistico; nei poeti ermetici
l'aspetto simbolistico; negli scrittori neorealisti del secondo dopoguerra,
infine, riscontriamo la contaminazione di elementi decadenti con elementi
realistici. La lentezza con cui il Decadentismo fu fatto conoscere e
diffondere in Italia -per merito de « La Voce », una rivista fiorentina dei
primi anni del '900- è dovuta: anzitutto
alla tenacia della tradizione culturale italiana da poco rinverdita dal
Carducci; all'opposizione
implacabile condotta dal Croce contro il Decadentismo, considerato come la
fabbrica del vuoto ed espressione di quell'irrazionalità, istupidimento,
bestialità e disumanità « che travagliano il mondo intero e che ha celebrato
la sua orgia sanguinosa nell'ultima guerra »; al senso di
misura e di equilibrio dello spirito nazionale. « L'Italia -scrisse Eugenio
Montale- è senza dubbio il paese nel quale hanno fatto minor guasto il culto
dell'irrazionalità, l'esasperazione dell'io, le teorie dell'arte intesa come
pura magia, in una parola tutto quanto si designa con l'abusato termine di
Decadentismo. Ciò che è entrato di questa teoria in casa nostra, ha mutato
volto, si è temperato, si è fatto più vero ». Alla vigilia della grande guerra l'Europa
«dominante», costituita dai paesi occidentali e centrali, offriva un'immagine
di forza e di prosperità: prosperità per le nazioni, ricchezza e benessere
per i ceti dirigenti, diffuso senso di sicurezza, libera circolazione di
uomini, di merci, di capitali, di idee. Il sistema liberale e quello
capitalista davano l'impressione di avere raggiunto il loro apogeo e di avere
assicurato all'Europa l'incontestato dominio del mondo. Si trattava in realtà
di un fragile equilibrio e non erano mancati segni premonitori di crisi
(prima e seconda crisi marocchina, 1905-06 e 1911, annessione da parte dell'Austria
della Bosnia e della Erzegovina, 1908 , prima e seconda guerra balcanica,
1912-13), che dovevano di fatto precipitarla in una guerra «civile» che
avrebbe segnato la fine del suo predominio mondiale a vantaggio degli Stati
Uniti d'America e del Giappone. Lo scoppio della rivoluzione in Russia
concorse potentemente a determinare la rovina del sistema liberale e
capitalista già prima che la grande depressione del 1929 la seconda guerra
mondiale del 1939-45 le vibrassero nuovi irreparabili colpi. Per quanto
attiene alla situazione politica l'Europa si presentava nella primavera del
1914 lacerata e divisa in blocchi contrapposti: da un lato Francia, Russia,
Inghilterra, unite dal 1907 nella Triplice intesa, dall'altro
Germania, Austria-Ungheria, Italia, strette dal 1882 nella Triplice
alleanza, anche se l'Italia, pur nel rispetto formale del trattato,
si muoveva in effetti con una sempre maggiore autonomia. Le più gravi ragioni
di conflitto erano la rivalità austro-russa nei Balcani, il mutuo risentimento
e la diffidenza reciproca tra Francia e Germania, l'insanabile rivalità
navale anglo-tedesca. La situazione era resa esplosiva dal fatto che il
«contenzioso» diplomatico era immerso in una atmosfera che la «logica
dell'imperialismo» e la larghissima diffusione delle passioni nazionali
avevano reso l’atmosfera mondiale incandescente. |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
PRECEDENTE
|
HOME PAGE
|
SUCCESSIVA
|