| |
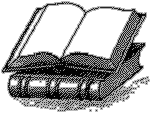
Medulla
cordis mei
di Lorenzo Berti
Volevo fare lo scrittore, e dio santo se mi
sembrava un proposito giusto e decoroso. Voglio dire, non c’era
nulla che mi piacesse, nulla che mi riempisse l’occhio.
Lavorai in un ufficio, roba di contabilità. Non mi tornavano
i conti relativi a delle bolle di accompagnamento, chi se ne
fregava, li facevo tornare di forza. D’accordo, non era
professionale; ma erano affari miei dopotutto? Non sapevo nemmeno
per chi lo facevo, e se quello comunque ci teneva tanto, beh,
che se li facesse lui, in prima persona. Lavorai in una specie
di agenzia di viaggi, regolarmente assunto eccetera. Ma anche
lì, che mi fregava a me di portare gruppi “qui
da noi” (gesù, NOI…), sistemarli in un albergo,
soddisfare le loro richieste, e così via? Sì insomma,
che diavolo di soddisfazione c’era? Era quello che volevo?
A me poteva anche piacere viaggiare, ok, ma stare a vedere e
accontentare gli altri che viaggiavano mica era la stessa cosa.
Proprio per niente. E in ogni caso, che c’era di tanto
entusiasmante a mettere in piedi il fatto che quel pullman avrebbe
dovuto essere a quell’ora in quell’aeroporto a caricare
su tutta quella gente che viaggiava? C’era gente che amava
queste cose? Si accomodassero. Io, per me, non mi sentivo affatto
entusiasta. E non era perché, come si potrebbe anche
pensare, l’attività non era mia e quindi, come
si dice, non ci sentivo. No, affatto; credo proprio che niente
sarebbe cambiato se io fossi stato il proprietario della tale
agenzia, del tale ufficio o del tale capannone industriale:
sai che bello alzarsi alla solita ora, guidare nel solito traffico,
fare le solite cose, ma da proprietario. Mi dicevo che avevo
un cervello, io, sissignore, e che così mi pareva di
buttare via la mia vita. Ok, ero presuntuoso; ma allora, se
proprio dovevo buttarla via, preferivo buttarla via tipo in
una catena di montaggio, con un bel lavorone meccanico e ripetitivo.
Lo feci, e andò meglio; ero meno infelice, anche perché
forse avevo meno tempo di pensare a quanto lo ero. Ero stanco,
a fine turno, e quando si è stanchi si riflette male.
È per questo che dopo gli uomini vanno a puttane, forse.
Non hanno altro da fare: o vanno a letto da soli, se non sono
sposati, o vanno in macchina con una puttana. Bel teorema profondo,
già. Ero proprio un intelligentone, Cristo. Certo che
lo ero, e per questo volevo essere uno scrittore. È solo
che pensiamo sempre che la felicità sia qualcosa che
non si ha? Può anche darsi, però a me non interessava
nulla di tutta quella roba, e soprattutto se niente niente facevo
tanto di alzare lo sguardo – una questione di prospettive,
di futuro, aspettative, capiamoci – mi prendeva qualcosa
allo stomaco, come vomitare alla rovescia. E allora c’era
l’idea della scrittura: forse, tutto sarebbe stato diverso,
se fossi riuscito a diventare uno scrittore. Così, le
cose non avevano un senso. Il mio desiderio feroce. C’era
un’autobiografia di qualche personaggio che aveva questo
titolo. Io mi immaginavo che quelle parole avrebbero benissimo
potuto essere mie. Il coglione smisurato e pretenzioso, che
ero…
volevo fare lo scrittore, e mi passavano per le mani i libri
di Flaubert e di Stendhal, di Kakfa, di Maupassant. Non ci sarei
riuscito mai. Lo scopo della vita. Lo scopo della vita poteva
essere aprire un bar, o un negozio in franchising. Scrivere?
Tutto sommato era un’idea. E poi Philip Roth, De Lillo,
Salman Rushdie: il loro occhio pareva abbracciare tutto quello
che era successo, da sempre a oggi, e uno si sentiva così
piccolo a leggere i loro libri, sapeva che era quasi inutile,
un gran casino a cogliere tutto quel che c’era, perché
era come se loro viaggiassero a una velocità mentale
mille volte superiore alla tua. Mi mettevo a pensare a come
avevano iniziato: c’era stata una piccola stella per ciascuno
di questi – l’idea di invischiarla e avvolgerla
con le loro belle parole, avvicinarla e coglierla, farsela cadere
nelle mani, entrambi persi l’uno dell’altra; c’era
stata una ragazza che li faceva alzare ogni mattina col pensiero
di lei in testa, esattamente come si erano addormentati la notte
prima? Erano stati molto più candidi, ingenui, teneri
e appassionati di adesso? E Saroyan, e John Fante, e Scott Fitzgerald
con la sua Zelda – quelli che rimanevano così per
tutta la vita, più o meno, e il loro occhio era sempre
e soltanto il loro cuore. Forse il primo libro su cui lasciai
i miei, di occhi, furono proprio i Racconti dell’età
del Jazz di Fitzgerald. Lo scopo della vita. Il mio qual era?
E chi lo sa… solo, così le cose non avevano un
senso.
Ancora, volevo fare lo scrittore, perché sentivo ribollirmi
dentro migliaia di idee che dovevo mettere sulla carta in un
modo o nell’altro. Sempre, le sentivo mentre guidavo,
tornando dal lavoro che avevo sul momento, o a letto, prima
di addormentarmi. Ridicolo, no? E allora sentite questa: erano
solo fantasmi che svanivano non appena mi mettevo in condizione
di scriverli. Dio, come se ne volavano via! Presi anche a portar
con me un piccolo taccuino e una penna; lo lasciavo sul sedile
della macchina, e quando mi veniva in mente qualcosa ce l’appuntavo.
Smisi quando mi accorsi che rischiavo sempre un incidente. Ma
poi, se anche riuscivo a fissarne qualcuno, quando andavo a
rivederlo mi pareva una gran schifezza. Non lo buttavo però,
anche se avrei voluto e dovuto. No, semplicemente lo guardavo,
rileggevo, lo stiracchiavo da una parte e dall’altra inutilmente,
e poi mi buttavo giù. Le idee non venivano, e io restavo
lì, con lo schermo bianco e i pensieri neri. Grande artista,
davvero. Nessun libro scritto né pubblicato, e già
il blocco dello scrittore. Ero lungimirante. E allora mi dicevo
che non bisognava pensarci, che avrei dovuto solo mettermi a
sedere e non assillarmi tanto, che tutto sarebbe venuto da sé,
esattamente come veniva da sé quando non facevo nulla,
e me ne stavo seduto in macchina o sdraiato sul letto. Cazzo,
lì era come se quei pensieri si impadronissero di te,
e ti portassero via da quello che stavi facendo – che
generalmente era assolutamente nulla, ma questo è un
altro discorso; però forse era quello il segreto: erano
loro che venivano a cercare te, quand’erano in comodo.
Ecco, sì… e per il resto ti prendevano in giro.
Non volevano lasciarsi fissare; com’erano venuti se ne
dovevano andare. Succedeva così anche agli altri, mi
chiedevo?
Volevo fare lo scrittore, e ancor di più lo volevo da
quando c’era lei. La mia, di stelle, si chiamava Camilla.
No, in realtà non si chiamava affatto Camilla; la chiamo
io adesso così, la mia dolce Camilla Lopez, perché
quando ero o non ero con lei, da quando insomma la conoscevo,
mi sentivo come Arturo Bandini. Come lui, ero destinato solo
a sbatterci la testa. E non era finzione, penso, né in
un caso né nell’altro. La conobbi, e le dissi quello
che cercavo di essere. Cioè, per vivere lavoravo nel
tale ufficio e facevo cose così, un modo come un altro
per prendere qualche soldo, certo, ma appena potevo mi mettevo
a scrivere, e avevo idee e fantasia, e tutto quello che si deve
avere insomma perché le cose vadano nel verso giusto.
Non so come fu: lei era così bella e cominciammo a vederci,
di rado, d’accordo, ma era pur sempre un inizio, e poi
lei mi aveva colpito così forte che qualcosa era cambiato
in me. Sentivo che quella ragazza era tutto ciò di cui
avrei mai avuto bisogno. Lei lo capì, si spaventò
e da allora fu dura. Cominciai a scriverle delle lettere, lettere
in cui cercavo di spiegare, di farle sentire che sarebbe stato
come nessun’altra cosa; che lei era tutto quello che cercavo
e che non ci sarebbe mai stato nessuno che l’avrebbe fatta
sentire come l’avrei potuta far sentire io. Il fatto era
però che non mi ascoltava. E le parole peggioravano solo
la situazione. Una volta, la tua Camilla si commuove e sei dolcissimo,
un grande scrittore che la fa piangere e sognare e abbandonare
alle fantasticherie più dolci; due volte, cominci a innervosirla
e annoiarla; tre, sei patetico, te e tutto il tuo bla bla bla.
E poi Camilla cambia, di brutto. E allora mi dissi che non ne
valeva la pena, che ero un uomo dopotutto – no, uno scrittore,
già! un grande scrittore, anche se per la verità
erano solo aspettative per il momento – e così…
no, Camilla! Eri proprio una persona da lasciar perdere, tu
e tutti i tuoi problemi e il non volermi ascoltar più;
io cercavo solo di essere gentile, di strapparti un sorriso,
e capirti, e le mie intenzioni erano le migliori che ci potessero
essere, davvero. Volevo solo farti capire quanto eri stata speciale
dal primo momento che ti avevo visto, ma era tutto inutile.
La magia se n’era andata. E quindi addio, si disse il
grande scrittore, con quella suprema dignità che hanno
certo gli immortali grandi artisti di questo mondo ridicolo.
Salvo poi continuare a tremare come un bambino al solo pensiero
che era tutto finito – senza che nemmeno ci fosse stato
qualcosa, per la verità; ma poi era anche bello dirsi
una frase come è tutto finito, sapeva così di
duro: da una frase così, da uno stato d’animo così,
potevano nascere certi racconti incancellabili e delicati da
farla innamorare davvero, Camilla, e allora forse non era poi
così finito, era solo questione di pazienza, di sentire
un po’ male, e poi ricominciare da capo. Perché
era lei che doveva essere la mia stellina, non c’erano
dubbi su questo.
Ma sì, aspettiamo! Torna da lei con le mani piene! Quando
le mani del grande scrittore stringeranno una lettera, una lettera
come questa: Lei è un genio. I Suoi lavori sono quanto
di meglio ci è capitato di leggere negli ultimi anni.
Assolutamente. Venga da noi, La aspettiamo a firmare il contratto.
Contratto in bianco. Vogliamo l’esclusiva su tutti i Suoi
libri, anche su quelli che verranno, QUANDO verranno. Gesù,
che grande scrittore che è! Non perda tempo! Le riserviamo
l’albergo tal dei tali, per il periodo che Le sembrerà
più comodo – ecco allora vedrai, vedrai che cambierà
tutto. Vedrai l’effetto che le farà quando qualcun
altro dirà che sei davvero un grande scrittore, e allora
anche lei riaprirà gli occhi, vedrà che eri sincero
e che tutte le tue intenzioni erano buone, e tutto quello di
sbagliato che c’era tornerà a posto. Sarai famoso,
grande scrittore, e le tue strade saranno lastricate d’oro,
se non lo sai. E godrai di un grande credito presso il destino
tutto, Camilla compresa. Sarà quasi una grande concessione
che le farai, quella di parlarle ancora. Ma no, Camilla, no…
era tutto così chiaro, invece: il grande scrittore avrebbe
rinunciato a tutto solo per sentire come ci si sentiva con te
che ti addormentavi sulla sua spalla mentre stavate tornando
dal mare, e lui ti guardava mentre respiravi, e ti passava una
mano fra i capelli. Sì, certo, affanculo la gloria, il
grande scrittore e tutto! Tanto, tutto quello che succedeva,
succedeva per lei, perché, come cercai di farle capire
in alcune delle parole che le scrissi dopo un po’ di tempo,
quando già non mi ascoltava più, il discorso era
proprio questo, né più né meno:
E poi c’era quell’incredibile
bisogno che avevo di lei. L’avevo avuto dalla prima volta
che l’avevo vista. Se ne era andata, quella prima volta,
era uscita dalla casa di sua zia dove ci eravamo incontrati
per il tè, e io divenni un buono a nulla senza di lei,
un incapace assoluto fino a quando non la vidi di nuovo. Se
non fosse stato per lei, la mia vita avrebbe percorso strade
differenti – sarei stato giornalista, muratore –
qualsiasi cosa mi fosse capitato. La mia prosa, così
com’era derivava da lei. Perché io abbandonavo
sempre quello che scrivevo, lo odiavo, disperato, accartocciavo
i fogli e li buttavo per la stanza. Ma lei rovistava fra tutta
quella roba che io gettavo e veniva a capo delle cose, e io
non sapevo mai se avevo fatto qualcosa di buono, pensavo che
ogni riga che avevo scritto non fosse migliore del solito, perché
non avevo modo di esserne certo. Ma lei prendeva le pagine,
vi trovava quello che c’era di buono e lo serbava, poi
me ne chiedeva altre, così che per me diventò
un’abitudine, scrivevo meglio che potevo e le davo i fogli,
lei vi faceva un’opera di taglia e cuci, e quando era
terminato, con un inizio, una metà e una fine, ero ancora
più meravigliato di quando poi lo vedevo stampato, perché
non avrei mai potuto farlo da solo.
Passarono tre anni così, poi quattro, cinque, e cominciai
ad avere qualche nozione del mestiere, ma erano le sue nozioni,
e non mi preoccupavo mai molto degli altri che avrebbero potuto
leggere le mie cose, scrivevo solo per lei, e se lei non fosse
stata lì, avrei potuto anche non scrivere affatto.
Sì, non era roba mia, d’accordo.
Ma era esattamente quello che volevo dire. Ed è quasi
commovente quando ti rendi conto che qualcuno l’ha già
detto, esattamente con le stesse parole che avresti dovuto usare
tu, o giù di lì. E poi non è che le ho
fatte passare come mie, Camilla… te l’ho detto,
no, che era preso da un libro, da uno degli scrittori che avevano
dato vita tra le altre cose al tuo nome, e a molto di tutto
quanto il resto.
Beh, nient’altro… ma al di là dei sogni,
non era che gli editori facessero a gara per accaparrarmisi,
e così tutto quello che potevo fare era chiedere un segno
alle stelle, quando era notte, un maledettissimo segno, perché
io sapevo che era così che doveva andare, e invece andava
in tutt’altro senso e allora perché, dio santo?
Qualcuno me lo dica, cazzo… perché non si può
barare un po’ con la vita? Fatemi conoscere un po’
del futuro, solo un piccolo pezzo, almeno quel tassello di presente
che ci manca per capire meglio perché ci succedano certe
cose, il modo per interpretare quei piccoli segnali che a volte
ci capitano. Qualcuno, lassù: Dio, una Dea, un angelo,
va bene anche un ufo, un cartomante, le stelle, qualsiasi cosa…
c’è qualcuno che possa aiutarmi? Un cazzo di essere
anche unicellulare, un meteorite in fiamme che perde i pezzi.
Solo un aiutino, così… una sbirciatina a quello
che sarà, o un consiglio per fare in modo che sia, se
per voi è più semplice.
Non c’era mai risposta, e tornavo ad aspettare, solo.
E badate che il punto di domanda è sempre peggio del
punto fermo. Tanto, a quella gente non gliene fregava niente
di me, e pensavo che magari pure lei se la rideva di gusto leggendo
le mie lettere sdolcinate e eccessive, e non rideva invece quando
ero divertente. Poi, c’era sempre questo strano tipo di
dubbio che era dentro di me, e che mi faceva dire che aveva
ragione lei, che le cose non sono mai così facili, specie
queste, perché per lei forse avrebbe voluto dire dare
la sua vita a uno che nemmeno conosceva e che parlava e parlava
e parlava; ma allora dio santo, che lo conoscesse, lui non la
mangiava mica! Ma no, ma no… lei non rideva quando leggeva
le mie lettere; lei era solo confusa, era tutto normale: tempo,
tempo, tempo. Merda, ma non poteva essere tutto più facile?
Perché doveva essere così difficile esser felici?
C’erano miliardi di persone che avevano la felicità
squadernata sotto gli occhi; miliardi di canzoncine del cazzo
in cui il fesso di turno parlava di quanto era felice e di come
era bello stare insieme alla signorina di turno. Ricco, famoso,
felice: un artista. Ma era veramente così, poi? La felicità
non esisteva, e quanto alle canzoni, in tanti avevano anche
scritto sulla finzione di quella felicità. Il nome Adorno
ti diceva niente, Camilla? Ma con lei, grande scrittore, ti
sarebbe piaciuto pure tutto il resto. O almeno non ci avresti
fatto più caso. Era così che era successo a tutti
gli altri, lì dentro, dove lì dentro sta non solo
per questa o quest’altra fabbrica o ufficio, ma per il
mondo intero. Non avresti più capito quanto era brutto
e inutile tutto questo; l’avresti fatto e basta, tanto
dopo c’era lei ad aspettarti. Allora ecco il destino,
caro il mio grande scrittore: dovevi soffrire, grande scrittore,
perché solo dalla sofferenza sarebbe nata la tua fortuna.
Ma la mia fortuna era lei. Io lo sapevo. Forse un giorno qualcuno
avrebbe ascoltato la tua storia, perché è così
che andavano le cose: ero uno scrittore, Camilla Lopez, e non
ci si poteva scampare, no di certo… solo allora saresti
stata, con me o senza, anche se non ci fossi stata più,
anche se non fossi esistita mai, l’oasi di un po’
tutti i miei pensieri stanchi, come si sentiva in una di quelle
canzoni che passavano alla radio, più o meno.
Dio santo come mi piacevi, Camilla… i tuoi capelli lunghi
e lisci, neri; quegli occhi, quel sorriso quelle tette; tutto,
tutto quanto. Eri un fuoco, e io solo un foglio di carta. Mi
avvicinai, e cosa può fare un foglio di carta accanto
a un fuoco? Cominciai a bruciare. E bruciai, non avevo scelta.
paperogonfio.splinder.com
|
|
![]()
![]()