| |
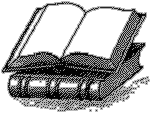
Serietà
professionale,
dalla parte giusta della scrivania
di Lorenzo Berti
Ok, la situazione è questa: io ho spedito più
di cinquanta curriculum, fatto un buon numero di colloqui, comprato
giornali di annunci. Niente. Non c’è stato nessuno
che abbia risposto, nessuno che abbia detto un sì. Mai.
Solo obiezioni, quando è andata bene, o comunque condizioni
che uno può lasciar perdere tutto, serenamente. I curriculum
li ho spediti in tutti i modi che conoscevo: lettera semplice,
posta celere, raccomandata, fax, e-mail; li ho portati di persona,
mettendoli direttamente nelle mani di chi se ne sarebbe dovuto
occupare: nemmeno uno fra tutti i destinatari si è poi
scomodato a rispondere. Avrò già speso un futuro
stipendio in francobolli, tasse postali e invii di fax, e da
quelli non ho nemmeno ricevuto due righe del tipo grazie tante
per l’interessamento, ma per il momento il nostro organico
è al completo; la terremo presente per eventuali necessità
future. E sì che mi avrebbe fatto piacere, in un certo
senso: a spedire tutte quelle lettere e non avere mai risposta,
uno si chiede se sbaglia qualcosa nell’operazione. Ti
vengono i dubbi più sottili: avrò sbagliato a
scrivere l’indirizzo? Non l’avranno ricevuta? Il
postino non sarà riuscito a leggere nella mia calligrafia
e avrà rinunciato a portare la lettera? L’avrà
buttata via solo perché è CATTIVO? Tutte ‘ste
cose si pensano, alla lunga; e allora il ministero delle poste
e telecomunicazioni – ci tengono alla tua tranquillità,
al governo… – ti mette a disposizione un servizio
più sicuro: le ricevute di ritorno. Allora invii il curriculum
secondo le modalità prescritte per usufruire del servizio,
e scopri che nemmeno con quello rispondono. La qual cosa ti
porta indi a pensare che probabilmente avevano ricevuto anche
le lettere precedenti, e che era stata solo una loro scelta
il fatto che non ti avessero risposto. La qual cosa ti fa di
seguito considerare il fatto che hai speso cinque volte il costo
di una lettera normale per arrivare a nulla. LA QUAL COSA ti
fa infine incazzare, perché non è la prima volta
che lo fai, e non sarà nemmeno l’ultima, probabilmente,
considerato che ci sono pure i fax, che in ogni cartoleria che
si rispetti costano quanto caffè e cornetto, ma moltiplicato
per otto.
In ogni caso, non è che le tue lettere le buttino via,
no: le archiviano, le mettono insieme a tutte le altre che arrivano,
in una cartellina colorata; ci scrivono sopra Curriculum, o
anche C.V. e le infilano in qualche cassetto, e ogni tanto magari
le guardano pure, così, per fare. Tanto il mercato è
sempre saturo o in fase di stallo e non possono assumere nessuno,
gli dispiace. Con le e-mail il discorso è più
pratico, per fortuna: arrivano subito, non costano nulla, e
via così. Ma le e-mail, in fondo, hanno questa caratteristica:
nessuno le legge. O meglio, nessuno legge le tue. Ci sono milioni
di persone che hanno il loro bel computer nel loro bell’ufficio
e ricevono e mandano e-mail ai loro amici, amiche, donne, amanti;
ma di qui a rispondere a te che hai inviato un curriculum, il
passo è lungo. C’è anche chi ci lavora,
con le e-mail; ma appunto per quello non è che può
perder tempo a rispondere a terzi, se no non riuscirebbe a lavorare,
mi pare anche chiaro. E perché tu ti ostini a intasargli
il terminale con le tue e-mail del cazzo?
Ma in fin dei conti tutto questo non importa granché:
il lavoro se lo tengano loro, che li nobilita, come uomini e
come donne. Gli dà un tono, un decoro. Tutti aspirano
ad avere quella facciata di serietà, di professionalità
che se uno non ha, passati i ventiquattro, è un immaturo
e un poco di buono. Fino ai ventiquattro si ride e si chiava
con x e y e z sette giorni su sette e ci si ubriaca e si fanno
esperienze e magari si fa anche dello sport; dopo, dal lunedì
al venerdì si è seri, si fa i soldi e il sabato
e la domenica si dorme e poi si va al mare. Solitamente con
x. Ogni tanto ci scappa qualcosa con y, ma poi sono crisi con
x, quindi è meglio non esagerare, anche per non mandare
in frantumi tutto quello che si è costruito. Solitamente
per rimettere insieme i cocci di x si usano parole importanti
e sentite che risanano un orgoglio ferito e cancellano i dolori.
Che comunque spesso sono bugie o poco di più. Soprattutto
servono a ricominciare la settimana in cui si fanno i soldi
al massimo delle proprie capacità mentali, senza distrazioni
o tristezze pericolose. Per i soldi, ovviamente. È più
o meno la vita, tutta, e chiunque prima o poi ci si butta a
capofitto. Brutta prima e brutta dopo, forse, eppure tutti te
lo dicono: trovati un lavoro, sistemati, costruisciti una vita.
E così vai a sentire in giro, e chi te lo dovrebbe dare,
il lavoro, ti chiede: ha esperienze precedenti? (perché
ti danno del lei, nel mondo del lavoro – ti rispettano,
cazzo), e che accidenti gli puoi rispondere tu, tu che sei al
primo impiego e magari anche pieno di buone intenzioni; che
gli dici a quella gente se non: no, mi spiace, non ho nessuna
esperienza, al che loro scuotono la testa di nascosto e poi
gentilmente ti dicono che ti faranno risapere, grazie per il
momento, arrivederci, e via così un colloquio dopo l’altro,
pezzi di enormi stronzi che sono, loro e quelle cose che ti
propongono in alternativa, come ad esempio uno stage formativo
in azienda di svariati mesi e chi cazzo, mi chiedo io, chi cazzo
ve l’avrà insegnata la parola stage? Mi piacerebbe
tanto parlargli un attimo, a quel genio sommo della stramaledettissima
nerchia. Dove sarà, ora? Starà in qualche villa
a ridersela ancora, lui che con la sua invenzione del menga
ha salvato la ghirba alla crema e al fior fiore delle aziende
italiane ed estere le quali perciò gli avranno assegnato
una pensione come quelle che dava Luigi XIV a chi gli leccava
il culo nella miglior maniera. Basta una parola, e milioni di
persone sono fregate. Sottomesse e soprattutto FELICI. Perché
sì, siete contentissimi, e basta guardarvi – ah,
come siete fieri di fare lo stage formativo in azienda! Ah,
ma quanto vi sentite professionali! Idioti. Mucchi di stronzi.
Cumuli di nullità assurde che hanno come massima aspirazione
il diventare qualcuno, come se la cosa avesse un qualche significato.
E vi mettete pure la giacca e la cravatta. Diventare qualcuno;
e alla fine siete ancora peggiori. Voi coglioni di merda non
ne avete abbastanza della vostra vita già abbastanza
squallida di per sé, e vi date pure da fare per renderla
ancora più squallida, senza nemmeno capirlo. E allora
vi meritate tutti gli stage di questo mondo del cazzo e dello
schifo. Che tra parentesi durano dai tre ai sei mesi e sono
del tutto gratuiti. Gratuiti dal punto di vista dell’azienda,
ovviamente, la quale non può scomodarsi nemmeno per darvi
un piccolo rimborso spese. Purtroppo. È la legge, o comunque
sono le congiunture negative del mercato, che volete farci…
tuttavia, alla fine vi si presenteranno EVENTUALI POSSIBILITÀ
di assunzione – o meglio, di inserimento nell’organigramma
aziendale. Ma andate in culo, signore e signori.
Riepiloghiamo: grazie alla parola magica in questione, stage,
un tale lavorerà per un periodo di tre o sei mesi presso
qualcuno o qualcosa, senza percepire – e senza percepirlo
programmaticamente; a tavolino, cioè – un qualche
stipendio; anzi sarà lui a rimetterci, di tasca sua,
anche le spese. Però alla fine, PROBABILMENTE FORSE CHISSÀ
MAGARI CI STA DI SÌ, l’azienda lo assumerà.
E di tutto questo ne sarà anche felice, quando non orgoglioso,
perché d’altra parte, loro, ESSI, nel periodo dello
stage ti insegnano a lavorare. A lavorare per loro. È
questo forse che vi rende così orgogliosi: la consapevolezza
di stare facendo un sacrificio momentaneo che poi vi servirà
in ogni caso; o ancor di più il sentirvi dei martiri,
presto o tardi ricompensati, in un modo o nell’altro.
Ma è mai venuto in mente a nessuno, cristo santo, che
per mostrarvi quello che dovrete fare una settimana sarebbe
più che sufficiente? Che per il resto del vostro PERIODO
FORMATIVO voi lavorerete per loro come (e magari di più:
visto che ci sono vi danno una bella strizzatina, niente glielo
vieta…) un dipendente effettivo – il tutto, non
so se mi spiego, a titolo prettamente gratuito? Che, una volta
arrivati alla fine dello stage, è molto probabile che
vi dicano qualcosa tipo ci spiace, ma le contingenze del mercato
sono tali che non ci è possibile prendere in considerazione
l’ipotesi di un suo inserimento nei nostri quadri, e vi
rispediscano nel vostro inferno di merda e seghe, voi e le vostre
pretese? Provate a ripassare di lì dopo una settimana
o due, allora: ci sarà un altro stagista al vostro posto,
e come voi starà lì a sorridere e a farsi in quattro,
lottando con tutto quello che ha per ottenere la conferma, esattamente
come voi avete già fatto. Rallegratevi, allora; godetevi
la vita, una volta tanto: anche lui (o lei) l’avrà
presto in culo, basta che passino tre mesi, o anche sei.
Ma anche questo non vi basta, per farvi aprire gli occhi: in
fin dei conti, anche se dovesse andarvi male, anche se non vi
confermassero, nessun problema… sarà una voce in
più sul vostro curriculum. È tutta esperienza.
Esperienza, certo, cosicché la prossima volta che qualcuno,
seduto dalla parte buona della scrivania, vi chiederà:
esperienze precedenti?, voi gli potrete rispondere, orgoglioso:
sì, ho fatto uno stage formativo; l’ho scritto
anche sul curriculum… ecco, lì, vede?
Aaah, be’…, sarà allora il commento del vostro
pragmatico interlocutore, il quale magari così continuerà:
no, dico sul serio, le sto facendo un colloquio di lavoro…
esperienze precedenti?; oppure, senta, non faccia tanto lo spiritoso,
qua si lavora; noi non stiamo qui a perdere tempo, sa?
Al che, voi, forse:
ma io HO FATTO quello stage… c’ho pure l’attestato!
Guardi! Eccolo qua! Sei mesi!
E lui:
mi faccia vedere… oooh, non ci posso credere! Ce l’ha
veramente, l’attestato! E se l’è pure portato
dietro! Guardi, voglio essere buono, lei mi fa un po’
pena… esca, se ne vada… io non la mando neanche
in culo, né tento di pulirmelo col suo pezzo di carta…
però lei se ne vada… così, tranquillamente:
si alza, zitto, io le rendo il suo attestato, e lei esce di
qui. Piano piano. E facciamo conto che non è mai venuto.
In piena pace e stima reciproca…
voi vi alzerete, riprenderete il vostro foglio, e sarete già
sulla porta, con la maniglia in mano. E proprio allora vi raggiungeranno
le ultime parole, tipo così:
ehi, senta… le faremo sapere… non so, dovessimo
mai far qualche stage!
e giù a ridere come matti, voi e il vostro uomo del colloquio;
sennonché le cose non vanno neppure così, in realtà,
guastate come sono dalla formalità e riparate dietro
le buone maniere, che uno non può nemmeno divertirsi
a collezionare rifiuti: così mi hanno già risposto;
questo non me l’avevano ancora detto; quella era bella,
magari la riciclo, ecc. ecc. No: o non ti fanno sapere nulla,
o ti respingono nella maniera più incolore. Il bianco
e nero del rifiuto. Almeno si ridesse un po’…
invece deprimersi è fondamentale. Deprimersi
per sentirsi niente e pensare quindi che il lavoro sia tutto;
deprimersi per poi accettare le proposte più umilianti.
Deprimersi è andare all’ufficio di collocamento,
iscriversi, e sbattere la propria faccia-di-merda su quel che
è il genere umano. L’umanità più
scalcinata, sgangherata, e stracciona; il popolino più
gretto e misero; tutto ciò che sta all’ultimo stadio
della vita civile e immediatamente prima di quella vegetativa
si dà continuamente appuntamento negli uffici di collocamento
del mondo, che tra l’altro devono avere un qualche regolamento
segreto per cui il loro aspetto esterno è sempre lo stesso,
ad ogni latitudine ed in ogni periodo storico. Solitamente si
parte da un prefabbricato a pannelli che paiono di polistirolo,
più largo che lungo, uno stanzone del quale viene appunto
adibito ad ufficio, le pareti al latte di calce e il pavimento
di linoleum nero e grigio. Luci al neon sul soffitto e aria
artificiale completano l’opera – e poi si tratta
solo di arredarlo: due o tre scrivanie di formica laccata bianca
o nera, più o meno in mezzo alla stanza, e una in un
angolo, rinchiusa da quei separé per metà di plastica
nera e per l’altra di plexiglas: lo sgabuzzino di chi
comanda. Sul muro di fronte, delle tavolacce di compensato;
e attaccati con cimici colorate, annunci vari. Infine, un tavolone
centrale dalle zampe secche, con un paio di grossi raccoglitori
ad anelli contenenti le inserzioni dei diversi quotidiani, ritagliati
e messi lì. Più ancora delle cose, può
la presenza umana. Sparsi qua e là, raggruppati disordinatamente
e appoggiati ai muri, rabbiosamente in fila dietro le scrivanie,
più spesso aleggianti intorno ai raccoglitori come avvoltoi
ridicoli, gli elementi più squallidi e sciatti della
categoria uomo sfilano tranquilli, dando al tutto qualcosa di
tragicamente divertente.
Io ci sono stato, al collocamento, e sono pure arrivato all’orario
giusto, o cinque minuti prima che comunque fa lo stesso, e nell’atrio
(l’atrio non è altro che una parte dello stanzone
prefabbricato di cui sopra, semplicemente separato dal resto
da un sottile muro in cartongesso), in attesa che aprissero,
già mi trovavo in compagnia di un paio di ceffi piuttosto
loschi e di tre donne schiamazzanti, due più o meno giovani,
ed una di mezza età: gli uomini avevano uno i baffi e
l’altro no (la barba comunque di un paio di giorni, entrambi);
i capelli unti e il petto gonfio e pieno di peli, insaccato
alla meglio in canottiere da quattro soldi; le donne portavano
vestiti attillati, fumavano di continuo e avevano il rossetto
fin sotto il naso. Una di quelle più giovani aveva le
cuffie per il walk-man nelle orecchie e sentiva la sua musica
ovvia a tutto volume. Doveva aver avuto un rapporto sessuale
con i suoi jeans neri, a vedere come le entravano nel culo.
Quella più anziana aveva gli occhiali scuri e parlava
con l’altra, i folti riccioloni neri lasciati sciolti,
ad appoggiarsi sul dietro di una maglietta scollata rosa confetto.
Le loro voci erano rauche e irritanti, sfrontate. Entrambe avevano
le sopracciglia foltissime e scure, e denti un po’ a caso
sparati in bocca, e probabilmente gli uomini in canottiera stavano
pensando a come fare per abbordarle. Alle nove e qualche minuto
la porta si aprì. Le tre balzarono dentro quasi di corsa,
foglio e penna alla mano, pronte a litigare come comari acide
se qualcuno gli avesse sottratto i raccoglitori dal tavolo.
C’erano loro e loro avrebbero spulciato gli annunci, perdio.
La ragazza più giovane portò il suo culo e il
suo walk-man davanti alla parete degli annunci, e ogni tanto
guardava il cellulare, e ogni tanto gli annunci. Gli uomini
si erano messi davanti a me, vicino alle scrivanie, in una ipotetica
fila. Ipotetica anche perché io ero arrivato prima di
uno dei due, ma adesso mi ritrovavo dietro ad entrambi. A pensarci,
poi, ero arrivato anche prima delle due che si erano messe al
tavolone dei raccoglitori, ma probabilmente lo stesso regolamento
segreto che imponeva l’uniformità edilizia degli
uffici, diceva anche che chi primo varca quella porta, primo
conquista il raccoglitore o la scrivania. Comunque fosse, non
mi parve affatto il caso di protestare – chissà,
magari uno dei due, quello con lo sfregio sotto l’occhio,
mi avrebbe minacciato con un coltello, proprio mentre l’altro,
col suo bel dragone tatuato sull’avambraccio, dava tranquillo
i suoi dati alla signorina della scrivania.
Nell’attesa, uno dei raccoglitori era passato a una donna
appena arrivata. Accanto a lei, in piedi, stava un tale arruffato
e sudicio, che pareva conoscerla. Parlavano; questa aveva sotto
l’occhio sinistro una lunga macchia rossastra, come una
grossa voglia, che arrivava più o meno al labbro superiore,
e stava spiegando all’uomo come se l’era fatta:
stava spaccando legna per il suo padrone – doveva essere
una domestica in una qualche villa di campagna – e una
scheggia era partita, schizzandole di striscio sul viso. I due
si conoscevano, dicevo, e l’altro ne era assai felice,
perché il fatto implicava certo che il prossimo a cui
sarebbe toccato il raccoglitore sarebbe stato proprio lui. A
ciascuno secondo la sua raccomandazione.
Attendevo il mio turno, e i due uomini stavano lì davanti
a me, a puzzare di sudore e sghignazzare, mostrando tante gengive
e pochi, pochissimi denti. Quando il primo ebbe fatto, si allontanò
dalla scrivania e si mise a leggere gli annunci sul muro di
fronte, aspettando l’amico. Notai che gli mancava una
buona metà dell’indice della mano destra. Poi lo
raggiunse anche l’altro, col suo pancione gonfio e teso
e i peli sotto le ascelle che sporgevano da sotto le braccia
nodose come legno. Disse qualcosa a quello che leggeva gli annunci
e insieme se ne andarono. Forse li attendeva un bar, o una moglie
sformata gonfia e distrutta, seduta lì, davanti alla
sua telenovela delle undici del mattino.
Toccava a me: mi avvicino alla scrivania in questione e mi siedo.
Piena di nei e quasi cianotica, l’impiegata mi chiede
– fatico a sentire il tono di voce – di riempire
i moduli che mi porge cosicché possa inserire i miei
dati al computer che ha lì di fianco. Io penso che stia
per esalare l’ultimo respiro mentre parla, e mi sporgo
per sentire le sue ultime volontà; tuttavia, vedendo
i fogli intuisco cosa vuole da me e li compilo. Non la volevo
mica contrariare. Eseguita l’operazione mi fa un paio
di domande veloci e mi stampa un altro foglio il quale, dice
lei, è quello che richiedono le aziende assieme al libretto
di lavoro, libretto che io, avendo lavorato saltuariamente all’età
di quattordici anni o giù di lì, peraltro ho già,
e quindi non c’è bisogno di rifarlo. Chiedo perché
questo non basti più; perché ora insomma abbiano
aggiunto anche quel foglio:
“sa”, dico per giustificarmi, “non si sa mai…
un foglio così, singolo, volante, è facile da
perdere”.
E poi ho da faticare un bel po’ per sentire quello che
l’impiegata dalla flebile voce mi risponde, che comunque
non conta, perché se la legge dispone così, vuol
dire che così ha da essere, e anche la signorina non
è nient’altro che un pesce piccolo, dovrei saperlo
del resto, cosa sto a fare domande tanto cazzute.
Saluto e mi volto. Lo stanzone si era riempito, e tutti erano
accalcati vicino alle bacheche degli annunci. Con un occhio
leggevano le offerte di lavoro, perlopiù posti di caldaista,
aiuto-barista, manovale, operaio generico e così via,
e con l’altro vigilavano sui fortunati che, arrivati prima,
stavano spulciando quei raccoglitori sui tavoloni di formica
bianca. Quelli con gli annunci seri, non scritti a penna e appesi
con le puntine da disegno. In piedi, apparentemente attenti
a quel che il muro offriva, tutta questa gente scrutava e indagava
in realtà il comportamento di quelli seduti; se questi
ultimi mostravano soltanto l’intenzione di alzarsi, o
comunque di abbandonare il raccoglitore precedentemente conquistato,
gli altri erano subito pronti a subentrare. E allora succedeva
un casino. Erano mani che si tendevano, sguardi che si cercavano,
a richiamare attenzione; voci che azzardavano: ha fatto?; altre
voci che rimbeccavano: nossignora, ora tocca a me, e tutto insomma
era valido per riuscire a mettere il culo sulla sedia e le mani
sul raccoglitore ad anelli. A quel punto quella era una posizione
di assoluto prestigio, e chi l’aveva conquistata doveva
far pagare a tutti gli altri ciò che aveva dovuto sopportare
per arrivare fin lì, e faceva le sue cose con tutta la
calma del mondo, spulciando il suo raccoglitore per una mezz’ora
buona e anche di più. Non si arrivò mai ad un
litigio vero e proprio, ma gli sguardi erano sempre carichi
d’odio, e a chi riusciva a sedersi – il Re di turno
dell’ufficio di collocamento – erano sempre riservate
ogni tipo di maledizioni a bassa voce.
Mi venne la curiosità di chiedermi che fine avessero
fatto le tre che avevo incontrato all’apertura. Erano
ancora lì? Guardavo, e magari c’erano ancora, tutte
e tre, sempre lì, sempre a leggere tutti quegli annunci;
ma ormai pareva di essere al circo, o al reparto mostri di qualche
laboratorio segreto, e non aveva più alcun senso ricercare
una persona precisa lì in mezzo. Era uno sciame, variopinto
e compatto allo stesso tempo, sfaccettato ma assolutamente uniforme;
uno sciame che aveva, per così dire, un suo significato
solo considerato come insieme, un insieme decisamente pittoresco,
in cui ciascuno rappresentava una categoria. Tipi, non singole
persone: c’era la donna che aveva poco più di quarant’anni
e ne mostrava sessanta, sciupata da una vita di sacrifici, e
i fianchi larghi più di metro e le mani rovinate, grattate
dal lavoro; la ragazzina volgare, truccata e vestita in maniera
eccessiva, le unghie lunghissime, smaltate in nero o rosso scuro;
c’erano gli uomini, rozzi e bruschi, quasi deformi con
la loro pancia gonfia e le gambette secche; i ragazzi, stupidi
e sgarbati, che cercavano solo un buco dove poter infilare il
loro cazzo. Tutto questo, e in tutti gli uffici di collocamento
del mondo continuava ad esserci SEMPRE tutto questo. La singola
donna, i singoli uomini, tutti quanti non erano altro che singoli
esempi messi lì a rappresentare altri individui come
loro, migliaia, milioni; stessi individui all’interno
della stessa categoria, indistinguibili l’uno dall’altro,
come soldati semplici di quattro pulciosi plotoni sterminati
e dilaganti per il mondo.
Senza lavoro sarebbero morti. Non avrebbero potuto viverci,
e non era soltanto questione di soldi o sussistenza. Per quanto
si lamentassero e imprecassero e bestemmiassero quando lo avevano,
nel momento in cui si trovavano disoccupati erano finiti. Senza
qualcosa da fare (qualunque cosa fosse), la loro vita non aveva
più senso; non sarebbero mai riusciti a far passare le
ore: per arrivare a sera l’unica cosa era lavorare. Qualcuno
gli aveva insegnato che la vita era tutta lì, e loro
che ne potevano sapere? Anche per questo era perfettamente normale
che il secondo rovinasse la prima (già… e a pensarci,
il fatto era che a differenziarle l’una dall’altra,
quelle persone parevano avere esclusivamente una differente
menomazione fisica). Per fare in modo che fossero anche contenti
di questo, gli avevano trovato e lasciato degli spazi successivi,
serali, ritagliandoli da quel che rimaneva. I loro cosiddetti
divertimenti. E così tutti quelli che erano là,
pigiati davanti a quel muro di annunci, erano pure raggruppabili
secondo il motivo per cui se lo cercavano, il lavoro: le donne,
col loro buon senso animale, per dar da mangiare ai figli; le
ragazze per potersi comprare le ricariche del cellulare e pagare
l’ingresso in discoteca e comprarsi questo o quell’altro
vestito; gli uomini per andare a puttane, o al bar e bere e
parlare e litigare con altri uomini sulla tale partita e sul
rigore che non c’era; i ragazzi per comprarsi la macchina
o lo stereo per la macchina e per ubriacarsi e andare a puttane
così da parere grandi, proprio come gli altri.
Fosse quel che fosse, adesso ero fuori e me ne stavo andando,
e in una mano tenevo il mio libretto di lavoro col foglio nuovo
infilato dentro, ripiegato. Ero quasi felice di essere in regola
con la legge e poter condividere con chi l’aveva fatta
il dato certo che adesso con questo nuovo foglio tutte le procedure
si sarebbero semplificate e ogni cosa sarebbe stata più
semplice nella vita, ma avrei voluto lo stesso chiedere a qualcuno
il perché di tutto: perché quelli là dentro
non erano nient’altro che animali; perché non riuscivano
a capire, perché pochi altri (ma chi, cazzo?), sopra
di loro, facevano in modo che quelli non potessero capire. Camminavo
e tenevo la testa bassa, e intanto incrociavo altra gente polverosa
e schiamazzante che andava verso quell’ufficio. Probabilmente
non sarebbe finita mai, ma quella del collocamento era più
o meno per tutti la prima carta da giocare, e uno può
anche accettare che si riveli la più inutile. In mano
ne ha tante altre, e nessuno pensa di vincere così, alla
prima.
Per quelli che se ne accorgono, almeno per
metà, dello squallore e presa per il culo che è
l’ufficio di collocamento, sono state approntate altre
vie, giusto perché trovino la loro sistemazione pacifica
all’interno della società, ché è
così che ha da essere. In fondo questi non comprendono
la cosa in tutta la sua portata, ma si fermano solo all’esterno,
alle apparenze, per così dire. Quindi basterà
dargli un po’ più di eleganza e di tono, un surplus
di professionalità, magari qualche parolone, e loro saranno
contenti e beati. È per questo che esistono le aziende
di lavoro interinale, veri e propri uffici di collocamento che
però salvano l’etichetta e l’apparenza, con
tanto di etica cristallina e lucida.
“Hai sentito? Aprono anche qui una filiale di un’agenzia
di lavoro interinale”
Me lo stava dicendo un tipo che conoscevo, contento.
“Di cosa?”, chiesi io.
“Un ufficio per il lavoro interinale… l’aprono
in via Roma… davanti al cinema…”
“ah, quello… Ci sono pure passato davanti, qualche
giorno fa”.
Non sapevo che lo stessero aprendo; non sapevo dove, e non sapevo
cosa cazzo fosse il lavoro INTERINALE. Lì per lì
pensai fosse qualcosa che aveva a che fare con esperimenti medici
particolarmente delicati e importanti, magari roba fatta su
cavie animali, per testare qualche farmaco. Cercavano aiutanti,
pensai (e lo pensai in presenza di quel tipo, subito dopo che
mi aveva detto quelle cose, anche se a lui non dissi nulla),
studenti di medicina, che assistessero i professori veri e propri.
Poi, non mi ricordo esattamente come, saltò fuori che
era, molto più semplicemente, LAVORO TEMPORANEO. Glossolalia
– e solita storia: gran presa sugli idioti. Vaffanculo.
Passò un po’ di tempo: i giornali scrivevano del
grande successo di queste aziende, la gente parlava, alcune
persone che conoscevo si erano affidate, con fortuna, ad esse.
Provai ad andarci – che avevo da perdere? Magari per una
volta sarei riuscito a stare dalla parte di quelli che vincono.
Appena entrai nell’ufficio, la prima volta, una voce femminile
mi fermò:
“scusa, devi iscriverti nel nostro database?”
“Sì”
“mi spiace allora… le selezioni vengono effettuate
solo la mattina!”
“Ok, fa niente, arrivederci…”
e ripassai la mattina successiva. Forte del successo precedente,
entrai di nuovo dalla stessa porta, nello stesso ufficio. Stavolta
potei restare lì dentro per un tempo abbastanza lungo
per notare le differenze: pareti, sedie, scrivanie, arredamento
in genere; tutto riprendeva con eleganza e semplicità
i colori e lo stile del logo, della scritta appesa fuori. E
le impiegate (o, come avrei appreso più tardi, le Responsabili
di Selezione) erano pure carine. C’erano due o tre persone
prima di me, comodamente sedute, e una di queste era il mio
amico spalle-a-gruccia. I giornali scrivevano del loro successo,
la gente ne parlava, miei conoscenti ne usufruivano, e io, nell’agenzia
di lavoro temporaneo, ci trovavo il mio amico spalle-a-gruccia.
Il Caso. Il mio amico, poi, mica tanto in fin dei conti: eravamo
compagni di classe alle elementari, e questa era la terza, quarta
volta che lo rivedevo. Me lo ricordavo come un bambino vispo
e allegro e vivace, sempre a parlare di calcio e delle grandi
parate che faceva nella squadra dove suo padre lo portava a
giocare; ed ora invece non rideva praticamente mai, e aveva
stampato sul muso un ghigno scuro, cattivo e risentito. Soprattutto
aveva il fisico da culturista. Con ovviamente le spalle a gruccia,
che nel caso specifico non è proprio il massimo…
spalle gonfie che guardano verso il basso, tristi e sconfitte
come lui.
(L’ultima volta che lo avevo rivisto ero appunto dalle
parti di una palestra. Ero lì che aspettavo un mio amico,
uno che avrebbe dovuto accompagnarmi da qualche parte che ora
non ricordo, non appena avesse finito là dentro. Invece,
dagli spogliatoi uscì spalle-a-gruccia, accigliato come
sempre. Ci salutammo; mi stava raccontando non ricordo cosa,
sempre coi soliti toni amari, da sfogo, quando poco dopo uscì
anche il tipo che aspettavo. Salutai spalle-a-gruccia, che se
ne andò per la sua strada, e l’altro mi chiese:
“conosci quel tipo odiosissimo?”
Dissi che era stato a scuola con me, un tempo, e tutto il resto:
che era un bel po’ che non lo rivedevo, e che non sapevo
andasse in palestra. Dissi un sacco di cose.
“Be’, verrà anche in palestra, ma lo vedi?
Si muove che pare l’abbiano caricato a molla… sempre
incazzato com’è… e poi, soprattutto…
vedi te”, e quindi lo indicò, da lontano, mentre
quello stava infilando il suo borsone in macchina, “c’ha
le spalle a gruccia!”
Onde il nome: spalle-a-gruccia – ma lui non ne sapeva
nulla).
Insomma, spalle-a-gruccia non rideva mai, pieno di risentimento
com’era verso il mondo e la vita. Magari era allegro in
altre occasioni, ma comunque non quando lo vedevo io, e questa
era certo una di quelle volte, anche perché, nell’attesa
che toccasse a lui, mi salutò e mi disse:
“chi si vede! Anche te a cercare qualcosa, eh?”
Il tono era il solito, scoraggiato ma secco e duro, pronunciato
quasi guardando per terra.
Risposi (e più che altro dicevo queste cose a me stesso,
per convincermi):
“uno le prova tutte, no? E poi c’è chi dice
che con loro le cose funzionano!”
“Seee, ma tanto… fra tutti ti fanno passare la voglia!”
Un tipo che doveva aver patito tante amarezze, quello lì.
Neanche trent’anni e già sul groppone tutta la
rassegnazione e il fatalismo di un misero bracciante di sessanta,
abituato alle prepotenze del Signorotto del Paese. Cos’erano
le lamentazioni di Geremia, confronto a spalle-a-gruccia? La
rassegnazione rabbiosa, lo sconforto amaro: ancora, guardava
quasi per terra quando disse quelle parole, e la fronte era
accigliata e gli occhi cattivi, torvi. Ok, lo so… con
tutta probabilità aveva perfettamente ragione, il mio
amico spalle-a-gruccia; ma era così che doveva essere?
La malinconia di spalle-a-gruccia mi aveva restituito all’attesa
dell’ufficio, e quando fu il mio turno (c’erano
solo due Responsabili di Selezione – l’altra era
in ferie, al pari del Direttore della Sezione – e quindi
le cose andavano a rilento, mi dissero dopo) mi fecero compilare
un foglio, lo presero, e in base a quello mi fecero delle domande.
Parlavo con una signorina bionda, tutta tirata a lucido e con
delle bellissime mani e un sacco di altre cose. Una di quelle
ragazze per cui si può anche evitare di perdere il proprio
tempo, tanto avranno certo il loro principe azzurro ad aspettarle
a casa, alto, bello, abbronzato e muscoloso e con i soldi. O
comunque ne avranno in fila trecento, e tra loro ce ne saranno
certo un paio o anche di più, alti belli e intelligenti
e muscolosi e abbronzati e alla moda e sicuri di sé e
cos’altro? Ma non ero lì per notare certe cose,
e nemmeno lei del resto, e così quella prese a farmi
domande professionali, la voce impostata ma bassa di tono, come
in una sala da tè del secolo scorso:
“qui vedo che hai lavorato in una ditta d’abbigliamento,
come magazziniere… cosa facevi con più precisione?”
Glielo dissi, e lei continuò:
“per quale motivo è cessato il vostro rapporto
lavorativo?”
Per quale motivo è cessato il vostro rapporto lavorativo:
il fatto di dare del tu, e di mostrarsi informali e alla mano,
vicini alla gente comune, strideva coi termini professionalissimi
che dall’alto imponevano nonostante tutto. L’effetto
era involontariamente comico, e lo stesso valeva per l’abolizione-a-tutti-i-costi
dell’accento, dell’inflessione, delle parole più
regionali – il tutto a favore di un tono assolutamente
neutro, e perciò (secondo loro) garanzia di serietà
ed efficienza. Per lo stesso motivo, forse, imponevano di prendere,
come lei stava effettivamente facendo, degli appunti veloci,
dopo ogni risposta che il candidato aveva dato, ovviamente senza
far vedere cosa scrivevano, tanto per dare al tutto un’aria
professionalmente misteriosa. Comunque, qualcosa mi feci venire
in mente e qualcosa risposi, accennando al fatto che ero stato
là solo temporaneamente, per circa un mese, che non avevo
nessun contratto ben preciso, che mi davano qualcosa come collaboratore
occasionale. Cominciavo a sentirmi a disagio, e senza saper
bene perché.
“Quanto prendevi, se posso permettermi?”, chiese
poi la ragazza.
Non ero meravigliato o seccato da questa domanda (tutto sommato
l’aveva fatta con innocenza, educatamente; che male c’era?),
però non potei non pensare a tutta la gente che era dietro
di me. Finora il colloquio si era svolto, per così dire,
alla luce del giorno, a neanche due metri dalle altre persone,
senza divisione alcuna. Poteva essere imbarazzante in un certo
senso, anche perché se una volta arrivati alla classica
domanda cosa ti piacerebbe fare?, uno avesse voluto rispondere:
l’astronauta!; lo scienziato!, o anche: il dottore degli
animali!; non poteva. Cazzo, mica bello, in fin dei conti. Considerai
tutto questo, pensai a spalle-a-gruccia che se n’era andato,
salutandomi come sempre di sotto in su, e risposi. Lei, bella
come prima, non fece una piega e continuò:
“eee… cosa giudicheresti più importante,
in un lavoro? Godere di maggior libertà di movimento,
e quindi di più responsabilità, anche a livello
di orario e organizzazione di lavoro; o fare il tuo compito
e basta, dipendendo maggiormente da altri, senza dover prendere
iniziative di alcun tipo?”
“Probabilmente entrambe le cose hanno i loro vantaggi
e svantaggi. È difficile dirlo così su due piedi:
di certo la prima dà più soddisfazioni, ma la
seconda ha sicuramente meno preoccupazioni. Responsabilità.
Bisognerebbe valutare… anche se generalmente la responsabilità
viene col tempo. È difficile insomma che un’azienda,
penso, dia subito grandi libertà di movimento a un nuovo
arrivato”.
La risposta le piacque e accennò un sorriso. Avevo guadagnato
dei punti, mostrandomi bellamente intriso di buon senso piatto.
Chiacchiericcio travestito da massimi sistemi. Se insistevo,
alla prossima domanda avrei potuto chiederle se potevo, più
tardi, offrirle qualcosa da bere.
Proseguì:
“e cosa ti piacerebbe fare, o comunque cosa escluderesti?
Hai qualche preferenza?”
Esitai un attimo:
“non saprei… diciamo che forse preferirei non essere
contattato per lavori nel settore alberghiero, o da quelli che
dicevamo prima – da quelle parti diciamo che mi è
rimasta qualche conoscenza, e al limite potrei trovare qualcosa
da solo…”
“bene, grazie, abbiamo terminato. Avrei bisogno però
di una foto tessera – se l’hai con te sennò
non importa, ripasserai – e di un documento, per favore”.
Tirai fuori la carta di identità; lei mi indicò
un tale seduto ad una scrivania lì dietro:
“dalla pure al collega, grazie, che fa una fotocopia”.
E il collega si protese a prendere il documento e, mentre io
cercavo la foto, si diresse alla fotocopiatrice. Era vestito
in maniera assolutamente esagerata, per quella che era l’occasione:
un completo grigio molto elegante, una camicia in tono, e una
cravatta alla moda, di quelle col nodo gigante che strozza,
bordeaux. Stava tutto impettito, ma aveva una faccia da ragazzino,
e il tutto appariva assai ridicolo. Pareva un bambino che qualcuno
avesse vestito da ometto, così, tanto per ridere un po’
in famiglia. Mancava solo il cappello, il costoso Borsalino
del nonno, quello per i giorni di festa. Cerimoniosamente, il
collega mi diede la mano e mi rese il documento. Poi uscii di
lì. Ero convinto che non mi avrebbero mai richiamato;
qualcosa mi diceva che dalla parte di chi vince non ci sarei
stato nemmeno quella volta.
Avevo ragione, avevo torto? Non conta granché,
in fin dei conti. Quello che si fa, si dice, o si prova in materia
di lavoro non fa alcuna differenza. Per quel che mi riguarda,
credo che se dovessi mettere in fila le esperienze più
degradanti o tragicomiche – è lo stesso…
dipende sempre dal punto di vista da cui si guardano –
che ho vissuto, cose come queste starebbero subito sopra a quando
cacai davanti al portone d’ingresso di un’università,
una notte dopo una festa. Lì almeno stavo male, avevo
una congestione, e a quell’ora non avevo trovato un bagno.
C’ero, per così dire, costretto; non lo feci per
spregio (casomai lo feci CON spregio, già che c’ero
– ma questa è un’altra faccenda e un’altra
storia). A cercare lavoro e a sentirsi o rifiutare per qualche
motivo, o assumere come se ti facessero un grande piacere, c’ero
andato di mia spontanea volontà, nel pieno possesso di
me e delle mie facoltà mentali. E pure speranzoso, in
fondo. Ok, forse speranzoso no; ma comunque c’ero andato,
e tanto basta. A quel punto il passo successivo era obbligato:
parlare con uomini o donne importanti, chiedere un lavoro, anche
le cose peggiori, pur di mettere insieme qualche soldo, e loro
si sarebbero presi il mio tempo, la mia vita, ogni energia,
tutto quanto, e avrebbero continuato a prosperare e divertirsi,
mentre io e migliaia di altre persone lasciavamo scorrere le
nostre esistenze sollevandogli casse, facendogli conti, risolvendogli
problemi. Di trecentosessantacinque giorni, ce ne avrebbero
regalati quindici, al massimo ventidue. E con la scusa dei tempi
che stavano cambiando, si sarebbero pure attrezzati per coniare
nuove formule che consentissero loro o di non pagarti per un
certo periodo di tempo, o di scansare obblighi fiscali –
di fare, in definitiva, qualsiasi cosa fosse più vantaggiosa
per la loro azienda di merda. Il futuro era certo, mi dicevo:
se mi fosse andata bene, in altre parole, avrei saputo oggi
ciò che avrei fatto le otto ore successive dell’indomani.
Fino a quando mi sarebbe durato il contratto. Già, perché
al proposito, uno degli slogan più amati era è
finita l’era del posto fisso, il che voleva dire che loro
erano autorizzati a fare tutto, e gli altri ad arrangiarsi.
Curiosamente, a dirtelo erano spesso e volentieri persone che
il loro bravo posto fisso ce l’avevano eccome, e se lo
tenevano ben stretto. Le cose andavano così, ed era tutto.
Che ti restava di tutta questa brodaglia merdosa? Cercare di
ridere, ridere il più possibile, senza pensarci. Tutto
stava, mi dicevo, a saper guardare le cose da un certo punto
di vista. Quando finivi di ridere però, o eri impazzito
o ti avevano digerito lo stesso, in qualche altro modo. Finivi
di ridere, e se eri ancora buono ti ritrovavi di là dalla
scrivania. O almeno temporaneamente, fin quando faceva comodo
(a loro). Ridere era solo un modo per allontanare quel momento,
per non farci caso. Però alle volte ridevi per davvero,
e quando ti aiutavano proprio quelli che stavano dalla parte
buona, quelli che vincevano, i cavalli di razza insomma, era
un gran bel momento. Voglio dire, sapevi che prima o poi sarebbe
finito, e sapevi pure che quelli erano lì, pronti a prenderti
quantomeno per fame; ma per un po’ te ne scordavi e te
la ridevi, arrivando quasi a provare pena per loro e per tutti
quei cumuli di cagate che vomitavano. E in cui credevano, cazzo.
Il problema, semmai, era che la realtà andava sempre
al di là di ogni tua fantasia. E tu ti ritrovavi a ridere
di cose che erano incredibilmente vere. Nessuno l’avrebbe
mai detto, un tempo. Nessuno ci avrebbe mai creduto. E tutto
questo capitava a te, come fosse un film. Tutto sommato, era
meglio impazzire…
paperogonfio.splinder.com
|
|
![]()
![]()