| |
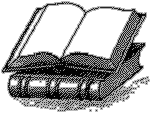
Fallimento
terapeutico
In una fredda
epoca di giorni tutti uguali fui passato al turno di notte.
Offrivo la mia forza lavoro nella catena di montaggio di un’azienda
che produceva serramenti. Il lavoro non era una pacchia. Stare
dietro a quelle dannate macchine non era semplice come poteva
sembrare. Il turno di notte era quello con la maggiore incidenza
d’infortuni. E’ difficile mantenere la concentrazione
ripetendo sempre le stesse azioni per otto ore di filato durante
il giorno, figuriamoci di notte. Le macchine erano sicure, a
prova di legge, purtroppo ciò non impediva di farsi molto
male senza la necessaria attenzione. Se non erano le macchine
era la sfiga che rincorreva noi sonnambuli. Solo una settimana
fa, un operaio da poco assunto, scivolando ha sbattuto la testa
contro la fresatrice. E’ ancora in coma. I parenti gli
portano fiori che lui non può vedere. Gli servano a poco
nella situazione in cui si trova.
A parte questo, era un lavoro brutto come altri…
…Ero
uscito dalla scuola con il massimo dei voti e un fido diploma
di ragioniere solo cinque anni prima. Pensavo che quel successo
sarebbe stato solo il primo di una lunga serie. Decisi di non
andare all’università e per non perdere tempo cercai
subito lavoro. Il lavoro non si fece attendere, bussò
presto alla mia porta. Fui assunto da una ditta che commerciava
calzature per sostituire un impiegato appena licenziatosi. Le
prospettive erano ottime e le mie referenze mi mettevano nell’invidiabile
condizione di poter crescere sia professionalmente sia socialmente.
Così mi dissero. Ne fui molto felice. Nulla nei primi
mesi di lavoro mi tolse questa sensazione. I colleghi erano
gentili con me, io ero gentile con loro. Il datore di lavoro
era gentile con me, io ero gentile con lui.
Non ci volle molto però prima che quella fresca brezza
mutasse in aria stantia. Non so dire se fu il mio atteggiamento
a cambiare, ma iniziai ad isolarmi sempre più dalla gente
che mi circondava. Nell’ufficio c’erano tre donne
ed un altro uomo. Le donne erano stupide al limite del ridicolo
quando parlavano delle “loro cose”: i regali ricevuti
dai mariti, il mestruo, il finto pietismo. L’insulsa mediocrità
della quale erano affette le rendeva immeritevoli d’ogni
mia minima attenzione. L’altro uomo mi era assolutamente
indifferente, poteva non esserci ed io non avrei notato la differenza.
Il datore di lavoro da gentile che era divenne invadente e assumeva
sempre più tendenze dittatoriali.
Decisi allora che era giunto il tempo di cavarmi dal pantano
in cui ero finito. Fondamentalmente il problema era che non
riuscivo a far credere agli altri e a me stesso che spostare
carta da un posto all’altro, perché poi era quello
che facevamo, fosse una sorta d’irrinunciabile missione
sulla terra, cosa di cui erano fermamente convinti i miei colleghi.
Erano passati solo sei mesi dalla mia prima assunzione e senza
motivi plausibili, a detta di molti, mi licenziai. Era solo
l’inizio. A breve distanza rifiutai altre quattro o cinque
ottime proposte di lavoro. Gli altri non capivano, mi chiedevano
che cazzo avevo nel cervello o meno bruscamente mi dicevano
che stavo sprecando la mia vita, che ad una certa età
è dura svegliarsi sentendosi un fallito. Erano tutti
amorevoli consigli, di gente che aveva esperienza, che certe
delusioni magari le aveva anche provate sulla propria pelle,
come mio padre. Ma non capivano che a me non fregava niente
della filosofia del “cogli l’attimo” che animava
le loro buone intenzioni. Finalmente mi rendevo conto di avere
sempre fatto scelte sbagliate al solo scopo di gratificare qualcun
altro. Ero stato un bravo figlio e uno studente modello, pronto
per essere un brillante lavoratore, un amorevole marito, un
premuroso padre, un onorevole morto.
Stranamente invece, mi sentivo sempre più attratto dal
ruolo del fallito, non ero nato per esserlo, e forse proprio
per questo mi dava la sensazione di qualcosa di eversivo, spiazzante.
Seguirono mesi difficili. Ebbi forti dissidi con i miei genitori.
M’incalzavano ogni giorno con le solite questioni riguardanti
il mio avvenire. Fu questa situazione più che l’ansia
per il mio futuro che mi spinse a trovarmi un’occupazione.
L’idea di trovarmi al più presto possibile una
sistemazione lontano da tutti e da tutto fece, in seguito, il
suo naturale capolinea nella mia mente.
Cercai un impiego come operaio e dopo circa un paio di mesi
fui accontentato. Entrai a far parte dell’azienda in cui
ancora oggi lavoro. Aspettai un altro paio di mesi prima di
andare a vivere in uno squallido monolocale in una zona suburbana.
L’affitto portava via gran parte del mio ridicolo stipendio.
La zona era un cesso ed i miei iniziarono ad ignorarmi…
…Fuori
era già buio, in uno stato di dormiveglia mi resi conto
che a breve sarebbe iniziato lo show. Io ero il fottuto protagonista.
Tra meno di tre ore sarei entrato in quel cazzo di stabilimento,
per uscirne solo l’indomani, quando sarei tornato a casa
ridotto ad un ammasso di carne molle e fiacca.
Il nostro lavoro era trasformare un pezzo di metallo senza forma
in qualcosa che l’aveva, ma il processo, ne ero sicuro,
funzionava anche in senso opposto, su di noi. Erano ormai diversi
giorni che sentivo le forze mancarmi e desideravo con disperazione
di poter tornare subito a casa. Poi pensavo che non ci sarebbe
stato nessuno ad accogliermi, non un abbraccio, non un bentornato,
non una schifosissima colazione già pronta. Allora tiravo
dritto fino a mattina senza più lagnarmi. La solitudine
si stava facendo largo dentro di me. Potevo sentirla nello stomaco,
nella spina dorsale, nel sangue. Feci anche degli esami ma tutto
sembrava andare bene. Non capivo cosa cazzo li facessero a fare
quegli esami se non capivano neanche ciò che per me era
chiaro.
Non ero sempre solo, qualche amicizia nello stabilimento l’avevo
stretta. Scoprii come, quando si soffre e si vive di poco, i
rapporti con gli altri si fanno più veri e profondi.
C’era stata anche qualche donna ma con loro purtroppo
funzionava in modo diverso, non ero mai stato particolarmente
fortunato, tutte storie brevi e burrascose, finivano tutte per
sentirsi a disagio con me.
La maggior parte erano donnacce che sfruttavano qualche malcapitato
per divertirsi un po’ senza impegnarsi, lo trattavano
come un ignorante, lo prendevano in giro e si divertivano a
pavoneggiarsi, piene di se.
Queste erano quelle con cui mi divertivo di più. Facevo
il loro gioco dimostrandomi un completo imbecille, le scopavo,
poi, lentamente, lasciavo trasparire che non ero l’idiota
che avevano pensato.
Arrivava sempre un tempo in cui la mia dialettica le disarmava
a tal punto che, rosse dalla rabbia, scappavano a gambe levate.
Era come estirpare l’erbaccia dal raccolto. Rimanevo straordinariamente
di buon umore per qualche giorno.
C’erano state anche donne per le quali spremere il cuore
non era un delitto, ma io, incapace bastardo, finivo sempre
per dover far i conti con l’orgoglio e mi ritrovavo a
raccogliere i cocci di me stesso.
…Il
tragitto dallo stabilimento a casa mia era breve e quando fui
messo al turno di notte, per un po’ mi rese felice l’idea
che quando tornavo a casa alle 6.00 di mattina gli altri dovevano
ancora andare a lavorare. Ci misi poco però a capire
che era solo una stupida consolazione, non era una sfida tra
me e qualche altro poveraccio, era tutto ciò che avevamo
intorno che non aveva senso. Tutta la dura scuola di vita che
avevo voluto provare sulle mie spalle per arrivare ad una così
squallida verità?
Poi, un giorno, lungo il tragitto di ritorno dallo stabilimento,
notai in lontananza un personaggio che pian piano acquistava
nitidezza. Come in quei giochi di enigmistica c’era qualcosa
di fuori posto nella scena che mi si presentava dinnanzi. L’uomo
era anziano, magro e rugoso. Mi veniva incontro correndo sul
marciapiede. La corsa era secca e regolare. L’età
dall’uomo era incompatibile con il ritmo della sua corsa.
La macchina che guidavo e l’uomo s’incrociarono
e proseguirono per la loro strada in direzioni opposte. Istintivamente
seguì l’uomo con lo sguardo finché non fu
più visibile.
Da quel giorno in poi tutti i giorni alla stessa ora si ripresentava
la stessa scena. Questo vecchio, in barba all’età,
aveva ancora voglia di darsi da fare e dimostrare qualcosa al
fottuto mondo. Il tutto aveva qualcosa di surreale, forse un
po’ per l’orario che richiamava facilmente un’atmosfera
onirica, forse perché, non so come, ma sembrava che quell’uomo
avesse iniziato a vivere proprio il giorno in cui lo avevo incontrato
la prima volta. Perché le mattine precedenti non lo avevo
mai visto?
Iniziai a domandarmi se anche lui aveva la stessa sensazione
nei miei confronti. In fin dei conti a quell’orario non
è che circolasse molta gente ed era presumibile che anche
lui mi avesse in qualche modo notato.
Passò l’inverno, arrivò la primavera che
mutò in estate per distendersi poi in un tranquillo autunno.
Il vecchio non ne aveva saltata una. Io d’altro canto
trasformai quell’uomo, come mia abitudine, in un’altra
delle mie ossessioni. Il vecchio mi affascinava, mi stimolava
e mi dava nuova forza per sopportare l’inferno che io
stesso mi ero creato. Avevo trovato una distrazione al mio deprecabile
incedere verso una morte per troppo “niente”. Se
lui alla sua età trovava la forza di fare ciò
che faceva anche io dovevo trovarla, e convincermi che quello
che facevo avesse un maledetto senso. Avevo bisogno di sentirlo
dire, frustato da questi anni di dolente mediocrità dovevo
ritrovare fiducia nelle mie scelte. Per anni, nei momenti difficili,
mi dicevo che quello che mi ero lasciato alle spalle era solo
merda. Un ragionamento che nessuno era riuscito a smontare.
Ma mi ripetevo spesso anche che il fallimento ormai conseguito
a pieni voti, forse non era una condizione in cui volevo soffermarmi
per tutta la vita. Ci doveva essere qualcos’altro che
mi era sfuggito.
…Un
martedì come tanti, mi svegliai alla solita ora, mi recai
al lavoro, feci quello che c’era da fare, tornai a casa.
Qualcosa stonava maledettamente, ci misi poco a capire cosa
non andava: il vecchio. Non c’era. Fui subito certo che
qualcosa doveva essere successo. I miei sospetti ebbero conferma
il giorno seguente quando un triste manifesto gemeva su un muro
all’angolo di una strada. Diceva pressappoco che un tale
veniva ricordato con profondo affetto e riconoscenza da tutta
la famiglia unita a commemorarlo ecc. ecc.
Il vuoto si impadronì del mio stomaco. Tornai a casa
senza dirigermi al lavoro, mi scaraventai sul letto ed un sonno
profondo senza sogni s’impadronì di me.
Mi svegliai nel cuore della notte. Pioveva. Mi diedi tre o quattro
schiaffoni per rianimarmi, calzai una tuta da ginnastica, un
paio di scarpe da tennis e mi fiondai all’aperto. La pioggia
scrosciava incessante a lavar via strade e palazzi ed io lì
sotto bisognoso dello stesso trattamento. Mi misi a correre.
Corsi. Corsi più forte. Quella spiacevole sensazione
mi rimaneva appiccicata addosso come pece. Ero stato preso in
giro. Quell’uomo era apparso dal nulla, aveva fatto breccia
nella mia vita ed io mi ero fidato di lui, avevo creduto nella
sua forza d’animo, il suo coraggio, vederlo vivere con
tale forza un esistenza che volgeva al termine mi aveva fatto
stare bene. Ora, che maledetto senso poteva avere la sua morte?
A me cosa rimaneva?
Esausto mi accasciai al suolo, sconfitto. Ancora una volta.
La pioggia lentamente si ritirò ed io, come al risveglio
da un sogno, mi chiesi cosa facevo lì disteso, per terra,
in mezzo alla strada. Quell’eccesso di melodrammaticità
non mi apparteneva.
Quando i primi bagliori dell’alba stavano per fare capolinea,
tornai a casa tirai fuori tutto ciò che avevo di alcolico
in casa e ne abusai fino al mattino seguente.
La sbornia ebbe successo. Quando mi svegliai, nel tardo pomeriggio,
avevo sì mal di testa e gola infuocata, ma in compenso
mi ero schiarito le idee sul da farsi. Non andai a lavorare.
Scesi in strada e vagai alla ricerca di informazioni sul vecchio,
sulla data e il luogo del suo funerale. Ottenni quello che cercavo.
La funzione sarebbe stata celebrata l’indomani nella parrocchia
del quartiere poi, a seguire, la processione verso il vicino
cimitero.
Il giorno seguente feci le cose con calma. Prima mi recai al
lavoro dove consegnai, con infinito sollievo, ad uno dei direttori
la mia lettera di licenziamento. Dopo passai a casa e infilai
l’unico vestito lontanamente adatto a certe tristi ricorrenze.
Fui il primo ad arrivare alla parrocchia, mi sistemai in una
delle ultime panche della navata centrale e, in silenzio, rimasi
lì per tutto il tempo della funzione. Solo questo avevo
da donare a quell’uomo che non conoscevo nemmeno. Con
tristezza mi resi conto della vacuità delle persone presenti,
più che altro vogliose di concludere la faccenda il più
in fretta possibile.
Quando tutto fu finito tornai a casa e telefonai ai miei. Era
trascorso molto tempo da quando lo avevo fatto l’ultima
volta, rimasi a lungo a parlare con loro. Fu bello sapere che
mi amavano ancora.
Era ormai sera, preparai il letto per la notte e spogliandomi
mi soffermai un poco davanti allo specchio.
…Avevo
solo 25 anni.
berto
|
|
![]()
![]()