| |
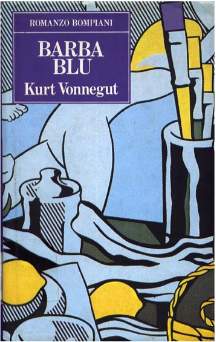 Nome:
Rabo. Cognome: Karabekian. Nato a San Ignacio di California
nel 1916, da genitori armeni. Stato civile: vedovo. Professione:
pittore e collezionista d'arte. La grande casa sulla riviera
di East Hampton - dove Rabo vive con la cuoca e la figlia di
questa, Celeste - ospita infatti un'importante raccolta di quadri
dell'espressionismo astratto. Ma che provenienza e che significato
hanno queste tele? E, soprattutto, che cosa nasconde nell'antico
patataio, accanto alla casa, l'eccentrico protagonista di questa
storia? Barbablù, nell'omonima favola, conduce la giovanissima
sposa nel suo castello e le dice: "Puoi entrare in tutte
le stanze, tranne una." E le mostra la porta proibita.
Alle insistenti domande di Circe Berman, morbosamente curiosa
di sapere che cosa contenga il capannone, Rabo Karabekian risponde:
"Senta, pensi a qualcos'altro, a qualsiasi altra cosa.
Io sono Barbablù e quello studio è la mia stanza
proibita, per quanto la riguarda."Tuttavia, come la moglie
di Barbablù, anche Circe Berman riuscirà alla
fine a scoprire il segreto del patataio. E quello di Rabo Karabekian.
La storia di Rabo e degli strani personaggi che gli gravitano
attorno è il pretesto che consente a Kurt Vonnegut di
tracciare un'altra satira pungente delta società americana
contemporanea e, in particolare, del mercato e del mondo dell'arte.
Il periodare rapido e incalzante, che i lettori dei precedenti
romanzi di Kurt Vonnegut già ben conoscono, la battuta
pronta, la distaccata ironia fanno di questo romanzo un'altra
prova significativa dello scrittore americano. Nome:
Rabo. Cognome: Karabekian. Nato a San Ignacio di California
nel 1916, da genitori armeni. Stato civile: vedovo. Professione:
pittore e collezionista d'arte. La grande casa sulla riviera
di East Hampton - dove Rabo vive con la cuoca e la figlia di
questa, Celeste - ospita infatti un'importante raccolta di quadri
dell'espressionismo astratto. Ma che provenienza e che significato
hanno queste tele? E, soprattutto, che cosa nasconde nell'antico
patataio, accanto alla casa, l'eccentrico protagonista di questa
storia? Barbablù, nell'omonima favola, conduce la giovanissima
sposa nel suo castello e le dice: "Puoi entrare in tutte
le stanze, tranne una." E le mostra la porta proibita.
Alle insistenti domande di Circe Berman, morbosamente curiosa
di sapere che cosa contenga il capannone, Rabo Karabekian risponde:
"Senta, pensi a qualcos'altro, a qualsiasi altra cosa.
Io sono Barbablù e quello studio è la mia stanza
proibita, per quanto la riguarda."Tuttavia, come la moglie
di Barbablù, anche Circe Berman riuscirà alla
fine a scoprire il segreto del patataio. E quello di Rabo Karabekian.
La storia di Rabo e degli strani personaggi che gli gravitano
attorno è il pretesto che consente a Kurt Vonnegut di
tracciare un'altra satira pungente delta società americana
contemporanea e, in particolare, del mercato e del mondo dell'arte.
Il periodare rapido e incalzante, che i lettori dei precedenti
romanzi di Kurt Vonnegut già ben conoscono, la battuta
pronta, la distaccata ironia fanno di questo romanzo un'altra
prova significativa dello scrittore americano.
***
Questo
è un romanzo e anche, se vogliamo, una burlesca autobiografia.
Non va preso come una storia seria, responsabile, dell'espressionismo
astratto, quella scuola di pittura che fu il primo importante
movimento artistico a nascere negli Stati Uniti d' America.
Di niente, è la storia, se non delle mie reazioni idiosincratiche
a questo e quello.
Rabo Karabekian non è mai esistito, ne mai vissero Terry
Kitchen e Circe Berman, Paul Slazinger o Dan Gregory, Edith
Taft, Marilee Kemp o alcun altro dei personaggi principali del
presente libro. Quanto alle persone reali e famose di cui tratto,
non faccio far loro alcunché che non fecero in realtà,
se messe al cimento su questo terreno di prova.
Vorrei anche far notare che gran parte di ciò che dico
in questo libro fu ispirato dalle cifre grottesche pagate, in
quest'ultimo secolo, per opere d'arte. Tremende concentrazioni
di ricchezza cartacea han fatto sì che poche persone
o istituti potessero attribuire, a certe forme di umana giocosità,
una sproporzionata, inadeguata e quindi angosciante serietà
d'intenti. Penso non solo alle formine di terra dell'arte, ma
anche ai giochi dei bambini: rincorrersi, nascondersi, saltare,
far la lotta.
O ballare.
O cantare canzoni.
l'inizio...
Scritta
la parola "fine" a questa storia della mia vita, ho
ritenuto prudente tornare subito all’inizio - qui, sul
portone d'ingresso per così dire - per porgere le mie
scuse agli ospiti in arrivo, in questi termini: "Vi avevo
promesso un'autobiografia, per cena, ma qualche cosa è
andata storta nel cucinarla. Ne è venuto fuori un diario
di quest'ultima, inquieta estate. Possiamo sempre però
mandare a prendere pizze e panini, in caso di bisogno. Entrate,
entrate pure."
Sono il quondam pittore americano Rabo Karabekian, e sono orbo.
Nacqui, da genitori immigrati, a San Ignacio di California,
nel 1916. Do inizio a questa autobiografia settantun anni dopo.
Per chi non abbia familiarità con gli antichi misteri
dell'aritmetica, siamo nel 1987.
Non sono nato ciclope. Persi l'occhio sinistro mentr'ero al
comando di un plotone di genieri (che erano, fatto curioso,
tutti artisti di questo o quel genere, nella vita civile) in
Lussemburgo, verso la fine della seconda guerra mondiale. Il
nostro era un reparto di esperti in mimetizzazione ma, in quel
periodo, si combatteva per salvare la vita, anche noi, come
fanti comuni. Il plotone era composto da artisti poiché,
secondo la teoria di qualche pezzo grosso dell’esercito,
dovevano essere particolarmente bravi nei camuffamenti.
E
lo eravamo. Altroché! Quante traveggole noi procurammo
ai tedeschi, circa ciò che fosse o non fosse pericoloso
per loro nelle nostre retrovie! Si, ci veniva consentito di
vivere da artisti, anche allegramente trascurati nella foggia
del vestire e nel galateo militaresco. Non dipendevamo da un
comando di divisione e neppure di corpo d armata, no, niente
di così banale: ricevevamo ordini direttamente dal comando
supremo delle forze di spedizione alleate, che ci assegnava
a questo o quel generale, il quale aveva udito parlare dei nostri
sorprendenti illusionismi. Costui fungeva da nostro patrono
per appena un po' di tempo, permissivo e affascinato e, infine,
riconoscente.
Poi si cambiava ancora.
Poiché ero andato sotto le armi due anni prima dell'entrata
in guerra degli Stati Uniti, divenendo tenente entro breve,
sarei potuto arrivare alla fine del conflitto con il grado,
perlomeno, di tenente colonnello. Sennonché rifiutai
ogni promozione, dopo capitano, allo scopo di restare in seno
a quella felice famiglia di trentasei uomini. Fu la mia prima
esperienza con una famiglia così numerosa. La seconda
fu dopo la guerra, allorché divenni amico e sodale di
quei pittori americani che passeranno alla storia dell'arte
come fondatori dell'espressionismo astratto.
Mio
padre e mia madre avevano, nel vecchio mondo, famiglie ancor
più numerose di queste due mie, e poi, s'intende, i loro
parenti erano tutti consanguinei, là. Li persero, i loro
parenti carnali, nella carneficina perpetrata dall'impero turco,
che fece massacrare circa un milione di suoi cittadini armeni
ritenuti traditori per due motivi: primo, perché erano
intelligenti e istruiti; secondo, perché molti di loro
avevano congiunti al di là della frontiera turca, nel
nemico impero russo.
Era un'epoca di imperi, quella. E anche questa lo è,
neanche tanto ben camuffata.
L'impero germanico, alleato dei turchi, inviò impassibili
osservatori militari a valutare il primo genocidio del secolo,
parola che, allora, non esisteva in alcuna lingua. Oggi è
corrente ovunque e sta a indicare un ben programmato impegno
mirante a uccidere ogni membro - siano uomini, donne o bambini
- di una determinata sottofamiglia della razza umana.
I problemi che siffatti ambiziosi progetti presentano sono puramente
industriali: come uccidere sì gran numero di grossi,
ingegnosi animali alla svelta e a buon mercato, far si che nessuno
sfugga e, poi, smaltire montagne di carne e di ossa. I turchi,
nella loro pionieristica impresa, né avevano attitudine
per operazioni veramente grosse, né disponevano di adeguati
macchinari. I tedeschi daranno prova di possedere, in misura
eccellente, e l'una e gli altri appena un quarto di secolo dopo.
I turchi prendevano, semplicemente, tutti gli armeni che riuscivano
a trovare - o nelle loro case, o nei luoghi di lavoro o di svago,
o di studio, o di preghiera, o che - li portavano, intruppati,
in aperta campagna, li lasciavano senza cibo ne acqua ne riparo
alle intemperie, li prendevano a fucilate o a mazzolate o a
che altro finché non sembravano morti. Spettava quindi
ai cani, agli avvoltoi, ai roditori e così via, e infine
ai vermi, di fare piazza pulita.
Mia madre, che ancora non era mia madre, fece finta di essere
morta frammezzo ai cadaveri.
Mio padre, che ancora non era suo marito, si nascose fra il
piscio e la merda di un pozzo nero - dietro la scuola dove insegnava
- quando vennero i soldati. Le lezioni erano terminate, quel
giorno, e il mio futuro padre si era trattenuto, tutto solo,
in un'aula - mi racconterà un giorno - a scrivere poesie.
Quando udì la soldataglia, arguì subito che intenzioni
avessero. Babbo né vide né udì la carneficina.
Per lui, la quiete del paesino - del quale, al calar della sera,
era rimasto l'unico abitante, inzuppato di piscio e merda -
fu il ricordo più orrendo del massacro.
Sebbene
i ricordi che del vecchio mondo serbava mia madre fossero assai
più macabri di quelli di mio padre - poiché essa
era venuta a trovarsi sul campo di sterminio - riuscirà
tuttavia a lasciarsi il massacro dietro le spalle e a trovare
molto di cui rallegrarsi, negli Stati Uniti, molto di cui sognare
a occhi aperti per l'avvenire della sua famiglia.
Mio padre invece non ci riuscì mai.
Sono
vedovo. Mia moglie, la mia seconda moglie, Edith nata Taft,
è morta due anni fa. Mi ha lasciato questa casa di diciannove
stanze, sulla riviera di East Hampton a Long Island, appartenente
da tre generazioni alla sua famiglia, anglosassone, oriunda
di Cincinnati nell'Ohio. I suoi antenati certo non si aspettavano
che finisse in mano a un tipo esotico come Rabo Karabekian.
Ammesso che infestino la casa, l'infestano con sì buone
maniere episcopaliane che finora nessuno s'è accorto
dei loro fantasmi. Ne incontrassi uno sullo scalone, e mi dicesse
che non ho alcun diritto a codesta dimora, gli risponderei:
"Pigliatela con la Statua della libertà."
La
cara Edith e io siamo stati felicemente sposati per vent'anni.
Lei era pronipote di William Howard Taft, il ventisettesimo
presidente degli Stati Uniti e il decimo presidente della Corte
Suprema. Inoltre era vedova di un banchiere di Cincinnati, gran
sportivo, a nome Richard Fairbanks junior, discendente a sua
volta di Charles Warren Fairbanks, senatore dell'Indiana e vicepresidente
sotto Theodore Roosevelt.
Ci si era conosciuti assai prima che il marito morisse allorché
persuasi entrambi - sebbene la padrona fosse lei, non lui -
ad affittarmi, uno studio, un granaio (o per essere pin esatti
un patataio) in disuso. Essi non avevano mai coltivato patate,
s'intende. Avevano semplicemente acquistato della terra da un
contadino loro confinante, sul lato nord, cioè lontano
dal lido, onde impedire che vi si costruissero case d'abitazione.
Insieme al terreno, era compreso il capannone.
Edith e io non ebbimo a conoscerci bene se non dopo la morte
di suo marito e dopo che la mia prima moglie, Dorothy, e i nostri
due figli, Terry e Henri, furono andati a stare per conto loro.
Venduta la casa, nel paesino di Springs a dieci chilometri da
qui, feci del rustico di Edith non solo il mio studio ma anche
la mia abitazione.
Questa inconsueta dimora, fra parentesi, non a visibile dalla
villa, dove adesso sto scrivendo.
Edith non aveva figli di primo letto e aveva superato l'età
puerperale quando la tramutai, da consorte di Richard Fairbanks
Junior, in consorte di Rabo Karabekian.
Quindi era una famiglia piccolissima ad abitare questa enorme
villa, con piscina e due campi da tennis, con la sua brava rimessa
per carrozze e annesso capannone per le patate - nonché
trecento metri di spiaggia privata sull'oceano Atlantico.
Si potrebbe pensare che ai miei figli, Terry e Henri - da me
così chiamati, l'uno in onore del mio più caro
amico, il defunto Terry Kitchen, e 1'altro in onore dell'artista
che Terry e io più invidiavamo, Henri Matisse - faccia
piacere venir qui a villeggiare con le rispettive famiglie.
Terry è padre di due figli. Henri di una figlia.
Invece, neppure mi parlano.
"Così sia! Così sia!" grido io, in questo
ben curato deserto. "Chi se ne frega!" Scusate lo
sfogo.
|
|
![]()
![]()