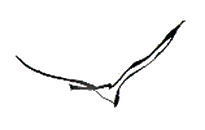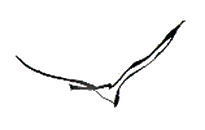Ho fatto una scoperta interessante: digitando il nome
di Stig Dagerman, una delle figure di maggior spicco della letteratura
svedese, e nordica in generale, di questo secolo, non in uno ma in più
motori di ricerca, mi sono stati indicati solo due siti italiani (tra
l'altro non proprio eccezionali, se scusate l'eufemismo)
Il risultato è stato ben diverso facendo una ricerca estesa a
tutti i siti del web: i siti di Dagerman, tra l'altro tutti rigorosamente
in svedese e tutti rigosamente a me incomprensibili, fiorivano come
il mio glicine in primavera…una moltitudine di informazioni, di
commenti, forse anche di testi.
A mio modo di vedere tutto questo ha un suo razionale, e dirò
di più, una sua necessità: Dagerman è stato veramente
un grande scrittore, uno di quegli scrittori di cui difficilmente ci
si stanca, di cui ci si annota il modo di scrivere, alcune frasi, il
pensiero. Geniale e maledetto dotato di una capacità stilistica
davvero notevole (e dicendo questo mi accorgo di quanto mi dispiaccia
non conoscere lo svedese).
Autore più che altro di racconti, Dagerman si fa il portavoce
del disagio verso un mondo dilaniato non solo dal conflitto mondiale,
ma soprattutto dal conflitto sociale tra i ricchi e i poveri, che sono
contrapposti come modelli di un'umanità diversa eppure sempre
irrisa dal destino, irrimediabilmente tragico.
Questo destino drammatico e ineluttabile ci viene rovesciato addosso,
a volte anche dalle prima pagine o anche solo dalle prime righe (come
in quel brevissimo racconto che è "Uccidere
un bambino" e che riassume in modo impeccabile gra parte della
concezione sia poetica che della vita di Dagerman): siamo di fronte
a un racconto che sa di cinematografia, siamo anche noi spettatori,
consapevoli, a differenza dei protagonisti, di un destino che attende
i personaggi e che non potrà in nessun modo essere cambiato.
Vediamo così i personaggi dirigersi incontro al dramma che da
subito è sviscerato: eppure questo da al tutto un pathos incredibile.
Non c'è spazio però per la disperazione,
la tensione drammatica è resa con lucida consapevolezza, con
disillusione: come se non valesse neppure la pena lottare per cambiare
le cose, in un clima di rassegnazione, che solo poche volte viene vinto.
Ognuno si dirige stancamente, più o meno conscio di ciò
che lo aspetta, verso un destino tragico-ironico, che porta sempre l'opposto
di ciò che si ricerca.
Dagerman rivolge il suo sguardo soprattutto sui bambini, presenti nei
suoi racconti come "dannati dal destino", impossibilitati
sia a dare che ad avere, ma soprattutto disillusi come gli adulti, senza
più sogni, senza possibilità di uscire dalla loro statica
condizione, assillati dal proprio dramma a causa di una maggior sensibilità
che li porta a sentirsi essi stessi sbagliati, con il rimorso di vivere.
Ma il dramma vero sembra essere soprattutto la mancanza di comunicazione,
il restringimento degli affetti, l'incapacità di mettersi in
comunione profonda. (La scacchiera, A casa della nonna)
Persino all'interno della propria famiglia non ci si (ri)conosce: forse
perché ognuno non conosce neppure se stesso. (Una tragedia
minore, La notte di San Giovanni)
In realtà Dagerman è molto più sottile: non ci
conosce infatti perché è sbagliato l'oggetto del conoscere,
perché si va a analizzare la materialità. Sono le cose
che ci dicono chi siamo? Potremmo mettere questa frase un po' come una
provocazione, anche oggi molto attuale.
Dagerman si fa allora specchio critico di una società profondamente
malata dalla ricerca della felicità nelle cose, dimenticando
gli affetti, i rapporti, ma mostra al contempo l'impossibilità
di trovare davvero la felicità, perché il mondo è
assurdo e drammatico anche per i ricchi.
Insomma un pessimismo cosmico che fa pensare anche se con molte diversità
a Leopardi, e che Dagerman visse sulla sua pelle, giungendo a suicidarsi
giovanissimo, all'apice del successo.