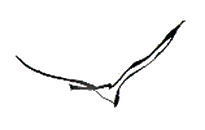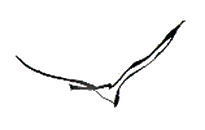Nei suoi scritti Raymond Carver (1938-1988) centra quasi sempre l'attenzione
su relazioni che ormai non funzionano, che non hanno mai funzionato,
che è quasi sicuro che non si potranno aggiustare; su protagonisti
- esseri umani, quasi sempre uomini - che sono stati sopraffatti dalle
circostanze, dal disamore o dalla prospettiva egocentrica frutto del
loro egoismo, facendo così fallire l'unico progetto che rappresentava
la possibile felicità nelle loro vite: l'amore. Gli uomini di
Carver si azzuffano con la vita, e con la donna. Si rifugiano nell'alcol,
nella menzogna, nel pretesto, nello sguardo anticipatore o incerto riguardo
a un mondo che deraglia e che, apparentemente, nulla può salvare.
Come sembra sostenere il regista Robert Altman nel film America oggi
(Short cuts, 1993), che incrocia trame e personaggi dello scrittore,
le storie di Carver potrebbero compendiare la diagnosi della società
californiana (molte di esse si svolgono in quella parte degli Stati
Uniti) o delle persone che abitano i consunti Paesi del benessere dell'Occidente.
Ma forse le intenzioni dello scrittore si fanno carico di un'esigenza
più profonda: eseguire una radiografia dell'anima dell'uomo contemporaneo,
mettere a nudo noi stessi.
La tesi che si vuol sostenere in queste pagine è la seguente:
il modo in cui Carver vede l'uomo, nonostante la scorza dura e disincarnata
che il lettore potrebbe percepire a tutta prima come l'elemento dominante,
è uno sguardo che al fondo conserva una luce di speranza. È
pur vero che quella luce pare a volte molto tenue; ma è altrettanto
vero che lo scrittore sembra non volersi distaccare dalla mimesi del
mondo che lo circonda, ed è per questo che vede necessario incentrare
la propria attenzione sull'assenza di valori, sul disorientamento che
subentra in un contesto carico di fatalismo. Questa tensione, nella
quale forse si potrebbe scorgere l'origine dell'amarezza beffarda di
tante sue storie, è in fin dei conti la ragione che fa delle
opere di Carver una lettura raccomandabile: senza mai voler insegnare,
di fatto insegna, poiché riesce a far sì che il lettore
si purifichi della propria mediocrità.
Ma per realizzare il compito che ci prefiggiamo, converrà prendere
in esame alcuni dei suoi racconti.
Il primo libro pubblicato da Carver mostra uno stile ancora in formazione,
che può andare assai oltre. Storie molto brevi (ventidue in duecentocinquanta
pagine), frasi corte (perentorie), metafore pressoché assenti:
si cerca l'essenziale, quasi che l'ideale fosse scrivere il silenzio,
o evidenziare il carattere del tutto non epico dei personaggi che popolano
l'opera.
Le storie sono, in genere, concluse in sé stesse: la cameriera
zotica che deride un grassone che appare felice quando mangia, benché
la vita di lei risulti non meno triviale dell'ingurgitare del suo cliente
(Grasso); la curiosità meschina e morbosa dei Miller, che approfittano
dell'assenza e della fiducia dei loro vicini, e la gratificazione che
ricavano dallo scavare nella miseria di coloro che si presentano come
perfetti, e l'insuccesso anche in questa povera attività, che
li porta a un abbraccio "come per ripararsi dal vento", quasi
annunciasse la fragile condizione della loro stessa unione (Vicini).
La fragilità delle coppie come Earl e Doreen (Loro non sono mica
tuo marito); la fragilità dell'adolescente che marina la scuola
fingendosi malato per andare a pescare, e finisce per interrompere la
costante litigiosità tra i suoi genitori (monotona come il rumore
della televisione), che fanno di lui un altro Holden Caufield, senza
la posizione sociale e la dimensione lirica del protagonista di Salinger,
eppure con altrettanta componente patetica (Nessuno diceva niente).
Le storie si susseguono al ritmo stanco della tristezza che le pervade:
giovani sposi che sono allegri se hanno "fumato"; infantili
neodivorziati a caccia di programmi notturni poco impegnativi; disoccupati;
una giovane coppia che veglia di notte e ha paura della morte; piccole
infamie con amanti nascoste e con cani e con bambini. Le storie di Carver
si susseguono. E così pure il disagio. I naufraghi dei suoi racconti
muovono alla pietà: sembrano così deboli da farci capire
l'amore che il loro autore ha per loro. Non sono spregevoli; appaiono
semplicemente poca cosa e - per questo motivo - suscitano il bisogno
di curarsene, di aiutarli, di spingerli al meglio. Le storie di Carver
vertono su persone reali e perciò esigono l'indulgenza del lettore
e un po' di comprensione, vale a dire d'impegno.
Questo clima di pietà si concreta in modo magistrale nel racconto
che conclude e dà il titolo al volume: Vuoi star zitta, per favore?
Ci troviamo nel tipico universo di Carver: Ralph, un uomo ammonito da
suo padre circa la durezza della vita, con una giovinezza carica di
promesse, che negli anni universitari smarrisce la chiarezza di obiettivi.
Un uomo comune che, superata la crisi alcolica così abituale
in Carver, si redime per mezzo di un professore (la verità) e
di una condiscepola (la bellezza) che lo rimettono sulla via dello studio.
Di lei, Marian, si innamora; i genitori approvano il fidanzamento; "la
sera prima delle nozze si erano tenuti per mano e avevano giurato di
mantenere sempre vivi l'eccitazione e il mistero del matrimonio";
forse Ralph non ricordava più i consigli di suo padre.
Raymond Carver è realista: nessun sempre, in questa successione
temporale che consuma tutto, dura troppo tempo. I due lavorano insieme,
entrambi professori a Eureka, nel nord della California. Vi si stabiliscono:
la moglie, la casa, due figli, le radici. "Senza rifletterci molto,
Ralph aveva la sensazione che lui e Marian si capissero alla perfezione
- nella misura in cui, per lo meno, una cosa del genere è possibile
tra due persone. Inoltre, Ralph era convinto di capire sé stesso
- le sue capacità, i suoi limiti e i traguardi che avrebbe raggiunto
grazie a questa prudente valutazione di sé stesso". Viveva
nella sicurezza di un mondo interpretato senza la consapevolezza di
ciò che Martha Nussbaum ha chiamato "la fragilità
del bene", e perciò senza rendersi conto di quanto fosse
contingente la sua interpretazione.
Passano gli anni. "Si consideravano una coppia felice, e l'unico
trauma del loro matrimonio era ormai passato da un pezzo: quest'inverno
sarebbero stati due anni". Anche se non ne avevano più parlato,
Ralph era roso dal dubbio: due anni prima sua moglie gli era stata infedele?
La fragilità. Il chiarimento avviene - quando i bambini sono
già addormentati - una domenica sera, in cucina - scenario dei
dettagli contingenti dell'amore (lei stira, lui corregge compiti, lei
lo chiama "amore") -, con una conversazione che tenta di sondare
il mistero: è arrivato il momento di parlare.
Il ricordo di quella sera permane vivo in entrambi, affiora alla prima
sollecitazione. Il passare dei giorni non sembra cancellare la colpa.
Questa volta non c'è violenza, non ci sono pugni come due anni
prima. Marian va sgranando gli avvenimenti: dapprima giunge fino al
bacio - l'alcol e la notte, ancora una volta, sono le cause scatenanti
del dramma, insieme alla debolezza - e poi accenna a un impulso sbagliato.
Marian non vuol continuare a parlare. Ralph promette che non si arrabbierà.
Una sigaretta accesa, la notte di due anni fa, l'infedeltà. "Ralph
chiuse gli occhi. Scosse la testa, provò a creare ipotesi, altre
conclusioni. Si chiese addirittura se fosse possibile tornare a quella
sera di due anni prima". Ma questo non è possibile. Nell'universo
tragico il tempo è spietato, non permette né di retrocedere
né di aggiustare, e perciò impedisce il perdono, per cui
la colpa rimane senza possibilità di cancellazione. Il passato
è mera necessità: in esso - come bene ha individuato Nietzsche
- non c'è posto per la libertà. È questo il mondo
di Carver? Proseguiamo la sua storia.
Ralph se ne va di casa. S'immerge nella notte, si dispera: "Sì,
pensò, c'era proprio una gran malvagità che premeva sul
mondo e aveva bisogno solo di uno spiraglio, bastava la benché
minima fessura". Donne ebbre, locali gremiti, lui stesso ubriaco,
una confessione davanti a estranei, un pestaggio al porto. Ci ricorda
Edipo dopo la caduta: innocente e vittima, castigato per delitti che
non ha commesso, incapace di cambiare un destino cieco. Fa giorno. Gli
uccelli marini lo svegliano sul molo del porto. Ora Ralph potrebbe essere
Ulisse, il naufrago che decide di ritornare a casa: a Itaca, da Penelope.
Ma chi è la sua Penelope se non la donna che l'ha ingannato?
Dov'è allora la sua casa, se è vero che la sua convivenza
è stata costruita su una menzogna, se non c'è posto per
la fiducia, se non è possibile il riposo?
In casa tutto è aperto. Le tracce della sconsolata Marian sono
restituite da mozziconi di sigarette, residuati dalla fretta e dalla
veglia insonne. Ralph se ne deve andare? Che cosa deve fare? I bambini,
le radici, la felicità promessa con quel "per sempre"
che era sembrato avere la vocazione di parola al di sopra del tempo,
al di là della menzogna e delle circostanze. Che cosa ne rimane?
"Poi sentì muoversi i bambini. Si tirò su e cercò
di sorridere quando entrarono in cucina": l'attenzione che esigono
quelle vite che incominciano a schiudersi, la consapevolezza della realtà
del volto dell'Altro (Lévinas), che sta dicendo "non uccidere",
"non puoi recar danno a quella innocenza", lo costringono
a cambiare, a lasciar da parte il proprio dolore e la possibile giustizia
del proprio distacco, della propria vendetta. I bambini, la loro vista,
è la prima porta perché Ralph abbandoni il proprio dolore:
la realtà non è quella "gran malvagità"
della quale si lamentava prima, benché sia impregnata di sofferenza.
Quella sofferenza gli fa scoprire la realtà dell'Altro (in questo
caso, del figlio) come qualcosa che merita attenzione; in questo modo
l'orma del male si trasforma in possibile redenzione. C'è anche
Marian: egli non la vuol vedere. Lei insiste. "Vuoi star zitta,
per favore?", le grida Ralph dal bagno. Lei insiste ancora: gli
parla con affetto. E alla fine lei lo abbraccia, e il marito - desolato,
perché soltanto gli amanti sono capaci di dolore ("l'ultimo
modo di amare", dice Salinas) - "si era girato e rigirato
in quello che avrebbe potuto essere un sonno stupendo, e si stava ancora
rigirando, stupito dagli impossibili mutamenti da cui si sentiva travolto".
Finisce il racconto: se soffre è perché ama; se lei non
ha dimenticato quella notte non è per quanto di emozionante aveva
potuto contenere quella sua relazione illecita, bensì per la
ferita che la menzogna ha lasciato nella sua anima. Lei chiede perdono
a lui - che, in quanto l'ama, accetta sua moglie come essere debole
- ed egli la perdona. Il perdono non è l'accettazione rassegnata
di qualcosa di fatale. Perdonare diventa il segno per eccellenza dell'atteggiamento
di benevolenza di chi capisce che la fragilità del bene può
a volte risolversi, ma non negando il tradimento dell'amato, bensì
assumendo in proprio detta fragilità e facendosene carico. Vengono
in mente le considerazioni di Spaemann: "Prendere un uomo veramente
sul serio significa distruggerlo, poiché essere preso veramente
sul serio è qualcosa che esige troppo da noi".
Le storie di Carver, nel secondo volume di racconti (Di cosa parliamo
quando parliamo d'amore), a prima vista non sembrano storie d'amore.
Sono popolate da contrasti. Gli uomini di cui trattano sono "brave
persone, sono attaccati alla famiglia, responsabili sul lavoro. I loro
figli vanno a scuola con nostro figlio", eppure sono così
mostruosi da riuscire a convivere con il cadavere di una ragazza ripescata
dal fiume per non guastarsi alcune giornate di pesca. Lo rilevava Hanna
Arendt: il carattere mostruoso della modernità consiste nell'astrazione.
Gli uomini non sono cattivi, ma insulsi, incapaci di rendersi conto
del carattere di novità insito in ogni persona. Così si
capisce che un cadavere ripescato in un fiume, il corpo nudo di una
ragazza, per loro si riduca a diventare l'unico problema che potrebbe
guastare un fine settimana di pesca, svincolato da fatti dei quali essi
non sono colpevoli e che pertanto non li riguardano.
E trattano di donne infelici che, ubriache, si lamentano dell'infedeltà
del marito, mentre questi recrimina che la fiducia sia morta per un
piacere meschino e sventurato del quale non resta più nulla.
E parlano di coppie mature che invecchiano unite nella paura della malattia
e della morte.
Nelle storie di Carver assistiamo alla debolezza di personaggi privi
di orientamento e di radici, sconcertati, sorpresi e trascinati dalle
atrocità che sono capaci di commettere in un mondo insicuro,
lamentevole, opprimente, triste (per esempio in Di' alle donne che andiamo).
Alcuni si chiedono Di cosa parliamo quando parliamo d'amore e giungono
a proporre delle risposte che affiorano solo a patto che non si sappia
se ciò di cui parlano è davvero amore, nostalgia di un
bene di cui sentono la mancanza, o cieco frutto di vapori alcolici.
Esseri solitari, davanti ai quali si dovrebbe avere compassione, ma
che spesso si imbatteranno nel vuoto scherzare della ragazza del primo
racconto, forse la più penosa delle creature che si trascinano
per quelle pagine (Perché non ballate?).
Grazie a Dio anche Carver conosce la pietà, ma in questo secondo
volume essa appare di rado. Il bagno è il titolo di una delle
storie. Una seconda versione, notevolmente più lunga, comparirà
in Cattedrale con un titolo diverso: Una cosa piccola ma buona. Ann
Weiss entra in un centro commerciale per ordinare una torta di cioccolata
alla pasticceria. "Il pasticcere, un signore anziano dal collo
robusto, rimase ad ascoltarla senza dire niente mentre lei gli spiegava
che il figlio avrebbe compiuto otto anni lunedì [...]. Le diede
tutto il tempo che voleva. Era appena arrivato al lavoro e sarebbe stato
lì tutta la notte a infornare dolci, perciò non è
che avesse fretta". È in questo modo che si scontrano l'entusiasmo
e l'abitudine, la madre del proprio figlio unico - Scotty - e il produttore
in serie di torte. Lei gli lascia il nome e il numero di telefono, e
se ne va irritata. Fin qui tutto è vita di ogni giorno, anche
la noia dell'uno e la stizza dell'altra.
Il lunedì mattina Scotty, andando a scuola, viene investito da
una macchina mentre attraversa distrattamente su un passaggio zebrato.
Il bambino, frastornato, si rialza. Il guidatore, vedendo che il bambino
sembra illeso, se ne va. Scotty ritorna da solo a casa. Lo accoglie
Ann. Scotty si sdraia sul divano, chiude gli occhi e si abbandona. Howard,
il marito di Ann, li raggiunge all'ospedale. Il medico insiste che non
si tratta di coma, ma il bambino rimane ricoverato. Mentre Howard ritorna
a casa a farsi un bagno, Ann veglia presso il letto; la festa di compleanno
viene sospesa.
A casa Howard è nervoso, vorrebbe tornare accanto alla moglie
e al figlio. Suona il telefono: qualcuno all'altro capo informa che
c'è una torta che non è stata ritirata. Howard non capisce
e riaggancia in malo modo. Altre telefonate, ma nessuno parla. Ritorna
all'ospedale. Scotty non si sveglia: frattura del cranio e il solito
"stiamo facendo tutto il possibile" in cui si riassumono i
limiti dell'arte di guarire di cui siamo capaci noi esseri umani.
I due coniugi rimangono soli. Si confidano di aver pregato fin da quando
hanno avuto la notizia. Ann, dopo questa confessione, "per la prima
volta, sentì che erano insieme in questa cosa, in questo guaio.
[...] Si sentì grata d'essere sua moglie". La prima volta
che nell'universo di Carver compare la preghiera, la presenza di Dio,
è in questo àmbito di dolore, di nonsenso: Scotty non
ha alcuna colpa, Ann e Howard neppure. L'automobilista che se n'è
andato forse non saprà mai di che cosa è stato causa.
Il medico e le infermiere fanno il loro lavoro. Ma Scotty sta morendo,
ed è il loro figlio, e per lui arrivano a fare quello che non
sapevano neppure che fosse possibile: pregare, elevarsi a Dio, trovare
un po' di pace nel fluire delle parole. Potrebbero sembrare motivi interessati;
forse lo sono; ma sono motivi strettamente umani.
Alla fine, Howard ottiene che Ann se ne vada un momento a casa: a riposare,
a fare un bagno, a stemperare la sua pena, il suo dolore. All'uscita
dall'ospedale, una famiglia di persone di colore sta seduta in una sala
d'aspetto e Ann viene scambiata per un'infermiera. La moglie, una donna
grassa, ergendosi, le chiede se si tratta di Franklin. Lei risponde
che sta cercando l'ascensore. Il marito della donna le racconta che
a Franklin - suo figlio: sia Ann che lui si stanno muovendo sempre a
livello di discorso inerente a ciò che è personale, non
alla totalità - hanno inferto una coltellata in una rissa, a
una festa, mentre "stava lì a guardare". Anch'essi
pregano. Ora Ann sa di non essere l'unica madre che soffre e forse può
sentire una certa solidarietà con i genitori di Franklin, anche
se non si conoscono.
Arriva a casa. Dà da mangiare al cane (che significato hanno
i gesti abituali quando è apparso il pungolo del dolore nel cuore
della vita ordinaria?) e suona ancora il telefono. Prende il ricevitore.
Sono le cinque del mattino: vorranno darle notizie di Scotty? "Si
tratta di Scotty, già", conferma una fredda voce maschile.
Si sentono rumori di fondo, qualche macchinario. "Si è forse
dimenticata di Scotty?", insiste la voce, e riaggancia la cornetta.
Ann telefona all'ospedale, pensa che potesse essere l'automobilista,
ne parla col marito, poi torna da lui e da suo figlio. Arrivata all'ospedale,
si rivolge in cuor suo alla figura adolescente della sorella di Franklin,
che affiora nel suo ricordo, e cambia il contenuto della sua preghiera:
"Non fare figli; per l'amor di Dio, non farli"; poiché
Ann sa che, in questo mondo carico di contingenza, l'amore - il suo
dolore, infatti, è diretta conseguenza dell'amore - è
la porta d'entrata della vera sofferenza. Ricordiamo i pensieri di Ralph:
"C'era proprio una gran malvagità che premeva sul mondo...".
Arrivata al piano, chiede del ragazzo nero. Un'infermiera, mentre si
liscia i capelli, le risponde che è morto. Sembra che stiano
per operare Scotty, quando questi apre improvvisamente gli occhi: li
guarda, volge lo sguardo, grida finché non gli rimane più
aria nei polmoni, e spira.
"Una volta su un milione", dicono i medici; ma Ann e Howard
ritornano a casa soli: lei non capisce più nulla, se non che
suo figlio è morto. Mentre, senza avere l'idea di come farlo,
cercano di consolarsi, suona di nuovo il telefono. Silenzio, rumore
di macchine sul fondo. Qualcuno che riaggancia. Lei capisce e, infuriata,
intima a Howard di portarla al centro commerciale: "È il
pasticcere. Quel figlio di puttana del pasticcere, Howard. [...] Il
pasticcere, quel bastardo".
La scena finale è commovente. La triste giovane coppia arriva,
in piena notte, alla pasticceria. È chiusa, ma c'è luce
e il suono di una radio: c'è qualcuno che lavora. Il pasticcere
dal collo robusto li accoglie malamente: chiede se vogliono la torta,
benché sia ormai stantia. Ann dà in escandescenze e il
pasticcere - che non capisce che cosa stia accadendo (l'assurdo che
sempre aleggia) - prende un matterello come per difendersi. Ann comincia
a insultarlo, Howard si mette di mezzo, e soltanto allora lei esprime
al pasticcere il motivo di tanta esasperazione: "Mio figlio è
morto". Questo basta perché si operi un cambiamento radicale
e il pasticcere offra loro quello che ha: una sedia, un luogo per la
loro desolazione.
Ann gli dice che desidera la sua morte, ma lui sa che Ann non sa quello
che dice e libera il tavolo dalle cose, mentre rivolge loro la parola
lentamente, con delicatezza. Si siede con loro. È un semplice
pasticcere; è dispiaciuto per Scotty e per l'atteggiamento assunto,
e continua a chiedere perdono. Il fatto è che il pasticcere sa
che la sua relazione occasionale con l'esistenza ormai passata di Scotty
non lo obbligava a essere al corrente della tragedia ("L'uomo non
è capace di troppa realtà", dice T.S. Eliot), ma
al contempo è consapevole che avrebbe preferito esserlo. Riappare
così il sentimento di solidarietà. Lo stesso che Ann aveva
provato nei confronti della famiglia di Franklin. Il pasticcere, inoltre,
ha occasione di dimostrare il proprio desiderio di riparare e ricorre
a uno dei tópoi arcani dell'umanità: il prendere cibo.
"Spero vogliate assaggiare alcune delle mie paste calde. Dovete
mangiare per andare avanti. Mangiare è una cosa piccola, ma buona
in un momento come questo.
Ed è "buona" non soltanto perché i due coniugi
hanno trascorso tre giorni penosi al capezzale di un malato in ospedale,
né perché hanno fame, ma perché tra i rimedi contro
la tristezza, oltre alla contemplazione della verità, al rapporto
con Dio (poco prima si parlava di preghiera), accanto al pianto liberatore
e al riso distensivo, si deve anche parlare di vino e di bagni, di mangiare
insieme (origine e realizzazione di ogni festa) e - soprattutto - di
compagnia. L'atteggiamento del pasticcere risulta meravigliosamente
empatico. È la prima volta, in tutto il racconto, in cui si apre
una porta di fronte al nonsenso. Subito buona parte dell'accaduto prende
una piega che restituisce alla speranza: alla superficie di quell'oceano
di pazzia rimangono gli uomini, esseri capaci di farsi carico del fardello
degli altri, di prestare aiuto e condividere il peso. E così
fu: "Rimasero lì a parlare fino all'alba, quando dalle vetrine
cominciò a entrare la luce alta e pallida del primo sole, e a
loro non venne in mente di andarsene".
È vero che il dolore in sé stesso non ha senso. Ma è
anche vero che è possibile trovargli una via d'uscita mediante
la convinzione cristiana che la sofferenza è già stata
consumata e redenta. Comunque, però, è necessaria la presenza
di testimoni di quella consumazione: di sguardi che mutino l'estraneo
in fratello, nell'oggetto delle blandizie affettive di chi lo capisce.
È necessario evitare l'astrazione, i casi generali, la totalità,
e scoprire - seguendo Lévinas - il carattere infinito, di novità
radicale e irriducibile a concetti, di ciascuno, della persona: di Ann,
Howard, Scotty, Marian, Ralph e anche di quel solitario pasticcere di
un centro commerciale. In questo modo si dimostra che è falso
che sul mondo prema "una gran malvagità": sì,
il dolore abita con noi, ma anche l'amore, la scoperta dell'altro; e
anche - come rileva Carver con l'immagine dell'aria di famiglia che
si stabilisce istantaneamente tra i due coniugi e il pasticcere - la
possibilità di una trascendenza, di quello che sant'Agostino
chiamava "un fine senza fine". Questo si coglie nella frase
che conclude il racconto: "a loro non venne in mente di andarsene".
Un'ultima questione. Alla fine verrà il mattino, la riunione
alla fine si scioglierà. Ann e Howard ritorneranno a casa loro
e la ritroveranno vuota (giocattoli disseminati, l'armadio di Scotty...).
È anche possibile che non rivedano mai più quell'uomo;
o che il loro matrimonio affondi; o che generino un altro figlio, il
quale, senza sostituire Scotty, riempia ancora di vita la loro casa.
Questo accade sempre nelle storie umane: si lasciano raccontare, ma
continuano; l'eternità ancora non ci appartiene. E allora? La
generosità del pasticcere e la capacità di Ann di scoprire
che cos'è una relazione autenticamente umana, danno adito alla
nostra speranza che il grande anelito di felicità che gli esseri
umani portano dentro di sé non corrisponda a un'utopia.
Il quarto volume di Raymond Carver, Elephant, è probabilmente
il migliore di tutti. Più breve, sebbene costituito da racconti
più estesi (solo 7 in 150 pagine). L'ultimo di essi, Tre rose
gialle, sfugge alle coordinate spazio-temporali dell'opera dello scrittore
statunitense e tratta della morte di Cechov. Gli altri conservano le
costanti narrative. Vi si rinnova il tema del disagio: "Tutto quello
che chiedo è una casa e una città dove vivere ed essere
felice", dice la madre del protagonista di Scatole; la stessa che
passava la vita a fare e disfare le valigie, imbarcata in un'esistenza
fatta di continui traslochi. La felicità, la casa; il fatto che
la quiete - la contemplazione? - riesca attualmente impossibile, ma
sia sempre presente sul piano del desiderio; il conseguimento dell'amore
e della stabilità delle coppie; le ferite dell'alcol: questi
- insieme a una certa dose di fatalismo - sono i temi degli ultimi racconti
di Carver.
Gli stessi temi appaiono nel terzo racconto, Intimità, nel quale
il protagonista va a far visita alla sua ex-moglie e sembra che questa
lo maltratti. Ma lo fa perché non ha potuto cessare di amarlo:
perché la parola di lei sì che era stabile, ma si era
scontrata con il fatto che il suo dono non era stato recepito, che il
suo amore era finito buttato via dal capriccio del suo amato. La storia
si conclude come la prima: con la nostalgia della normalità nel
cuore dell'uomo, della casa illuminata che attende, dei bambini che
realizzano il compimento della donazione d'amore che non fu mai realizzata.
Forse è bene ricordare le parole di Milan Kundera che aprono
il libro: "Non si sa mai che cosa volere, perché, vivendo
una sola vita, non possiamo né paragonarla con le precedenti,
né migliorarla in quelle a venire". Ma lo scrittore protagonista
di questa storia non rimedia forse alla sua mancanza? Cade in ginocchio
e piange, aggrappato all'orlo della gonna di quella che fu sua moglie.
La preghiera, anche se questa volta priva di trascendenza, torna a farsi
presente nelle pagine di Carver. E così pure la coscienza della
colpa e la domanda di perdono.
Elefante muta la prospettiva: ora si tratta di un padre che passa in
rassegna tutte le persone che dipendono economicamente da lui, che deve
chiedere prestiti per poterle portare avanti, benché quelle persone
(i figli, la madre, un fratello) non lo ringrazino neppure una volta.
In realtà è un altro naufrago. Spinto dall'angoscioso
accumularsi di debiti, pensa di togliersi di mezzo e che ognuno s'arrangi.
A questo punto fa un sogno in cui gli appare suo padre: "Lui mi
reggeva forte. Ci reggevamo forte l'uno con l'altro [...]. Non sapevo
dove stavamo andando. Magari andavamo a fare la spesa o al parco giochi
dove lui mi avrebbe spinto sull'altalena". Il passato è
l'età dell'innocenza; il presente è un incubo; il futuro
rimane come possibilità: "L'estate doveva essere il periodo
in cui la fortuna di tutti sarebbe cambiata". "C'erano tante
cose in cui sperare". In questo si può decifrare l'idea
centrale che unisce i protagonisti di questa storia: per tutti loro
l'unica cosa terribile è trovarsi soli. Avere qualcuno da amare,
anche se questi non ti è grato, è l'unico modo per arrivare
a pensare che la vita meriti di essere vissuta. L'Elefante non può
fuggire: hanno bisogno di lui. È essenzialmente - esistenzialmente
- relazionale. Coloro che sono privi di legami, di relazioni, sono privi
di vita.
Questi stessi motivi vengono riproposti in modo magistrale negli altri
due racconti. Pasticcio di merli descrive proprio il momento di una
separazione: una donna che se ne va dalla casa di un uomo tanto egoista
da non essere assolutamente capace di comprendere le ragioni di quella
decisione. Quando ormai è rimasto solo, contempla una foto di
lei da giovane, sorridente. Evoca la passata felicità e riconosce
che sia lei che lui erano felici allora. La donna perfetta, perduta
nel succedersi dei giorni e delle abitudini, e per il progressivo rinchiudersi
di lui in un lavoro assorbente. La sua confessione finale non ha bisogno
di commenti: "Si potrebbe dire, per esempio, che prendere moglie
equivale a entrare a far parte della storia. E se le cose stanno così,
devo intendere che ormai sono fuori dalla storia - come i cavalli o
la nebbia. O viceversa si potrebbe dire che la mia storia mi ha abbandonato.
O che d'ora in poi dovrò fare a meno della storia. O che la storia
dovrà ora fare a meno di me - a meno che mia moglie non decida
di scrivere altre lettere o racconti tutto a un'amica che tiene un diario,
mettiamo. Allora, anni dopo, qualcuno potrà ripensare a questo
periodo e interpretarlo secondo quanto vi troverà scritto, tutte
le liti e le invettive, i silenzi e le allusioni. È a questo
punto che mi viene in mente che l'autobiografia è la storia dei
poveri. E che, in effetti, sto dicendo addio alla storia. Addio, mia
cara".
L'autobiografia è la storia dei poveri: la persona si costituisce
dotata di significato nelle sue relazioni, nelle sue radici, nella sua
possibilità di donazione. Invece avvizzisce nell'egoismo, nella
centralità dell'io, nell'assenza di un focolare, di un luogo
al quale ritornare. Un pianeta di nomadi è un pianeta di esiliati:
l'autobiografia è sempre la storia del fallimento. La nostra
storia ha significato solo se la raccontano altri, se per gli altri
costituiamo una trama che valga la pena di raccontare. Persona, ha affermato
Spaemann, si dice sempre al plurale. E, quella che sembra un'affermazione
strettamente teorica, prende corpo nelle storie di separazioni che ci
presenta Carver, storie che - quasi sempre in chiave negativa, nell'espiazione
- sono storie d'amore.
In Menudo si pone lo stesso problema: Huges, un uomo che non può
dormire, ci presenta la sua "piccola situazione". Vicky, la
sua seconda moglie (Molly, la prima, eterno amore di gioventù,
l'aveva abbandonata lui senza alcun motivo) probabilmente lo tradisce
con un altro. Perciò egli tradisce lei con Amanda, la vicina.
Ma Oliver, il marito di Amanda, sospetta qualcosa e ha dato a sua moglie
sette giorni di tempo per abbandonare la casa. Amanda ha una bambina
piccola, Beth. Il signor Huges si fa carico anche del mantenimento di
sua madre. La vita di tutti questi personaggi - che non sembrano cattivi,
ma solo meschini - sta andando fuori rotta e Huges, il narratore di
quanto accade, non sa fare nulla per evitarlo: la sua carenza di virtù
è marcatamente realistica. Troppi nomi per la storia di una sola
persona, troppo grande la complicazione, e il nostro eroe si sente come
se navigasse nel vuoto.
Appare di nuovo la nostalgia del focolare domestico: "Vorrei tanto
essere come qualsiasi altro da queste parti - una persona normale, essenziale,
senza particolari qualità -", ma sembra che non lo possa
più. Comunque, ci prova. La sua vita di redenzione sarà,
questa volta, il servizio e il lavoro. Prende un rastrello e incomincia
a raccogliere le foglie del suo giardino. Quando ha finito in quello,
si dirige a quello di altri vicini: i Baxter, una coppia anziana e pacifica.
Come riparare il danno causato? Ancora non lo sa, ma cercherà
di farlo. Pena, colpa, rimorso; redenzione? Per lo meno il desiderio
di questa. Gli esseri di Carver sono esperti di peccato, sono esseri
umani: non hanno commesso grossi crimini, ma hanno ingannato Molly,
Vicky, Amanda, Beth, Oliver e sé stessi. Sono "brave persone,
sono attaccati alla famiglia, responsabili sul lavoro", e anche
persone che danneggiano la convivenza, la vita di altri esseri umani
sulla terra. Come noi, come tutti.
E nei Baxter s'incarna la meta alla quale tutti questi personaggi sembrano
aspirare. "Nei suoi momenti migliori il signor Baxter è
una brava persona, uno qualunque - un tipo che difficilmente prenderesti
per una persona speciale. Ma lui è una persona speciale. Almeno
secondo me, sì. Tanto per cominciare ha una notte intera di sonno
dietro di sé, e poi ha appena abbracciato sua moglie prima di
andare al lavoro. Ma prima ancora che parta, già si sa che tornerà
a casa dopo un numero preciso di ore. È vero, nell'ordine supremo
delle cose, il suo ritorno a casa sarà un evento della minima
importanza - però sarà sempre un evento".
Avere un luogo al quale ritornare, avere una casa: senza questo, la
mentalità di pionieri perde la sua prospettiva di significato.
Senza la casa si cancella il compito dell'eroe, perché rimane
privo di motivi per esercitare il coraggio, la fortezza. Senza Itaca,
senza Penelope, Ulisse dovrebbe rimanere tra le braccia della dea Calipso.
Ma non può farlo, e lo sa. Ogni essere umano lo sa e per questo
i personaggi delle storie di Carver vivono in un deserto di disagio:
perché manca loro la calma di un focolare domestico, di qualcuno
con cui costituire stabilmente una vera storia e non quel triste insuccesso
che sono i solitari monologhi interiori in cui consistono queste pagine.
E poiché ciò manca loro - ed è loro naturalmente
dovuto - non possono cessare di pretenderlo, perché questa è
la costituzione dell'uomo: aperta all'amore, al per sempre, a un uso
della volontà che non consiste in passioni e moti, bensì
nelle delicatezze contemplative - quotidiane - delle quali si sente
tanto la mancanza nelle storie di Elephant.
Le storie di Carver sono sì storie d'amore, ma proprio perché
in esse si intravede quanto sia antinaturale il disamore. Personaggi
deboli, eppure alla ricerca. Cercano ciò che Isak Dinesen annunciava
ai quattro venti: un luogo dal quale si possa dire, pieni di gioia,
"sto dove devo stare".
Javier Aranguren Echevarrìa
Scarica il formato word di
Le
storie d'amore di Raymond Carver
Torna alla pagina iniziale di
Raymond Carver