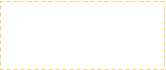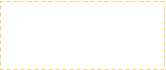|
Le amicizie e i maestri non hanno età.Io e il “Professore”
Premessa
Questo testo è una panoramica e una cronaca di tempi remoti, di ieri, di oggi, di persone ed eventi molteplici, importanti o meno.
Insomma quella mélange imprevedibile che si chiama vita.
Espone altresì un fatto svoltosi di recente, beh! diciamo negli ultimi anni, che ancor oggi mi fa’ riflettere e stupire, forse non meravigliare.
La narrazione ha subito liberi adattamenti rispetto un excursus sostanzialmente vero, che ha riguardato me e altri con i quali ebbi rapporti di amicizia e conoscenza. La conclusione del testo, di più ampia ed obbligata fantasia, non è lontana affatto dalla realtà effettiva.
Non è facile per un ragazzo stringere amicizia con una persona maggiore di trenta anni la quale, più che un fratello maggiore, potrebbe essere il padre. Maturità, formazione e esperienze diverse vengono in tali casi ad evidenziarsi e impedire, o limitare, l’instaurarsi di quei rapporti chiamati comunanza e intimità, trasformandoli nei più distaccati di rispetto, emulazione.
Eppure io mi ci trovai addentro, e posso dire di essere riuscito a concretare un feeling sentito e particolare, un po’ forse per merito mio, molto più per quello di un uomo che ebbi la fortuna di conoscere ed averne la confidenza, che chiamai e chiamo il “Professore”, come era per noi alunni dell’Istituto Commerciale Pietro della Valle nel 1943.
Non posso affermare fosse ricco, importante, nel senso come questi attributi si intendono, era persona colta, retta, impregnata di un senso filosofico alla Platone o alla Marco Aurelio, provata dalle vicissitudini della vita, che decise di prendermi per mano e accompagnarmi per un po’ nel tragitto della mia maturazione ed esistenza. Ciò che mi appagò maggiormente fu il considerarmi un giovane amico, non un discepolo, non un sottoposto, non come ragazzo da dover solo indirizzare e plasmare, tale un novello Pigmalione.
Mi preme chiarire l’assenza assoluta di rapporti particolari, si possono supporre quali essi siano, mai pensati o immaginati, quali ad esempio quelli intercorrenti fra Socrate e Alcibiade, sui quali dei meschini lanciarono le solite insinuazioni. No! Fu un iter di vita che maturò da solo e se ne decise il prosieguo solo da noi due, soprattutto per merito e scelta suoi, pur con le differenze intercorrenti fra noi.
Inutile dire che questa comunanza, dati i tempi e le mentalità in atto, mi creò qualche difficoltà anche con i miei di casa, ma non ne feci problema e cercai di fargli comprendere che stavano errando nei loro giudizi. Riuscii a convincerli? Ancora oggi mi pongo il quesito, credo di si, almeno lo spero.
Il mio amico non c’è più. Le leggi di natura hanno fatto il loro corso, ma una sua traccia notevole persiste sempre in me, pur con la mia età non più verde come un tempo lontano. Il “Professore” sarà uno di quei pochi dai quali mi aspetto che un giorno vengano ad aprirmi le porte del loro mondo a me sconosciuto. Magari incontrerà di nuovo mia madre che tanto lo stimava e, può darsi, pure il Duce dei miei tempi col quale, sono certo, qualche bel discorso severo lo avrà già fatto o lo farebbe molto volentieri.
L’incontro
Il “Professore”, al quale questo racconto è dedicato, lo conoscevo di vista, e per averne sentito e parlato a volte nell’ambito scolastico.
Divenne mio amico per un caso fortuito, era il 1941, un primo pomeriggio sul finire del mese di Ottobre, con la temperatura già abbastanza fresca e il cielo corrucciato. Io ero ben coperto, ma non indossavo ancora giaccone o pastrano. Aveva preso a diluviare, come avviene spesso a Roma, ove gli scrosci temporaleschi e le folate di vento sono forse brevi di durata ma non scherzano affatto quanto ad intensità.
Ero appena uscito dalla scuola che frequentavo, l’Istituto Pietro Della Valle in viale Manzoni, scuola nuova per me, che frequentavo da pochi giorni per il primo anno delle superiori, ringraziando in cuor mio mia madre che il mattino, mi aveva quasi imposto di prendere con me un grosso ombrello nero, avendo valutato al peggio le avvisaglie meteorologiche della giornata.
Anche se ero grandino di età e corporatura, andavo verso i quindici anni, portavo ancora i calzoni corti (beh! un po’ lunghi, mi arrivavano al ginocchio) e l’acqua sferzante, indirizzata da un vento robusto, che aveva pure rigirato l’ombrello aperto, mi bagnava polpacci, calze e scarpe, vendicandosi del non potermi infradiciare il capo, protetto a sufficienza dalla volta del parapioggia.
La logica avrebbe voluto che mi riparassi in qualche portone o negozio, ma in gioventù il raziocinio ha un valore relativo e non pensai minimamente ad interrompere il cammino, casomai ad accelerarlo.
Già, il tragitto verso casa. Dovevo percorrere più di tre chilometri dalla scuola, sita nella zona Esquilino, alla mia abitazione nel quartiere Tuscolano. Percorrevo la strada due volte il giorno, per l’andata e il ritorno, senza prendere il tram o il bus in quanto in famiglia di soldi ce n’erano pochi e, quelle volte che li avevo, preferivo tenerli per me. C’è da dire che, anche volendo, i collegamenti pubblici, almeno per me, erano di scarsa utilità, in quanto per usufruirne dovevo percorrere a piedi un bel pezzo del tratto totale.
Inutile dire che non esistevano i motorini e le moto di oggi; anche le biciclette, rarissime, non erano usate dagli alunni.
Fu così che nei pressi della grande Villa Wolkonski, sede allora dell’Ambasciata di Germania, sita alle spalle della scuola, mi trovai vicino ad un signore bagnato, che camminava veloce, quasi correndo, curvo, stringendosi nelle spalle e ritirandosi sul collo, senza alcun riparo salvo un cappello ormai sgualcito e il bavero della giacca rialzato da cui scendevano gocce sul collo e all’interno del vestito. Lo accostai e domandai se gradiva lo riparassi fino al primo punto coperto, negozio o ingresso di palazzo fosse, in quanto in quel tratto specifico di questi non ce n’erano.
Egli ringraziò e chiese se potevo giungere con lui in Via Umberto Biancamano, non molto distante, ove si trovava il suo laboratorio di sartoria, nonché la sua abitazione. Allora lo riconobbi in quanto molti di noi studenti, me compreso, passavamo ogni giorno di fronte il suo minuscolo locale, situato al piano terreno dello stabile, leggermente rialzato di un paio di gradini, definito pomposamente “Atelier per Uomo” da un cartello posto al di sopra delle ante d’ingresso, di norma aperte sia per invitare ad entrare, sia per far giungere un po’ di luce in un ambiente che n’era largamente sprovvisto.
Il laboratorio infatti era largo poco più di tre metri, profondo sui cinque-sei, senza finestre, con una porta sulla parete di fondo; l’unica cosa ampia che avesse, in senso però verticale, era il soffitto, più elevato di quelli consueti, penso sui quattro metri o forse più.
Dall’esterno si notava un’unica vera suppellettile, un bancone da lavoro lungo, largo, massiccio, con una lampada che scendeva fino a giungere vicina al piano; vi erano poi un paio di mensole con pacchi e stoffe, s’intravedevano una sedia, una o due macchine da cucire, un paio di ferri da stiro a carbone e qualche foglio di modelli alle pareti.
Dietro il banco, con il locale aperto, vi era un signore sorridente, di mezza età, che salutava quanti si fossero indugiati sulla porta o avessero rallentato l’andare, gettando uno sguardo all’interno o fermandosi per curiosità.
Io, pur avendolo notato più volte, non ci avevo mai parlato, né l’avevo incontrato; sapevo però che per molti di noi egli era il “Professore”, per motivi che ignoravo e comunque non mi ponevo, come penso li ignorassero coloro che nella scuola lo chiamavano così.
Ugualmente, nell’accompagnarlo, mi sentii in un certo disagio in quanto circolava la voce che si trattasse di un omosessuale (figura allora strana, poco chiara, almeno per me, nonché termine delicato usato oggi, mentre all’epoca era ben più greve). Egli mi chiese di passargli l’ombrello di modo che, essendo più alto di me, potesse con più facilità coprire entrambi dall’acqua.
In pochi minuti giungemmo al palazzo umbertino ove eravamo diretti e alla porta del suo locale. La pioggia era aumentata e ci bagnammo ulteriormente dato che, nella fretta di far girare la chiave nella serratura, questa ebbe delle difficoltà, rifiutando all’inizio di scattare. Infine ci trovammo all’asciutto e chiudemmo l’ombrello; il “Professore”, lo chiamo così anch’io, lo aprì di nuovo, lo girò velocemente al di fuori dell’ingresso, facendone allontanare l’eccesso di acqua, e lo pose aperto vicino una stufa a gas, che accese con uno di quei puzzolenti zolfanelli allora in uso, gli accostò poi due sedie e vi pose ad asciugare la sua giacca ed io la mia.
Quindi, con il tono fra il faceto e il grave, mi disse:
“Giovanotto, mi hai salvato da questo tempaccio, bravo e grazie!”.
Mi chiese il nome, confermò che mi aveva notato passare, aggiunse che ci saremmo fatti un caffè bollente, cioè del pessimo surrogato che, data la guerra, era spacciato al suo posto. Si assentò nell’ambiente retrostante, sentii che maneggiava con qualcosa di metallico, e ricomparve poco dopo indossando pantaloni e camicia asciutti, oltre un paio di pantofole felpate.
Ne aveva in mano un altro paio, apparentemente nuove, che m’invitò a calzare, onde far asciugare le mie scarpe e calze vicino la stufa (di fronte a questi elogi e cortesie pensai di nuovo, sbagliando, di avere a che fare con uno di quei misteriosi gay). Io gli ubbidivo automaticamente anche se, malgrado che al temporale si fosse aggiunto il boato di alcuni tuoni, avrei voluto proseguire verso casa, ancora parecchio distante.
Egli insistette che prendessi una mezza pasticca di Aspirina, onde prevenire possibili raffreddori e colpi influenzali. Portò poi il “caffè” in una grossa caffettiera napoletana. La tazza colma, che ricevetti e zuccherai abbondantemente, mi scaldò e rinfrancò, nonché mi piacque, pur se non potevo giudicare alcunché, non conoscendo affatto l’aroma e il sapore del vero caffè, raffinatezza riservata, per via della guerra, ai soli americani, inglesi, preti del Vaticano e, di sicuro, a parecchi gerarchi del partito fascista.
Frattanto la stufa funzionava a meraviglia e il piccolo locale si era riscaldato, mentre uno strato di condensa si depositava sui vetri della porta la quale, data l’inclemenza del tempo, era stata chiusa.
La mia giacca, la meno bagnata, era già quasi asciutta, mentre dalle scarpe e calze, poste anch’esse di fronte la stufa rovente, mi parve si alzasse un leggero velo di vapore. Il “Professore” disse che di lì a poco avrei potuto riprendere il cammino, in quanto i temporali romani, malgrado la loro veemenza, non duravano a lungo e cessavano con la stessa rapidità del loro inizio.
Ci fu però un imprevisto, il sibilo ripetuto e lugubre delle sirene annunciò l’inizio di un allarme aereo, cosa consueta in quei tempi.
Al che egli, rivolgendosi a me, aggiunse:
…“non c’è da preoccuparsi, il tempo è brutto, è pomeriggio e siamo a Roma, vedrai che tutto cesserà presto e non accadrà nulla; comunque, occorrendo, ho un rifugio che potremmo anche usare”…
Ormai ero bloccato fino al cessato pericolo, cioè per un’ora almeno, tanto duravano mediamente gli allarmi, né avrei potuto uscire in quanto durante l’emergenza era proibita la circolazione di chicchessia, salvo quella delle forze dell’ordine, della Croce Rossa, della Protezione Antiaerea (UNPA), e esercito; dovetti così accettare l’ospitalità e l’eventualità di usare il ricovero antiaereo, di cui non avevo ben compreso se si trattasse di quello comune per il palazzo e i passanti, o uno suo del tutto personale.
Il “Professore” prese poi due imposte di legno e le fissò all’esterno dell’ingresso, onde proteggere i vetri dalle vibrazioni di eventuali scoppi di proiettili o bombe, lasciandone aperto comunque un esile spiraglio.
In conseguenza di ciò, anche se era accesa la luce sopra il bancone, piombammo di colpo in una quasi oscurità.
Egli aprì allora la porta sul fondo e ci spostammo nel retro, ove c’era più luce, sempre poca, data da quel cielo imbronciato e grigio.
Il locale che seguiva, unico, era più vasto del laboratorio, ritengo misurasse una trentina di metri quadri, forse più, con una ampia finestra che guardava nel cortile dell’edificio, con grata esterna, una tenda, e infissi un po’ malconci.
Era la sua abitazione. Le pareti erano tinteggiate in un colore indefinibile, sbiadito dal tempo. Sul fondo, in una specie di nicchia senza porta, vi era una piccola cucina. Un’analoga nicchia adiacente, con la porta semiaperta, poi chiusa dal Professore, dichiarava la sua funzione a toilet.
Entrambi i mini-vani erano stati ottenuti dall’ampia sala, utilizzandone una parte laterale, riducendo di poco la superficie utile, e prendevano aria entrambi da una minuscola apertura in alto.
La stanza era fornita dell’indispensabile, cioè di un letto a una piazza abbondante, con testate metalliche, un armadio con specchio, qualche mensola, un tavolo, delle sedie, e un paio di cassapanche di cui una, con sopra un lume e una piccola radio Marelli, fungeva da comodino notturno. Un lampadario a tre bracci pendeva dal soffitto, anche questo molto alto, tale quello del laboratorio. La parete di destra era impostata differentemente, come costituisse un’area separata e un ambiente diverso. Vi era una libreria a ponte con volumi ordinati e ben tenuti, una scrivania con sopra una lampada da tavolo, una macchina da scrivere Royal, oltre una poltrona un po’ vetusta.
Il tutto, non nuovo, espresso però con un certo tono, faceva pensare sia ad un salotto-studio, sia ad un collegamento con tempi di maggior benessere; testimoniava altresì la presenza di persona con interessi più ampi di quelli della conduzione di una sartoria artigianale, con tutto il rispetto dovuto per tale non facile occupazione creativa.
Di mobilio ed accessori recenti non c’era nulla, almeno mi parve, ciò che vedevo mi ricordava alcuni pezzi liberty della casa dei nonni materni , nonché di altri zii, in Umbria, a Perugia. Aggiungo che era evidente la presenza di un’eccellente pulizia, percepibile, oltre che visivamente, anche per l’assenza di ogni traccia olfattiva di chiuso, cucina, fumo, in quanto il “Professore” non fumava, insomma di ogni traccia di scarsa nettezza presente in tante case del tempo (non esistevano le miriadi di prodotti e apparecchi odierni per l’igiene della casa e persona; ma solo sapone, soda, varechina, e poca acqua).
Il “Professore” si era accorto della mia panoramica visiva e di curiosità, durata meno di quanto abbia impiegato a descriverla e, vedendomi interessato ad osservare la libreria, nonché quanto altro era nell’angolo, mi invitò a farlo con calma, mentre lui in cucina puliva la caffettiera e lavava le tazze.
L’occhio mi cadde su alcune opere che, in parte, già conoscevo, fra le quali la Storia di Roma di Tito Livio, dei testi di matematica e analisi, volumi su Goethe, Shakespeare, Nietsche, alcuni su Aristotele, Plotino, oltre la Storia di Roma del Mommsen in tre grossi volumi, in edizione di lusso, rilegati in similpelle, più grammatiche e antologie.
Una Bibbia di pregio, antica, in formato maggiore, spiccava in un angolo del ripiano superiore. Alcuni dei testi erano in inglese o in tedesco. Infine, in primo piano, a portata di mano, faceva mostra di se il Dizionario Enciclopedico della UTET di Torino in undici volumi, la mia passione, comprendente anche il primo aggiornamento edito nel 1940, appena giunto e non ancora aperto. Questa opera merita una precisazione; io già la conoscevo avendola utilizzata più volte in casa di un amico alquanto più benestante, grazie alla disponibilità dimostrata dal padre, importante dirigente assicurativo, il quale ci consentì l’accesso al suo studio onde consultare le opere a noi necessarie, sia enciclopediche, che altre.
In quel locale lucido, asettico, con un sottile aroma di mogano, sempre in penombra, vi era pure l’Enciclopedia Treccani, in più di trenta volumi dal dorso in pelle scura, di cui non ottenemmo il permesso di lettura anche se, per la verità, la consideravamo opera lontana, irraggiungibile, preferendole la UTET più di nostra praticità e utilità (oltretutto la Treccani si trovava in uno specifico comparto-vetrina, forse chiuso). Invidiavo il mio amico anche per “Il Tesoro del Ragazzo Italiano”, opera enciclopedica per studenti medi e superiori, in cinque o sei volumi dalla copertina rossa, sempre della UTET.
Io invece, oltre a non possedere alcuna enciclopedia, dovetti rinunciare ad acquisirne una più modesta per la quale, in un concorso scolastico, vinsi un buono sconto del cinquanta per cento sul prezzo di vendita, quale terzo classificato su cinque (erano da pagare poche decine di lire, ma mio padre non se lo poté permettere). Il primo di noi l’ebbe gratis, gli altri l’acquistarono.
Terminata l’osservazione, rapidissima in quanto l’occhio e la mente corrono più veloci delle parole, rivolsi lo sguardo alla parete. Vidi così due quadri, entrambi contenenti un attestato, mentre un terzo recava una foto con un folto gruppo di giovani, ragazzi e ragazze, con uno strano copricapo nero, di forma quadrata, che circondavano una persona più matura. Per non far notare troppo la mia curiosità lessi disordinatamente più termini inglesi, come Boston, Massachusetts, University, Philosophy, Mathematics, Doctorate, e altro, più un nome inglese e un cognome italiano che non riporterò, avendo deciso di non fare il nome sia del “Professore”, sia di altri.
Rimasi stupito, pur se qualcosa mi aspettavo. Chi era veramente l’uomo che avevo di fronte? Che si trattasse di un Professore, e che Professore, ora non c’era più dubbio, ma l’averlo scoperto di mia iniziativa m’aveva intimidito. Egli se n’avvide e liquidò il tutto con un: …“non ci far caso, la vita decide spesso diverso da come tutti vorremmo, o almeno gradiremmo”…
Poi più nulla; capii che non gradiva l’argomento, almeno in quel momento, così evitai di fare domande inopportune.
Del suo passato ne venni a conoscenza frammentariamente, nel tempo e senza sollecitazione, tramite un amico di scuola ebreo, Vittorio, per noi Vitt (lo chiamavamo pure Suss, rifacendoci al film tedesco “Suss l’Ebreo” allora in programmazione), che collaborava con il padre in un negozio di ottica situato nel centro di Roma. Il papà, che appoggiò il fascismo sin dagli inizi, e partecipò alla marcia su Roma (pentendosene amaramente al punto che, dopo le leggi razziali, rifiutò la discriminazione che gli spettava quale “antemarcia”), voleva chiamarlo Benito, ripiegando poi su Vittorio, nome del re, per lo scarso gradimento espresso dal loro sacerdote.
Egli dovette inghiottire il rospo dell’allontanamento di Vitt dalla scuola pubblica, inserendolo in quella israelita, nonché dai Balilla e dalla GIL, cosa che colpì anche me ed i comuni compagni, non parlando poi di Vitt, che fra noi era stato sempre studioso, ligio, affezionato alla Gioventù del Littorio. Circa il “Professore” seppi che egli, di razza ebraica ma di famiglia cristiana, non so quanto praticante o rimasta osservante al vecchio credo (qualche antenato si convertì al cristianesimo, magari obbligato), venne portato dai suoi, nei primi del 900, dalla Calabria natia negli Stati Uniti, con il famoso “passaporto giallo”, il quale consentiva l’andata, non il ritorno.
Lui e la famiglia vissero inizialmente a Brooklin, N.Y., cioè a Little Italy, meglio chiamata “Broccolino” dai nostri meridionali, con il papà che riprese l’occupazione di sarto per uomo, la mamma che collaborava, oltre dedicarsi alla numerosa famiglia di parecchi figli.
Il “Professore” poté seguire sia le superiori (le High Schools), sia l’Università, con la famiglia che per consentire ciò affrontò sacrifici immensi, non estesi agli altri fratelli, che dimostrarono però scarsa propensione per gli impegni scolastici, nonché alle sorelle in quanto, essendo donne, meglio femmine, per quei tempi era loro sufficiente una istruzione di livello modesto, saper leggere, scrivere, fare di conto.
Si trasferirono poi intorno Boston, ove il papà tentò di mettere in piedi qualcosa di più d’una semplice sartoria. In effetti la piccola manifattura non riuscì a decollare e andò in dissesto, di modo che il piccolo imprenditore mancato tornò alla professione primitiva e nel laboratorio di sempre.
Il “Professore”, stavolta con tanto di Laurea o Lauree (ne aveva di certo due, oltre qualche specializzazione), divenne un giovane e qualificato docente universitario, e ciò sia per le sue doti di preparazione e disposizione all’insegnamento, sia per l’appoggio ricevuto da un “compare” calabrese, il quale contava parecchio fra la comunità dei nostri emigranti del sud, e affermava che fra corregionali fosse un dovere aiutarsi e stare uniti
No, non era un boss mafioso nel senso deleterio del termine odierno.
Disse il “Professore” a Vitt trattarsi di un capo di fatto, un Super Pater da tutti considerato tale, benestante in patria e in loco, che tutelava molti dei nostri disperati, nuovi e vecchi, e ciò sin dalla partenza dall’Italia, i quali gli dimostravano a modo loro rispetto, riconoscenza, magari sottomissione.
Quanto alle vere bande mafiose, che si scatenarono in quegli anni, è da notare anzitutto l’amplificazione data al fenomeno dal settore anglosassone, preminente nella società USA, tesa a drammatizzare le malefatte dei latini, più in particolare degli italiani, ignorando quelle proprie e di altre etnie, e poi l’instaurarsi di forme di reazione-autodifesa-offesa in quelle prime comunità di italici trattati al pari di bestie, di delinquenti, reietti, peggio di come possano esserlo oggi i clandestini extracomunitari in Italia.
Comunque il “Professore” non poté godersi la nuova situazione e la docenza ottenuta. Interruppe tutto e rimpatriò velocemente in quanto si trovò coinvolto, suo malgrado, in un delitto plurimo di mafia, un regolamento di conti, con il torto di essersi trovato inaspettatamente in un luogo, giorno e ora sbagliati, quando un gruppo, credo irlandese fece fuori alcuni dei calabro-siculi, loro concorrenti in qualche traffico irregolare, forse alcool, o per sconfinamenti dalla zona di competenza. Egli, estraneo ai fatti e al giro malavitoso, non venne colpito dalle raffiche della piccola strage, tipo quelle dei film su Al Capone e simili, della quale fu però osservatore diretto, nonché involontario.
Così, onde evitare venisse sbrigativamente eliminato da una delle due parti, onde togliere di mezzo un testimone pericoloso, o d’essere coinvolto dalla Polizia e giustizia, qualcuno che contava in Ambasciata, mezzo loro parente (in Calabria lo sono quasi tutti fra loro), regolarizzò il passaporto e lo rimise su una nave per Napoli, ove rientrò lasciando famiglia, ragazza (restando poi scapolo) e, ironia della sorte, incappando dopo circa un anno nelle leggi razziali fasciste le quali vanificarono la promessa ricevuta, e inizialmente mantenuta, di ricevere un incarico di insegnamento superiore o universitario..
Non ritenne d’allontanarsi dall’Italia anche perché, USA esclusi, non sapeva ove ricominciare una vita; poi, per quanto riguardava l’Italia, c’era la speranza che le cose nei loro confronti si potessero alla fine sistemare. Scelse così di tornare alla primitiva occupazione del padre e sua, quella modesta, ma autonoma e autosufficiente, del sarto per uomo, lavoro che, fra l’altro, conosceva e svolgeva molto bene. Inoltre a Roma, città ove scelse di vivere, aveva dei parenti a cui potersi riferire, nonché appoggiare.
Nel frattempo la pioggia stava scemando e entro poco sarebbe cessata. Durante l’allarme, come il solito, non era successo nulla (i bombardamenti arriveranno, e molto presto), né era entrata in azione la contraerea della fascia periferica cittadina; lo stato di allerta però continuava e io non potevo uscire, salvo il pericolo di essere arrestato se fermato dalla forza pubblica.
|