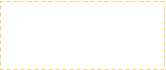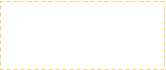|
Siamo usi considerare le relazioni fra noi e i nostri simili come le uniche meritevoli della nostra considerazione. Eppure in questi tipi di rapporti potrebbero inserirsi quelli con il mondo animale che con noi convive, almeno per la parte che consideriamo più evoluta, come gatti, cani, per noi cittadini, o per quelli da stalla, cortile, casa, per coloro delle campagne.
C’è da considerare che questo rapporto domestico o agreste si svolge sovente non da pari a pari, bensì basato su un buonismo generico e ipocrita, teso per lo più a soddisfare noi anziché immedesimarci nei rispettivi modi di vita. Da bravo abitante urbano considero inoltre, forse errando, l’anomalia sia del nostro comportamento, con eccessi esagerati di affettività elargita, sia del comportarsi delle genti del contado che si riferirà soprattutto all’ambito utilitaristico che possa derivarne, come lavoro, guardiania, fornitura alimentare per le nostre tavole. Così i cani e gatti, per essere accetti nelle campagne, devono svolgere le loro brave mansioni. I mici acchiappare i ratti, i cani sorvegliare o difendere qualcosa, oppure collaborare coi padroni a eliminare quei quattro uccellini, fagiani, lepri, sopravvissuti ad una caccia ormai anacronistica e inconcludente. In questa testo però intendo accennare a un rapporto particolare intercorso per anni fra me e un “subumano”, cioè un mastodontico gorilla, con un enorme capo, sempre nel dubbio che il “subumano” non fosse tanto il suo genere quanto il nostro.
Nella poca fantasia dei guardiani dello zoo di Roma, ove il colosso era ospitato, gli era stato affibbiato il nome di “Bongo”, un po’ come novantanove proprietari su cento di pappagalli decidono di chiamarli Loreto. Io da subito, da quando cioè l’amico non era ancora la montagna che divenne, lo chiamai MAX, e mi parve lui lo gradisse. Il considerarlo un compagno nel percorso di vita non mi era risultato difficile. A parte poi che avevo un mezzo parente acquisito, in quel di Latina che sembrava un vero animale, stavolta umano, e gli somigliava pure in molti tratti ed espressioni, se non nella mole.
Max-Bongo giunse allo zoo di Roma forse perché nato in cattività (cosa per loro difficile) o, ancor peggio, in quanto sottratto da piccolo ai suoi, alle sue lontane foreste e montagne africane.
In lui vedevo notevoli sprazzi di quel sentimento che chiamiamo umanità, accompagnato sia da attenzione nei miei confronti, con i suoi occhi ravvicinati che mi fissavano e le parvenze di ghigni che potevano essere tentativi di sorriso, sia da una perenne tristezza che mi colpiva, dovendo accettare quella sistemazione innaturale entro due-tre grossi locali, chiusi da sbarre o da vetri antisfondamento. Salvo il trovarsi all’ergastolo non è poi che stesse troppo male, considerando che nella sua dimora, attrezzata con patetiche strutture che avrebbero dovuto simulare un angolo di foresta, ci infilarono una compagna silenziosa, riservata, di mole minore, appollaiata per lo più su una pedana sopraelevata, con tratti decisamente meno umani del padrone di casa. Ignoro quale fosse il loro ménage sessuale, il fatto è che di gorillini non ne vennero, nonché i guardiani mi dissero che i gorilla in cattività si accoppiano di rado, anche mai. Non così avveniva nella vicina gabbia ove scontava la sua condanna una famiglia di orribili oranghi (mamma! quanto erano brutti! pur se simpatici e buoni) che mise al mondo dei buffi oranghini, nonché in un’altra gabbia ove una scatenata combriccola di scimpanzé che, oltre a sberleffi e scherzi di cattivo gusto, si esibivano a volte in show sessuali onanistici o in coppia, senza ritegno e problema alcuno.
Incontrai Max-Bongo i primi tempi del suo arrivo, in una delle visite che con una certa frequenza facevo con le mie nipoti allo zoo per passare qualche ora all’aria aperta, fra i miei e nostri amici.
Con Max-Bongo fraternizzammo presto. Lo fissavo negli occhi e gli parlavo, come faccio di norma con chi disposto ad ascoltarmi. Lui notava questa attenzione e in qualche modo contraccambiava.
Tutti gli facevano mosse buffe e gli tiravano noccioline, mirando alla manona che a volte tirava fuori, io invece gli offrivo mele, e le porgevo con cautela, consentendogli di prenderle con le dita.
Max-Bongo stava di norma seduto dietro le sbarre e osservava tutto con lo sguardo attento. Mi avvidi presto che mi gratificava della sua attenzione. Quanto a qualche gentilezza alimentare si aspettava e gradiva proprio le mele, meglio se di buone dimensioni e rosse. Mi vedeva, faceva capire di accettarmi, e infine tendeva il braccio dalla gabbia in attesa del primo dei due-tre grossi pomi che avevo per lui, e i guardiani tolleravano, anche perché erano ottimi frutti e non le solite caramelle, noccioline, lanciategli come un tiro al bersaglio. In qualche giornata inclemente, specie invernale, potevo sbirciarlo solo all’interno dell’edificio riservato ai grossi primati, separato da un pesante cristallo, pertanto niente mele ma lui, appena mi vedeva, si piazzava in prossimità della lastra trasparente e sembrava chiedesse “oggi niente?” e anche sorridesse un po’.
Pregavo allora il guardiano abituale di recapitargli un cartoccio con alcune mele rosse. Egli mi faceva la cortesia e Max-Bongo andava così nel locale adiacente tornando con la busta dopo di che, accovacciandosi e guardandomi riconoscente, le mangiava lentamente una dietro l’altra, ovviamente intere, senza capare o scartare alcunché.
Avevo preso l’abitudine, con la buona stagione, di sfiorare con cautela le sue mani porgendogli il pomo non nelle dita, ma nel palmo, sicuro per me, non per gli altri, di non rischiare nulla, cautela a parte.
Lo conobbero anche le mie due nipoti, allora ragazzine, le quali, come tutti i bambini, si aspettavano da lui salite sulla corda, sull’albero secco interno, piroette, salti, cose da far ridere.
Gli lanciavano caramelle, lo consideravano alla pari dei vicini scimpanzé e oranghi. Faticai a fargli capire che dovevano trattarlo da “umano”, parlarci un po’, dedicargli una parte della loro attenzione.
E queste cose erano pure per lui, dicendogli che gli volevamo bene.
Arrivammo al punto, e i guardiani lo notavano, che appena varcavamo il cancello d’ingresso Max-Bongo scendesse dal suo albero finto, o si girasse se già a terra, seguendoci con lo sguardo e attendendo la visita. La sua casa infatti non era distante dall’entrata e la vista non interrotta da altre strutture.
La sua compagna no! Restava in alto, accoccolata nel suo angolo aereo, non la vidi quasi mai giù, sul pavimento.
Le mie bambine già dall’ingresso gli gridavano “Bongo!”, “Bongo!” (a loro piaceva così, Max era per me), e lui attendeva e si predisponeva al prossimo incontro. Gli insegnai a non offrirgli caramelle o noccioline. Le prime anche pericolose alla dentatura, considerando poi che gli erano offerte da tutti, le seconde in quanto poco dignitose e avvilenti (arachidi a un re delle montagne!), nonché ininfluenti come cibo stante la massa corporea che aveva raggiunti i due-tre quintali di stazza, forse più, e le noccioline, oltretutto, si disperdevano in larga parte sul pavimento o fuori del gabbione per i lanci imperfetti. Così gli offrirono anch’esse mele, stavolta di colore biondo, e a volte pere, che lui rigirava con curiosità fra le mani, prima di farne un boccone unico, senza problemi per le dimensioni.
All’inizio, per logico timore, gli ponevano i frutti sul canale che circondava la gabbia, ove l’amico subumano poteva raccoglierle.
Poi con cautela, molta, gli insegnai a porgerle direttamente, calcolando un minimo di centimetri di sicurezza fra le rispettive mani.
Presero a volergli bene e parlargli, come me, mentre nelle altre parti dello zoo gli animali tornavano ad essere bestie e non subumani.
Poi Max-Bongo si ammalò. Sapevo e sapevamo che lo curavano bene, e quando ci vedevamo il suo sguardo mi fissava come per esprimermi la sua sofferenza. Era visibilmente meno attivo.
Si stringeva in se, riuscendo perfino a sembrare di mole minore di quella possente sua propria. Venne un giorno che lo vidi più provato del solito, coi guardiani che affermavano stesse facendo le bizze, in quanto era curato meglio di in cristiano, e non avrebbe dovuto soffrire con tutte le pasticche ridotte in polvere che gli somministravano.
Gli offrii una mela, non tese il braccio per prenderla, non l’aveva mai fatto. Anche i tentativi delle nipoti risultarono vani.
Allora ci parlai, addolorato, con lui che mostrava attenzione sia a me, sia alle bambine che gli dicevano: “bello Bongo!”, “guarisci Bongo!”, “non ci far piangere Bongo!”. Lui ascoltò e poi lentamente spinse il braccio destro fuori dalla gabbia con la palma aperta in sù.
La nipote minore, sette-otto anni, gli porge una bella mela gialla, la fa scivolare dalle sue dita nel grosso palmo. La mano non si chiude, la mela cade, il braccio e la mano restano fuori. Mia nipote allora estrae dalla tasca un inusuale torroncino, destinato a lei e non a lui, e ripete l’azione con lo stesso risultato. Il dolce, anche vistoso, cade in terra, ma il braccio resta teso e la mano aperta. Lui mi fissa, io altrettanto, e allora capisco! Max-Bongo vuole toccare le nostre mani, per ricevere e dare un segno di affetto, di saluto, non altro. Tendo il mio braccio e con le dita tocco le sue, gli sfioro un po’ della mano, troppo simile alla mia salvo le dimensioni, poi la ritiro.
Max-Bongo mi è chiaramente riconoscente, ma il braccio resta sempre fuori.
Lo sguardo si gira un po’ e fissa mia nipote. Io allora: “Stella, Bongo ti sta salutando (l’altra, Dalia, si era allontanata un po’ timorosa), vogliamo sfiorare, toccare, un po’ la sua mano?” (mamma, che incoscienza da parte mia!)…
…“Bongo, sei un amico, stai buono, non farmi reazioni delle quali potrei pentirmi, non muoverti, lo vedi quanto è piccola mia nipote?”…
Prendo Stella in braccio, mi sporgo oltre la bassa recinzione che è la prima barriera di divisione, gli faccio tendere il braccino, pronto a tirarmi indietro qualora necessario. Le ditine e i ditoni si avvicinano, si toccano nei polpastrelli, e così resteranno per attimi infinitamente lunghi. Lo sguardo di Bongo è buono, felice, mia nipote piange di commozione, non di paura, anch’io ho un groppo in gola. Poi gli dico: “Stella, ritira il braccio (non era una stretta di mano, troppo pericolosa, solo un contatto di estremità, un po’ come faceva ET, l’extraterrestre), ma Stella, con un gesto fulmineo e spontaneo, gli fa’ una rapidissima carezza sulla mano. Mi si gela il sangue ma ormai è fatta. Non avrei potuto ripresentarmi in casa se fosse successa qualcosa. La tiro via, Max-Bongo ritira il braccio ignorando mela e torroncino in terra, ci lancia uno sguardo, poi si volta e si accovaccia di fronte il muro interno senza più girarsi. Forse piange a modo suo.
“Bongo, non far così!”, “Bongo, noi andiamo!”, “Bongo, ti vogliamo bene!”, “Max, ciao da me e dalle tue amichette!” Una settimana dopo Bongo morrà di malattia, di vecchiaia, aveva più di trentacinque anni, non male per loro, e ne parlarono i giornali nelle cronache cittadine.
Potete non crederci, ma a leggere la notizia anch’io feci una lacrima, e le nipoti si disperarono. Si può piangere per uno scimmione? Si, è avvenuto! Max-Bongo lo consideravo del nostro ambito, con tratti di evidente umanità che tanti a me prossimi non avevano. Non presumo, sono certo, che egli mi riconoscesse e cercasse di farmi comprendere qualcosa di se, del suo mondo.
Lo sguardo finale fu di affetto, riconoscenza, di implorare qualcosa che non gli potei dare, salvo il mio e nostro affetto.
Tornai più volte allo zoo romano con le nipoti e la prima visita era alla sua gabbia nella speranza di rivederlo. Non c’era più, rimase la sua compagna animalesca che accetta caramelle, noccioline, e quanto possa essergli gettato, malgrado il divieto di dare cibo sia divenuto nel frattempo più rigido, anzi punito. Ormai le nipoti sono signorine e l’epoca dello zoo è passata. Riprenderò forse un giorno con i loro figli. Ciao Max, ciao Bongo, sei tornato alle tue montagne, alle tue foreste, ma sei sempre presente con noi.
|