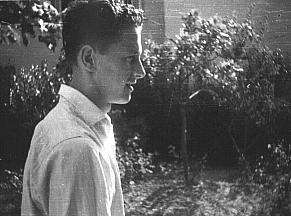La quinta elementare (anno scolastico 1942-43) la trascorsi alle scuole “De Amicis, dove avevo frequentato tutte le classi, esclusa la prima (alla Scuola elementare San Bartolomeo), con la guida del Maestro Pini. Era composta, in parte da un gruppo di alunni dell’Istituto San Filippo Neri di Via Sant’Orsola (i Patronatini) e da due terzi di bambini della zona nella quale mi trovavo, molti dei quali figli della “buona” borghesia modenese (come si può evincere dalla fotografia della classe allegata al testo), i quali ebbero la possibilità di fare delle belle carriere nella società modenese, negli anni del boom economico e successivi.
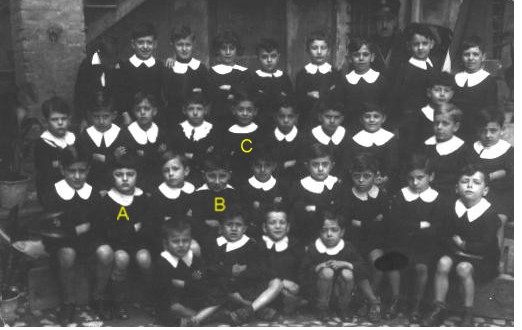
| Anno scolastico 1938-39 - Classe 1° San Bartolomeo (A) Bruno
Zucchini (B) Sergio Brighenti (C) Ivan Manicardi |
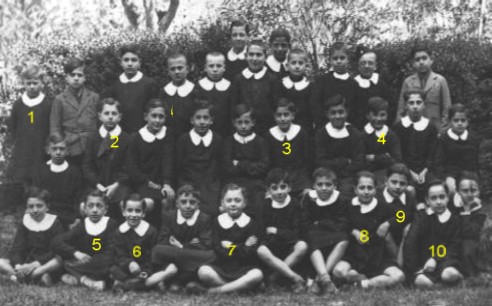
| Anno scolastico 1942 – 1943 - Classe 5° Scuole De Amicis – 1
Gozzi – 2 Piero Vicini – 3 Gianni Bulgarelli – 4 Vergnani 5
Giancarlo Vezzalini – 6 Giorgio Loi –7 Tavani –8 Giulio
Piccinini – 9 Bruno Zucchini – 10 Loi |
| Anno scolastico 1940-1941 Scuola De Amicis In piedi i maschi- il primo Vergnani. Il secondo Bruno Zucchini. Il quarto Saguatti Giordano. Delle femmine sedute ricordo solamente : Vecchi Anna Maria, Taglini, e Gozzi |
Ricordo Giancarlo Vezzalini poi noto ingegnere e industriale, uomo Fiat,
direttore generale e amministratore delegato Fiat trattori, Presidente
New Holland Italia, presidente del Banco San Geminiano e San Prospero, e
Presidente di Confindustria modenese; Giulio Piccinini, amico del gruppo
dei “Cordigeri” e della banda di Corso Vittorio Emanuele, poi noto
assicuratore, Piero Vicini, anche lui ingegnere e amico-nemico nelle
lunghe discussioni politiche al Bar Pellini di Largo Garibaldi, ritrovo
abituale della mia compagnia, i fratelli Loi (figli dell’olimpionico e
insegnante di Educazione Fisica degli anni trenta) affermatisi, l’uno
nella carriera militare, essendo stato, allora, uno dei pochi modenesi a
frequentare la nostra Accademia e l’altro, Giorgio, funzionario
dell’INA. Gianni Bulgarelli, in seguito impiegato al Banco di San
Geminiano e San Prospero, componente del mitico gruppo di amici del Bar
Pellini, oltre a Gozzi, Vergnani, Tavani e tutti gli altri che non
ricordo. Si era nel pieno del conflitto mondiale, la guerra si stava
mettendo male per gli eserciti dell’Asse impegnati su vari fronti e
dall’estate del 1943, anche in casa nostra, dopo lo sbarco americano in
Sicilia. A Modena si cominciava a “mugugnare”, le cose non andavano nel
modo che il “mascellone” aveva dato ad intendere agli italiani, già in
quei tempi si parlava di tradimenti e di “alte gerarchie” colluse con il
nemico, tanto è vero che a Luglio si ebbe il crollo del Regime Fascista.
Noi bambini sentivamo, senza rendercene completamente conto, che
qualcosa non andava, vedevamo le nostre case, i nostri viali privati di
tutte le cancellate in ferro che dovevano servire per fare cannoni e
venivano sostituite con cancellate in cemento; il cibo scarseggiava, le
nostre madri erano sempre preoccupate per quel poco che veniva passato
attraverso la carta annonaria, non proprio sufficiente per dei ragazzini
nella fase dello sviluppo adolescenziale; molte città italiane avevano
già subito terrificanti bombardamenti, quello sulla vicina Bologna, alla
fine del ’43, toccò particolarmente anche la mia famiglia dato che
rimase sotto le macerie, in Via Galliera, il marito della sorella di mio
padre (la zia Adele). Durante la calda estate, alla caduta del Fascismo,
il 25 Luglio, la gente s’ illuse che presto la guerra sarebbe terminata
e ancor più all’otto Settembre. Ma proprio quei due fatti furono le
premesse per lo scatenamento della vera tragedia italiana. Fu subito
guerra civile. Fratelli contro fratelli, Modena e la sua Provincia
ebbero a subire pesantemente tale tragica situazione.
Non ci si aspettava che la nostra città potesse subire attacchi dal
cielo, ma un triste giorno toccò anche a noi conoscere il terrorismo
aereo degli anglo-americani, accadde il giorno 14 Febbraio 1944.
Da parecchio tempo le sirene, che segnalavano ai modenesi gli allarmi
aerei e la possibilità d’incursioni, laceravano l'aria sempre più
frequentemente. Le formazioni aeree anglo-americane avevano ormai
conquistato la supremazia dei cieli di tutta Europa e in particolare su
quelli italiani; già moltissime città del Centro-Nord avevano subito
pesanti bombardamenti e la possibilità di contrastare le centinaia di
aerei delle forze alleate da parte della caccia italiana e tedesca,
nonostante i numerosi episodi di eroismo dei pochi piloti della
rinnovata aviazione repubblicana, andava sempre più riducendosi.
A Modena il terrore dal cielo arrivò di Lunedì, poco dopo l'ora di
pranzo. L'allarme aereo aveva avvertito i cittadini, ma ben pochi si
erano recati nei rifugi, che in realtà erano delle grandi buche
ricoperte di sacchi di sabbia e di terra e che, data la loro limitata
consistenza, avrebbero, tutt'al più, protetto dagli spezzoni delle
micidiali bombe sganciate dalle formazioni anglo-americane.
La maggior parte dei modenesi era dunque rimasta nelle case e si
limitava a guardare, come in tante altre circostanze, il passaggio di
tutti quegli aerei. Il cielo era limpido, i bambini nei cortili o dalle
finestre delle case si additavano quelle grosse macchine volanti che,
malgrado l'altitudine, facevano un rumore assordante.
Tutti pensavano fossero diretti verso i grandi centri industriali del
nord, dato che Modena poteva offrire solamente bersagli di ben limitata
portata e di scarso interesse militare. Ma ormai la guerra terroristica,
anche dal cielo, aveva preso il sopravvento sulla guerra guerreggiata.
Così come gli agguati e le imboscate partigiane aumentavano via via di
intensità con l'incrementarsi degli aiuti anglo-americani, anche la
guerra aerea era programmata con incursioni esclusivamente
terroristiche, su obbiettivi di ogni tipo e particolarmente contro le
inermi popolazioni. Queste incursioni avevano lo scopo principale di
spezzare il morale della gente comune che, ovviamente, veniva a trovarsi
in prima linea e altro non poteva sperare se non in una veloce
conclusione di tanto massacro.
La guerra psicologica, fatta di azioni terroristiche, di bombardamenti a
tappeto, di mitragliamenti continui, di spezzonamenti notturni, di
continue trasmissioni radiofoniche tendenti alla frattura del fronte
interno, fu un’arma micidiale, che i comandi delle potenze militari
"alleate" misero in atto con spietata ferocia e con particolare dovizia
di mezzi.
Modena era ancora, in quei giorni, una città piena di vita e di attività
e la maggioranza della popolazione era rimasta, nonostante gli esempi
della città vicine, come Bologna e Reggio Emilia, più volte duramente
colpite: tutti confidavano sull'ipotesi che, ben difficilmente gli
angloamericani avrebbero attaccato un centro di scarsa importanza
strategica.
Alle 13,30 si scatenò su Modena il finimondo; centinaia e centinaia di
bombe piovvero dal cielo in pochi minuti; scene di panico avvennero
ovunque, si correva fuori dalle case con il cuore in gola a cercare
scampo, mentre tutto sussultava e la terra tremava come in un violento
terremoto; una polvere bianca aveva coperto tutta la città colpita in
vari quartieri.
Io mi trovavo alla finestra a guardare quelle formazioni di aerei nella
mia casa di Viale Mazzoni quando, al primo rumore di bombe che cadevano,
assieme ai miei genitori, mi precipitai fuori casa per raggiungere il
ponte del cavalcavia della Sacca. Non facemmo in tempo poiché le bombe
piovevano da tutte le parti e ci buttammo a terra sul terrapieno prima
del ponte. E lì subimmo l’inferno, vidi saltare in aria la conceria
Pellami al di là della ferrovia e enormi massi arrivarono sino a pochi
metri da noi. Siamo scampati miracolosamente.
Quando la nube cominciò a diradarsi, la tragedia apparve in tutta la sua
vastità. Furono particolarmente devastate le zone della Sacca e di San
Cataldo, molte bombe caddero attorno alla stazione ferroviaria che non
subì gravi danni. Danni enormi, al contrario, subirono numerosi
stabilimenti e case di abitazione civile nelle zone circostanti; saltò
in aria la conceria pellami, nel luogo ove attualmente sorgono gli
edifici delle scuole Ferraris; vennero colpite varie scuole elementari,
le De Amicis, le Campori, le Carmelo Borg Pisani e fortunatamente le
lezioni erano state terminate da poco; moltissimi palazzi vennero
totalmente distrutti, specialmente in Viale Crispi; altre bombe caddero
un pò ovunque: in Via Emilia Ovest, nei Viali del Parco e nei giardini
pubblici. I morti, furono oltre cento, e parecchie centinaia i feriti. I
danni alle cose incalcolabili.
Ha inizio in questo modo la serie dei pesanti bombardamenti che in
seguito colpiranno la città e la Provincia modenese sino al termine
della guerra; centri come Pavullo, Vignola e tanti altri paesi subirono
enormi distruzioni e grosse perdite tra la popolazione civile. La
maggior parte di questi bombardamenti non portò danni consistenti nè
alle strutture dell'esercito tedesco, né alle strutture industriali e
tanto meno agli obbiettivi militari; subirono invece distruzioni ingenti
moltissimi monumenti ed opere d'arte, oltre alla distruzione di interi
quartieri popolari.
Va inoltre ricordato che molti degli obiettivi da colpire, in realtà
quasi mai centrati, erano comunicati alle forze angloamericane da
speciali formazioni partigiane munite di radiotrasmittente ed in
collegamento con i comandi militari anglo-americani.
Modena entra così nell'occhio del ciclone della guerra. Nessuno aveva
più scampo, militari e civili erano continuamente bersagliati dagli
attacchi aerei e dalle imboscate sulle strade; la città dopo questa
bestiale aggressione cominciò a svuotarsi, tutti coloro che potevano
rifugiarsi da amici o parenti nelle campagne, scapparono; ebbe inizio
così il triste esodo degli "sfollati" con tutti i drammi umani che si
portò dietro.
I bombardamenti massicci, i mitragliamenti a bassa quota su tutto ciò
che si muoveva di giorno, il terrore notturno con i lanci isolati ed
indiscriminati di bombe, da parte di aerei che la popolazione chiamava
"Pippo", avevano creato in tutti una vera e propria psicosi, d'altronde
ben comprensibile, al minimo rumore di aereo.
Il bombardamento successivo avvenne esattamente tre mesi dopo.
Il 14 Maggio alle ore 14,35, Modena subisce il secondo e più
terrificante bombardamento, superiore per danni, distruzioni e vittime a
quello, già pesante, del mese di Febbraio. A ondate successive, le
formazioni dei bombardieri angloamericani, le famose fortezze volanti,
scaricarono, indiscriminatamente dal cielo, sulla nostra città,
tonnellate e tonnellate di bombe; furono quindici minuti lunghissimi; i
bombardieri alleati dimostrarono ancora una volta, che il loro impegno
principale era quello di seminare il terrore tra la popolazione civile,
senza curare minimamente gli obiettivi militari. Il centro della città
subì gravissimi danni; venne semidistrutta la Chiesa di San Vincenzo,
completamente distrutta la Chiesa dei Servi, di cui oggi rimane,
simbolicamente, il vecchio campanile, unica parte rimasta integra, della
Chiesa. Gravissime lesioni subirono, il Tempio Monumentale dei Caduti e
la Chiesa di San Domenico; il Duomo cittadino subì gravi danni, in
particolare modo alla “Porta dei Principi”; sembrava che dal cielo fosse
stato preordinato un preciso disegno per la distruzione dei monumenti
storici e dei luoghi di culto.
Danni enormi subirono, il Palazzo delle Poste, il Palazzo Ducale,
l’Arcivescovado, il Portico del Collegio, ecc.
Ai mulini nuovi fu colpito un ponte sul canale Naviglio, sotto al quale
si erano rifugiati i bambini e le suore del vicino asilo; fu una vera e
propria carneficina. Venne anche colpita la Caserma “Ciro Menotti” sede
della Scuola Allievi Ufficiali della GNR.
Subito dopo il bombardamento di Febbraio, la mia famiglia si trasferì,
dopo aver caricato su di un carretto i pochi bagagli utili e le cose di
maggior pregio, nelle campagne di Ravarino dove abitavano i parenti di
mio padre, questa fu una manovra giusta in quanto nel bombardamento di
Maggio la nostra casa venne colpita e fortemente danneggiata.
Lo “sfollamento” in campagna stravolse tutto il mio sistema di vita; si
dovette abbandonare oltre alla casa, gli amici, i giochi nelle strade e
ai giardini, la scuola, anche se, noi ragazzini, non ci lamentammo più
di tanto per la forzata chiusura delle scuole. Ed ecco che iniziarono le
scorribande per i campi, anziché sulla strada di Corso Vittorio, alla
ricerca di tutto quello che era possibile trovare allora e che potesse
dare sfogo alla nostra esuberanza e al desiderio di divertirci anche in
momenti così difficili. La frutta sulle piante, che entrava nelle nostre
camicette, e i contadini urlanti che ci rincorrevano senza mai riuscire
a prenderci, la “spigolatura” dei campi di grano dopo la trebbiatura
alla ricerca delle poche spighe rimaste sul terreno, la battitura del
grano, la pigiatura dell’uva a piedi scalzi nelle aie, la macellazione
dei maiali, la caccia alle munizioni che si trovavano un po’ ovunque,
bossoli di fucili, di mitragliatrice, ricercatissimi quelli da 20 e 12
mm. degli aerei americani che durante il giorno mitragliavano ogni cosa
in movimento. Con quei giochi ci divertivamo “un sacco”. Un giorno fu
mitragliato e bombardato un treno tedesco carico di munizioni, fermo
alla stazione di Ravarino e saltato completamente in aria, lasciando per
lungo tempo la possibilità, a noi bambini, di un recupero incredibile di
“materiale”, micce, bossoli, ecc.
Erano giochi pericolosi che i “grandi” ci offrivano in quei giorni
crudeli, molti subirono mutilazioni per lo scoppio di questi ordigni
messi tra mani inesperte, oltre agli “omaggi” che gli americani ci
lanciavano dal cielo, come penne stilografiche esplosive che allettavano
la fantasia di noi ragazzini quando le trovavi in mezzo a un campo, e
non sapevi, se non dopo che erano esplose nelle mani di qualcuno, che
quei “doni” che ci venivano offerti erano delle micidiali trappole
mortali.
La guerra non più solamente al fronte, era quotidianamente tra i civili
che continuavano a scannarsi tra loro, colpiva tutti, bambini compresi.
La strada che porta da Ravarino, frazione La Grande, a Nonantola è
ancora un lunghissimo rettilineo, allora non asfaltato, lo percorrevamo
una mattina in bicicletta quando, dopo aver superato un carro agricolo,
vedemmo venirci incontro, a bassissima quota un aereo americano;
istintivamente, i quattro o cinque ragazzini, quanti eravamo, si
infilarono, biciclette comprese, nel fossato laterale abbastanza
profondo, un attimo prima che l’aereo, vedemmo perfettamente il volto
del pilota dentro l’abitacolo, sgranasse le sue mitragliatrici, con un
fuoco spietato, sul carro agricolo che venne completamente distrutto; il
carrettiere, fortunosamente, si lanciò anche lui dal carro, nel fossato,
salvandosi.
Inoltre c’era sempre il problema della presenza dei tedeschi: nella
nostra zona precisamente nell’edificio della Scuola elementare di Rami
di Ravarino s’installò per lungo tempo un distaccamento di truppe
germaniche, che in realtà non diede mai grossi problemi, anzi vi fu un
buon rapporto tra la popolazione e questi militari. Vi era un certo via
vai di mezzi militari, sia fascisti sia tedeschi: una notte si fermarono
nel cortile interno dei fabbricati dove ero alloggiato, tre o quattro
carri armati “tigre”e lì si attestarono per alcuni giorni. Vi fu
un’enorme preoccupazione da parte di tutti i residenti, per
l’eventualità di un attacco aereo che sarebbe stato devastante se i
carri fossero stati visti dall’alto.
I tedeschi li misero in posizione strategica e inoltre li coprirono con
reti mimetizzanti, così, noi bambini, che facilmente facevamo amicizia
con tutti, riuscimmo a convincere i soldati a farci visitare,
all’interno, i loro “mostri d’acciaio” che avevamo visto, sino allora in
fotografia, in particolare sulle riviste tipo “Signal” che qualche volta
raggiungevano la nostra località. In questa circostanza, i tedeschi,
restarono al loro posto e non disturbarono nessuno.
Una notte, in casa mia c’era l’unica radio della zona portata con noi
dopo lo sfollamento dalla città, si radunarono alcuni parenti e
residenti del borgo per ascoltare “Radio Londra”; la trasmissione
radiofonica inglese in lingua italiana, che trasmetteva, tra l’altro,
comunicati ai partigiani ed era osteggiata dal Governo della Repubblica
Sociale, ne era tassativamente proibito l’ascolto, ci fu veramente
paura. Erano previste sanzioni pesanti se si fosse stati scoperti.
Ad un tratto sentimmo bussare alla porta, assieme a voci tedesche,
terrorizzati o quasi, gli adulti ammutolirono, e si spense
immediatamente la radio. Mia madre, Bruna Della Casa, tutta tremante
andò ad aprire, si trovò di fronte due “carristi” che, con il loro
italiano stentato e quasi timidamente chiesero “in prestito” alcuni
bicchieri poiché all’interno dei loro carri stavano festeggiando un
camerata; ovviamente furono dati loro i bicchieri che ritornarono
regolarmente il mattino successivo. Per alcune sere la voce di Radio
Londra rimase spenta, ma dopo alcuni giorni gli ascolti “clandestini”
ripresero, dato che, il desiderio di sapere notizie, assieme alla
speranza della fine del conflitto, era troppo forte per tutti.
Mia madre, per tutto il periodo dello ”sfollamento”, lavorava come sarta
presso l’Ospedale Militare di Via San Geminiano a Modena, si faceva
quotidianamente una pedalata di 18 chilometri al mattino e altrettanti
alla sera per il ritorno, per la tratta Ravarino-Modena.
L’unico episodio, di un certo rilievo, che la vide protagonista in quei
15 mesi di “allenamento ciclistico” le capitò il giorno 21 Aprile 1945.
I giorni della “liberazione”. Le truppe anglo-americane avevano sfondato
il fronte della Linea Gotica e stavano rapidamente conquistando tutta la
pianura padana. Modena, proprio in quelle ore, era evacuata da tedeschi
e fascisti.
All’Ospedale Militare lasciarono libero il personale non
infermieristico, di conseguenza mia madre si rimise in bicicletta per
tornare a Ravarino. Con le strade quasi deserte si avviò per la Via
Nonantolana quando, giunta sul ponte di Navicello, si vide venire
incontro un soldato tedesco che la implorava: “Mamma, mamma, tu dare a
me bicicletta che io dovere scappare”, lei non ci pensò due volte, e non
per la paura, ma perché pensò subito al figlio che non era, e non
sarebbe, tornato dalla guerra, lasciò la bicicletta al soldatino che
fuggì per andare chissà dove, facendosi tutto il tragitto sino a casa, a
piedi.
Nei racconti, prodotti a profusione, che parlano di quei tempi,
specialmente in tutti i testi “resistenziali” i soldati tedeschi vengono
sempre, spregiativamente, chiamati i “tognari”. Sempre in quel giorno,
mentre aspettavo il ritorno di mia madre, nel sito dove mi trovavo,
tutti si erano portati fuori casa in attesa degli eventi che stavano
precipitando. Molti si improvvisarono “partigiani dell‘ultima ora” e
qualcuno aveva tirato fuori i fucili nascosti attendendo, agli angoli
delle case, di poter fare la “loro guerra”.
Davanti a miei occhi accadde che all’improvviso, dalla curva della
strada, spuntò una bicicletta montata da un militare tedesco. Senz’altro
non era quello al quale mia madre aveva lasciato la sua al ponte di
Navicello. Appena lo videro, gli eroi dell’ultima ora, tra lazzi e
risate, iniziarono il tiro al bersaglio contro il poveraccio, colpendolo
prima alle gambe poi in altre parti del corpo, finendolo una volta che
era carambolato per le terre. Poco importava che quel disgraziato fosse
o no responsabile di misfatti, fosse semplicemente un furiere o un
addetto alle cucine, era un “tognaro” e bisognava eliminarlo.
Nelle campagne attorno, nel frattempo, era iniziata la mattanza, la
caccia al fascista o al presunto tale: coloro che avevano avuto
rapporti, anche i più banali, oppure dettati da semplici situazioni di
doveri istituzionali, entravano nel mirino perverso dei “liquidatori”
che con la prospettiva di creare sulle nostre terre una parvenza di quel
“paradiso sovietico” verso il quale erano stati indottrinati,si
preoccuparono di spedire “tra gli angeli” il maggior numero di persone
che avrebbero potuto essere, nell’immediato futuro, dei potenziali
avversari.
Nelle zone dove ero sfollato, molte cose le imparai tempo dopo,
accaddero massacri ed eliminazioni arbitrarie che mai, sino ad oggi,
hanno avuto la possibilità di essere scoperte e tanto meno puniti gli
esecutori. Quei territori nascondono ancora oggi cadaveri di fascisti,
di possidenti, di religiosi, di persone dabbene che furono eliminate con
una programmazione feroce e spietata.
Non riuscirono nei loro intenti e l’Italia, in particolare per la
spartizione del mondo voluta a Yalta, non cadde nelle mani dei comunisti
russi e nostrani, come invece successe a molte nazioni del cosiddetto
est europeo. Appare semplicemente irrazionale che a distanza di oltre
sessanta anni, dopo tutto quello che è successo nel “loro paradiso”, ci
siano ancor oggi in Italia persone e gruppi, che occasionalmente si
trovano al governo, convinti del miraggio di quella fallimentare e
criminale ideologia.
I ragazzini allora, terminata la tremenda carneficina, si scatenarono
allegri e divertiti nelle nuove formule dell’americanismo trionfante.
Era impossibile, in quel contesto e a quell’età, recepire che “le
novità” portateci dalle truppe, americane, inglesi, francesi,
neozelandesi, brasiliane, marocchine, sudafricane ecc. altro non erano
se non i presupposti di una conquista, che dura ancora oggi, della
nostra civiltà crollata e conquistata dai nuovi padroni, gli americani,
che tutto hanno livellato al loro volere e alla loro pseudo-cultura
attraverso un capitalismo che ha inglobato e fagocitato tutto e tutti,
compresi anche coloro che si erano dichiarati loro acerrimi nemici, i
comunisti.
Siamo pertanto calati in una dimensione, dopo l’epoca dei Giganti, nel
tempo dei nani, omuncoli e donnicciole che della politica politicante,
hanno fatto il loro mestiere, dal 1945 ad oggi, siamo arrivati al tempo,
come diceva lo scrittore siciliano Sciascia, dei quaquaraqua, per
arrivare sino alla genia degli invertebrati, che strisciano e sbavano
davanti ai padroni del mondo, quelli che ci hanno massacrato,
bombardato, svillaneggiato e svuotati di ogni dignità continuando ad
incensarli come i nostri “liberatori”.
Cosa ne sapevano i ragazzini del 1945, dato che imperava solamente il
nuovo “verbo” e dato che anche le generazioni successive furono educate
scolasticamente in modo unilaterale nelle conoscenze storiche e della
libertà di pensiero, del mondo che era stato sconfitto?
La libertà è bella e sacrosanta, ma obbligatoriamente deve avere delle
regole, la scusante della libertà è stata una falsa chimera e non solo
la mia, ma anche le generazioni successive ne sono state “sconvolte”. A
quei tempi, noi che ancora giocavamo, eravamo all’oscuro di tante cose,
sia da una parte sia dall’altra, mentre “i monatti” portavano al
cimitero i nostri fratelli maggiori con la scusante della”nuova libertà
conquistata”.
Modena e la sua Provincia hanno subito pesantemente questa “liberazione”
che ancora oggi sentiamo, come “la scimmia della droga”, sulle nostre
spalle.
Il benessere diffuso ci ha resi completamente “ciechi”, anche gli uomini
della cosiddetta “destra” hanno fallito miseramente il loro scopo, in
quanto sono rimasti prigionieri di un passato che cercava di andare
avanti tra “doppiopetto” anacronistico e, ancor più fuori tempo,
attraverso le “pagliacciate” nostalgiche. Le nuove generazioni erano
desiderose di creare qualcosa di nuovo e di combattere la “decadenza
dell’Europa” ma purtroppo non ebbero riferimenti culturali di sorta che
spiegassero loro il perché di passati gloriosi di fronte al vuoto del
presente. I giovani di allora come in buona parte quelli di oggi, sono
soprafatti da una concezione del mondo che tutto “cloroformizza”, anche
quell’ultima ridotta che concettualmente avrebbe dovuto ribellarsi alla
decadenza e allo sfascio di una Europa e di una Italia disarticolata,
disintegrata in tante battaglie di retroguardia e in una forma
reazionaria improbabile e a dir poco disgustosa, che và a sollecitare
gli istinti peggiori di un popolo decisamente imbelle, incapace di ogni
reazione e decisamente vile e traditore.
Nel 1945, al termine del secondo conflitto mondiale le nuove generazioni
furono sopraffatte, nella stragrande maggioranza, dalla prepotenza
economica e in parte culturale, delle forze coalizzate che avevano
conquistato il mondo.
Fu una conquista quella della bicicletta, una volta tornato a Modena, e
non era certo la mitica “Bianchi”, né la “Legnano”, ma un “burtel”, come
venivano chiamati i vecchi “catorci”; cercando di tenerla ben oliata e
in ordine, ebbi la possibilità, assieme ad un gruppetto di ragazzi, di
partecipare a tante gite con percorsi, anche esterni alla città. Spesso
andavo e tornavo nelle campagne di Ravarino, dove avevo trascorso il
periodo dello sfollamento, a trovare parenti e amici¸vi furono anche
puntate in montagna arrivando “sino” a Serramazzoni con la famosa curva
del “Taglio” che, fatta con la mia bicicletta, assumeva quasi la scalata
di uno “Stelvio” o di un “Tourmalet”. Una delle gite più lunghe fu una
Modena-Ferrara, che a quei tempi con strade sterrate e con mezzi così
scadenti a disposizione assumeva una specie di “trionfo ciclistico”.
Un’altra gran passione di quel periodo, anni 1946-47, era, per il nostro
gruppetto, la scalata alla Ghirlandina, ovviamente fatta, salendo le
ripidissime scale, di corsa per arrivare primi in vetta a goderci lo
splendido panorama di Modena e delle campagne circostanti, con visuale,
durante le belle giornate sino al Cimone e alle prealpi venete; si
restava, sul ballatoio più alto, a lungo a goderci il lancio dei nostri
aereoplanini di carta volteggiare, e vederli atterrare sui tetti della
città.
Ci teneva molto impegnati anche la raccolta e la rilegatura dei
giornalini. Avevo costituito il mio primo “club”, il club Salgari, che
ovviamente raccoglieva tutte le pubblicazioni del grande romanziere
veronese: leggevamo quei libri con avidità, e vivevamo, con la nostra
fantasia, quelle storie come fossero reali, immedesimandoci nei vari
personaggi delle, “Tigri di Monpracem”, in “Sandokan alla riscossa”, nel
“Corsaro Nero” e in tutte le altre mirabolanti avventure di quei mitici
racconti. Per non dimenticare le altre splendide storie della raccolta
della “Biblioteca dei Ragazzi” della Casa Editrice Salani.
Vi è un grosso rammarico da parte mia per non aver conservato la
vastissima raccolta dei giornalini di quel periodo, che, se fosse ancora
in mio possesso, costituirebbe un discreto capitale, visti i prezzi che
ci sono su quel particolare mercato.
Avevamo acquisito una buona tecnica della rilegatura, e nella nostra
esclusiva biblioteca avevamo gli “Albi d’oro” di Topolino, le collezioni
di “Gordon” con i mitici personaggi di Dale, Ming, Zarro, Flash Gordon
illustrati in splendide tavole a colori. La raccolta di “Mandrake” con
il suo fedele “Lotar”, gli album ricercatissimi di “Cino e Franco” e
dell’”Uomo Mascherato”, il mitico personaggio anteguerra, italiano,
“Fulmine”, “L’Avventuroso” con le prime striscie del grande Jacovitti,
gli album, più piccoli ma molto interessanti di un personaggio meno
famoso, ma sempre molto avvincente, “Jim Toro”. Avevamo scoperto anche i
famosi giornalini dell’americano “Joe Petrosino” con le sue formidabili
lotte alla mafia come, “La mano Nera”.

| Squadra di calcio Tof Modena : Biondini, Mariotti, ?,
Zamboni, ?, ?, accosciati: Mantovani, Bertocchi, Piccinini,
Zucchini, Incerti, Sartoris. |
Certo che, man mano che si “diventava” grandi, si tralasciavano questi
interessi per dedicarci alla conoscenza “più approfondita” delle bambine
nostre coetanee che, al tempo dei giornalini, non degnavamo nemmeno di
uno sguardo,
Vi furono episodi, accaduti in città, che hanno lasciato un ricordo
indelebile nella mia memoria, come il grave incidente nella gara
automobilistica sui Viali del Parco cittadino che avvenne il 27
Settembre del 1947. L’avvenimento era attesissimo, il “Gran Premio
Automobilistico” per le strade di Modena, nessuno lo voleva perdere.
Ero, assieme ad una moltitudine di modenesi quel giorno sul circuito,
abitando, tra l’altro, ai margini dello stesso, avevo potuto seguire
tutte le prove. Durante la gara mi ero sistemato vicino ad uno dei
platani, all’altezza dell’Istituto dei Salesiani”, attualmente vi si
trova uno dei più noti e frequentati “chioschi” dei nostri viali, dove
erano stati sistemati, tra un platano e l’altro, per contenere la folla,
rotoli di filo spinato pericolosissimi; a circa 100/150 metri dal mio
punto di osservazione uscì di strada la “Delago” del pilota Bracco. Fu
una strage: 5 morti e 20 feriti; corsi immediatamente sul posto e mi si
offerse uno spettacolo “atroce”, tutti quei corpi dilaniati e dalla
macchina e dal filo spinato, mi lasciarono sconvolto per giorni e
giorni.
Ricordo anche le notti insonni, trascorse su quei viali, per assistere
al passaggio o dalla curva di Largo Garibaldi o al Monumento dei Caduti,
della mitica “Mille Miglia” o della cavalcata dei centauri
dell’altrettanto famosa Milano-Taranto.
Un’enorme impressione ci fu il 5 Maggio del 1949, alla notizia della
tragedia del “Grande Torino”, quando l’aereo, che trasportava giocatori,
dirigenti e giornalisti di quella famosa squadra, precipitò,
schiantandosi sul Colle di Superga.
Il Cinema è stata un’altra grande passione: ci fu un periodo che si
andavano a vedere due, tre film al giorno. Si partecipava a “cineforum”,
i locali come il “Principe”, lo “Splendor”, l”Orientale”, l’Excelsior”,
la “Scala” e poi l’”Astra”, il “Metropol”, il “Paradisino”, la sala del
TOF, erano sempre affollatissimi anche nelle prime ore del pomeriggio.
Così come d’estate i cinema all’aperto quali, l’”Italia”, l’Estivo”, il
“Tennis” erano costantemente frequentati dal mio gruppo di amici.
Frequentemente cercavamo di entrare di “straforo” o con la “patouna”,
oppure con l’accorgimento dei biglietti strappati, poi ben ricomposti
tanto da superare la prova del bigliettaio; per un certo periodo, con
altri due amici, scoprimmo una strada per entrare gratuitamente al
cinema Astra da poco inaugurato. Dall’ingresso del fabbricato a lato del
cinema, saliti nella zona granai, trovammo una porta che, dalla
terrazza, dava direttamente accesso alla galleria, di fianco alla cabina
di proiezione. Sfruttammo quella situazione per un periodo abbastanza
lungo, ma un giorno, credo una maschera, si accorse di quel nostro
stratagemma e ci portò in Direzione. Da allora quella porta fu ben
chiusa a chiave.
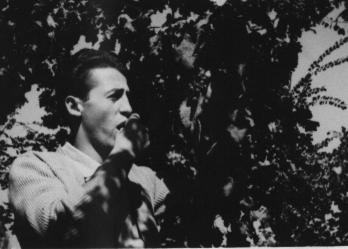
|
AMICI A Fianco MAURIZIO REBUCCI
A fianco OTELLO INCERTI
|
 L'amico Franco Casolari |
 L'amico Ivan Manicardi, deceduto in un incidente nel 1951 |
 Inaugurazione del gagliardetto della Società Sportiva " La Fratellanza" allo Stadio Braglia (si notano da sinistra: Nando Romagnoli, Gek Bertolini, Grillenzoni, Giulio Magnoni, nascosto dal gagliardetto, Franco Squadrini e Tosi) |