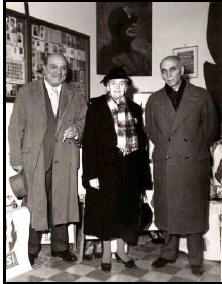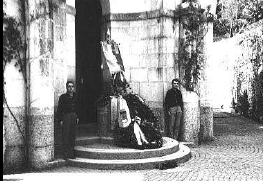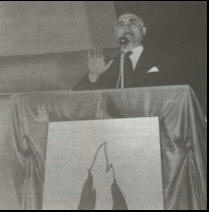ANNI ‘50
Nel capitolo “Rossi e Neri”, nella prima parte dedicata alla “Mia” Modena, ho raccontato del primo incontro avvenuto nei primi mesi dell’anno 1949, alla Trattoria del Bersagliere, con gli ex fascisti e i neo fascisti modenesi di quegli anni.
Avendo trascorso, tutto il periodo del Movimento Sociale Italiano, sino alla sua trasformazione in Alleanza Nazionale e pur non essendo, da quel momento, rimasto legato né alla “Cosa di Fiuggi” né ai piccoli Partiti dell’area dell’estrema destra, sono pur sempre rimasto vicino, idealmente, al mio trascorso in quel variegato e, contraddittorio mondo, della “impropriamente chiamata” destra, del nostro territorio.
Non è mai stato trattato un bilancio storico di un periodo che va dal dopoguerra ad oggi, di quella, se si vuole, piccola fetta della società modenese legata idealmente al discusso, vituperato, incensato, periodo storico che prende la storia d’Italia dal 1921 al 1945, pur sempre attraverso tutte le contraddizioni, le polemiche, le conflittualità portate sino all’eccesso, nelle diversificate componenti ideologiche da sempre trovatesi all’’interno di quel minuscolo partito, almeno per quanto riguarda l’area territoriale modenese.
Già al tempo del Fascismo, sia dentro al Partito che nel Regime, convivevano fianco a fianco italiani che si dicevano ugualmente fascisti, avevano la stessa tessera e lo stesso distintivo, ma ragionavano, nel loro intimo, in modo completamente diverso in funzione di una diversa origine e preparazione politica. Quello che vi era nel suo fondo sostanziale nel fenomeno fascista, e certo non mi permetto osservazioni nuove, aveva la sua origine nelle due componenti nazionalista e socialista, tendendo a risolvere in una sintesi, il problema della società italiana uscita da una guerra, la prima guerra mondiale, vittoriosa sul piano militare ma sconfitta sul piano economico e politico. Non vi fu improvvisazione ma una precipitazione, sottoposta dalla confluenza di quelle correnti, sino a quel momento separate, del nazionalismo esasperato e dal sindacalismo socialista. Furono poi esercitate, in modo confuso, varie influenze da parte di tanti movimenti culturali quali, l’estetica dannunziana, l’esasperazione nietzchiana, la componente tradizionalista, quella futurista, le tendenze oligarchice, la gerarchia, le interferenze ecclesiastiche, quelle massoniche, quelle monarchiche e conservatrici. Malgrado tutto questo, la linea più forte, quella nazionale e sociale, servì come fattore di coesione attraverso la presenza dell’uomo Mussolini che coagulò attorno a sé le varie istanze dell’animo comune.
Ma sotto sotto e malgrado l’apparente conformismo, vi era dentro al fascismo la conflittualità tra le stesse categorie culturali e sociali, gentiliani e antigentiliani, artisti che si ispiravano al novecento avevano contro gli antinovicentisti, vi erano sindacalisti che volevano a tutti i costi la socializzazione e vi erano i conservatori reazionari e autoritari, anche la mistica fascista, rivoluzionaria e intransigente, si scontrava con le gerarchie imborghesite, vi erano repubblicani e monarchici, militaristi e pacifisti, i filo inglesi e quelli che sostenevano un fronte mondiale delle nazioni proletarie, quali l’Italia, la Russia, la Germania e il Giappone. Al termine del conflitto gli uomini sconfitti dispersero le varie correnti, che un uomo solo era riuscito ad unire, nelle diverse e disparate direzioni, a volte opposte.
In questo racconto, che cerca di ricordare brani di storia locale, sino ad oggi mai presi in considerazione, vorrei che un briciolo di memoria storica fosse dedicato a tutti quegli uomini, che, pur provenendo da diverse culture e da diverse impostazioni spirituali, sociali e comportamentali, ben sapendo in quale posizione sociale si andavano a collocare cioè di emarginazione e di allontanamento dai vertici societari, si sono pur sempre battuti ed esposti per dare un senso a quella che è stata la nostra tradizione, a quello che era stato il nostro recente passato, che non può essere cancellato dalla protervia dei padroni del potere locale provenienti tutti da una cultura che ha sconvolto il mondo e che è rimasta totalmente sconfitta nella terra dove era cresciuta.
Lo scrivente, pur non essendo uno scrittore, né uno storico, né un politico di professione, ha pur sempre militato, seppure con fasi esistenziali alterne, in quel partito dal 1949, ritengo pertanto di poter tracciare una sintesi di questi sessanta anni, che si cerca di far dimenticare, come il periodo precedente. Non sono in possesso di documenti storiografici tali da poter dare un taglio scientifico a questo mio racconto; cercherò ugualmente, facendo riferimento alla “mia memoria” che ancor oggi mi supporta, di mettere in luce personaggi, fatti e avvenimenti con riferimenti cronologici sufficientemente esaurienti.
Il Movimento Sociale Italiano nasce a Roma il 29 Dicembre 1946 nello studio di Arturo Michelini, (futuro Segretario), alla presenza di: Pino Romualdi, Giorgio Almirante, Giorgio Bacchi, Giovanni Tondelli, Cesco Giulio Baghino, Mario Cassiano e Biagio Pace.
Al momento della fondazione di quel raggruppamento politico esistevano una molteplicità di gruppi e gruppuscoli di orientamento neofascista, oltre a partiti costituiti, come il Fronte dell’Uomo Qualunque (UQ), monarchici e liberali che pescavano nel mondo “nostalgico” che si presentarono alle prime consultazioni elettorali del 1946 per la Costituente e alle amministrative dell’anno dopo, e che ottennero un certo successo.
La comparsa sulla scena politica nazionale del MSI fece sì che formazioni come l’UQ e tanti gruppuscoli si sciogliessero per confluire, in buona parte, in quella struttura che già al suo primo apparire sembrava molto più omogenea e convincente per un suo reale inserimento politico nel paese, a quei tempi.
A Modena le prime elezioni amministrative si svolsero il 31 Marzo 1946; si presentarono i partiti del CLN. Su di un totale di 62.676 voti validi, il PCI ne ottenne 30.162 pari al 48,1%, il PSIUP, 11.991 voti pari al 19,1% e il PdA (Partito d’Azione) lo 0,9%. Questo era lo schieramento di sinistra che conquistò il potere locale sommando un totale pari al 68,1%. I comunisti erano già potentemente organizzati e sulla base di forti pressioni, violenze postbelliche che non si erano ancora concluse, riuscirono a far presa sull’opinione pubblica conquistando quel potere che ancor oggi mantengono, ininterrottamente, da quegli anni. Dalla parte opposta si presentarono: la DC, che ottenne 17.417 voti pari al 27,8%, il PRI 592 voti con lo 0,9% e il PLI 1.991 voti con il 3,2%. Venne eletto Sindaco, il partigiano comunista, Alfeo Corassori.
Subito dopo, il 2 Giugno, con il Referendum su Repubblica o Monarchia, si votò anche per la Costituente, dove l’area di destra era rappresentata dall’UQ che ottenne 2497 voti pari al 3,8%e l’UDN 1396 voti con il 2,1%. A sinistra il PCI ebbe un netto calo, il 6% in meno a vantaggio dl PSIUP e sia l’area di sinistra che quella di centro non subirono sostanziali modifiche rispetto alle amministrative.
In città, le prime riunioni degli sconfitti avvennero principalmente in due case: in quella del Rag. Giorgo Fabbri, assicuratore, e in quella del “proletario” Otello Rovatti in Rua Muro. Erano riunioni “carbonare”, girava ancora per la città la cosiddetta “Volante Rossa”, la polizia partigiana che, per un certo periodo, con una parvenza d’autorità concessale dal CLN, fermava, arrestava, fucilava, commetteva soprusi di ogni sorta ma che, dopo il ripristino di una certa legalità e con la ricostituzione quasi immediata dell’arma dei Carabinieri, fu esautorata, operando però in una specie di semi-clandestinità, continuava ad esercitare una certa pressione sulla cittadinanza, di conseguenza per i fascisti, per quelli rimasti tali o per quelli presunti, era estremamente pericoloso circolare per la città, specialmente di sera.
In quella casa venne anche ospitato, per un certo periodo, colui che diventò il capo indiscusso del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante, il quale, dopo il crollo della RSI trovò rifugio nella nostra città svolgendo un’attività di copertura, il rappresentante di commercio, ed iniziò così a reinserirsi nella vita sociale del paese.
Nel 1947 venne scelto il simbolo del partito, la “Fiamma Tricolore” che era stato l’emblema degli arditi della prima guerra mondiale.
In quei primi anni, i gruppuscoli di area neofascista come i FAR (Fasci di Azione Rivoluzionaria) e altri si andarono via via dissolvendo per entrare nella legalità del nuovo Movimento Sociale Italiano; presero forma una serie di periodici di area che ebbero una certa rilevanza e diedero la possibilità, anche in provincia, di conoscere ciò che avveniva e “bolliva in pentola” nella Capitale. A Modena arrivavano queste pubblicazioni e, alcune edicole, quali la “Rosina” in pieno centro, l’edicola Panini in Corso Duomo o quella di “Palmino” in Via Saragozza, erano il punto di riferimento per tanti giovani che desideravano essere “informati”. Molti erano i settimanali e i quindicinali che fornirono una tribuna molto importante, alle diverse anime del neofascismo che si stava impegnando per una ripresa politica “democratica”.
Ricordo il “Meridiano d’Italia” diretto da Franco De Agazio, “Il Pensiero Nazionale” di Stanis Ruinas, “Rivolta Ideale” diretto da Giovanni Tonelli, e che nei primi anni risultò essere uno dei più seguiti; “Il Merlo Giallo” diretto da Alberto Giannini, il “Rosso e Nero”, “Senso Nuovo” diretto da Achille Cruciani, “Noi” del Direttore Bruno Spampanato, “ Asso di Bastoni”, chiamato anche: “Settimanale satirico anticanagliesco” uno dei più seguiti, e che raggiunse anche le centomila copie vendute settimanalmente, diretto inizialmente da Ferdinando Marchiotto, poi da Pietro Caporilli; il settimanale di Leo Longanesi “Il Borghese” e il notissimo “Candido” di Giovanni Guareschi. La lettura di questa stampa dava ai giovani la possibilità di “iniziare” una “cultura di destra”, ma non la forgiava completamente, e non la rendeva “pregnante”.
Alle elezioni politiche del 18 Aprile 1948, si presenta anche la lista del Movimento Sociale Italiano, che su una parte limitata del territorio nazionale riesce a portare in Parlamento sei deputati e un senatore con 583.000 voti pari allo 0,8%. Vi fu, in quella tornata elettorale, una dura sconfitta del “Fronte Popolare” delle sinistre a favore della vittoria della Democrazia Cristiana, a Modena vinsero le sinistre con 38.160 voti pari al 52,2% contro i 25.646 voti della DC pari al 35,1%.
Subito dopo il Movimento Sociale celebra a Napoli, dal 27 al 29 Giugno 1948, il suo Primo Congresso. Le varie anime del Partito si confrontarono su posizioni non esasperate, con la visione di un certo compromesso: risultò vincente la componente di sinistra che mantenne il controllo del Partito con Giorgio Almirante alla Segreteria e con Vice Segretari Gianni Roberti, Arturo Michelini e Massi.
La sintesi tra i fautori ad oltranza della “Socializzazione” e quella dei sostenitori del “Corporativismo” venne costruita da Augusto De Marsanich che, in riferimento al Fascismo, trova, nella formula “Non rinnegare, non restaurare”, l’accettazione dei congressisti, attraverso l’invito alla pacificazione tra le generazioni che il dramma della guerra civile ha diviso.
La posizione dei sei deputati missini in Parlamento suscitò perplessità e polemiche che vennero messe a tacere dalla Dirigenza del Partito che, sulla “Rivolta Ideale”, precisò che “essendo l’estrema sinistra occupata dagli uomini di Togliatti, per logica coerenza, gli uomini del Movimento Sociale non potevano, se non collocarsi all’opposto di questi”.
Nella mattinata del 14 luglio Palmiro Togliatti viene colpito da tre colpi di pistola, sparati a distanza ravvicinata mentre esce da Montecitorio in compagnia di Nilde Iotti. L'autore dell'attentato a Togliatti è un giovane simpatizzante di estrema destra, iscritto al Partito Liberale, Antonio Pallante. I proiettili, sparati da una pistola calibro 38, colpiscono il leader del PCI alla nuca e alla schiena, mentre una terza pallottola sfiora la testa di Togliatti. Nelle ore in cui si attende l'esito dell'intervento si diffondono le più diverse voci sullo stato di salute del Segretario del PCI: circola addirittura la notizia della sua morte. Il clima politico del paese è caldissimo. Poche ore dopo l'attentato si verificano incidenti a Roma e morti a Napoli, Genova, Livorno e Taranto nel corso di violentissime manifestazioni di protesta. Il Paese sembra sull'orlo della guerra civile.
Anche a Modena vi furono momenti di tensione notevole. Le strade della città erano percorse, in un clima surreale, da pattuglie della polizia e dai gruppi dell’estrema sinistra. La maggioranza delle persone restava chiusa nelle proprie case. L'operazione a Togliatti andò a buon fine e, si dice che, il dirigente del Partito Comunista Italiano, impose ai suoi luogotenenti, Secchia e Longo, che diressero il Partito in quei drammatici momenti, di fermare la rivolta. L'insurrezione di massa delle organizzazioni militanti e militari comuniste si arresta, ma tutti sono convinti che abbiano contribuito a moderare gli animi e superare quella crisi, le imprese di Gino Bartali, al Tour de France.
L’anno 1949 mi vedeva, all’inizio, ancora impegnato con la congregazione dei Frati Cappuccini di Via Ganaceto e con la partecipazione alle varie manifestazioni condotte dai “Terziari Francescani”. Partecipai difatti, come delegato modenese, assieme al Dott. Carlo Luppi, al Congresso Nazionale che si tenne a Maggio al convento dei Francescani di Frascati.
Gradualmente mi avvicinai, come raccontato nel capitolo “Rossi o Neri”, al raggruppamento Giovanile chiamato “Giovane Italia” del Movimento Sociale Italiano, dove mi iscrissi nel Novembre di quell’anno.
Nel frattempo, dal 28 Giugno al 1° Luglio, si era tenuto a Roma il 2° Congresso del MSI, che vide rinnovarsi il confronto tra le posizioni di sinistra che tendevano ad orientare il Partito in senso più sociale e le posizioni moderate. Le due fratture sostanziali, all’interno del MSI si evidenziarono nella posizione dei “moderati”, Arturo Michelini, Augusto De Marsanich, Nino Tripodi che desideravano l’unione delle forze nazionali in funzione anticomunista; anche i “traditori monarchici e badogliani” potevano tornare utili nella lotta al comunismo, così come sul tema dell’Alleanza Atlantica (NATO) questo schieramento era decisamente favorevole; a sinistra, Giorgio Almirante, Giorgio Pini, Concetto Pettinato, Domenico Leccisi e altri dichiararono che coloro che rimasero fedeli a sé stessi durante la RSI, non erano, e non sono, gente di destra e quelli che concepiscono il partito in esclusiva funzione anticomunista, conservatrice e reazionaria non fanno parte della famiglia del MSI, così come schierarsi a favore del Patto Atlantico non può essere accettato dato che, non è possibile essere “alleati e vinti” nello stesso tempo.
Queste due anime del partito saranno sempre presenti nella storia del Msi seppure con alcune varianti e in molte zone, Modena compresa, con grosse conflittualità.
Ma il successo del Movimento Sociale Italiano arrivò, sia a Modena che in tutta Italia, con la grandissima partecipazione giovanile. I giovani che non avevano fatto la guerra diedero un’entusiastica adesione alle organizzazioni del RGSL (Raggruppamento Giovanile Studenti e Lavoratori) fondato a Roma il 12 Marzo 1949 dall’esuberante deputato, ex combattente di “Bir El Gobi”, Roberto Mieville.
L’anno successivo, il 21 Maggio 1950, si diede corpo all’organizzazione degli studenti Universitari con la costituzione del FUAN (Fronte Universitario di Azione Nazionale), mentre, due mesi prima il 24 Marzo, si era costituita la CISNAL (Confederazione Italiana Sindacato Nazionale Lavoratori) guidata dall’On. Gianni Roberti.
Si andavano così delineando, sul territorio nazionale, tutte le strutture che costituivano l’ossatura portante del Partito. La Cisnal a Modena ebbe sede, inizialmente in Via Cesare Battisti, in seguito in Via Canalino con alla guida, il sindacalista Cesare Piccinini poi, Giuseppe Grasso.
Dei personaggi modenesi incontrati in quei lontani anni ne ricordo alcuni e mi spiace se non riesco a ricordare tutti.
Uno dei fondatori e dirigente del Msi è stato il Rag. Giorgio Fabbri, Segretario del Partito per un certo tempo e collaboratore del quotidiano “Il Secolo d’Italia”, noto assicuratore, ha sempre dato, anche negli anni a seguire, la partecipazione attiva al Partito assieme alla grande esperienza sempre unita alla sua proverbiale bontà d’animo.
Il Prof. Amerigo Ansaloni è stato Segretario del Partito nei primi anni cinquanta lasciando un ricordo indimenticabile della sua personalità; il Professor Ansaloni divideva la sua passione per la politica con l’attività professionale: aveva in centro storico, precisamente in Via Università un negozio di arte dove si confezionavano cornici di pregio e commerciava oggetti d’arte di valore.
Uomo dotato di un carattere aperto e bonario, lo trovavi sempre disponibile, in modo particolare quando i giovani avevano bisogno di consigli e aiuti che venivano dettati da una “umanità” e conoscenza dei problemi della vita, non indifferenti.
|
|
Novembre 1951 Inaugrazione della sede del MSI in Via Cesare Battisti 14 I Dirigenti: Prof. Amerigo Ansaloni. Sig,na Lina Grandi, Avv. Gino Mori |
Il Prof. Francesco Zambrano, insegnante di lettere all’Istituto
Magistrale Sigonio, grande dantista e latinista, uomo di fede dotato di
notevole senso di responsabilità anche nei momenti difficili della vita
del Partito, sapeva sempre creare attorno a sé unanimità d’intenti che
portavano a stemperare anche scontri accesi e apparentemente insanabili.
 |
11950 IN PIAZZA MATTEOTTI IL PROF, FRANCESCO ZAMBRANO PRESENTA AI CITTADINI MODENESI I L SEGRETARIO Nazionale del MSI Giorgio Almirante |
Nino Saverio Basaglia si può dire sia stato un “faro” per molti giovani
modenesi. Uomo di fede adamantina, con il suo “pizzetto” e la sua figura
“carismatica”, sapeva cogliere le istanze giovanili in modo lucido e
razionale. Sindacalista pieno di “verve”, dotato di vasta cultura,
scrittore, giornalista, combattente in Albania sul Monte Kosica con le
Camicie Nere modenesi, aveva attraversato tutti i momenti pù difficili
del periodo della Rsi, riusciva sempre ad instaurare un rapporto di vero
“cameratismo” specialmente con i giovani, dando loro quella “sicurezza”
necessaria anche nei momenti più difficili.
L’Avv. Gino Mori, primo Consigliere Comunale del MSI della nostra città,
per la signorilità, compostezza, rettitudine che lo distinguevano, seppe
conquistare le simpatie e il rispetto anche degli avversari, in quella
difficile arena nella quale venne a trovarsi. I suoi interventi in
consiglio comunale furono sempre apprezzati per il suo senso di
moderazione e di civiltà.
L’Ing. Bruno Rivaroli, uomo partito: vivacissimo, piccolo e minuto ma
carico di energia, i suoi interventi nelle riunioni in sede, nei
tantissimi anni di sua militanza (si è spento alcuni anni or sono quando
ne aveva compiuti novanta), avevano sempre un aspetto e un contenuto
significativo per tutti i presenti. Aveva avuto un ruolo importante in
quel di Pavullo durante il periodo dei “Seicento Giorni”,
contraddistinto anche da polemiche, durante e dopo, sia con gli
avversari politici che all’interno dello stesso MSI. Fu per lunghi anni
Consigliere Provinciale, dove si confrontò sempre ad armi pari con la
“marea” di comunisti, socialisti e democristiani, che doveva affrontare
in memorabili battaglie.
La Sig.na Lina Grandi, responsabile del settore femminile del MSI ebbe
un ruolo rilevante nei direttivi dei primi anni del partito a Modena. Ha
curato con competenza e sacrificio la ricostruzione degli schedari dei
Caduti della RSI in territorio modenese, dirigendo la sezione
dell’Associazione Nazionale Caduti e Dispersi della RSI, curando inoltre
la sistemazione, al cimitero di San Cataldo, del piccolo sacrario dei
Caduti.
Assieme a Lei ha seguito, con particolare competenza e partecipazione
quel settore, il Rag. Fabio Rebucci, fratello di un caduto Repubblicano,
ucciso dai partigiani di Moranino, nell’efferato eccidio delle carceri
di Novara nell’immediato dopoguerra.
Dei primi anni di vita del Movimento Sociale Italiano a Modena ricordo
ancora il Dott. Vincenzo Marino e l’Ing. Gianfranco Bacchi, fratello di
Annamaria, uccisa dai partigiani pochi giorni prima della fine della
guerra, il Prof. Mario Ciulla, il Prof. Primo Guerzoni di Mirandola,
Manfredo Garuti, Fausto Greco, Brenno Moretti, Enzo Beltrami, Nino
Gualtieri, Libero Todaro; di molti altri si avrà modo di ricordarli man
mano che procede il racconto.
Erano anni di difficoltà e contrasti interni al partito, di non poco
conto. Ci fu un momento in cui non si riusciva ad eleggere il Segretario
Provinciale e da Roma fu inviato un Commissario Straordinario, che resse
la Federazione per circa un anno, Franco Dragoni. Era, come si suol
dire, un “fegataccio”, non aveva difficoltà ad esporsi in prima persona,
anche perché proveniva da esperienze romane di quelle “toste”.
Gli inizi degli anni ’50 furono, per il Raggruppanto Giovanile del MSI
pieni di attività. Le manifestazioni studentesche per Trieste Italiana,
erano sempre seguitissime. I numerosi e “vivaci” cortei; per il centro
di Modena, guidati dagli Universitari del Fuan e dagli studenti medi
della “Giovane Italia”, riuscivano a portare migliaia di studenti
dell’Università e delle scuole medie superiori, al canto di inni
nazionali e con lo sventolio di innumerevoli bandiere tricolori, a
percorrere quelle strade del centro storico che, negli anni settanta
videro invece sfilare gli studenti modenesi al seguito delle “bandiere
rosse” e vietnamite.
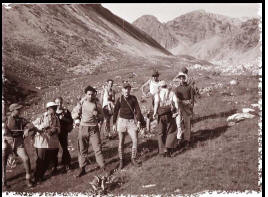 |
11951 Modenesi al Campeggio della Giovane Italia nel Parco Nazionale d'Abruzzo |
Ricordo che ad una di quelle manifestazioni del 1951, il corteo degli
studenti venne bloccato dalla polizia e dirottato per strade diverse da
quelle programmate; di solito si percorreva la Via Emilia per concludere
la sfilata al Monumento dei Caduti sui viali del parco cittadino. Quel
giorno i gruppi si dispersero per Via Università e nelle strade
adiacenti, per ricompattarsi di nuovo sotto i portici del Collegio.
Proprio in pieno centro, tra il bar Molinari e l’edicola della “Rosina”,
si venne a trovare il questore (uomo di piccola statura e grassottello)
contornato da numerosi agenti di polizia. All’improvviso, dal gruppo
degli studenti, si alzò un coro: “Lo sai che i papaveri sono alti alti
alti e tu sei piccolino e tu sei piccolino….” (era l’anno della canzone
di Nilla Pizzi al Festival di San Remo): La “presa in giro” degli
studenti non piacque al questore che ordino una carica violentissima
sotto al Portico del Collegio, con le camionette della “Celere” che
facevano evoluzioni “pazzesche” tra le colonne dei portici e la Via
Emilia, con i tavolini e le sedie del bar Nazionale che volavano da
tutte le parti e con gli studenti che o si rifugiavano nelle stradine
laterali dentro ai portoni o si “aggrappavano” alle colonne e ai
“fittoni” del Portico ove solitamente si era soliti passeggiare per lo
“struscio”. I manganelli e gli “sfollagente” dei poliziotti, roteavano
sulle schiene e sulle teste dei giovani che avevano “osato” schernire
l’autorità costituita.
Lo scrivente di queste note organizzava le manifestazioni all’interno
dell’Istituto Barozzi, nella maggior parte quegli scioperi partivano
proprio da quella scuola, poi ci si recava davanti al Liceo Scientifico
“Tassoni”, al Liceo Classico “Muratori”, all’Istituto Magistrale,
all’Istituto Corni e al Liceo d’Arte “Venturi” a cercare di far uscire
dalle aule quelle scolaresche. In alcune circostanze mi capitò di
“prelevare”, dall’ufficio di Presidenza, la bandiera tricolore, con il
Preside, Prof. Mario Negri, che mi rincorreva per i corridoi del vecchio
convento di Corso Cavour dove si trovava allora il “Barozzi”, poiché non
gradiva quel primo tipo di “esproprio”. Era ovvio che al termine della
manifestazione il tricolore ritornava al suo posto, magari attraverso la
consegna ai bidelli e non al Capo d’Istituto, per ragioni comprensibili.
Noi avevamo la soddisfazione, mentre sfilavamo per le strade della città
di ricevere il plauso e il saluto di tanti cittadini che, al passaggio
del tricolore, si sentivano in dovere di segnalare il loro gradimento
partecipando in quel modo al nostro entusiasmo.
Il 10 e 11 Giugno di quell’anno, partecipai al raduno dei Bersaglieri a
Gorizia; andai con un gruppo di reduci, cercando di rappresentare e
onorare il “piumetto” di mio fratello che, Ufficiale del 3° Reggimento
Bersaglieri, non era tornato dai campi di concentramento sovietici. Fu
una giornata di vibrante italianità e mi resi conto del dramma che
stavano vivendo quelle popolazioni. Gorizia era divisa a metà, una parte
italiana, l’altra jugoslava. Entrai in una casa dove sui pavimenti,
segnato da una grossa striscia rossa, vi era il confine, se valicavi
quella linea ti trovavi in territorio Yugoslavo con tutte le conseguenze
che potevi correre. Era un clima allucinante e assurdo.
Si andava, in quei primi mesi del 1951, in giro frequentemente per
comizi e ad ”attaccare” manifesti elettorali sui muri della città;
frequentemente ci si “scontrava”, più spesso a parole, ma qualche volta
anche con brevi tafferugli, in modo particolare con i “rossi”. Era
normale che si facessero le “ore piccole”, logicamente la mia attività
sportiva e le mie lezioni scolastiche subivano pesanti “contraccolpi”.
Il 10 Giugno ci furono, sul nostro territorio, le elezioni
amministrative alle quali partecipò, per la prima volta, anche il
Movimento Sociale che ottenne un buon successo conquistando, con 2.153
voti, il 3% ed eleggendo il primo Consigliere Comunale nella figura
dell’Avv. Gino Mori.
Gli altri partiti si attestarono sui seguenti valori: Area di sinistra:
PCI 32.427 voti con il 44,6%, il PSI il 7,8% l’IS il 2,1%. L’area di
centro vide la DC al 30,8%, il PSULI lo 7,8%, il PLI il 2,7% e il PRI lo
0,7%. Si presentò anche il PNM (Partito Nazionale Monarchico) che
ottenne lo 0,5%.
Partecipai, sempre in quell’anno, al campeggio organizzato dalla Giovane
Italia al Parco Nazionale d’Abruzzo, nelle vicinanze di Villetta Barrea,
splendida località inserita in una natura bellissima, tra il Monte Meta
e la “Camosciara”, con l’orso marsicano sempre nelle nostre vicinanze,
ci fece visita notturna alcune volte, ripulendo i pentoloni con i resti
della nostra cena. Erano con mè altri modenesi, Carlo Luppi, Libero
Todaro, Franco Casolari, Carlo Poppi e Libero Lolli. Furono quindici
giorni splendidi, anche perché quelle furono le prime “vere vacanze” che
riuscivo a fare. Quando lessi, a distanza di tempo, che il Msi
organizzava, in terra d’Abruzzo, campeggi paramilitari, restai
esterrefatto. Ma dove? Ma quando? La mia esperienza con i “camerati”
romani fu di tutt’altro tipo. Si cantavano sì, canzoni nostalgiche
assieme agli struggenti cori alpini, la sera attorno ai fuochi, si
discuteva anche di politica, ma la nostra vita quotidiana trascorreva,
tra escursioni agli splendidi monti che ci circondavano con camminate
che duravano ore e ore, e la preparazione del cibo: occorrevano circa
due ore di cammino per raggiungere il paesino di Villetta Barrea e fare
i nostri rifornimenti. Mai, dico mai, ho avuto il sentore della presenza
di armi e nemmeno di proposte a compiere esercitazioni paramilitari. La
nostra era, una dimensione puramente cameratesca e sportiva.
Il 6 Novembre vi fu l’inaugurazione della sede del Msi in Via Cesare
Battisti, finalmente locali abbastanza ampi. A quei tempi, la sede era
frequentata da tantissimi giovani, studenti e lavoratori e, in quell’ambiente,
ebbi la possibilità di crearmi delle buone amicizie, non solo sul piano
politico, ma fondamentalmente su quello umano. Cito coloro che mi
vengono alla memoria: di tanti avrò modo di parlarne in questo mio
ricordo della vita del movimento sociale dei primi tempi: il Prof.
Franco Bartolamasi, il Dott. Gianpaolo Manzini, il Prof. Pietro Cerullo,
il Dott. Gianni Calabrese, l’Avv. Adriano Sciascia, Sergio Bacchi, Nino
Gualtieri, l’Avv. Leopoldo Parigini, Erio Pellicciari, Giancarlo
Monducci, Arturo Messerotti, Sergio Franchini, Enzo Cavazza di Carpi,
Trentini Rodolfo di Pievepelago, Dino e Rosanna Orsi di Carpi, Manfredo
Garuti, Vittorio Ledi di Carpi, Otello Rovatti, Dino Corradi, l’Ing.
Turno Sbrozzi e Alfredo “Dino” Ferrari, nato il mio stesso anno, il
1932, e che, di tanto in tanto, nonostante la sua già evidente
“distrofia muscolare”, frequentava la nostra sede ma che, per evidenti
ragioni, non era molto presente alle nostre azioni più “dinamiche”. Una
sola volta gli chiesi: “Ma cosa ne pensa tuo padre di questa tua
frequenza nel nostro ambiente?” mi rispose “che gli andava bene”. Quando
ne parlai con mia madre, che era stata amica della moglie di Enzo
Ferrari, ne uscì anche un piccolo “gossip” che allora non mi interessava
più di tanto.
Il 17 novembre 1951 il principe Junio Valerio Borghese aderisce al Msi,
che dirama in proposito un comunicato con il quale saluta "con senso
commosso di orgoglio" l’ingresso di Borghese nel partito, affermando:
"L’atto del Comandante probabilmente altro non fa che dare crisma di
ufficialità a quella comunione di fede e di intenti che ha sempre legato
il Partito all’Eroe; ma non è per questo meno importante ed indicativo
agli effetti politici e morali… ".
La vita al partito andava avanti, per il sottoscritto, con alterne
vicende poiché avevo frequenze attive in altre compagnie, di conseguenza
la mia presenza non era costante. Sempre nel 1951, agli inizi di
Settembre vi fu uno scontro con i comunisti. Uscivamo da una serata a
casa dell’Avv. Araldi, non ricordo se in Via G. Guarini o in Via
Saragozza e, dopo cena, ci incamminammo per i viali cittadini in un bel
gruppetto, per una salutare passeggiata “digestiva” dopo la “mangiata”
di gnocco e salumi annaffiata da buon lambrusco: certamente vi furono
anche una serie di canti “nostalgici”, quando arrivammo in Viale
Berengario all’altezza circa di Via Voltone e di Via della Cerca, sbucò
all’improvviso un gruppo di comunisti armati di catene e spranghe. Ci
fronteggiammo in “cagnesco”, qualche spintone un po’ violento e qualche
cazzotto ci furono prima che arrivassero le camionette della polizia,
probabilmente avvertita da qualche cittadino, che misero termine alla
“vivace discussione” con alcuni fermi da entrambe le parti. Il giorno
seguente, sul quotidiano comunista, venne pubblicato un lungo articolo
che deprecava “la bravata notturna” dei soliti fascisti, con
argomentazioni che niente avevano a che vedere con la realtà di quell’episodio.
Nel 1952, a L’Aquila, dal 26 al 28 Luglio si svolse il terzo Congresso
del MSI con la guida del Segretario Nazionale Augusto De Marsanich, che
aveva sostituito Giorgio Almirante.
Già prima, all’interno del vertice del partito, si era creata notevole
tensione per il rifiuto della corrente di sinistra ad accettare
l’intensificarsi dei contatti con la destra monarchica e democristiana;
vi fu anche una piccola scissione dei quadri piemontesi con la
costituzione di un Gruppo Autonomo Repubblicano. Il grosso successo del
Partito alle elezioni amministrative diede la possibilità di contenere
gli scontri tra “falchi e colombe” e la sinistra, pur avendo avuto al
Congresso, una vittoria sostanziale, si vide costretta ad accettare e ad
abbozzare le posizioni “filo-atlantiche” dei moderati.
Il 1953 fu l’anno del consolidamento su tutto il territorio nazionale
del Movimento Sociale Italiano che ottenne, alle elezioni del 7 Giugno
un notevole successo elettorale; alla Camera 1.582.567 voti pari al 5,8%
portando in parlamento 29 Deputati , e a1.473596 voti pari al 6,0% al
Senato dove entrarono 9 Senatori. A Modena la battaglia elettorale fu
accesissima, striscioni per le strade, manifesti su tutti i muri,
volantini che ricoprivano letteralmente le strade, comizi ad ogni angolo
di strada, tutto il partito, in modo particolare il Raggruppamento
Giovanile, fu tenuto, per alcuni mesi, decisamente “sotto pressione”.
La posizione del Msi in questa tornata confermò, in parte, le elezioni
amministrative del ’51; con 2.215 voti pari al 2,8%. Sempre a destra si
presentarono anche i monarchici che, con 994 voti ottennero lo 1,3%.
Discreto il successo dei partiti di centro con la DC che raggiunse il
suo massimo storico con il 32,0% e 24954 voti, lo PSDI 5.314 voti con il
6,8%, il PRI 441 voti e lo 0,6% e il PLI al 2,4%. L’area di sinistra
subì un netto ridimensionamento, con il PCI “ridotto” al 41,5% con
32.445 voti, il PSI con voti 7.160 e il 9,6% e l’UP 1303 voti pari al
1,7%.
Il 5 marzo 1953 muore Giuseppe Stalin. A Modena i “rossi” inscenarono
una veglia funebre. Ricordo che alla Camera del Lavoro, in Via San
Vincenzo angolo Via Modonella, era stata allestita una camera ardente
con la fotografia del defunto e con la folla comunista in “adorante”
processione a portare l’estremo saluto al “sanguinario” dittatore russo.
Ovviamente a destra vi era un clima completamente opposto, però non
andarono “in scena” quelle manifestazioni che molti giovani della
“Giovane Italia” avrebbero voluto allestire. Certo, pensare a come gli
italiani avevano trattato il “loro” dittatore a Piazzale Loreto e vedere
come invece osannavano il defunto “baffone”, senza conoscere le
devastanti conseguenze che il comunismo aveva portato nella stessa
Russia, non poteva essere accettato dagli uomini che si erano battuti
contro il “moloch” moscovita.
La “rossa” Modena sembrava dovesse ridimensionarsi su posizioni più
vicine alla media nazionale, ma fu una “pia illusione”. Obiettivamente
la situazione della destra modenese era, in quegli anni, abbastanza
positiva; la massiccia presenza di giovani faceva ben sperare nel futuro
ma, come sempre accade per i giovani, l’inserimento nella vita
lavorativa con i problemi familiari che man mano emergono, con le
situazioni economiche personali, nella maggior parte dei casi difficili,
tanti di questi, con il passare degli anni affievolirono la loro
tensione ideologica e si emarginarono gradualmente; molti passeranno
anche sull’”opposta sponda”.
I Segretari del partito e le Direzioni che man mano si avvicendavano
alla guida del MSI, in Provincia di Modena, si trovarono sempre ad
affrontare difficoltà quasi insormontabili. Benefici economici non
c’erano, anzi spesso si dovevano fronteggiare certe situazioni, di
“tasca propria”, le “sovvenzioni” di qualche privato non erano
sufficienti, le conflittualità interne sempre attuali, la “pressione”
pesante dei “sinistri” che dominavano e dominano ancora il territorio,
oltre a tante frange di area democristiana e clericale, non davano quel
margine di “sicurezza” per gestire un partito politico in quelle
particolari condizioni. Bisogna dare atto a tutti coloro che si sono
impegnati nell’”area di destra”, di aver avuto il coraggio morale e
civile di affrontare una difficile battaglia in anni irti di ostacoli,
che vanno dal 1950 al 1990.
Il 4° congresso del Msi, si tenne nei primi giorni del 1954, da 9 all’11
Gennaio, a Viareggio.
Le varie anime che costituivano, sia a Modena, che in tutta Italia
l’ossatura del MSI, si scontrarono nuovamente al Congresso, nella
splendida località della Versilia, dove, ai lavori congressuali furono
presentate tre mozioni; quella di maggioranza: “Per l’Unità del
Movimento” alla quale aderisce anche Giorgio Almirante, su posizioni
atlantiste e favorevoli alla collaborazione con il PNM, disponibili
inoltre alla contrattazione parlamentare; la mozione di “ sinistra” con
la presenza di uomini quali Bruno Spampanato, Giorgio Bacchi,
Palamenghi-Crispi e chiamata “Per una Repubblica Sociale” ed una terza
mozione che rappresentava le istanze del “Raggruppamento Giovanile
Studenti e Lavoratori” con alla testa, Pino Rauti, Enzo Erra e Pino
Romualdi, che sostenevano la tesi che “sia il marxismo che il
capitalismo sono i nostri mortali nemici in quanto rappresentano in
pratica la stessa concezione di vita che è inconciliabile con quella che
anima le nostre idee”. Nella mozione finale si troverà un
“aggiustamento” in modo da poter far entrare in Comitato Centrale tutte
le componenti, saranno in 66 quelli del gruppo “centrista”, in 31 quelli
di “sinistra” mentre i restanti 22 andranno al gruppo di Rauti e
Romualdi.
Alla fine vi fu soddisfazione da parte di tutti poiché si videro, in
parte, superate le incertezze e le preoccupazioni sorte nei precedenti
Congressi, sentendo di aver conquistato, anche sulla base dei positivi
risultati elettorali, legittimità e cittadinanza politica. In
conseguenza a questa situazione, durante il mese di ottobre del’54, il
Segretario del Partito Augusto De Marsanich passerà le consegne a quell’abile
mediatore e tessitore di alleanze che è stato Arturo Michelini che
reggerà le sorti del MSI per un lungo periodo, sino al 1969.
Personalmente, negli anni dal 1953 al 1956, frequentando l’Isef romano,
durante i mesi invernali, e lavorando in quelli estivi, presso
l’Istituto Autonomo delle Case Popolari per potermi sostenere le spese
degli studi, non ebbi molto tempo da dedicare al partito; molti episodi,
specialmente della vita modenese, li imparavo a distanza di tempo, o
dalla lettura dei giornali, o da qualche rara comunicazione da parte
degli amici rimasti a Modena. Una delle ultime mie partecipazioni, di
quel periodo, avvenne il 4 Novembre 1954 quando, con un gruppetto di
modenesi si partecipò, a Trieste, all’immensa manifestazione di
patriottismo che vedeva ritornare quella città sotto la giurisdizione
italiana. Dopo tutti gli scioperi e le manifestazioni studentesche alle
quali avevo partecipato negli anni precedenti per cercare di ottenere
questo risultato, mi pareva opportuno essere presente, quel giorno,
assieme a centinaia di migliaia di italiani, a quella grande festa
Tricolore.
Un’altra imponente manifestazione, alla quale partecipai, trovandomi in
quel periodo a Roma, fu quella dei grandiosi funerali del Maresciallo
d’Italia Rodolfo Graziani che era deceduto l’11 Gennaio 1955.
|
|
1956 Alla Tomba di Gabriele D'Annunzio a Gardone Giovani modenesi |
Le elezioni amministrative del 1956 diedero un ottimo risultato al MSI
che al Comune di Modena conquistò , con 3.455 voti il 4,3% e due seggi;
gli alti partiti ebbero questi risultati: PLI 3.354 4,1%; PSDI 6.752
voti e il 7,8%; la DC con 22.965 voti il 28,4%; il PS 9.178 voti
l’11,4%; il PCI con 35.158 voti ottenne il 43,45%.
A Modena, in quegli anni, si verificarono due episodi dei quali venni a
conoscenza a distanza di tempo e cioè di un tentativo fatto, si diceva,
da due militanti di destra, di incendio alla sede dell’Anpi e
dell’esplosione di un ordigno alla redazione modenese dell’”Unità”; per
quest’episodio venne “fermato” un giovane missino.
A fine Ottobre 1956 inizia la rivolta Ungherese, che verrà repressa nel
sangue dai carri armati russi. Vi furono decine di migliaia di morti e
tutto il mondo rimase sbigottito dalla ferocia dei sovietici, i quali,
chiamati dai comunisti ungheresi che si vedevano sfuggire di mano il
loro potere, appoggiati dall’Internazionale comunista e dal Partito
Comunista Italiano soffocarono brutalmente quell’audace tentativo di
ribellione. Grosse responsabilità vi furono da parte di certo mondo
occidentale che, in precedenza, attraverso le radio in lingua ungherese,
dichiaravano che il: “così detto mondo libero” era pronto a dare tutto
l’aiuto possibile a sostegno dei “rivoltosi” La contemporanea azione
anglo-francese contro gli egiziani, la chiusura del Canale di Suez e la
conseguente grave crisi internazionale, fu la causa, almeno apparente,
dell’abbandono, al loro tragico destino, del popolo ungherese.
A distanza di cinquanta anni, i “capoccioni” rossi nostrani, che allora
non presero le distanze, anzi applaudirono l’intervento sovietico, si
sono dimostrati “pentiti” di quanto successo allora e sono andati in
“pellegrinaggio” a portare corone di fiori e “lacrime di coccodrillo”
sui luoghi dello sterminio del popolo ungherese
A Modena, come in tutte le città italiane, i giovani di destra non
persero l’occasione per dimostrare la loro rabbia e il loro disgusto
verso l’intervento russo, ma in particolare contro l’appoggio
incondizionato dei comunisti nostrani a tanta barbarie. Sfilate per la
città, bandiere rosse trascinate nella polvere e bruciate davanti alla
sede del Partito Comunista in Via Ganaceto. I “rossi” non muovevano un
dito, nascosti nelle loro “tane”, non si vedevano in giro, nemmeno i
rari personaggi che, in quei giorni, presero le distanze
dall’interventismo “togliattiano” e da tutto il suo “entourage”.
Raggiunsero la nostra città alcuni ragazzi ungheresi che riuscirono a
fuggire dalla loro Patria, accolti da alcune organizzazioni modenesi;
ebbi modo di conoscerne alcuni; ci raccontarono episodi di
un’incredibile efferatezza commessi, non solo dai “padroni” sovietici,
ma dai comunisti ungheresi, che protetti dai carri armati, stavano
riprendendo il potere.
Pochi giorni dopo quei fatti, dal 24 al 26 Novembre, si svolse a Milano
il 5° Congresso del MSI, che vide l’ultimo forte attacco della
“sinistra” alla dirigenza”moderata”. Vi furono forti tensioni e
“scontri” tra le varie fazioni. Vi sarà un “compromesso dell’ultimo
minuto, merito e del cedimento di Arturo Michelini sulla maggioranza dei
punti in discussione e dal ritiro di un emendamento di Giorgio Almirante
sull’alleanza con i monarchici, che porterà ad una votazione unitaria
sulla mozione finale. Vi fu anche l’uscita dal Partito da parte di
alcuni componenti il grupp orautiano di “Ordine Nuovo”.
|
|
L'On Pino Romualdi alla tribuna di un comizio del MSI tenutosi al Cinema Odeon nel 1959 |
Un grosso successo politico, per la Segreteria Michelini, fu quello,
durante il Governo di Adone Zoli, per il trasferimento a Predappio, il
30 Agosto 1957, della salma di Benito Mussolini.
L’inserimento, nella vita politica nazionale, del MSI raggiunse il suo
obiettivo contribuendo con i suoi voti all’elezione per la Presidenza
della Repubblica, di Giovanni Gronchi e sostenendo, in alcuni casi, i
Governi Pella e Segni. Questa posizione, che allontanò dal Partito la
parte “antisistema” e l’allontanamento di alcune figure carismatiche,
comporterà un costo elettorale al MSI. Difatti, alle elezioni politiche
del 1958 vi sarà un lieve calo, avendo ottenuto alla Camera, 1.407.919
voti pari al 4,7% con l’elezione di 24 Deputati e 1.149.000 voti , pari
al 4,4% al Senato con l’elezione di 8 Senatori.
Al Comune di Modena il MSI ebbe il 3,18% pari a 2.791 voti. Gli altri
partiti: PCI, 40,33% con 35.3505 v oti,
lala DC il 30,58% con
voti 26.810; i socialisti PSI ottennero 12.188 voti e il 13,90%; il PLI
3.269 voti e il 3,18%.
Home page