Al termine degli studi superiori, diploma di Geometra ottenuto nella sessione estiva del 1953, quando ancora l’esame di stato terrorizzava tutti i “maturandi” e quando l’ottenere la promozione a Luglio era un’eccezione, (nella mia classe composta da trentacinque alunni, cinque, compreso l’estensore di queste note, furono promossi nella sessione estiva e gli altri mandati ad ottobre o bocciati), mi trovai ad un bivio. Proseguire l’attività professionale relativamente agli studi appena conclusi o continuare?
Quello che era stato il percorso scolastico di mio fratello, che aveva frequentato l’Accademia di Educazione Fisica (allora “tout court” La Farnesina), non conclusa a causa della guerra, mi aveva sempre affascinato, se non condizionato.
Sarebbero stati altri tre anni di grandi sacrifici per i miei genitori; sobbarcarsi il mantenimento agli studi e in più lontano da casa, non era facile. Fortunatamente si presentava la possibilità di avere (come poi riuscii ad ottenere) la borsa di studio del Coni, in quanto erano appena stati riaperti i corsi di studio all’Istituto Superiore di Educazione Fisica, dopo la lunga sosta causa la guerra e il dopoguerra, essendo stata, l’Accademia Fascista di Educazione Fisica un’istituzione del regime, la sua epurazione durò a lungo, solamente nel 1952 venne riaperta e nel contempo si vollero incentivare i giovani alla professione di insegnante di E. F anche attraverso aiuti economici ai bisognosi e ai meritevoli.
Si pensi che la retta mensile, per il vitto e l’alloggio alla Foresteria Sud del Foro Italico, ammontava a trentamila lire, ma con la borsa di studio più favorevole, vi era una serie di gradazione, potei soggiornare a Roma con la cifra di cinquemila lire, che oltre alle mie spese quotidiane, il vestirsi, i libri, il prezzo del biglietto del treno per i viaggi Modena–Roma andata e ritorno, era pur sempre, per la mia famiglia un impegno economico gravoso, che riuscii a mitigare con il lavoro che svolgevo durante i mesi estivi, in qualità di Geometra presso l’Istituto Autonomo Case Popolari, dove venni assunto, come si dice oggi, a tempo determinato, per tre anni, come assistente tecnico ai cantieri edili; gran parte del tempo del mio impegno in quell’Istituto, venne dedicato alla costruzione delle Case Popolari di Via Bonacini e di quelle del chiamato allora, “rione Corea”.
Gli amici di mio fratello in particolare Franco Anderlini e Fernando Ponzoni mi “supportarono” presso i miei genitori, per far sì che si potesse esaudire questo mio desiderio.
Dopo un severissimo esame di ammissione, 50 ammessi su circa 300 candidati, entrai in quell’agognato Istituto Superiore di Roma assieme ad altri tre colleghi modenesi, due amici di compagnia e di studi, Germano Morandi e Sergio Zanasi e il terzo proveniente dall’Istituto magistrale “Sigonio” e “grande” giocatore di pallavolo, Oddo Federzoni.
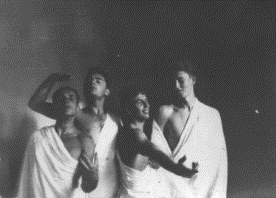 |
1954 I quattro modenesi all'ISEF di Roma
Germano Morandi, Bruno Zucchini, Sergio Zanasi, Oddo Federzoni. |
 Durante gli anni all’Istituto J. Barozzi, continuai, con fasi alterne, a
frequentare la Società Sportiva Fratellanza sotto la guida di “Pirein”
Baraldi. Le mie specialità erano il salto in lungo e la velocità, 80,
100 e 200 m. con unica eccezione, una gara sui 400m ad ostacoli a
Bologna durante i Campionati di società, dove l’allenatore, in quanto
avevo un buon passaggio sull’ostacolo, in sostituzione del titolare
ammalato, mi fece fare quella “durissima” prova, che terminai
dignitosamente, pur abbattendo gli ultimi due ostacoli, in un tempo,
1’07”, che per un principiante non era del tutto male.
Durante gli anni all’Istituto J. Barozzi, continuai, con fasi alterne, a
frequentare la Società Sportiva Fratellanza sotto la guida di “Pirein”
Baraldi. Le mie specialità erano il salto in lungo e la velocità, 80,
100 e 200 m. con unica eccezione, una gara sui 400m ad ostacoli a
Bologna durante i Campionati di società, dove l’allenatore, in quanto
avevo un buon passaggio sull’ostacolo, in sostituzione del titolare
ammalato, mi fece fare quella “durissima” prova, che terminai
dignitosamente, pur abbattendo gli ultimi due ostacoli, in un tempo,
1’07”, che per un principiante non era del tutto male.
Anche sulla velocità, pur avendo vinto parecchie gare, quali il Gran
Premio Giovani e altre, mi trovai spesso a competere con altri ragazzi
più forti, quali il potente Giulio Reggianini, in seguito noto avvocato,
l’elegante e sciolto Vittorio Bargellini, poi valente imprenditore, il
futuro medico psicologo Giovanni Pedrazzi, forte ed elegante nella corsa
come l’altro velocista,Tosi.
In Fratellanza trovai tantissimi amici, alcuni con qualche anno in più,
come il mitico “Carlo Rinaldi” campione italiano di salto con l’asta e
nazionale di pallavolo, (quando, durante gli allenamenti allo Stadio
Braglia saltava lui, tutti si fermavano per seguire le sue splendide
evoluzioni sull’asticella) e in seguito stimatissimo collega
nell’insegnamento dell’Educazione Fisica. Subii anche la sua immane
tragedia quando, per un incidente stradale gli morì il giovanissimo
figlio minore, che era mio allievo, e atleta molto promettente, in una
prima classe al Liceo Scientifico “Tassoni” dove allora insegnavo.
In Fratellanza, in quegli anni, ebbi altri carissimi amici, allora
ottimi se non grandi personaggi dello sport e in seguito, uomini di
punta della vita sociale modenese.
Ne cito solamente alcuni, il forte quattrocentista “Jack” Bertolini, il
triplista Nando Romagnoli, il saltatore in alto e campione italiano, il
medico Giulio Magnoni, oltre all’altro potente quattrocentista, Franco
Squadrini poi medico anche lui, scusandomi con tutti gli altri che non
ho citato.
Il mio confronto con tanti forti atleti modenesi, essendo il
sottoscritto relativamente dotato da madre natura, mi ha messo a volte
in seria difficoltà come in occasione dei Campionati Studenteschi del
1951. Ero il favorito per la vittoria finale nel salto in lungo avendo,
in quel periodo raggiunto buoni risultati complessivi: tali campionati
si svolgevano in un pomeriggio di sabato, nel mese di Maggio, verso la
fine dell’anno scolastico, allo Stadio Braglia con la tribuna coperta
strapiena di studenti che tifavano rumorosamente per i loro coetanei
impegnati nelle gare e in particolare quelli che vedevano impegnati,
nella lotta per la supremazia sulle scuole di Modena e Provincia, il mio
Istituto “Barozzi” e il Liceo Tassoni. Per le varie specialità ogni
scuola presentava due atleti, nella mia si fece la selezione per trovare
il secondo per il salto in lungo, dato che il primo era occupato dal
sottoscritto.
La spuntò un certo Franco Bortolamasi che, al suo primo salto, fece
quasi la mia miglior misura di sempre, (eravamo attorno ai sei metri),
aggiudicandosi il merito di partecipare alla gara. Ma quel giorno mi
superò in bellezza, e arrivai nettamente dietro di lui. Mi misurai con
un grande atleta, che eccelleva in tutte le discipline, e per molti anni
fu campione d’Italia di pallavolo con la squadra della Ciam di Modena,
oltre a rivestire numerosissime volte la maglia della nazionale italiana
e in seguito insegnante di Ed. Fisica e carissimo amico collega.
La mia volubilità e la mia incostanza fecero molto spesso arrabbiare il
Prof. Agide Magnoni mio insegnante e responsabile del settore atletica
della nostra scuola. In alcune occasioni, sia per le gare sia per gli
allenamenti, dovette venire a casa mia (allora non c’era telefono
tantomeno i cellulari) a “prelevarmi” di forza poiché, o mi dimenticavo
dell’impegno, o mi trovavo a letto completamente “distrutto” per aver
passato la serata precedente a fare le ore piccole o nelle sale da
ballo, o in giro per comizi elettorali oppure a fare l’”attacchino” dei
manifesti politici.
Tutte quelle frenetiche attività non si conciliavano bene con lo sport e
nemmeno con lo studio, ma una volta entrato all’ISEF di Roma, mi
tranquillizai per cercare di fare in modo di uscire da quell’Istituto
Universitario, nei termini previsti dal regolare corso di studi e
quantomeno nel modo migliore per iniziare quella professione, alla quale
tenevo moltissimo, e che in seguito mi diede enormi soddisfazioni.
I tre anni a Roma passarono, tra l’immersione negli studi e
nell’intensissima attività fisica che svolgevamo nelle palestre e negli
stadi del Foro Italico (ex Foro Mussolini). Tantissimi furono gli
episodi, di un certo rilevo, che sottolinearono la vita in comunione di
giovani ventenni, in una splendida città come Roma e portati a svolgere
una sana vita sportiva oltre che di Studio.
La nostra vita si svolgeva con le attività fisiche tutte le mattine.
Tutti i pomeriggi si andava a frequentare le aule universitarie della
Facoltà di Medicina dell’Università romana, le nostre materie e i nostri
esami, almeno per le materie più importanti (anatomia, fisiologia,
costituzionalistica, psicologia, biologia) non variavano da quelle degli
studenti di medicina. Alcuni episodi divertenti, che ebbero come
protagonisti due dei modenesi frequentanti il Corso B dell’Isef,
suscitarono le simpatie dei colleghi e anche degli insegnanti, per la
goliardia, seppur provinciale, che ci portammo dalla nostra città.
Era il primo anno, anzi, erano i primissimi mesi di vita all’Isef. Le
giornate trascorrevano tranquille e monotone: vita di palestra e di
università tutti i giorni, alla sera rientro in Foresteria entro le ore
10. Il custode ”Sig. Felli”, gran brava persona, non transigeva. Le
domeniche, giorno finalmente di libertà, trascorrevano tra le visite
mattutine alle bellezze della città di Roma e i pomeriggi, a volte, in
qualche locale (più o meno “balere) a ballare per cercare di
“rimorchiare”.
Dato che, le “nostre ragazze”, le isefine, ci snobbavano, noi cercavamo
qualche “improbabile avventura” con le ragazze romane. Beh, in realtà
molti di noi, qualche conquista, l’hanno avuta. Successe che una
domenica, il sottoscritto ed il suo “compare” di tanti episodi, Germano
Morandi, riuscissero a strappare un incontro con due colleghe, che però,
dopo un paio d’ore trascorse a girovagare per Roma, dovettero rientrare
al “Tufello” (la località dove erano alloggiate le ragazze dell’Isef)
poiché il loro tempo di “libera uscita” stava per scadere.
Erano circa le 19,30, l’ora di cena in foresteria. I due pensarono bene
di fare uno strappo alla regola, (le finanze erano sempre scarse) e
restarono fuori a cena (era tra l’altro una delle primissime occasioni).
Trovarono una tipica trattoria romana dove, senz’altro, cenarono meglio
che in foresteria. Arrivò così l’orario del rientro; salirono
sull’autobus, il solito 32, per rientrare al foro Italico, quando,
passando per Via Nazionale, forse perché avevano bevuto un bicchiere di
Frascati in più, lessero un’insegna luminosa che diceva “Night Club
Nirvanetta”; uno sguardo rapido, un commento reciproco e alla prima
fermata i due scesero e s’incamminarono verso il “luogo della
perdizione”; entrarono che non erano ancora scoccate le ore 22. Il
locale aveva, ovviamente, appena aperto i battenti, sedute ai tavoli vi
erano solamente delle ragazze che, appena ci videro, ad un’ora così
insolita per loro, si precipitarono su di noi: incredibile, a quell’ora
due clienti!
Frastornati ne scegliemmo due, o ci scelsero loro, ed ebbe così inizio
una serata, veramente “indimenticabile”.
Si cominciò con il bere “qualche cosa” e poi, la musica, il sorriso
delle ragazze che ci sembravano bellissime, le promesse del “dopo”, il
vinello che avevamo bevuto a cena in trattoria, ecc. ci fecero perdere
completamente il senso della realtà.
Le ore fuggivano e il tavolo si riempiva sempre più di bevande, si
rideva, si scherzava ci solleticavano le proposte allentanti delle
ragazze e ciò che sarebbe accaduto alla chiusura del locale; intanto
arrivavano altri clienti e verso l’una e mezza, dopo lo “spettacolino”
al quale avevano partecipato anche le nostre due ragazze, ordinammo una
cenetta per quattro e al termine o durante, una bella bottiglia di
champagne. Verso le tre o le quattro le ragazze, così, tra una
chiacchera e l’altra, ci chiesero se eravamo sicuri di avere il danaro
per pagare tutto quello che avevamo consumato. Rimanemmo perplessi:
difatti dopo poco si avvicinò il gestore del locale e ci presentò il
conto “Parbleù” e chi aveva tanti soldi in tasca?
Il locale stava per chiudere, il gestore ci chiedeva di saldare il
conto, finalmente la situazione si sbloccò, al momento, quando al
Morandi venne in mente di aver appena ricevuto da casa un vaglia che
avrebbe senz’altro risolto il problema. Era però nella valigia, sopra
all’armadietto, nella camerata della Foresteria al Foro.
Il gestore “ascoltò” la nostra posizione: uno di noi doveva restare come
“ostaggio” mentre l’altro, il sottoscritto, fu accompagnato dalla
macchina del Nirvanetta (con sopra un grosso cartellone pubblicitario)
in Foresteria: ma come entrare alle 4,30 del mattino
 |
Allievi ISEF a Gubbio Da sinistra: Oddo Federzoni, GermanoMorandi, Bruno Zucchini,
|
Il custode non avrebbe aperto. Gettai allora un sasso o vari sassetti,
contro la finestra della mia camerata, finalmente qualcuno si svegliò e
con l’aiuto di un lenzuolo salii a prendere il vaglia nella valigia e a
ritornare al locale notturno. La cosa ovviamente si regolarizzò; venne
pagato il “salatissimo conto” e data l’ora ormai tarda, erano le cinque
del mattino, le ragazze andarono a dormire e noi rimanemmo con un palmo
di naso.
Si pensò dunque al rientro, mezzi non ce n’erano, per il taxi non
avevamo i soldi, avevamo dilapidato tutti i nostri averi, finalmente,
verso le sei, riuscimmo a trovare un autobus che ci fece arrivare al
Foro. Eravamo appena rientrati dalla finestra che dopo circa dieci
minuti suonò la sveglia. E’ chiaro che i due “sprovveduti modenesi”
rimasero a letto “marcando visita” accusando malattie incredibili.
Verso le 10 arrivò il medico che s’accorse immediatamente della ragione
della “nostra malattia”, come cura ci ordinò un bel bicchiere di “olio
di ricino” (e poi si affermava che era somministrato solamente nel ’22
all’epoca della rivoluzione fascista), che dovemmo bere in sua presenza.
Tralascio il racconto delle continue corse ai bagni nella giornata che
avrebbe dovuto essere di tutto riposo. Il giorno dopo eravamo già in
pista. Poi, per circa un mese, dovemmo “tirare la cinghia”, poiché
eravamo rimasti senza una lira.
 |
Modenesi su di uno "strano" aereo Gita dell'ISEF a Gubbio alla guid: ODDO FEDERZONI, DIETRO: BRUNO ZUCCHINI, GERMANO MORANDI, SERGIO ZANASI
|
Il Primo esame “non si scorda mai”, potrebbe titolare quest’aneddoto del
primo anno di Università. Erano passati alcuni mesi di vita all’Isef
romano, con alterne vicissitudini, attraverso lo scorrere delle lezioni
pratiche al mattino e quelle teoriche pomeridiane all’Università nella
sede romana di Viale Regina Margherita.
Durante i mesi di Febbraio, Marzo, si dovevano sostenere gli esami della
prima sessione del nostro Corso. Erano in programma esami tosti, quali,
Anatomia, Biologia e altri, tra questi anche quello di Italiano e Storia
con il Prof. Giorgio Petrocchi. Per il sottoscritto fù il primissimo dei
tanti esami, tra teorici e pratici, che avremmo sostenuto durante il
corso degli studi.
Bene, arriva il mio turno, ero uno dei primi, se non il primo in
assoluto; è ovvio che vi era un po’ di agitazione, anche se in realtà
questo non era tra i più importanti e non destava eccessiva
preoccupazione. Ugualmente avevo cercato di prepararmi al meglio delle
mie possibilità. Entro, con un po’ di tremarella, il Prof. con un bel
sorriso, che segnalava la sua buona disponibilità, mi fa accomodare e,
in modo molto corretto, mi chiede: “lo statino”.
Il sottoscritto, anche per precedenti esperienze, reputava che
l’esaminando per ottenere interesse e per fare buona impressione
all’esaminatore dovesse, se vi fossero state le possibilità, quasi
aggredirlo, con un profluvio di parole, onde mettersi in condizioni di
sicurezza per il prosieguo dell’interrogazione. Premesso questo, al
sentirmi chiedere, “Lo statino” partii come si suol dire “in quarta” e
cominciai a sciorinare una serie di dati e di considerazioni sulla
situazione dei piccoli stati italiani, quali San Marino, Il Vaticano
ecc. che si trovavano in una situazione socio-politica particolare in
quel determinato momento storico.
Dovevamo difatti studiare quel periodo del 1800; il Prof. mi stava
guardando sbalordito, io ritenevo fosse rimasto colpito dal mio
“sapere”; mi lasciò andare avanti per un po’, e finalmente decise
d’intervenire interrompendo il mio dire. Mi disse: “Guardi che io le ho
semplicemente chiesto lo statino, cioè il foglietto rilasciato dalla
segreteria per sostenere l’esame”. Rimasi perplesso e mi ricordai di
averlo in mezzo a un libro, un po’ mortificato lo estrassi e lo
consegnai all’esaminatore.
Sistemato il fatto burocratico l’esame continuò e andò anche bene, mi
“beccai”, malgrado il piccolo incidente iniziale un bel 28. Al termine
dell’interrogazione si fece un po’ di conversazione libera, mi chiese da
quale parte d’Italia provenivo: Modena risposi. Uscii soddisfatto. Ma
l’episodio non si ferma a questo punto.
Subito dopo entra l’amico di tante avventure scolastiche ed anche
“extra” (eravamo sempre assieme già dai tempi delle scuole superiori)
Germano Morandi. Appena entrato, il Prof. allungò la mano per prendere
il “famoso statino” dall’allievo, il quale pensò bene, vedendo quella
mano protesa, ma guarda com’è gentile questo Prof. gliela prese con la
sua e stringendola fortemente, da buon isefino, disse “piacere Morandi”.
A quel punto il Prof. lo guardò allibito, si ripetè più o meno la scena
dell’allievo che aveva preceduto il Morandi e d’istinto gli venne di
chiedere: “ma Lei di dov’è”, di Modena disse l’allievo, al chè il Prof.
si mise le mani nei capelli dicendo, ma proprio oggi e uno dopo l’altro
dovevate capitare voi modenesi!
Anche in quella circostanza tutto andò per il meglio. In fondo i
“modenesi”, con la loro carica di simpatia, e se vuoi anche di
ingenuità, seppero dare, in quel luogo austero, un “tocco” di
“estemporaneità” che a quei tempi non era abituale nei classici “templi
del sapere”.
Il secondo anno fu istituito un corso d’equitazione, al quale
parteciparono una ventina di allievi. Le lezioni si tenevano tutti i
giovedì pomeriggio, (giorno di non frequenza all’Università) a Tor di
Quinto, località ad alcuni chilometri da Roma, al maneggio militare.
Ordinaria amministrazione verrebbe da dire, ma l’episodio del primo
approccio con i cavalli necessita un breve ricordo.
Il giorno del “battesimo” della sella, gli istruttori, tra i quali i
notissimi Col. Oppes e Tenente D’Inzeo, dopo averci illustrato, a terra,
le caratteristiche del Cavallo, del come stare in sella, dei finimenti,
insomma tutte le informazioni necessarie, fecero entrare, guidati dai
soldati addetti, i cavalli nel recinto.
Ciascuno di noi si avvicinò al quadrupede che gli era stato aggiudicato,
altre informazioni, poi, tutti in sella. Sempre con il “soldatino” che
teneva il cavallo per il morso, cominciammo a girare nel maneggio.
L’istruttore al centro continuava nelle sue istruzioni; dopo cinque-sei
giri, ordinò agli addetti di uscire dal recinto; rimanemmo soli in sella
ai nostri splendidi animali continuando i giri, per trovare la giusta
postura, per sentire bene le redini, accarezzando il collo del cavallo
per far sentire la nostra presenza amichevole quando, improvvisamente,
un cavallo diede o un morso, o una forte testata, a quello che lo
precedeva, che partì subito in un galoppo sfrenato, seguito da tutti gli
altri.
Iniziò così il “rodeo”; nessuno di noi, ovviamente, sapeva come fermare
un cavallo scatenato, chi fu scaraventato per l’arresto improvviso
dell’animale di là dalla palizzata, chi cadde rovinosamente per gli
improvvisi scarti, chi come il sottoscritto scivolò gradualmente sui
fianchi e quasi sotto l’addome, per finire rotolando per le terre. Vista
da fuori, come ci dissero i comandanti e gli istruttori, che assistevano
alla nostra prima lezione, fu veramente una scena comica alla “Ridolini”.
Fortunatamente andò bene, eravamo tutti ben preparati e nessuno si fece
male. Le lezioni continuarono e tutti partecipanti a quel corso,
iniziato in modo così disastroso, furono soddisfatti al termine per il
traguardo raggiunto, sapevamo andare a cavallo.
Un altro momento molto importante fu quello delle Olimpiadi di Cortina
del 1956. Un gruppo di noi isefini del Corso B fu scelto per collaborare
all’organizzazione di quell’evento. Partimmo da Roma quindici giorni
prima dell’inizio dell’Olimpiade per prepararci ai nostri compiti.
L’inaugurazione avvenne allo Stadio del Ghiaccio il 26 Gennaio, ebbi
l’onore, assieme ad un gruppo di colleghi, di sfilare durante la
Cerimonia d’apertura dei giochi, portando la bandiera del Comitato
Olimpico Internazionale.
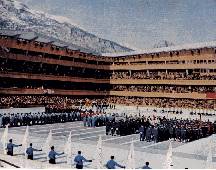 |
Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi di Cortina. Febbraio 1956 in primo piano, con le bandiere del CIO gli allievi dell'Isef; il terzo da destra Bruno Zucchini |
Collaborai, per tutto il periodo, con l’Ufficio Stampa che aveva sede
presso l’Hotel Savoia nel centro di Cortina recandomi, quotidianamente
sui vari campi di gara, dalle gare di sci alpino a quelle del fondo, dal
salto dal trampolino a Zuel, alle partite di hockey su ghiaccio, allo
stadio olimpico. Al termine dei Giochi, rimanemmo a Cortina per altri
quindici giorni, per partecipare ad un corso di sci. Fu quello il mio
primo vero contatto con la neve, che negli anni successivi ebbe tanta
parte della mia attività professionale.
 |
All’arrivo della pista del Faloria, l’allievo Bruno Zucchini |
Ritornato a Modena al mio primo anno d’insegnamento mi dedicai con
grande passione a due sport che all’Isef non erano stati trattati: Judo
e Tennis. L’arte marziale giapponese andai ad iniziarla, sotto la guida
del Maestro Stefano Scantamburlo, alla palestra dell’ex Gil ancora
perfettamente funzionante. Mi dedicai con molto impegno a quella
disciplina perché il Maestro aveva notato in me una buona disposizione
oltre a buone doti per quello sport, avrebbe voluto portarmi a
raggiungere, nei tempi possibilmente più brevi, il traguardo della
“cintura nera” per passare subito dopo all’insegnamento. Molte ore, ogni
giorno, erano dedicate a quegli allenamenti, ero già vicino al traguardo
quando morì mio padre, dovetti, per forza di cose, tralasciare alcune
delle attività intraprese, judo compreso, per ricercare motivazioni
economiche soddisfacenti. Di quel periodo ricordo alcuni amici del “tatami”,
inizialmente, Salvaterra, Ivan Vaccari e Franco Belletti in seguito, il
Prof. Emilio Tosatti e Franco Zanasi.
Durante il periodo estivo (allora non esistevano campi coperti), assieme
all’amico e collega Germano Morandi, ci dedicammo all’altro sport. Il
Circolo del Tennis di Viale Monte Kosica, l’unico a quei tempi a Modena,
era un Club esclusivo, non era facile entrarvi, se non facevi parte di
una certa “elite” modenese; con l’aiuto di alcuni amici, in particolare
del Prof. Orazio Coggi, Maestro di Tennis in quel circolo, riuscimmo ad
iscriverci.
Iniziò così un’attività frenetica per cercare, in tempi brevi, di
acquisire una discreta tecnica che ci potesse permettere di affrontare
corsi qualificati per proseguire in un’eventuale carriera professionale.
Purtroppo, causa le ragioni per le quali avevo dovuto abbandonare lo
Judo, interruppi quella disciplina che ripresi, a distanza di parecchi
anni, con un certo interesse, ma senza le motivazioni iniziali.
Di un altro aneddoto che inquadra la situazione della società italiana
di quei tempi, devo darne testimonianza. Un amico di quegli anni tentò,
l’anno dopo il mio ingresso all’Isef, di entrare in quell’Istituto. Non
passò l’esame e, purtroppo toccò a me dargli quella notizia non gradita.
Passarono alcuni anni, transitavo un giorno in “Vespa”, lungo Corso
Canalgrande quando sento alcuni colpi di clacson dietro di me, mi giro,
vedo una gran Maserati con il braccio del guidatore che mi faceva cenno
di fermarmi. Era l’amico dell’esame, il noto industriale Giancarlo Lei;
saluti, convenevoli poi lui sbotta: “Tè ve te bein fortunè, che te fat
l’Isef” in dialetto modenese, “tu sei ben fortunato che hai fatto l’Isef”.
Rimasi perplesso per questa sua battuta e risposi: ”vè, Giancarlo ma vot
torem per al cul o dit daboun, tè cun na gran Maserati e mè in Vespa,
c’a dev ancara finir ed pagher” (Giancarlo mi vuoi prendere per i
fondelli o dici sul serio, tu con una gran Maserati e io con una Vespa
che devo ancora finire di pagare).
Difatti, la sua non entrata alla “Farnesina” fu in realtà la sua fortuna
dato che, con la “Glem Gas” aveva iniziato la sua carriera di
industriale delle cucine creandosi una bella fortuna. Fui in seguito
grato a Giancarlo, il quale, avendo la passione dei cavalli, ne teneva
uno nei box allora in Piazza d’armi (ex ippodromo), mi permise di
proseguire per un certo tempo l’esperienza fatta a Roma anni prima.
Le attività sportive non frequentate durante gli studi a Roma mi
interessavano sempre di più. Venni a conoscenza che un collega di
Pesaro, Washington Patrignani, avrebbe tenuto in quella località, un
corso d’iniziazione alla vela. Mi iscrissi subito e presi così contatto
con questa affascinante disciplina, che portai avanti per parecchi anni,
si iniziò a parlare di “mure a dritta”, di “spinnaker”, di “strambate”,
di “poppa di prua” e così via, con tutta la terminologia marinara,
appresa su quelle piccole, ma estremamente versatili barche, che sono i
“Flyng Junior”.
Ne fui inebriato. L’anno successivo, assieme ad un collega di Forlì,
organizzammo un corso di Vela all’Isola di Lussino in Dalmazia. Furono
quindici giorni entusiasmanti; avevamo come capo istruttore, al corso
partecipavamo, come allievi, anche noi organizzatori, un certo Giano di
Trieste. Espertissimo, con alle spalle anche la famosa scuola dei
“Glenans” francese, si rivelò, oltre che ottimo maestro, velista
impareggiabile.
 |
Corso di vela all'Isola di Lussino il "Gozzo" |
La scuola la tenevamo su di una vecchia “stella”, barca velocissima di 9
metri con un albero di dodici, la “star”una delle classi olimpiche più
belle e impegnative, appoggiati da un “Gozzo” che ci serviva come base.
Il marinaio triestino riusciva a portarla con una facilità e una
destrezza tali da far impallidire, oggi, il più esperto timoniere di
“Luna Rossa”. Non posso trascurare, di quei giorni a Lussino, un fatto
significativo della situazione politica in quel paese. Imperava in
Yugoslavia il comunismo di Tito.
Il secondo Istruttore della nostra “equipe”, era un ragazzo indigeno di
Lussinpiccolo, anche lui esperto velista. Non per niente eravamo nella
terra delle medaglie olimpiche Straulino e Rode. Per alcuni giorni, con
quel ragazzo che parlava solamente yugoslavo, non era facile intendersi;
un bel giorno, in alto mare, lontanissimi dalla costa, uscì con una
perfetta frase in italiano seppure con la classica cadenza
veneto-dalmata che ci lasciò “basiti”.
“Ma come, allora tu…..! “Mi raccomando ragazzi” ci disse in tono
implorante, “quando torniamo a terra e anche nei prossimi giorni, non
rivolgetemi la parola in italiano, fate in modo che non possa essere
scoperto, perché, se qui si accorgono che parlo e sono d’origini
italiane, vado incontro a guai, molto ma molto seri!”
Vi fu, nell’organizzazione delle mie vacanze un altro corso di vela,
nuoto e tennis a Cesenatico all’inizio degli anni ’60, che vide la
partecipazione, tra gli altri, di due ragazzi provenienti dalla
Sardegna. “Ma come, voi, con il vostro mare e le vostre coste venite in
Adriatico?” Chiedemmo loro. A qui tempi in Sardegna non vi era ancora
niente d’organizzato, anche se, in seguito, fu istituita all’arcipelago
della Maddalena e precisamente all’Isola di Caprera, una delle più
importanti scuole di vela europee.
La possibilità di praticare questo sport mi venne data anni dopo quando
l’amico fraterno, con qualche mezzo a disposizione superiore al mio, il
Dott. Luciano Della Casa acquistò, a Cesenatico, un “catamarano”. Ecco
che vi fu nuovamente la possibilità di andar per mare, seppure sulla
costa Adriatica e in seguito anche sul Lago d’Iseo dove l’amico tenne la
barca per un certo periodo.
Un giorno abbiamo corso un’avventura che avrebbe potuto avere
conseguenze ben più gravi. Ci si telefonava al mattino, se era una bella
giornata e se si riusciva a trovare spazio dallo svolgimento del nostro
lavoro, si partiva immediatamente per arrivare celermente al rimessaggio
della barca a Cesenatico, portarla in acqua e….via, con il favore del
vento a godere della bellezza e del fascino dell’andar per mare a vela.
Che cosa successe quel giorno? Il vento tesissimo, il mare più che
increspato, una splendida giornata di sole; il catamarano filava che era
un piacere, le nostre manovre al “trapezio” si succedevano alle “strambate”,
eravamo al largo e la costa una linea lontana. Tutto procedeva
regolarmente, all’improvviso ci trovammo scaraventati da poppa, al
centro della barca, abbracciati all’albero. La barca si era
“letteralmente” piantata e si era messa in verticale rispetto alla linea
d’acqua. Cos’era avvenuto? Il catamarano ha due scafi: nella parte
posteriore di ciascuno di questi vi erano due fori, chiusi da tappi. Il
fatto lo imparammo una volta ritornati a terra, dopo alcune ore; nel
cantiere dove l’amico teneva la barca, vedendo che da alcuni giorni “al
dutour” non la usava, pensarono, avendone necessità, di togliere i due
tappi, “tanto poi li rimettiamo al loro posto”: noi arrivammo quel
giorno, con la frenesia dell’uscita in mare, prelevammo la barca
velocemente senza controllare, non ve ne era mai stato bisogno, se tutto
era a posto. Al largo, fatte alcune miglia, l’acqua entrò nei due scafi
che si riempirono a prua tanto da farci fare quella repentina impennata.
Lascio a voi pensare cosa fu detto a coloro che dovevano tenere ben
controllata e custodita, la barca.
Alcuni anni dopo mi prese anche la passione per il volo, cosa che avevo
già “addosso” da tempo. Ai primi anni ’50 avevo preso parte ad un corso
di paracadutismo tenuto dall’appassionato ed esperto di quello sport, il
modenese Mazzacurati, alla palestra dell’ex Gil.
Il primo lancio lo effettuammo all’aeroporto di Bologna, in un
pomeriggio settembrino che ci diede la soddisfazione di assaporare tutta
l’ebbrezza e l’emozione di volteggiare nell’aria.
A bordo di un vecchio, e traballante “Savoia Marchetti” salì il
gruppetto di paracadutisti modenesi che, dopo circa un’ora di volo sul
cielo di Bologna per trovare il momento e la posizione giusti per uscire
dall’aereo, si gettarono, uno dietro l’altro, nel vuoto, per toccare
terra dopo pochi minuti. Entusiasmante! Arrivato a casa, parlai
dell’esperienza avuta a mia madre dicendole: “Sai mamma, oggi sono
andato in aeroplano”. “Cosa hai fatto?” e giù una serie di
considerazioni sulla mia leggerezza ecc.ecc. Quando le ho detto: “Ma non
sono atterrato con l’aereo, sono sceso con il paracadute”, per poco, non
sviene.
All’aero Club ebbi come istruttore, per l’acquisizione del brevetto di
primo grado, uno dei “grandi” dell’aviazione modenese, il maresciallo
Danilo Billi, pilota di aerei da caccia nel secondo conflitto mondiale.
Feci anche parecchi voli assieme all’amico pilota Franco Mazzi, titolare
del negozio “Pirelli” nelle vicinanze del Duomo, uno dei più esperti
piloti dell’Aereo Club modenese, scomparso anni addietro in un incidente
di volo: Franco mi fece assaporare quelle evoluzioni che io non sarei
mai riuscito a fare, “looping, tonneau”, poiché dovetti rinunciare a
quella passione: avevo già famiglia e un figlio, arrivavano a casa conti
salati, per le mie tasche, dall’aereo Club per le ore di volo
effettuate; non era più possibile frequentarlo.
Ebbi la soddisfazione, relativa se si vuole, di tenere in mano per circa
un ora i comandi di un aereo di linea, un “Boeing 707”. Successe durante
un volo a New York, con un gruppo di amici e allievi da me organizzato:
feci amicizia con il pilota di quell’aereo che, imparato che stavo
facendo la scuola per il brevetto di pilota, mi ospitò in cabina di
pilotaggio, facendomi accomodare sulla poltrona del secondo pilota,
lasciandomi, ovviamente a 10.000 metri d’altezza e con pilota automatico
inserito, i comandi di quell’enorme bestione. Era un napoletano
simpaticissimo che, mi diceva, quando voleva veramente divertirsi con il
volo, andava all’aereoclub della sua città a pilotare uno di quei
piccoli aerei sui quali, anch’io, stavo apprendendo i segreti del volo.
Nei primi anni ’60, esattamente nel 1962, mi si offerse la possibilità
di ritornare a Roma, città che è sempre rimasta nel mio cuore. La
Federazione Italiana Scherma, in collaborazione con il Coni e il
Ministero della Pubblica Istruzione, con l’intenzione di sviluppare, sia
scolasticamente sia per la componente agonistica nelle società sportive,
la conoscenza di questa disciplina che tante soddisfazioni ha dato, con
medaglie olimpiche, mondiali ed europee, allo sport italiano, lanciò un
corso residenziale per Maestri di Scherma in favore di un gruppo di
Insegnanti di Educazione Fisica già inseriti nel mondo della scuola.
L’offerta era abbastanza vantaggiosa, a casa correva lo stipendio
regolare e, a Roma era corrisposta una cifra equivalente per il
sostentamento fuori casa. La situazione personale di quel periodo era
abbastanza “ingarbugliata”. Mia madre stava ancora bene e non avevo
problemi a lasciarla sola a Modena; colsi la “palla al balzo” e
approffitai della possibilità offertami per ritornare nella Capitale a
“lavorare” in modo piacevole, in una situazione economica abbastanza
favorevole, dando nello stesso tempo la possibilità ad uno o più
colleghi giovani, di fare una serie di lunghe “supplenze”, poiché restai
a Roma, in pratica per tutto l’anno scolastico 1962-63.
Eravamo 20 insegnanti di E.F. provenienti da ogni parte d’Italia,
alloggiati nelle foresterie dell’impianto sportivo dell’Acqua Acetosa,
praticamente un ritorno ai vecchi tempi della Foresteria al Foro
Italico. La zona era, come penso la sia ancora, molto bella, da poco
tempo era stato inaugurato quel complesso in previsione delle Olimpiadi
del 1964 e, con noi vi erano frequentemente i raduni dei P.O. (probabili
olimpici) di molti sport.
Non ero più un “giovincello”, andavo verso i “trenta” ero a Roma con la
mia macchina, da poco acquistata, una “Ford Capri” abbastanza
appariscente, un coupè americaneggiante, di conseguenza la vita in
comunità mi andava un po’ stretta. Gli impianti dell’Acqua Acetosa
chiudevano i battenti di sera, verso le 22,30, massimo le 23, ed erano
“sguinzagliati” una decina di cani “doberman”, particolarmente
addestrati per la guardia, che scorrazzavano all’interno della struttura
in quanto, qualche tempo prima vi erano state delle intrusioni
dall’esterno, di malintenzionati. Una notte ritornai in ritardo, il
custode al cancello aprì ugualmente, dato che mi conosceva, con l’auto
potevo arrivare vicinissimo all’ingresso della mia camerata, dove
eravamo alloggiati in cinque.
Parcheggiata la macchina, un attimo, prima di scendere, mi vidi
circondato da sei o sette di quelle “simpatiche bestiole”, ringhianti e
ben poco disponibili nei miei riguardi. Ovviamente restai dentro
l’abitacolo a lungo, fintanto che un guardiano addetto a quelle bestie,
facendo il suo giro d’ispezione e di controllo mi trovò, in quella
situazione, assediato dai suoi bravi doberman.
Li condusse nei loro box così potei, finalmente, andarmene a riposare.
Tempo dopo ci fu la notizia che, in alcune occasioni si verificarono,
colpa di quei cani da guardia, episodi cruenti con feriti gravi e mi par
di ricordare anche un caso di morte, penso, che dopo quei fatti le
guardie canine siano state eliminate.
Quell’episodio mi convinse che non era più il caso di restare in quell’impianto,
malgrado qualche difficoltà con i dirigenti del Coni e del M.P.I. che
non volevano, in un primo tempo, versare lo stipendio a un esterno, mi
trovai una bella stanza con pensione, nelle vicinanze di Piazza Ungheria
da dove poi, tutte le mattine mi recavo alla sala scherma per acquisire
le tecniche schermistiche.
Ritornato a Modena, da allora non toccai più un “fioretto” o una spada
perché, come detto per altre situazioni analoghe, ancora si doveva fare,
in certi sport, del “volontariato” cosa che per me non era possibile, la
mia professione era quella e desideravo che ci fosse un corrispettivo
alle mie prestazioni. Ripresi in mano l’arma occasionalmente, dopo
tantissimi anni, con l’amico della sezione Scherma della Società Panaro
di Modena, Vittorio Cucchiara, ma non ricordavo assolutamente, o quasi,
nulla.
All’inizio degli anni 90 fui nominato Delegato Provinciale della
Federazione Italiana Canottaggio, in ricordo del Prof. Rubens Pedrazzi
con il quale durante gli anni giovanili provai quella spendida
disciplina sulle acque, ancora praticabili del fiume Secchia, e per
cercare di dare impulso a questo sport, praticato dalla gloriosa Società
“Canottieri Mutina”, accettai l’incarico quando mi venne proposto,
dall’allora presidente, l’amico Ing. Turno Sbrozzi.
La FIC, in quegli anni, si era separata in due: la canoa e il Kajak,
costituirono una loro Federazione, e il canottaggio rimase sotto la
sigla originaria. A Modena, ai laghetti di Campogalliano si pratica, e
con grande successo, per merito principalmente del Prof. Riccardo
Pedrazzi, di Gianni Anderlini e di Livno Bettelli, la canoa e il kajak,
con l’ottenimento di risultati eccellenti a tutti i livelli e ne fanno
fede le presenze olimpioniche di, Andrea Covi e di Josefa Idem.
La scuola modenese ha portato tanti atleti a livello di eccellenza a
dimostrazione di una impostazione e di una preparazione atletica di
grande rispetto: i laghetti si prestano bene per l’attività canoistica,
malgrado le precarie condizioni degli spogliatoi della Sede e del
rimessaggio barche, per il canottaggio il discorso cambia completamente,
dato che le barche del remo (il canottaggio) contrariamente a quelle
della pagaia (canoa), non hanno la possibilità di manovrare al meglio.
Da oltre venticinque anni, l’Amministrazione Provinciale, aveva
programmato, con tanto di stanziamenti pubblici la costruzione di un
bacino d canottaggio ai laghetti. Era stato più che pubblicizzato dalla
stampa, tante riunioni si sono tenute in Provincia, sul posto insistono
ancora i cartelli che prevedono la costruzione del bacino (lunghezza due
chilometri, non è il campetto da tennis o da pallavolo), ancora ad oggi,
2007, non si riescono a fare passi avanti.
A chi addossare la responsabilità ai Comuni di Campogalliano o di
Rubiera? All’Amministrazione Provinciale? Al Coni? Alle strutture
commerciali che insistono su quel territorio? La matassa non si riesce a
dipanare. Alcuni anni or sono scrissi un articolo che rilevava lo stato
di quella mancata realizzazione, che tanti vantaggi porterebbe non solo
alla zona, ma a tutto il territorio modenese, e che qui vorrei proporre.
REMO CONTRO DEGRADO
I molti modenesi che hanno frequentato i laghetti di Campogalliano in
cerca di pace e di tranquillità per andare a pescare o alla ricerca del
fresco durante i mesi estivi avranno senz'altro notato i due grandi
cartelloni installati dalla Provincia e che pubblicizzano la costruzione
nel Parco Fluviale di un bacino di canottaggio. Quei cartelli sono sul
posto da una quindicina d'anni, e della costruzione del bacino se ne
parlava anche dieci anni prima di quella data. E' trascorso dunque un
quarto di secolo ma di quei progetti, che in realtà avevano avuto un
inizio, non se se ne è mai più parlato e tanto meno oggi non si riesce a
sapere dove e come siano stati spesi gli stanziamenti e se vi è ancora
la volontà di proseguire.
L'importo devoluto per il primo stralcio dei lavori comportava una cifra
di L. 1.017.436.500. Le imprese che dovevano e che in parte hanno svolto
lavori erano : SISTEMA - INCAM e ACEA costruzioni;il progetto dell
studio CUPPINI e Associati di Bologna e lo Studio Tecnico dell'Ing.
Bambini e Ing. Lusvarghi di Campogalliano.
All'inizio degli anni novanta numerose riunioni si sono tenute nella
sede della Provincia di Modena con la presenza di assessori, esperti,
progettisti, rappresentanti di Federazioni Sportive e sembrava che il
progetto prendesse veramente consistenza poi tutto si è fermato.
L'attività sportiva che attualmente si svolge ai laghetti è quella della
canoa che tra l'altro ha dato tantissime soddisfazioni allo sport
modenese dato che gli atleti allenati dal Prof. Riccardo Pedrazzi e
condotti dal Presidente della Canottieri Mutina Livno Bettelli hanno
raggiunto prestigiosi traguardi anche a livello nazionale. Ma a costo di
tantissimi sacrifici: Avete mai visto i piccoli locali dove sono
accatastate le canoe e un solo skiff per il canottaggio? oppure i locali
dove gli atleti si spogliano o dove fanno allenamento con i pesi?
Non è possibile che negli anni duemila, con sport ricchissimi e
stramiliardari, altri sport, quali quelli della canoa e del canottaggio
per i quali la stampa si entusiasma solo quando vincono medaglie d'oro
alle olimpiadi o ai mondiali, debbano arrancare per avere il minimo
indispensabile per cercare di far gareggiare i loro atleti e non sempre
ci riescono. Ai laghetti di canoa se ne è fatta e se ne stà facendo
tanta; ma per il canottaggio niente. Le lunghe barche dei canottieri non
hanno lo possibilità di manovrare negli spazi ristretti dove invece la
canoa si muove con disinvoltura.
Di conseguenza da decenni, dopo che nel fiume Secchia dove vi era la
sede della Canottieri Mutina sino agli anni '50, la scuola modenese del
remo che negli anni anteguerra era vivacissima non ha più avuto alcuna
possibilità di esprimere quei talenti sportivi che la nostra terra
produce da sempre.
Non è poi da sottovalutare la situazione aria, acqua, territorio,
ambiente. Sono elementi che la natura ci offre per vivere, ma che l'uomo
d'oggi, malgrado le tante chiacchere, tende a trascurare se non a
distruggere. Si assiste sempre di più al degrado ed allo scempio di
questi elementi pur facendo enunciazione continua di principio nei
confronti della salvaguardia degli stessi e si promulgano leggi che
molto spesso sono in contrasto con i principi dichiarati. Non vi è mai
stata nella storia nessuna civiltà come la nostra che ha prelevato tanto
dall'ambiente rendendolo sempre più povero. Si commettono gravissimi
atti d’inquinamento che turbano sempre più l'equilibrio biologico.
Il mondo dello sport ha sempre dato molta importanza alle tematiche
ambientalistiche nel momento in cui il delicato equilibrio ecologico
rischia di essere seriamente compromesso da modelli di sviluppo spesso
inadeguati, e sopratutto nel concepire l'attività sportiva non solo come
pura espressione agonistica ma fondamentalmente come mezzo di formazione
educativo-culturale.
Lo sport del remo pertanto tra le varie attività sportive , più di ogni
altra, vive e fà sua la natura e introduce un discorso pedagogico che
non passa attraverso elucubrazioni sofisticate in dibattiti e
discussioni, ma attraverso la pratica, la presenza, l'esempio che deriva
dall'attività giornaliera sugli specchi d'acqua siano essi lacustri,
fluviali o marini si pone come assoluto protagonista di un tal modo di
concepire la vita.
Il Canottaggio si pone pertanto all'attenzione di chi ama natura ,
sport, vita sana e all'aria aperta come promotore di una cultura nuova
che proviene da un confronto che ha suscitato due percezioni ormai
consolidate: che l'ambiente è una realtà viva ,fragile, complessa e che
l'azione dell'uomo proprio perchè consapevole e dunque responsabile, è
essenziale per il il recupero e la conservazione, oltre che del
patrimonio culturale, anche di quello naturale.
L'area naturalistica di Campogalliano dove insiste una flora ed una
fauna di notevole interesse è sconvolta al momento attuale da
un’irrazionale situazione. A fronte dei cartelli, anche numerosi, dove
si consiglia di tutelare l'ambiente, si invitano i cittadini a
comportarsi in modo adeguato per la difesa della natura in tutti i suoi
aspetti, si lascia che sulla strada che attraversa i laghetti, dove vi
sono pure ai bordi questa due maneggi dove si esercitano bambini e non,
passino in continuazione ed anche a velocità sostenuta enormi autocarri
adibiti al trasporto di ghiaia e quant'altro sollevando enormi polveroni
alla faccia di chi và alla ricerca dell'aria pulita e della
tranquillità.
E' assurdo che,in un’area di riequlibrio ecologico,continuino ad
insistervi sopra varie attività di tipo industriale,e che nello stesso
tempo nelle varie pubblicazioni o nei siti internet dei vari comuni del
comprensorio e della Provincia si continui a reclamizzare l'area
naturalistica. Altro discorso bisognerebbe fare sul degrado degli
edifici che sorgono nelle adiacenze dei laghetti alcuni dei quali
riportano ancora la cartellonistica relativa agli scopi ai quali erano
destinati
Prof. Bruno Zucchini - Delegato Provinciale Federazione Italiana
Canottaggio
Così scriveva la rivista della Provincia di Modena, 20 anni or sono e
cioè nella primavera del 1988, relativamente alla sistemazione della
riserva naturale della Cassa di Espansione del fiume Secchia nella zona
dei laghetti di Campogalliano.
Campogalliano: presto bacino di canottaggio e piscina di nuoto
Sono stati approvati con il voto favorevole di tutti i gruppi nella
seduta dell'11 Maggio del Consiglio Provinciale, i due progetti di
massima riguardanti il bacino di canottaggio e la piscina coperta per
sport acquatici che verranno allestititi nella zona di Campogalliano
nell'ambito degli interventi previsti per la realizzazione del Parco
Fluviale del Secchia.
Il primo progetto presentato dall'assessore allo sport Patrizia
Guidetti, prevede la costruzione di un bacino con relativo campo di
regata all'interno del Parco con uno specchio d'acqua complessivo di
circa due chilometri.
L'impianto sportivo nel complesso costituirà un centro agonistico per
gare di canoa e canottaggio assolutamente unico in Italia, dove impianti
attrezzati si hanno solo a Roma e Milano, e di sicura caratura europea.
Intale senso le Federazioni Nazionali di sport acquatici hanno espresso
giudizi lusinghieri a favore del progetto che consentirebbe alla zona
del bacino di proiettarsi nel grande scenario continentale di gare
agonistiche.
Come corollario importante dell'impianto, verrà costruita in prossimità
del bacino presso il centro polivalente di sport acquatici di
Campogalliano una piscina coperta per nuoto e pallanuoto.
Il complesso, oltre a consentire la pratica delle diverse discipline ,
rappresenterà l'indispensabile appendice del campo di regata permettendo
l'allenamento degli atleti anche durante la stagione invernale.
Promesse non mantenute!
Home page