Ulrico Guerrieri
I
giorni che contano
Diario: 25 luglio 1943 – Dicembre 1945

Alla memoria di mio padre ed
a tutti volontari della R.S.I.
Prefazione.
Brevi
memorie che rappresentano un momento importante della mia vita.
Ho cercato di rivivere, per quanto ricordi, la
stesse sensazioni di quei lontani giorni e di scriverle piu’ fedelmente
possibile, sin da quando, appena diciottenne, mi trovai a prendere quelle
decisioni che poi, negli anni a venire, nel bene e nel male, hanno avuto e
tutt’ora hanno, una presenza continua nei mei pensieri.
Con il senno del poi, quante volte mi sono imposto
di giudicarle il più severamente possibile, ma uscendone sempre indenni, più
giuste e convincenti che mai.
Ho dato loro una veste ‘casareccia’ perché, pur non
essendone all’altezza, ho voluto fare tutto da solo anche nelle piu’ piccole cose,
senza un particolare motivo, ma forse, ora che ci penso, é stato un pretesto per restare più a lungo
possibile con questi ricordi, ne più ne meno come avrei fatto da ragazzo con il
giocattolo preferito.
U.G.
La vittoria nella
sconfitta
“GIURO DI SERVIRE E DIFENDERE LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA NELLE SUE ISTITUZIONI E NELLE SUE LEGGI, NEL SUO ONORE E NEL SUO TERRITORIO, IN PACE E IN GUERRA, FINO AL SACRIFICIO SUPREMO. LO GIURO DINANZI
L’AVVENIRE DELLA PATRIA.”
A DIO ED AI CADUTI PER
L’UNITA’, L’INDIPENDENZA
E
“Anno 1943 Venticinque del mese di Luglio”.
Siamo attraccati ad una banchina del molo di Trieste in attesa di proseguire una piccola crociera iniziata a Venezia con un trabaccolo il Flavio Gioia (1) che a vele spiegate ci aveva portato in alcune isolette dalmate e nei porticcioli di Capo d’Istria, Parenzo, Rovigno, Porto Rose ecc.
L’equipaggio era composto da una piccola parte degli allievi del corso “Freccia” da poco promossi al IV° liceo scientifico del collegio navale di Venezia (oggi Morosini) che aveva avuto l'opportunità di questa crociera, anche se limitata a causa del conflitto in atto e addirittura a distanza di tanti anni mi viene fatto di pensare come si sia potuto effettuarla. Fu una esperienza stupenda ma quello che doveva essere il primo vero approccio con il mare, in previsione di un prossimo futuro ben più impegnativo, si rivelò per quasi tutti noi l'ultimo.
Infatti la nostra avventura ebbe fine proprio al molo “Audace” del porto di Trieste il 25 Luglio 1943 data della caduta del fascismo. Si rese per noi necessario salpare e rientrare a Venezia e una volta arrivati, attraccammo alla Riva degli Schiavoni.
Come fummo al navale, sull’isola di S.Elena, il comandante ammiraglio Casentini mise tutti noi al corrente della situazione che si era creata e dopo un breve e commovente commiato, il giorno successivo ci mandò a casa dove, ci disse, avremmo ricevuto le eventuali disposizioni che poi mai ci pervennero.
Avevo diciassette anni e mezzo.
La mia famiglia abitava a Borgo a Buggiano dove mio padre si era trasferito nel 192O proveniente da Lucca e vi aveva costruito una fabbrica di copricapo che, nei momenti migliori, impiegava oltre cento dipendenti.
Come ritornai a casa, subito dopo i miei genitori mi dettero l'opportunità di passare due settimane al mare a Viareggio e quel breve ma felice soggiorno (anche se allora non potevo né saperlo né prevederlo) fece da cuscinetto tra due periodi della mia vita, ne chiuse uno e ne aprì un altro: da ragazzo divenni un uomo.
A quei tempi si cresceva in fretta ed in fretta dovevamo prendere le nostre decisioni se non volevamo essere sopraffatti dagli eventi. Ricordo benissimo che in quei giorni ci fu un bombardamento a Livorno in pieno giorno ed anche se a distanza di tanti chilometri, da Viareggio mi resi perfettamente conto dalla forza delle esplosioni e della veemenza dell’attacco. Avevo già assistito ad altri attacchi aerei, ma notturni e di lieve entità. Il primo fu quello che effettuarono gli inglesi su Venezia all’inizio della guerra nel 194O, ma anche se all’epoca avessi appena quindici anni, non mi lasciò grande impressione. Ricordo che ci fecero scendere negli scantinati del navale che per l’occasione furono adibiti a rifugio, ci passammo alcune ore, udimmo qualche scoppio e niente di più.
Al tre Settembre, data della firma dell’armistizio da parte dei badogliani con gli anglo -americani ad insaputa degli alleati tedeschi, seguì l’otto Settembre.
Quel giorno il refettorio che ospitava le operaie della nostra fabbrica a Borgo a Buggiano, in brevissimo tempo fu riempito di moschetti 91 oltre tante altre armi che i soldati, dislocati in zona, ormai certi della fine della guerra, pensarono di disfarsene per tornare a casa loro prendendo letteralmente d’assalto i pochi treni in transito. La fabbrica era il posto ideale perché vicinissima alla ferrovia (non per niente poco tempo dopo fu bombardata) e passaggio obbligato per chi avesse voluto prendere una scorciatoia per la stazione, costeggiando i binari ferroviari.
Mio padre già prima della guerra era in Eritrea nella città di Asmara. Il suo lavoro consisteva di importare manufatti, quelli che produceva l’azienda che in quel periodo era diretta da mia madre, oltre che autovetture e quanto altro poteva interessare agli arabi, suoi maggiori clienti. Assieme a lui c'erano anche i miei due fratelli più grandi, Giannetto e Aligi, i quali frequentavano in loco rispettivamente il liceo classico e l’Istituto Tecnico per ragionieri. Era stata una loro libera scelta che penso in gran parte motivata da quel pizzico di avventura che tutti, specie negli anni giovanili, abbiamo dentro di noi.
Come il conflitto ebbe inizio, anche se super mutilato, avendo subito nella prima grande guerra tre ferite di cui due mortali, essendo ufficiale superiore di complemento dell’esercito, fu ugualmente richiamato e gli fu affidato il comando dell'autocentro di Asmara che tenne fino all’occupazione inglese. Pensando alle colonie durante da guerra, isolate completamente dalla madre patria, era naturale, tra le tante altre cose, ci fosse carenza di ufficiali.
Come gli inglesi occuparono Asmara, fu fatto prigioniero, ma quasi subito dopo fu lasciato libero sulla parola e in un secondo tempo, nel 1943, (a seguito delle sue mutilazioni) fu rimpatriato con le navi della Croce Rossa Italiana, che rientrarono in Italia da Gibilterra dopo aver fatto il periplo dell’Africa e doppiato il capo di Buona Speranza.
Per questo motivo l’otto Settembre 1943 mio padre era già rientrato dalla prigionia e fu proprio lui, onde evitare che tutte quelle armi cadessero in mano di qualche sconsiderato, ad avvisare i carabinieri affinché le prendessero in custodia.
Intanto cominciavano a circolare voci molto insistenti che i tedeschi facevano delle retate, prendevano gli uomini che successivamente sarebbero stati deportati in Germania e fu che decisi di aggregarmi ad alcuni amici per andare a nascondermi sulle colline adiacenti.
I miei ricordi di quei due o tre giorni, si riducono ad una storta che presi ad un piede e che mi fece tribolare non poco, ma per il resto non ho memoria; solo che tornato a casa, presi a frequentare l’ultimo anno del liceo scientifico di Montecatini Terme.
Iniziai regolarmente l’anno scolastico e nella mia aula ci trovai vecchie conoscenze come Aldo e persino una cugina figlia di Amato.
Intanto Mussolini che era stato fatto prigioniero sin dal 25 Luglio, fu trasferito a Campo Imperatore sul Gran Sasso d'Italia, da dove i tedeschi con un audace colpo di mano, lo liberarono.
Non passò molto tempo dalla sua liberazione che fu fondata la “Repubblica Sociale Italiana”: si sarebbe continuato a combattere a fianco dei nostri alleati tedeschi. Ebbero inizio gli arruolamenti nelle varie città d’Italia, ma purtroppo si crearono i presupposti di una guerra civile. Molti italiani ormai stanchi della lunga guerra, per non ritornare sotto le armi andarono a nascondersi sui monti; ad essi si aggiunsero anche gli anti fascisti e successivamente furono paracadutati americani, russi e soprattutto armi.
Con il tempo le loro fila si ingrossarono e fu così che nacquero i così detti partigiani, che noi della Repubblica Sociale Italiana chiamavamo ribelli e si aprì un nuovo fronte alle spalle dei combattenti dell’Asse.
Mio padre molto spesso andava a Lucca e una sera ritornò a casa particolarmente euforico. Era raro che accadesse, doveva pur esserci un motivo e infatti, mentre eravamo a cena, raccontò di aver visto marciare per le vie della città dei “ragazzi” che vestivano le nuove divise della Repubblica Sociale Italiana, portavano la camicia nera e cantavano inni patriottici. Senza mezzi termini fece chiaramente intendere che quelli si erano veri uomini; non aggiunse altro e non ho mai saputo se quelle parole erano rivolte a me o se era semplicemente uno sfogo di un uomo, un vero patriota (il suo medagliere che ancor oggi gelosamente conservo ne é la prova più lampante) che si riconosceva in quei giovani.
Comunque sia quella frase mi obbligò a riflettere e dopo qualche giorno, senza dire niente, me ne andai a Lucca e mi arruolai nel “battaglione Lucca” della Guardia Nazionale Repubblicana che era dislocato nella caserma di S. Romano. Credo di ricordare si fosse nell'Ottobre, o nel Novembre del 1943 (1)
Iniziammo l’addestramento, con le solite marce e feci le prime amicizie. Conobbi Ciro Marianini con il quale ci fu un legame di amicizia cosi forte che si protrasse per tutta la durata della guerra, conobbi Aldo, Francesco Dardi, Enrico Del Rj, con i quali mi ritrovai anche dopo, Gigi e quel tipo “allarma” cui demmo questo soprannome perché come le sirene si mettevano in azione, urlava a gran voce anzichè allarme, “allarma, allarma”.
Abbastanza spesso tornavo al paese dai miei genitori che facevano di tutto per rendermi la “naia” meno faticosa possibile senza contare che il babbo, ogni volta che capitava a Lucca e avveniva molto spesso, trovava il tempo di fare una capatina in caserma; tra l'altro era amico del comandante del battaglione colonnello Casu, ma questo lo venni a sapere successivamente.
Alcune domeniche o giorni festivi che fossero venivo invitato a pranzo dallo zio Isandro e zia Fosca che abitavano in città e proprio in una di queste occasioni, dopo fine anno, il giorno di Befana, eravamo ancora seduti a tavola, che avemmo il primo bombardamento aereo.
Udivamo perfettamente il caratteristico rombo delle “Fortezze Volanti”. Era una bella giornata e dalle finestre le vedevamo distintamente, addirittura le potevo contare; era una grossa formazione ed il sole che si rifletteva sulle lamiere, trasmetteva sinistri bagliori.
Mai e poi mai avrei pensato che sganciassero le bombe, non c'era niente di importante da bombardare, almeno così credevo, ma i boati che seguirono mi fecero ricredere. Fu colpita la zona periferica dalle parti di S.Concordio proprio dove successivamente i miei genitori sarebbero andati ad abitare, una volta che decisero di ritornare a Lucca, sia a causa del bombardamento della fabbrica e della casa, ma non ultimo per le molte noie che mio padre stava passando a causa dei partigiani, che addirittura una sera lo avevano prelevato e messo al muro per fucilarlo. Solo il coraggio e la presenza di spirito di mia madre fece evolvere al meglio una situazione che pareva irrimediabilmente compromessa.
Io intanto, approfittando dell’opportunità di una sessione straordinaria per militari, sempre nel liceo che anche se per poco avevo frequentato, presi la maturità scientifica, iscrivendomi subito dopo alla facoltà di ingegneria a Pisa.
Un bel giorno parte dei militari e con loro praticamente tutti i miei amici, furono trasferiti in Piemonte a Rivoli Torinese per effettuare il corso ufficiali; io ne rimasi sconcertato perché non ero stato chiamato a fare parte del gruppo dei partenti, pur avendo tutti i requisiti richiesti. Feci le mie rimostranze, poi ne parlai con mio padre e da lui medesimo venni a sapere il motivo di questa mia esclusione.
Aveva pregato il suo amico, il comandante di tenermi a Lucca spiegandomi, visto la piega che stava prendendo il conflitto, che sarebbe stato più saggio rimanere dove ero, senza per questo venire meno ai miei doveri di soldato. Non volli sentire ragioni. Andai a rapporto dal colonnello e senza tanti preamboli chiesi ed ottenni il permesso di raggiungere gli altri a Rivoli. (2)
Effettuai il trasferimento in treno in compagnia di un altro ritardatario, Ciro che prima di partire volle portarmi a casa sua a Viareggio. Abitava vicino alla stazione e conobbi suo padre che era medico. Aveva pure due sorelle che però conobbi solo dopo la guerra, quando vennero a trovarmi per avere sue notizie.
Come arrivammo a Rivoli la prima operazione che facemmo fu di bruciare con dei fogli di giornale le reti delle brandine per eliminare gli “ospiti” che vi si erano installati prima del nostro arrivo.
Naturalmente ritrovammo gli amici di Lucca e tutti assieme fummo destinati al primo plotone della prima compagnia. (3)
Feci conoscenza del nostro diretto superiore il sergente Piero che alcuni di noi avevano già conosciuto a Lucca e che in seguito diventò per tutti il sergente “gamba”. Proveniva da Firenze e durante il periodo del corso, fu un bravo superiore ed impareggiabile amico. Ora é un architetto di chiara fama, abita a Genova e ci siamo rivisti fino a qualche anno fa, perché qualche volta gli é accaduto di essere ospite di Teresio Sordo, anche lui a Rivoli nella terza compagnia e che attualmente abita in una villa nella nostra campagna. Tra gli altri feci amicizia con “foffo” il caro amico Nencini che rividi subito dopo la guerra a Pisa dove frequentava la facoltà di medicina. Per lui purtroppo le peripezie non erano finite e subì un ulteriore calvario.
Parlando di
conoscenze fatte a Rivoli diventate amicizie dopo la guerra, come non ricordare
Amerigo Coveri all’epoca più conosciuto in sintonia con un altro allievo di
Pisa. Se cercavi uno trovavi pure l’altro e viceversa, così era più comodo
chiamarli: “ricchi e poveri” parafrasando le parole che accompagnavano la
tromba quando dava il segnale di adunata per il rancio e che si adattavano
molto bene ai rispettivi cognomi, con solo una leggera variazione di
consonanti. (4)

Con Ciro Mariannini (a destra nella foto) nella
Primavera del 1944 alla scuola All.Uff. della
G.N.R. di Rivoli Torinese
La vita a Rivoli era più movimentata e direi anche più avventurosa. A Lucca c’era stata purtroppo una fucilazione mi sembra di ricordare di un renitente alla leva ed il plotone di esecuzione era formato da alcuni dei nostri presi a sorte, ma per il resto niente di importante; l'unico sangue, a parte quel brutto incidente, fu versato da Francesco perché preso a pugni da un gruppo di facinorosi mentre solo e di sera stava rientrando in caserma.
La prima volta che fui di guardia, una nostra pattuglia si era scontrata con un gruppo di partigiani non lontano dalla caserma, passai praticamente buona parte della notte sul chi vive e con un certo batticuore, completamente solo come ero e con la prospettiva di dover fronteggiare per la prima volta una certa situazione, qualunque essa fosse, senz’altro poco piacevole.
A scuola avevamo iniziato con la teoria, poi con la conoscenza delle varie armi (non molte per il vero) e con le solite esercitazioni, (percorsi di guerra ecc.) il tutto condito dalle marce a passo cadenzato e sempre cantando.
Però cominciarono a farsi sempre più frequenti le richieste di volontari per effettuare rastrellamenti nelle campagne vicine e ad onor del vero, io ero tra quelli che non si tiravano mai in dietro e proprio a questo riguardo Rinaldo, che avevo conosciuto già prima ai tempi del collegio a Porcari il Cavanis, essendo anche di qualche anno più grande di me, non tralasciava occasione per farmi notare che rischiavo troppo. Le sue argomentazioni non facevano una piega: «La nostra presenza in questo luogo é una cosa giusta e necessaria, ma dato che la guerra comunque ormai la perderemo, a che titolo rischiare più del necessario.»
Le nostre chiacchierate di solito avvenivano la sera a notte fonda passeggiando nel piazzale delle esercitazioni; a volte andavano anche ben oltre e sconfinavano con vere e proprie dissertazioni pseudo filosofiche. Naturalmente nel mio intimo la pensavo esattamente come lui e sapevo che aveva ragione da vendere. Queste prediche, così le chiamavo per sfotterlo, non venivano da un codardo, ma da uno che sarebbe potuto stare tranquillamente a casa sua che nessuno l’avrebbe cercato o molestato; per questo l’ascoltavo e davo il giusto peso alle sue parole, ma era più forte di me la voglia di agire, di seguire quello che mi dettava l’istinto.
Una bella mattina ebbi la gradita sorpresa di ricevere la visita di mio padre. Era venuto al nord per fare acquisti di stoffe in modo che, una volta passato il peggio, avrebbe potuto riprendere l’attività. Aveva approfittato per fare una scappatina a Rivoli e venirmi a trovare. Quel giorno ero consegnato in caserma, ma riuscì ugualmente a tirarmi fuori e farmi passare una bella giornata a Torino.
Prima di ripartire mi lasciò l'indirizzo di un industriale del nord dal quale sarei potuto andare per qualsiasi necessità, anche per denari, nel caso ne avessi avuto bisogno. Aveva visto giusto perché lo rividi solo dopo un anno e mezzo. Subito dopo la sua visita inviai una mia foto alla mamma sulla quale avevo scritto una dedica: “come mi ha trovato il babbo o quasi”: Sinceramente non é che sembrassi tanto raccomandabile.
Quando andavamo in libera uscita si stava sempre sul chi vive e dovevamo fare in modo di non essere mai soli se non volevamo avere delle brutte sorprese. Ne erano capitate ad alcuni dei nostri anche sul trenino che da Torino portava a Rivoli.
I primi morti “ammazzati ”, é il caso di dirlo, li avemmo quando un gruppo dei nostri fu inviato in Val di Susa. Caddero in un imboscata e non si salvò quasi nessuno e Teresio che era uno di loro, ferito cadde a terra; ricevette l'ultima raffica di mitra, ma se la cavò perché creduto morto. Si fece un bel pò di ospedale e come ricordo gli rimase la sordità ad un orecchio che a tutt’oggi sussiste.
In quei giorni vennero pure i genitori di Francesco e le sue due sorelle che conobbi in quella circostanza. Suo padre, molto gentilmente, invitò anche me a passare una giornata con tutti loro come uno di famiglia; ne fui favorevolmente impressionato e a guerra finita, ebbi modo di frequentarli assiduamente.
Intanto nella nostra caserma avvenivano fermenti strani e c’erano state delle forme di ribellione che chiamerei più contestazioni, contro alcuni ufficiali del battaglione. La conseguenza immediata fu una lunga serie di marce forzate e successivamente il reparto più turbolento, aggregato ad altri reparti di altre armi, fu inviato in val di Lanzo a Lanzo Torinese paese che per alcuni giorni era rimasto in mano dei partigiani. Partimmo tutti con grande entusiasmo anche perché ormai alla scuola l’aria era diventata irrespirabile e addirittura si parlava di fare una marcia su Brescia. Così, tutto sommato, fummo ben contenti di andarcene prima di trovarci ulteriormente inguaiati. Però in anteprima, forse per farci sbollire un poco gli ardenti spiriti, ci fecero fare una bella passeggiata a piedi da Rivoli a Torino e ritorno.
Rimanemmo a Lanzo per qualche tempo accasermati in cima al paese nel convento. In quel periodo mi lasciai crescere il pizzo.
Alcuni frati del convento si offrirono tramite la Croce Rossa, di inviare nostre notizie ai familiari via radio perché ormai non potevamo in alcun modo comunicare con loro, dato che il fronte di guerra si era assestato in Garfagnana sulla “linea gotica”, dividendo di fatto l’Italia in due spezzoni. I messaggi arrivarono a destinazione, ma questo lo venimmo a sapere a guerra finita.
Le scaramucce erano frequenti e specie di notte l'attività dei partigiani di faceva piuttosto intensa; ci furono anche delle imboscate e persino alcune ragazze del posto si prestarono ad intrappolare alcuni dei nostri usando l’arma della seduzione. Accettavano di appartarsi facendo loro credere ad un facile quanto insperato momento di intimità, con il solo scopo di farli cadere in imboscate mortali.

Luglio 1944. 1° Plotono della 1^ Compagnia della scuola All.Uff, della G.N.R.
Di Rivoli a Lanzo Torinese, al convento, in un momento di relax, prima di
Partire in azione verso i confini della Francia. Guerrieri è il 4° da sin. In alto
Erano delle vere “eroine”.
Fu proprio a seguito di uno di questi fatti, che io e Ciro ci offrimmo di scorta per portare a Torino con il camion due di quei caduti, avendo così l’opportunità di passare una giornata in città e poter andare inutile dire dove. Non sarà stato poetico, ma almeno non avremmo corso rischi di quel genere.
Forse fu anche per allentare un poco la pressione dei partigiani in questa zona, che venne organizzato un grosso rastrellamento che da Lanzo Torinese ci portò al confine della Francia. (5)
Al primo scontro avemmo alcune perdite e tra gli altri fu ferito malamente Franco in più parti dell’intestino. Aldo ed Enrico lo riportarono a valle su una scala di legno trovata sul posto a mo di barella e contrariamente ad ogni previsione, se la cavò per il rotto della cuffia. Io rimasi turbato per diverso tempo anche perché gli ero amico ed inoltre in più di una occasione avevo avuto modo di apprezzare la sua lealtà ed il suo coraggio.
In quel momento eravamo gomito a gomito e come lo vidi cadere ebbi una vera reazione di rabbia e un gran desiderio di vendicarlo. Senza prendere la pur minima cautela, feci l’eroe, salii di corsa quel pendio, andando contro quegli spari: ero proprio fuori di me anche perché avevo la convinzione che l’avessero ucciso. Invece, come ho detto, se la cavò anche se per un lungo periodo fu più di là che di qua. Pure con lui ci siamo rivisti da non molti anni ma purtroppo alcuni mesi fa ho saputo della sua morte.
Conquistato di slancio quel colle, sotto di noi si affacciò una vallata che aveva sul fondo un gran bosco; notammo tra gli alberi un certo movimento senz’altro dovuto a partigiani in fuga e mentre me ne stavo in piedi a guardare e riprendere fiato, sopraggiunsero, mettendosi al mio fianco, il sergente Gamba ed una camicia nera di un altro reparto che non conoscevo e che ad occhio e croce ritenni mio coetaneo. Successe tutto in un attimo, sentii quel ragazzo pronunciare la parola mamma, non urlata, non con forza o con la disperazione dell’ultimo anelito di vita, ma come si può dire ad un amico “ciao” e nello stesso istante lo vidi cadere a terra esangue. Solo allora udii lo sparo che lo aveva raggiunto al cuore.
Intanto era sopraggiunta la notte e fu deciso di passarla su quel piccolo colle; si era formata una fitta nebbia e non si vedeva un bel niente. Comunque fu un susseguirsi continuo di spari da ambo le parti anche se quasi certamente senza senso. La nostra Fiat era incandescente e credo proprio per nostra inesperienza; l’avevamo surriscaldata oltre misura e non avendo acqua a disposizione, usammo la nostra urina per raffreddarla un poco.
Come Dio volle cominciò ad albeggiare ed il sole in poco tempo dissipò quella nebbia. Era l’ora dopo una notte passata completamente in bianco e con il batticuore, perché, sia ha un bel dire, ma non era stato piacevole. Quella stessa sensazione l’ho provata molti anni dopo in mare con la barca a vela con le stesse condizioni di tempo. Non sai dove ti trovi, non sai chi e cosa hai davanti e ti senti veramente impotente.
Il grosso dei partigiani nella notte si era sganciato lasciando pochi uomini che poi, alle prime luci dell'alba, si eclissarono.
Proseguimmo la marcia arrivando prima a Lemie e successivamente a Cirié dove ci fermammo alcuni giorni accampandoci in paese dentro alcune case abbandonate.
Fu concordata una tregua d’armi e avemmo modo di conoscere e parlare con alcuni partigiani che approfittando di questa tregua erano venuti in paese, ma gli argomenti che ci univano erano ben pochi e da parte loro sembrava non sapessero dire altro che se venivamo fatti prigionieri, noi con la camicia nera, non avremmo avuto scampo e saremmo stati immediatamente fucilati. Non é che facessimo gran caso a questo tipo di intimidazioni perché per noi non era una novità, lo sapevamo benissimo. Però tengo a precisare, che per ricevere quel particolare trattamento, non é che fosse proprio indispensabile indossare la camicia nera. Comunque quel ritornello ci accompagnò per tutto il periodo della guerra.
Dormivamo per terra e di notte il freddo si faceva sentire, indossavamo la divisa estiva e non avevamo coperte.
Avevo conosciuto una vecchietta che abitava in una baita posta all'estremità del paese. Ci viveva sola con l’unica compagnia delle sue capre. Solo per caso ci ero capitato, ma pur senza un particolare il motivo, quella nonnetta mi aveva incuriosito. La sera l’andavo a trovare e le compravo un pò di latte che credo proprio fosse l'unica sua fonte di sostentamento, ma anche nel corso della giornata, quando gironzolavo per il paese senza una meta, non era raro ci facessi una scappata. La trovavo sempre davanti la porta della baita con il viso rivolto ai raggi del sole, seduta su una sedia di legno impagliata e come mi vedeva arrivare non nascondeva una certa irrequietezza. Incominciava a muoversi su quella sedia quasi come per darsi un contegno; poi mi porgeva uno sgabello e cominciava a parlarmi. Non capivo un sola parola perché si esprimeva in dialetto, ma era piacevole ascoltarla e credo che con quel vocino suadente, mi raccontasse tante belle cose. I suoi discorsi erano lunghi anche se intervallati da altrettante lunghe pause. Mi limitavo a sorriderle ritenendo questo l'unico mio modo per farle capire che apprezzavo il suo dire anche se non sapevo cosa rispondere. Non so fino a che punto se ne rendesse conto, ma senza alcuna ombra di dubbio una cosa era certa, che si sentiva appagata per il fatto stesso di sapersi ascoltata.
Una mattina all’alba, era appena terminata la tregua, fu impartito l’ordine di proseguire, ci inquadrammo e attraversammo il paese. Lei era come il solito davanti la porta della sua baita a carpire i primi raggi del Sole e pareva attendermi. Anche se confuso con gli altri, mi vide. Capii perfettamente dai suoi occhi, per un attimo incrociarono i miei, che sapeva di non più rivedermi. Si alzò con un certo sforzo dalla sedia appoggiandosi con tutte due le mani alla spalliera, si eresse come mai l’avevo vista fare e protese la mano destra verso di me, parve quasi toccarmi, tracciando nell’aria un segno che vidi nitido come inciso nella pietra. Più che benedire fu un gesto di protezione; mi ricordò un poco quando bambino mia madre stringeva il mio capo al suo seno per consolarmi su qualche cosa, ed io mi abbandonavo completamente a lei perché tutto ciò mi dava una grande serenità e tranquillità. Disse pure qualche cosa, perché vidi le sue labbra muoversi, ma il rumore dei nostri passi cadenzati sull’acciottolato, mi impedirono di ascoltare per l'ultima volta quella “suadente” voce.
Può sembrare ridicolo ma da quel giorno fui un privilegiato ed ebbi come la sensazione che quella mano alzata, come per incanto, avesse compiuto il miracolo di proteggermi e rendermi immune da qualsiasi “dardo” come fossi un novello Achille.
Certamente il desiderio di infondere a me stesso il convincimento di un qualche cosa che bene o male mi desse tranquillità, mi faceva vedere e immaginare cose surreali, ma comunque sia, da quel giorno raggiunsi una serenità ed un equilibrio che prima non sapevo esistessero.
Si procedeva in montagna e durante la notte il freddo si faceva sempre più intenso. Per avere un pò di calore (dormivamo all’addiaccio) ci tenevamo più vicini possibile, praticamente abbracciati l'un l'altro e nonostante questo, debbo confessare che una mattina al risveglio, mi trovai completamente bagnato senza neppure aver avvertito alcuno stimolo. Durante il giorno, al contrario, facevamo delle ricche sudate, in particolare coloro che come me, oltre l’armamento personale, portavano a tracolla due bombe di mortaio da 45 mm.
Arrivammo ai piedi del “Colle di Coup” e subito iniziammo l’arrampicata verso il passo. All’improvviso ci trovammo sotto il fuoco incrociato delle mitragliatrici che dall’alto dominavano completamente la gola nella quale stavamo procedendo e fu inevitabile che alcuni di noi fossero letteralmente falciati. Come Dio volle conquistammo la vetta ed ancora una volta i partigiani ci fecero vedere i loro di dietro. Per cavarsela dovettero fuggire sconfinando in Francia, ma non tutti perché una parte rimase intrappolata e fu fatta prigioniera dalla colonna tedesca che di concerto con noi, sempre in contatto radio, proveniva da un’altra vallata.
Ci fu anche il lato comico perchè qualche attimo prima che cominciassero gli spari, Francesco che mi precedeva di qualche metro, si era tirato giù i pantaloni per un impellente necessità. Come ebbe inizio la sparatoria, per lui fu necessario prendere una decisione, ma anziché tirarsi su i pantaloni e mettersi al riparo, eroicamente...... decise di restare allo “scoperto”, sedere incluso e porre fine a quell’incombenza che aveva iniziato, infischiandosene di tutti i rischi cui andava incontro, ma che per sua buona sorte, restarono solo tali.
L’operazione era pienamente riuscita ma sarebbe stato facile scommettere che come avessimo lasciato la zona, i partigiani sarebbero ritornati. Tutta l’operazione era stata condotta da un maggiore tedesco il quale era rimasto talmente contento di noi, che cercò tutti i pretesti possibili per tenerci con se e non farci ritornare alla scuola di Rivoli.
Successivamente ebbi una comunicazione informale nella quale mi si ventilava la possibilità di una proposta per l’assegnazione della croce di ferro di II° classe. Poi non ne seppi più niente ed io non mi preoccupai minimamente di verificare fino a che punto la cosa potesse essere vera.
Rientrammo a Rivoli. Il corso ormai volgeva al termine e per quanto ci riguardava non saremmo certamente diventati dei gran teorici, ma in quanto a pratica credo proprio non ci fosse niente da eccepire.
Però erano passati appena alcuni giorni che il nostro maggiore Deutsch, non so come, trovò il modo di farci fare un altra passeggiata e questa volta in una zona chiamata Vallo Torinese.
L'azione consisteva nella solita combinazione, noi da una parte e i tedeschi dall'altra a tenaglia e per i collegamenti questa volta avevamo un caporale tedesco e la sua radio. La sorpresa l’avemmo proprio da questo caporale che non fu mai capace di mettersi in contatto con l’altra colonna. In codice noi eravamo “Paola” e la colonna Tedesca “Dora” e questo povero cristo non faceva altro che chiamare: “hactung, hactung, Paola von Dora, Paola von Dora” ma senza risultato alcuno; da quella radio l’unico suono che riuscì a carpire, fu una musichetta di un ballabile niente male.
Non so dire se fu a causa di questo mancato collegamento o perché non avevamo prese tutte quelle precauzioni che la situazione richiedeva, fatto sta che cademmo in una imboscata.
Poteva andare peggio, ma anche meglio se al comandante della nostra colonna non fosse venuto in mente di fare l’eroe. Per non dare ai partigiani la “soddisfazione di vederci retrocedere”, queste furono le sue parole, ci lasciò completamente allo scoperto con il risultato che subimmo perdite che avremmo potuto evitare. Alla fine raggiungemmo ugualmente il risultato sperato e li mettemmo in fuga, ma quanto sarebbe stato meglio metterci subito al riparo, riorganizzarci e dopo contrattaccare.
Proseguendo dentro questo vallone e successivamente salendone il pendio, prima di sera arrivammo ad un piccolo gruppo di baite dove pernottammo dopo aver fatto una lauta cena a base di mele cotte in provvidenziali recipienti di rame trovati in loco. Non avevamo niente da mettere sotto i denti e quel frutto fu una manna dal cielo che ci permise di andare a dormire con in pancia qualche cosa di caldo. Tutto questo perché avremmo dovuto ricongiungerci con l’altra colonna nell’arco della giornata, ma non era stato possibile anche a seguito dell’attacco subito e, aggiungo io, perché questa azione peccò di eccessiva leggerezza a tutti i livelli.
Comunque e lo dico a titolo di consolazione, non poteva esserci opportunità migliore per apprezzare appieno la bontà di quelle mele.
Quest'ultima avventura per fortuna fu di poco durata e ci permise, anche se all'ultimo tuffo, di andare finalmente a Torino e affrontare alla caserma Cernaia assieme agli allievi di tutte le altre scuole, l’esame per sottotenente di complemento della G.N.R.
Andò tutto
bene considerando il poco tempo dedicato allo studio e pure la graduatoria
risultò abbastanza soddisfacente; ottenni il 741 posto su 2175 candidati,
Bollettino del 16 Novembre 1944.
Diciamo che mio padre ammesso ne fosse venuto a conoscenza, ne sarebbe
stato “relativamente” soddisfatto. (6)

1944/45. Di prima nomina nella San Marco a Quiliano, con un piccolo amico
Di prima nomina fummo inviati a Brescia e appena arrivati, avemmo una breve licenza, praticamente la prima da quando eravamo al nord. Molti di noi che avevano la famiglia a sud della linea Gotica, non sapevano dove andare. Io fui fortunato perché avevo l'indirizzo di Maurizio, un lontano parente che abitava a Voghera e che mi ospitò per qualche giorno; suo tramite ebbi pure modo di conoscere Alfredo, un lucchese che aveva il grado di capitano. Stava in un ufficio e proprio non ho mai capito quali fossero esattamente le sue mansioni; mi propose di rimanere con lui e se ero d’accordo, avrebbe provveduto a fare la richiesta. Ritengo che fosse stata un imbeccata di Maurizio che fece di tutto per convincermi, ma comunque rifiutai; avevo altri progetti e avessi accettato mi sarei ritenuto un codardo. Alfredo, a guerra finita, quando cominciai a lavorare, per quasi trenta anni fu il mio consulente fiscale e amministratore essendo laureato in economia e commercio.
Successivamente il fratello di Maurizio, Enzo, come seppe della mia presenza a Voghera, mi volle ospitare qualche giorno pure lui; accettai di buon grado e andai a Milano. Fu proprio in quell’occasione che conobbi una ragazza che poi risultò essere l’unica relazione seria di questi due anni passati al nord. In seguito ebbi modo di incontrarla in più di una occasione e l’ultima volta che la rividi fu subito dopo la guerra, nel 1946, ma ormai l'incantesimo si era rotto. Non ho memoria se per lei fu un addio triste o meno, comunque per quanto mi riguardava, anche se breve fu più di una semplice avventura ed a distanza di tanti anni continuo ad averne un buon ricordo. Ebbe inizio una sera a Milano in centro, nei pressi della galleria, complice un allarme aereo.
Ritornato a Brescia io ed Enrico avemmo un’avventura che ancor oggi a distanza di cinquant'anni, quando ci incontriamo ricordiamo volentieri, non senza un pizzico di nostalgia. Avevamo conosciuto due ausiliarie che si dimostrarono molto disponibili. Anche se rapate a zero dai partigiani erano ugualmente molto belle ed ebbero il grande merito di renderci la permanenza a Brescia oltremodo piacevole.
Intanto assieme a Ciro che aveva passato il periodo di licenza in città, avevo fatto la domanda di trasferimento nella “divisione S. Marco” (fanteria di marina) che nel frattempo, dopo un periodo di addestramento effettuato in Germania, era rientrata in Italia ed essendo entrambi della leva di mare, fu subito accettata. Questo desiderio maturato negli ultimi mesi era fortemente motivato dalla nostra volontà di voler andare in un reparto operante al fronte, perché e lo avevamo capito benissimo, restando nella G. N.R. avremmo passato il resto della guerra alla migliore delle ipotesi a presidiare qualche piccolo centro. La S. Marco era stata dislocata lungo la riviera ligure e con alcuni reparti (battaglione Uccelli) pure sulla linea “Gotica” ed era proprio dove noi volevamo andare, anche se poi rimase sempre e solo un sogno, salvo qualche sporadica e occasionale puntata di servizio.
Ricordando questi particolari e soprattutto certi atteggiamenti, che poi non erano una rarità perché condivisi da una buona parte di tutti noi, oggi possono meravigliare ed essere considerati eccessivi.
Potremmo essere scambiati per degli infatuati o degli esaltati. In realtà erano sentimenti genuini che quanto meno avevano il merito di di essere stati in precedenza ben ponderati: c’era la consapevolezza che le loro conseguenze, nel bene e nel male, sarebbero ricadute solo ed esclusivamente sulla nostra pelle.
Pochi giorni dopo avemmo l’ordine di presentarci al comando di divisione ad Altare.
Facemmo il viaggio fino a Savona in treno e proseguimmo per Altare in parte a piedi ed in parte con l’autostop su un camion militare. Una volta giunti ci dette il benvenuto il generale Farina che subito dopo ci inviò a Cadibona al comando di battaglione. A seguito della nostra richiesta di poter restare assieme, lo stesso comandante ci destinò alla compagnia dislocata a Quiliano.
Cosi rifacemmo la strada fino a Savona sempre su un camion militare ed una volta imboccata l’Aurelia, poco dopo, come arrivammo al bivio che conduce a Quiliano; scendemmo dal camion e ci incamminammo “pedibus calcantibus”.
Questa strada seguiva a ritroso il percorso di un piccolo fiume ormai al termine del suo viaggio avendo la foce poco distante. Non sarebbe passato molto tempo che ne avremmo conosciuto ogni curva e ogni anfratto, dovendo transitarla quasi quotidianamente, ma sin da allora ci fu chiaro di quanto fosse adatta per imboscate.
Come Dio volle arrivammo in vista del paese e dato che nella notte aveva abbondantemente nevicato, l’accoglienza che ricevemmo appena entrati, non poteva essere migliore. Alcune ragazze che forse avevano voglia di ruzzare, ci accolsero a pallate di neve e noi non ci facemmo certo pregare nel rispondere al fuoco.... ingaggiando così una piccola battaglia. Ne fummo oltre che divertiti, anche favorevolmente impressionati, ritenendo questa simpatica accoglienza anche di buon auspicio per la nostra permanenza in quel paese.
Il comando di compagnia era accasermato nella parte alta dentro un convento. I marò presidiavano il paese e tutta la zona attorno fino a Zinola e noi avevamo dato il cambio a due tenenti trasferiti altrove. Questi ufficiali, uno in particolare, che per l’esattezza avrei sostituito io, erano tenuti dai loro subalterni nella massima considerazione e non ce ne fecero un mistero. A noi fu subito chiaro, specie per i primi tempi, che sarebbe stata dura e che non avremmo avuto vita facile. Tutte le nostre decisioni ed azioni, sarebbero state vagliate e confrontate con chi ci aveva preceduto. Questi marò avevano passato momenti difficili lo sapevo per certo e si vede che il comportamento del loro diretto superiore era stato all’altezza della situazione a tal punto, da guadagnarsi la stima di tutti loro. Era il massimo e fu inevitabile chiederci se mai ne saremmo stati all’altezza.
Ci consegnarono le nuove divise ma continuammo a tenere la camicia nera che avremmo dovuto sostituire con quella grigio verde. Non so perché lo facemmo, forse per un senso in colpa per aver cambiato arma o più ancora perché era un modo per sentirci ancora legati agli amici e camerati che avevamo lasciato nella “G.N.R.” (7)
Il capitano comandante della compagnia, un Triestino, a me fece un ottima impressione e mi parve molto simpatico ed alla mano.
Destinò Ciro a Zinola al comando di un bunker che si trovava sull’Aurelia vicino al mare, mentre io sarei rimasto in paese. Il mio reparto era alloggiato all’estrema periferia dell’abitato in direzione dei monti in una cappella conosciuta come “la Madonnina”. Ci son tornato tanti anni dopo la fine della guerra una sola volta, ma non esisteva più, forse abbattuta per esigenze di viabilità. Il capitano aggiunse pure che il mio compito non si esauriva qui perché il mio vero incarico era “addetto” al comando di divisione, come dire che dipendevo a tutti gli effetti da Altare. (8)
La prima notte la passai ospite di una famiglia in paese e successivamente, mi fu trovato un alloggio in una casa di contadini poco distante dalla Madonnina. Erano appena passati alcuni giorni che già mi sentivo a mio agio ed anche se di prima nomina, non trovavo difficoltà alcuna a sbrigare nel migliore dei modi tutto quello che era da ritenersi la routine di tutti a giorni. Cercavo é vero di fare del mio meglio e rendere al massimo, ma stavo anche molto attento a non dare ai miei marò l'impressione di voler emulare chi mi aveva preceduto. Avendo cominciato a muovere i primi passi in modo giusto, non accettai di buon grado la comunicazione di presentarmi al comando di Altare. Appena giunto, il generale Farina, dopo essersi interessato come un buon padre di famiglia sulla mia sistemazione e quella di Ciro a Quiliano, mi comunicò che sarei dovuto andare ad Acqui, da dove sarei stato dirottato in una località di montagna per fare un corso di specializzazione per l’armamento tedesco e prima di congedarmi aggiunse: «ci rivedremo molto presto»
La divisione S. Marco, come del resto tutte le altre divisioni che avevano fatto il corso di preparazione in Germania, nel rientrare in Italia, era completamente equipaggiata con armamento tedesco e così era scontato che pure io facessi un corso di aggiornamento per familiarizzare con queste armi.
Ebbi modo di prendere confidenza con la “MG”, il “pugno di ferro”, il “tubo da stufa” e non mi fu negato un saggio con il cannone da “88” che risultò essere un arma adatta a tutti gli usi.
Una sera, faceva un freddo cane ed ero andato a letto abbastanza presto, come un fantasma uscito dalla bufera di neve che fuori imperversava, mi vidi comparire davanti Giuseppe “giggé” con il quale per tre anni ero stato nello stesso corso il “Freccia” al navale di Venezia ed ancora oggi mi domando come avesse fatto a trovarmi. Erano piccoli miracoli che solo lui sapeva fare e di questo ebbi modo di accertarmene negli anni a venire. Come tanti di noi era partito volontario ed a guerra finita era sconfinato in Francia. Arruolatosi nella Legione Straniera e mandato a combattere in Indocina, ottenne la cittadinanza Francese. Ma tutto questo lo venni a sapere da lui medesimo dopo la guerra negli innumerevoli incontri che abbiamo avuto nel corso degli anni. Ormai credo proprio sia morto.
Tornato a Quiliano, durante la mia assenza la situazione era peggiorata in particolar modo alla Madonnina forse per la sua posizione decentrata ed a ridosso dei monti. Fu per questo che decisi di trasferirmi definitivamente in quella chiesetta dormendo in una brandina assieme ai marò e subito capii che era stata una mossa felice e lungi da passare inosservata, fu molto apprezzata. A me inoltre dette la possibilità di fraternizzare con tutti loro ed imparare a conoscerli meglio. Solo allora venni a sapere che nel mio reparto c’era un marò di Lucca.
Non nascondo che mi era dispiaciuto lasciare la camera che avevo avuto sia pure per breve tempo, ma più di ogni altra cosa rimpiangevo l’opportunità che avevo di passare qualche serata vicino al fuoco del caminetto posto nella cucina di quella casa e di non poter gustare al mattino quelle colazioni che la padrona mi preparava, a base di latte con polenta dolce di castagne, o con castagne secche. Per me era una novità e non so se era una consuetudine del posto, od un ripiego dovuto alla carenza di pane.
Un giorno, a seguito di una delle chiamate da Altare che ormai si facevano sempre più frequenti, mi fu consegnata una cartina militare della zona sulla quale erano stati evidenziati con una matita colorata vari punti e sui quali, una volta localizzati sul terreno, avrei dovuto segnare con dei picchetti a seconda dei casi, la posizione più idonea per postazioni antiaeree, bunker, nidi di mitragliatrici, trincee ecc. All’occorrenza, in caso di sbarco degli alleati, qualora fossero riusciti a superare il bagno asciuga, per impedirne il dilagare, sarebbero stati i punti chiave di riferimento sui quali articolare tutta la difesa di quella zona. Per la loro realizzazione successivamente avrebbe dovuto provvedere l’organizzazione “Tods.” Cosi era chiamato quel corpo di civili adibito ad effettuare lavori per lo più a carattere militare.
L’operazione richiese alcuni giorni e per me e i due marò che mi accompagnavano fu una faticaccia perché andare su e giù per i monti innevati come erano, tutto era più difficile sia il procedere che l’individuare le varie posizioni. Non ultimo, in qualsiasi momento eravamo soggetti ad imboscate e così la cautela non era mai troppa e dovevamo stare sempre sul chi vive. Di particolarmente impegnativo ci capitò solo una mattina quando all'improvviso ci trovammo di fronte alcuni armati che non avemmo difficoltà a riconoscere come partigiani. Appena ci videro, scaricarono su di noi i loro mitra; pure noi facemmo fuoco, ma senza risultato, a parte il fatto di vederli scappare giù per i prati a rotta di collo, anche perché l’incontro era avvenuto a breve distanza e aveva trovato sia noi che loro totalmente impreparati.
Queste gite in montagna mi avevano fatto un esperto della zona, o almeno così lo ritenne il comando di divisione e fu un motivo più che valido affinché da allora, qualsiasi azione di rastrellamento venisse fatta, il mio reparto non poteva mancare. In più di una occasione mi era capitato di partire ed andare in mezzo ai monti incontro a colonne che magari provenivano da Altare o da Cadibona.
Successe che una sera, era notte fonda, in compagnia di due marò, nel rientrare alla Madonnina, provenienti da un bar del paese dove qualche volta prima di coricarmi andavo a prendere un caffè, passando sotto un porticato che fiancheggiava la strada del paese, avemmo l’impressione di udire un lamento. Sul momento non ci facemmo gran caso, ma come ci avvicinammo al portone d’ingresso che portava alle abitazioni, il lamento si ripeté e questo volta fu udito distintamente da tutti. Detti una spallata alla porta e mi ritrovai in un androne buio pesto. Urlai “chi va là”, una lampadina elettrica mi accecò e contemporaneamente partirono alcuni spari, che fortunatamente non mi colpirono; poi un rumore di passi che si allontanavano.
A mia volta tolsi la pistola dal fodero e sparai gridando: «arrendetevi». La mia intimidazione fu un gesto istintivo, direi naturale, non aveva certo la pretesa di ottenere alcun risultato ed invece la risposta non si fece attendere perché dopo due o tre secondi udii una voce che diceva: «ci arrendiamo».
Erano entrati anche i due marò che in un primo momento, su mio ordine, erano rimasti fuori ed assieme raggiungemmo due partigiani, lo sapemmo subito dopo, i quali nella fuga si erano trovati intrappolati perché quell’ingresso conduceva da una parte alle scale degli appartamenti dei piani superiori e di fronte sfociava in un cortiletto interno circondato da un muro piuttosto alto che faceva da confine con i giardini di altre proprietà. Era quella la via che avevano scelto per la fuga, ma senza molta fortuna proprio per quel provvidenziale muretto. Mentre i marò armi in pugno li tenevano a bada, io con la loro stessa lampadina feci un pò di luce e in terra trovai le due pistole con le quali mi avevano sparato.
Aprendo il portone, proprio sul retro, più che visto avevo intuito ci fosse come un grosso fagotto ed era da quel punto che provenivano i lamenti, ma avendo ben altro da pensare ero passato oltre; ora che quei due erano stati immobilizzati, ritornando sui miei passi, ne ebbi la conferma; quel fagotto non era altro che una donna legata imbavagliata e con sopra il capo una coperta che come la sollevai, alla luce della lampada mi apparvero due occhi spalancati e terrorizzati. Era quello il soggetto per il quale si erano “inguaiati” quei due perché, lo seppi da loro stessi poco dopo, avevano ricevuto l’ordine di sequestrare quella poveretta per portarla sui monti, dove sarebbe stata processata e certamente condannata a morte per una grave colpa: era la sorella di un “gerarca fascista”, o qualche cosa del genere.
Per arrivare alla caserma che era dalla parte opposta, dovemmo attraversare tutto il paese e come fummo nel ben mezzo una voce di donna ruppe il silenzio. Gridava e invocava che non fosse fatto del male a suo figlio; certamente era al corrente della prodezza alla quale era stato incaricato e al rumore degli spari aveva capito che era stato scoperto.
Scesa in strada e si era aggrappata a uno dei due, quello che ritenni fosse suo figlio e non lo mollava. Era una scena straziante ma io non avevo scelta. Cosa potevo fare? Tentai di calmarla e convincerla di ritornare in casa e finalmente ci riuscii anche grazie all’aiuto di altre donne che nel frattempo erano sopraggiunte.
Come Dio volle arrivammo alla caserma, da un sommario interrogatorio venimmo a sapere che il più robusto dei due, che poteva avere venticinque anni, aveva il nome di battaglia lupo, mentre l’altro piuttosto mingherlino, non superava i venti anni si faceva chiamare giaguaro.
Messi a confronto cominciarono ad accusarsi a vicenda; specie giaguaro, che era del paese e figlio di quella donna che si era messa ad urlare, cercava di scagionarsi rinfacciando all’altro di averlo spinto in quell’impresa ed era facilmente deducibile che la scelta era caduta su di lui proprio per la conoscenza che aveva del paese.
Si presero qualche “sganassone” era il minimo che poteva loro capitare ed il giorno successivo furono portati via, credo a Savona.
Sapevo che la loro sorte molto dipendeva da quello che avrei scritto nel rapporto e per questo sorvolai sul fatto che erano armati e che mi avevano sparato, altrimenti non avrebbero avuto scampo.
Ovviamente la donna che bene o male avevo tolto dai guai, per tutta la notte tra un pianto e l’altro, non fece che ripetermi che senza il mio provvidenziale intervento l’avrebbero uccisa.
Partì il mattino successivo e un bel giorno, quando ormai non pensavo più a quell’episodio, ricevetti una sua bellissima lettera nella quale ancora una volta esternava tutta la sua gratitudine. Quella lettera la tenni nel portafoglio per un certo periodo e la distrussi prima di cadere prigioniero.
Nei giorni successivi a questo episodio avemmo molte imboscate specie nel tratto tra Zinola e Quiliano lungo il fiume e sempre quando transitava qualche marò isolato.
In una di queste imboscate fu ucciso un ragazzo del mio plotone e fu proprio a seguito di questa morte che ricevetti un biglietto anonimo nel quale mi si invitava per l’indomani in un albergo di Savona dove avrei avuto informazioni della massima riservatezza.
In un primo momento rimasi sconcertato e titubante se aderire o meno a quell’invio. Chi avevo messo al corrente della cosa mi sconsigliava perché riteneva si trattasse quasi certamente di un tranello, ma la curiosità era forte ed ebbe la meglio sulla paura. L’indomani mi presentai puntuale all’albergo indicato.
Dopo qualche minuto che aspettavo nella hall mi si fece incontro una signora ben portante e non senza un certo fascino, così almeno la ricordo che poteva avere massimo trent’anni e pregandomi di seguirla, mi fece strada fino ad una camera, che senz'altro aveva precedentemente prenotato.
Per un attimo mi balenò l’idea di una avventura galante, c'erano tutti i presupposti, ma come cominciò a parlare mi vergognai di quel pensiero e dovetti ricredermi. Si trattava di ben altra cosa.
Non vista e casualmente, quella signora si era trovata ad assistere all’uccisione del mio marò. Raccontò con dovizia di particolari il trattamento che gli era stato riservato e come avevano inveito su quel povero corpo prima di essere ucciso. Ne era rimasta così scossa che aveva deciso di parlarne con me in quanto dai paesani ero stato indicato come il diretto superiore di quel ragazzo.
Aggiunse pure che a Montagna, un paese che distava pochi chilometri da Quiliano, la sera a notte fonda, c’era un certo movimento di persone non del luogo che apparivano e poi, nei pressi di una fontana che era proprio sulla strada del paese, sparivano; aveva avuto modo di notarlo lei di persona ed in varie occasioni.
Non seppe o non volle aggiungere altro, ma ci tenne a precisare che quella era gente di primo piano della “resistenza” e comunque lasciava a me decidere sull’importanza di questa notizia.
Come era mio dovere misi il comando al corrente di quanto avevo saputo e fu deciso, anche se con molti dubbi, di effettuare un’azione l’indomani mattina.
Montagna almeno all’epoca, era un piccolo borgo piuttosto bruttino, che si trovava ai piedi di una collinetta sulla cui sommità era installata una postazione antiaerea tedesca.
I tedeschi, ovviamente avvisati, si dissero disponibili a collaborare per il buon esito dell’operazione ed ebbero l’incarico di mettere un posto di blocco a nord del paese.
Un reparto che proveniva da Vado doveva bloccare le zone a sud ed ovest, mentre il plotone che partiva da Quiliano e che era al mio comando, sarebbe entrato in paese da est lasciando parte degli uomini fuori per completare l’accerchiamento. Gli altri, una volta in paese, avrebbero dovuto individuare quello che si pensava fosse un covo di partigiani e se ce ne fossero stati, non avrebbero avuto via di scampo.
Il trasferimento lo iniziai prima dell'alba, quando ancora era notte ed a piedi visto che la distanza che separava le due località non era molta. L’operazione vera e propria ebbe inizio quando ormai era pieno giorno ed entrando in paese fu abbastanza facile, con le indicazioni che avevo avuto, individuare la zona.
Come vidi la fontana in bella mostra sulla strada, pensai che il più era fatto.
Al contrario per quanto ci si desse da fare, non trovammo niente che ci facesse supporre di essere vicini a quello che cercavamo. Eppure ero sicuro che quella signora non aveva mentito; che interesse avrebbe avuto a farlo? Tutto quello che mi aveva detto era stata una sua precisa scelta e rischiando anche molto, perciò non mi restava che continuare a cercare.
Questi pensieri mi passavano per la testa mentre stavo entrando in una stalla completamente vuota; da una porta attigua usciva un forte tanfo di stalla e come entrai, mi trovai davanti ad una grande buca rettangolare ricolma di letame, che raggiungeva l’orlo del pavimento e praticamente, meno un piccolo passaggio, occupava tutta la stanza.
Un marò’, inavvertitamente si spinse oltre, perse l’equilibrio e si trovò immerso fino alla vita in quel ben di Dio. Per non peggiorare ulteriormente la sua situazione e non cadere, con l’unica mano che aveva libera, dato che con l’altra teneva ben stretto il fucile sopra la testa, si appoggiò al muro di fronte, subito sopra quella poltiglia ma nel punto giusto, perché miracolo ben mimetizzata, come per incanto apparve ai nostri occhi una apertura appena sufficiente al passaggio di una persona. Non ebbi il minimo dubbio, era quello che cercavamo.
Non persi tempo, per superare senza danni quell’ostacolo, cercai una tavola di legno che messa come passerella, mi permise di raggiungere e oltrepassare senza danni quel buco. Mi ritrovai in una stanza non molto grande ma che mi parve abbastanza accogliente e nella quale, lo notai subito, c’era pure la corrente elettrica. Non avevo preso alcuna precauzione per la fretta di entrare ma per mia fortuna non c’era nessuno, altrimenti chissà come me la sarei cavata.
In quella stanza oltre che alcune sedie e un tavolo, non c'era altro. In un altro locale attiguo trovai varie armi allineate in buon ordine e ben conservate: alcune erano tedesche altre russe altre ancora americane.
Ritornai alla prima stanza che, anche se tutto sommato spoglia, da come era tenuta si capiva che era un luogo riservato e frequentato da poche persone. Mi avevano incuriosito alcuni quaderni lasciati alla rinfusa sul tavolo forse da qualcuno che aveva avuto piuttosto fretta e che si era guardato bene di perdere del tempo per metterli in ordine o meglio ancora di nasconderli.
Ci detti una scorsa e un quaderno mi parve particolarmente interessante. C’erano scritti i nomi di varie persone, ma la prima cosa che notai fu nel leggere alcuni di questi nomi che ebbi la certezza di aver già sentito, insomma non mi erano del tutto nuovi. Erano scritti uno per ogni riga e ben incolonnati. Mi sovvennni, si trattava di gente sparita da Quiliano senza un apparente motivo e che non ci aveva più fatto ritorno. La risposta era in quel quaderno. Sulla destra a lato di ogni nome in modo ripetitivo e meticoloso era evidenziata la parola: “giustiziato”.
Pensare che nel paese correva voce che noi repubblichini, come ci chiamavano, non eravamo estranei a queste sparizioni. Non occorreva tanta fantasia per capire che era una notizia fatta trapelare ad arte.
Trascurai gli altri quaderni perché tra alcuni timbri che avevo trovato messi alla rinfusa nel cassetto di quel tavolo, uno in particolare mi aveva incuriosito e che poi risultò essere importante. C’era disegnata la stella rossa con la scritta “comando di divisione della Liguria.”
La spiegazione al racconto di quella signora era tutta in quel timbro. Mi trovavo nel covo del comando partigiano della Liguria, o quanto meno in uno dei suoi vari nascondigli e senza ombra di dubbio “molto ben frequentato” se si pensa a parte le armi, all’importanza del materiale trovato. Era un rifugio ben nascosto, senza finestre e dall’esterno non c’era assolutamente modo di capire della sua esistenza.
Portammo via tutto quanto, feci scegliere ai miei ragazzi le armi che volevano e consegnammo il resto al nostro comando. Naturalmente non dissi niente ai miei superiori, fu una mia iniziativa che in quel momento, visto come erano andate le cose, ritenni fosse più che legittima. Ora tutti indistintamente avevamo armi automatiche anche se di varie provenienze.
Non so se questa azione all’atto pratico ci portò dei risultati, ma senz'altro creò non poco scompiglio nelle file partigiane; vennero scoperte molte delle loro malefatte che il più delle volte venivano attribuite a noi e quei timbri risultarono utili nel compilare documenti e lasciapassare falsi.
Bisogna pensare che ormai si era agli sgoccioli. I reparti dei partigiani ogni giorno che passava si organizzavano sempre meglio, erano sempre più armati e con l'ausilio dei russi paracadutati in alcune zone, ormai avevano veri e propri accampamenti e in determinate situazioni, un lasciapassare poteva risultare utile.
Non ho mai saputo che fine facessero quei documenti veramente scottanti e ritengo che a guerra finita siano ritornati in mano dei partigiani e da loro distrutti.
Papà Farina difficilmente si dimenticava di me e mi teneva sempre sotto pressione, così fu inevitabile che in poco tempo, tra i vari reparti, raggiungessi una certa notorietà e per loro divenni il tenente nero. Casualmente un giorno ebbi l’opportunità di rendermi conto che quanto avevo carpito dai bisbigli e mezze frasi dei miei marò, era tutto vero.
Per andare ad Altare normalmente facevo l'autostop approfittando dei camion della divisione che continuamente passavano e facevano la spola lungo l'Aurelia e la strada che da Savona portava al comando di divisione. Un posto in cabina lo trovavo sempre e con il freddo che faceva era ben accetto. Quel giorno al contrario dovetti salire sul retro del camion che in parte era già occupato da alcuni marò. Come fui sopra non mi ci volle molto per capire di essere diventato immediatamente il centro della loro attenzione. Parlottavano a mezza bocca e mi sbirciavano; io non sapevo cosa pensare, quando finalmente uno di loro, forse più deciso degli altri, mi rivolse la parola: «Comandante ma lei non é il tenente nero?» Non mi aspettavo certo una simile domanda che onestamente mi trovò completamente impreparato e non ricordo cosa seppi rispondere, ma rammento benissimo che mi venne da ridere, perché mi fu palese il motivo per il quale mi avevano appiccicato quel nome.
La camicia nera che portavo “fuori ordinanza” e la continua presenza nelle varie operazioni, le due cose collegate assieme, credo avessero creato nei marò o quanto meno in alcuni di loro, una certa considerazione nei miei confronti, ad di la dei meriti o demeriti. Nel modo in cui mi fu formulata quella domanda, senza ombra di dubbio era una manifestazione di stima e non certo una banale curiosità e questo, mi fece un gran piacere.
Sapevano perfettamente i rischi che correvo nel portare quella camicia in particolare se cadevo prigioniero dei partigiani, ma io in tutta onestà non lo consideravo un atto di coraggio, ma era diventata più che altro, una scommessa con me stesso. (9)
Una sera mi capitò di essere chiamato a far parte della giuria tutta formata da ufficiali, per processare un marò che aveva commesso non ricordo quale reato. Fu l'unica volta che venne a prendermi una macchina del comando direttamente da Altare, forse perché era stata una decisione presa sul momento e che il generale voleva risolvere la sera stessa. Il tribunale militare di guerra a Cairo Montenotte allestì un processo in piena regola. Solo a notte fonda ci fu il verdetto con la condanna dell’imputato a scontare un certo periodo di tempo in un campo di concentramento in Germania. (1O)
Il Generale Farina che presiedeva la giuria, non alzò un dito a favore dell'imputato; teneva moltissimo al buon nome della divisione ed alla sua immagine agli occhi della popolazione civile e questo forse fu determinante nel non voler concedersi debolezza alcuna, al contrario di come si era comportato in altre circostanze.
Lo ricordo come un uomo tutto di un pezzo che aveva i suoi princìpi ai quali non intendeva rinunciare. Basti pensare che pur ritenendo giusto e doveroso combattere i partigiani, quando ne moriva qualcuno, il loro posto era accanto ai nostri caduti nel cimitero di Altare “l'ultimo battaglione della divisione, il battaglione delle croci bianche presidio per l’eternità a guardia sopra le stelle”(11)
Non tralasciava occasione per ricordarci che una volta morti eravamo tutti uguali e perciò era giusto che al di là di ogni ideologia, i morti avessero diritto ad una degna sepoltura e quale posto migliore se non nel cimitero che lui fortemente aveva voluto e realizzato. Quello che in vita non eravamo capaci di fare, che almeno nella morte si fosse uniti e come in un fraterno abbraccio ci coprissero le stesse zolle di terra.
Realizzò quello che ancor oggi dopo cinquanta anni i nostri governanti non sono riusciti, meglio dire che non hanno voluto fare cercando tutti i mezzi di mantenere vivo l’odio anche oltre la morte, contro di noi perdenti.
Naturalmente queste erano tutte breve parentesi, perché subito dopo mi ritrovavo alla Madonnina con i miei marò che ormai, ne ero certo, mi avrebbero seguito anche all'Inferno.
Almeno una volta o due la settimana si andava a Vado in una fabbrica dove c’era l’opportunità di disporre di alcune docce degli operai e poter fare le nostre pulizie. Mentre una parte di noi si lavava, l’altra faceva la guardia per evitare brutte sorprese e all’occorrenza, non farci trovare impreparati. Ormai non potevamo ritenerci al sicuro in nessun luogo e dovevamo stare sempre sul chi vive.
A seguito di una conoscenza che avevo avuto con una ragazza del posto, qualche sera passavo con lei momenti di intimità e anche se può sembrare eccessivo, pure in quei momenti tenevo sempre a portata di mano la pistola, pallottola in canna e senza sicura.
Il tratto di strada che divideva la Madonnina dal paese, per necessità di servizio, lo facevo più volte al giorno e la mattina sempre alla stessa ora, salivo al comando di compagnia per le consegne della giornata e per ricevere se c’erano, le disposizioni che mi venivano direttamente da Altare. Dopo circa trenta minuti tornavo in dietro, mi fermavo al bar il tempo per prendere un caffè e proseguivo.
Anche quel giorno feci le stesse cose, solo sostai due minuti al negozio del fornaio per scambiare qualche parola con la figlia del proprietario, una gran bella ragazza che avevo conosciuto il primo giorno del mio arrivo in occasione di quella piccola battaglia con palle di neve e proseguii subito dopo verso la nostra chiesetta.
Il tratto tra le ultime case del paese e la Madonnina, come già detto, era molto breve e mai mi ero posto il problema di un qualche pericolo e tanto meno di imboscate specie in pieno giorno. Invece quella mattina non ebbi neppure il tempo di rendermi conto di cosa stava succedendo, che due individui nascosti tra i cespugli che si trovavano sulla destra della strada, uscirono allo scoperto ed uno di essi mi saltò addosso trascinandomi a terra. Rotolammo nella polvere cercando uno di avere il sopravvento sull’altro e non so esattamente come fu, ma riuscii ad estrarre la pistola e sparare un colpo a bruciapelo. In quel momento io ero sotto di lui, lo sentii mollare la presa e tutto il suo peso fu su di me. Lo credetti morto.
Intanto ci furono altri spari e come mi liberai da quel corpo e mi alzai, vidi poco distante in mezzo alla strada il mio sergente a terra e sanguinante. Era successo che essendo poco lontano dal punto dell’aggressione, si era precipitato nell’intento di darmi una mano, ma purtroppo non aveva visto il secondo partigiano che defilato faceva da palo e che, prima di darsi alla fuga, non ebbe difficoltà a centrarlo con alcuni colpi di mitra. Per fortuna non fu ferito in modo grave. (25)
In quel momento il mio primo pensiero fu di soccorrere il Sergente e assieme ad altri marò che nel frattempo erano sopraggiunti, lo portai alla caserma e dopo una sommaria medicazione, fu trasportato con una macchina all’ospedale di Savona. Io ancora sporco di sangue e tutto polveroso, tornai verso la Madonnina per darmi una pulita, ma come fui nel punto dell’imboscata, il mio aggressore era sparito e in mezzo alla strada, al suo posto ora c’era solo una strana macchia di poltiglia fangosa.
Certamente nelle vicinanze assieme a quei due, c’erano altri partigiani i quali, come la zona rimase deserta, ne approfittarono e si portarono via il loro compagno. Successivamente venni a sapere che le cose erano andate in quel modo ed inoltre il mio aggressore anche se ferito, non era morto.
La versione che fu data di questo episodio era che mi volevano sequestrare, portare sui monti, processare e aggiungere il mio nome in un libretto simile a quello che avevo trovato in quel covo nel paese di Montagna con a lato la scritta “giustiziato”.
Infatti se volevano uccidermi e basta, per loro sarebbe stato molto facile sia in quella occasione che in tante altre, ma si vede che le loro intenzioni erano ben altre e molto più raffinare. Devo dire grazie al cielo, perché, così facendo, pur non non avendone la certezza assoluta, quelle “particolari” attenzioni, mi avevano salvato la vita.
Il sergente che per venire in mio soccorso si era preso una pallottola, finì la guerra in ospedale, mentre io, che volente o nolente mi ero messo troppo in evidenza, avrei dovuto aspettarmi qualsiasi sorpresa perché, ormai era certo che in qualche modo me l’avrebbero fatta pagare cara. Mi era capitato di trovarmi in tante e tali situazioni, che ormai ero noto tra i partigiani, notorietà della quale, ben volentieri ne avrei fatto a meno.
Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, essendo alle dirette dipendenze del comando di divisione, molto spesso mi capitava di essere chiamato ad Altare al quartier generale della divisione e ricevere ordini direttamente dal generale Farina.
Anche in quella circostanza che poi fu l’ultima volta che lo vidi, ebbi l’incarico di trasferirmi con il reparto che in quel momento avevo alle dipendenze, in tutto trenta marò inclusi un sott'ufficiale e due graduati guastatori, da Quiliano alla fortezza di Savona. Sarei stato completamente autonomo e solo alle sue dirette dipendenze. L'unico vero ordine che in quella circostanza sapevo di dovere eseguire alla lettera era: in caso di sbarco nemico, resistenza era ad oltranza. Per quanto altro dovevo attenermi alla routine di tutti i giorni e alle eventuali comunicazioni del comando di divisione.
Prima di trasferirmi una mattina fu preso di mira il mio avamposto con il fuoco incrociato di armi automatiche. Sparavano dalle alture ma la precisione del tiro mi fece pensare che usassero mitragliatrici.
Comunque non ci furono né feriti né morti e il sottoscritto deve ringraziare il muretto posto a lato della strada lungo il fiume che faceva da divisorio a riparo del quale mi ero precipitato ai primi spari e che fu letteralmente crivellato di colpi. Mi raggiunsero solo alcune schegge di intonaco e sassi, ma senza conseguenze. Quello fu l'ultimo saluto dei partigiani della zona.
La fortezza di Savona si trovava in una bella posizione sul mare, vicino al porto e da terra ci si arrivava attraversando i giardini pubblici, così ricordo se la memoria non mi tradisce; era mal ridotta e i continui e quasi quotidiani bombardamenti dei caccia bombardieri inglesi avevano contribuito non poco al suo degrado. Sbucavano a bassa quota rasentando le colline adiacenti, sganciavano alcune bombe eclissandosi subito dopo.
Le cose non migliorarono neppure quando ne ebbi il comando e le mitragliere da venti in postazione fissa che avevo, non poterono certo impedire quelle scorribande. L'unico beneficio, si far per dire, era quel poco di ferro o altro materiale metallico che veniva ricuperato dai marò dopo il bombardamento tra le macerie, che veniva venduto in città perché molto richiesto e con il ricavato ci facevano qualche bevuta “fuori ordinanza". (26)
In quei giorni ebbi anche modo di incontrare vari camerati che avevo conosciuto in precedenza, come pure Vinicio e Ciro che vidi per l'ultima volta perché morì poco dopo. Potrei dire che molti militari che passavano da Savona una puntata alla fortezza era d’obbligo ed io facevo sempre in modo di consumare il rancio assieme a loro.
Una mattina, eravamo nella seconda metà del mese di Aprile del 1945, venne a trovarmi anche un collega del quale non ricordo il nome e che avevo conosciuto in occasione di quel processo a Cairo Montenotte.
Si trattenne alla mensa e successivamente volle seguirmi nella stanzetta che fungeva da camera e da ufficio. Fu allora che mi mise al corrente della situazione che si era creata a causa dello sfondamento da parte degli alleati, della linea Gotica . Era di sede al comando di Altare, credo in fureria .
Era disperato e nella foga del discorso tra un colpo di tosse e l’altro che non riusciva a trattenere, gli venne uno sbocco di sangue, imbrattandomi pure il lettino sul quale nel frattempo si era seduto. Poveretto, lo rividi per l’ultima volta quel giorno della resa ad Alessandria, in una grande piazza dove deponemmo le armi, era in piedi su una balilla scoperta, mentre lanciava alla popolazione i denari che toglieva da una valigia, pur di non farli cadere nelle mani delle bande partigiane.
Fu da allora che cominciai a prestare attenzione a certi movimenti e situazioni che non lasciavano presagire niente di buono.
Visto che ormai gli eventi stavano precipitando, radunai tutti i marò e come sempre mi ero comportato, li misi al corrente sull’evolversi degli eventi. Senza mezzi termini spiegai che ormai eravamo all’ultimo atto della guerra, aggiungendo pure che chi voleva andarsene poteva farlo, non l’avrei minimamente ostacolato, perché per la situazione che si era creata, assolutamente non era da ritenersi diserzione. Però volli anche puntualizzare che secondo il mio modo di vedere, se c'era una probabilità di uscirne vivi, era quella di rimanere uniti.
Tacqui solo sul contenuto delle varie telefonate che ricevevo, nelle quali mi si intimava la resa con l’assicurazione che solo in tal modo avremmo avuto salva la vita, perché sapevo che erano tutte menzogne.
Il sergente che avevo da poco alle mie dipendenze e che aveva sostituito quello ferito nella colluttazione di Quiliano, mi chiese il permesso di andarsene. Essendo fidanzato in zona, mi disse che pensava di nascondersi in casa della sua ragazza. Non ho mai saputo fino a che punto fu saggia la sua scelta.
Intanto le telefonate continuavano ad arrivarmi e gli accenti erano sempre più perentori e arroganti: «tenente Guerrieri arrenditi» mi si diceva«deposita le armi, non hai scampo». Mi chiamavano addirittura per nome, sapevano esattamente chi ero e mi imponevano la resa. In effetti era chiaro che ad ogni ora che passava la nostra situazione peggiorava ulteriormente. Ero certo che al più tardi nel corso della notte gli ultimi reparti ancora in città se ne sarebbero andati e così noi saremmo rimasti completamente soli ed isolati.
Infatti poco dopo il tramonto, nel vicino porto ebbe inizio un susseguirsi di esplosioni e boati che si protrassero a lungo. L'unico contatto rimasto con l’esterno era il telefono civile attraverso il quale mi si intimava la resa ma questa volta erano veri e propri ordini con minacce di morte se non aderivo alle loro richieste. Il telefono collegato con il comando già da due giorni non esisteva più e così non potevo neppure sperare su eventuali disposizioni, Non avevo scelta, sarebbe stato stupido e suicida illudersi; ero io che dovevo prendere una decisione, addossarmene tutte le responsabilità e sperare che fosse quella giusta, anche perché era fuori discussione una resa ai partigiani che avevo già da tempo scartato, consapevole se avessi accettato, al di là di ogni trattativa o accordo, la fine che comunque avremmo fatto.
Fu così che la mattina successiva, poco prima dell’alba, feci minare tutto quanto di interesse militare e non trasportabile, mitragliere incluse, ordinando al reparto di tenersi pronto per una sortita.
Dovevo cercare assolutamente di congiungermi con il grosso della colonna che aveva abbandonato Savona e che ero certo non poteva aver preso altra direzione che quella di Altare. In più di una occasione avevo sentito parlare, che una volta costretti a ritirarci, avremmo dovuto ripiegare verso nord per tentare un ultima difesa sul Po.
Verso le sette, una volta spostati i cavalli di Frisia posti all'ingresso della fortezza, ci allontanammo in ordine sparso. Gli scoppi che poco dopo seguirono mi confermarono che i due guastatori avevano fatto un buon lavoro.
Le strade erano deserte e rasentando i muri delle case, ci dirigemmo verso la periferia della città per imboccare la strada di Altare.
Fatto alcune centinaia di metri ci furono alcune fucilate e raffiche di mitra dalle finestre di alcune case confermandoci, ammesso ce ne fosse stato bisogno, che la città ormai era completamente in mano dei partigiani e che noi eravamo l'unico reparto della S. Marco rimasto in città. Dovevamo sbrigarci e approfittare della sorpresa.
Passammo davanti la caserma dei pompieri e mi venne un idea; non potevo rinunciare a quella insperata opportunità. La porta era aperta, entrammo, si requisì alcune biciclette ed auto che erano in garage ed in breve raggiungemmo la strada di Altare riuscendo dopo appena un paio di chilometri, ad agganciarci alla retroguardia della colonna.
A testimonianza degli scontri avvenuti durante la notte, sul terreno ai bordi della strada, c’erano rimasti alcuni morti.
A Savona a parte qualche scaramuccia non ci successe niente di grave; solo prima di arrivare alla caserma dei pompieri, avevamo incontrato due o tre passanti apparentemente innocui, ma la cosa mi parve strana. Ebbi la netta sensazione che come ci scorsero, particolarmente uno di loro che teneva la mano destra nella tasca della giacca, rimanessero sconcertati e indecisi sul da farsi. Furono immediatamente bloccati dai marò ed io mi preoccupai di bloccare pure quella mano che una volta fuori dalla tasca vidi che teneva ben stretta una beretta calibro 9 con pallottola in canna e senza sicura. Mi limitai a disarmarlo, perché cosa altro avrei potuto fare? Sapevo bene che se a lui fosse capitata l’opportunità non avrebbe esitato a spararmi, ma io non me la sentii di farlo così a sangue freddo e tanto meno, dato le circostanze, avrei potuto fare dei prigionieri, così mi limitai a dargli un colpetto sul mento dicendogli: «vai, vai».
Una cosa buffa mi era successa mentre procedevo al sequestro dei mezzi di trasporto dai pompieri. Stavo tranquillizzando il comandante, naturalmente allarmato, promettendo che una volta fuori dalla città avremmo lasciato tutto quanto sequestrato, in modo che avrebbe potuto rientrarne in possesso nel giro di poche ore, quando con la coda dell’occhio notai un pompiere che nel frattempo era entrato in ufficio. Ebbi l’impressione di conoscerlo o quanto meno di averlo già visto. I nostri sguardi si incontrarono e nel medesimo istante uno si ricordò dell'altro; io ne fui divertito, un pò meno lui, almeno dal terrore che lessi nei suoi occhi. Stranamente un marinaio addetto all’imbarcadero del navale di Venezia all’isola di S. Elena e questo almeno fino al Luglio del 1943, era diventato un pompiere a Savona. Cose che succedevano a quei tempi, ma naturalmente feci finta di niente.
Come promesso, una volta che fu raggiunta la colonna, lasciammo auto e bici ai bordi della strada.
Ai reparti della S. Marco che erano dislocati sulla fascia costiera della Liguria, man mano che si ritiravano, si erano aggregati altri reparti, camicie nere della “G.N.R.” anche perché, dislocate a piccoli gruppi come erano, solo unendosi a noi potevano avere qualche possibilità di cavarsela.
Stavo risalendo la colonna e cercavo di raggiungere Altare prima possibile, con la speranza di trovare qualche diretto superiore che mi desse eventuali consegne, quando da uno di quei camion stracarico di camicie nere e di civili, udii una voce che mi chiamava. La riconobbi subito, era quella di Rinaldo.
A Rivoli con me era stato generoso di consigli tutti dettati dal buon senso anche se poi da me non seguiti, mentre a Brescia ero stato io ad essere generoso con lui non di consigli, ma di soldi.
Aveva preso una sbandata per una ragazza che anche quel giorno vidi che era con lui su quel camion e anche se non me ne aveva detto la ragione, che però credetti ugualmente di averla capita, essendosi trovato ad avere un impellente necessità di danari. Li chiese a me, ma non ne avevo. Poi mi sovvenni di mio padre che quando venne a Rivoli mi aveva indicato dove potevo andare in caso di bisogno.
Con Rinaldo eravamo amici da ragazzi, allievi dello stesso collegio per alcuni anni, se si era inguaiato, avendone le possibilità, ritenevo mio preciso dovere aiutarlo e così gli chiesi quanto voleva: «Quindicimila». «Li avrai tra qualche giorno» gli risposi.
Chiesi ed ottenni alcuni giorni di permesso e con mezzi di fortuna raggiunsi Milano e poi Monza. Pur non conoscendo la città, non ebbi difficoltà a rintracciare l’abitazione della persona che cercavo che però era assente e mi fu detto che l’avrei trovata nella sua villa a Menaggio sul lago di Como. Anche a Menaggio dove andai nello stesso giorno, mi fu facile rintracciare la villa ma non chi cercavo. Fui ugualmente ospitato da suo genero e trattato veramente bene ma quello che più conta chiesi ed ottenni comunque il prestito.
Ero naturalmente in divisa da ufficiale della G.N.R. e anche se con un certo ritardo, capii di aver creato tra quelle persone, sia pure senza volerlo, un certo scompiglio. Se mi avevano ospitato non era stato certo per i miei ideali. Inoltre non era tanto consigliabile, specie nei piccoli centri, ospitare un repubblichino. c’era pericolo di rappresaglie e così per non inguaiarli ulteriormente, ritenni doveroso congedarmi e togliere l’incomodo la mattina del giorno successivo.
Avevo la barba lunga e prima di partire ebbi la malaugurata idea di accettare in prestito un rasoio di quelli da barbiere che tra l’altro non avevo mai usato. Non l’avessi mai fatto, tagliuzzai il mio viso così bene da renderlo un colabrodo.
Tornai a Brescia consegnai i denari a Rinaldo che poi rividi solo quel giorno sulla strada di Altare “parcheggiato” con la sua donna su un camion della S. Marco.
Parlammo poco, non ne avemmo il tempo perché il comandante di battaglione come seppe del mio aggancio ai reparti, mi trasmise l’ordine di raggiungerlo in testa alla colonna. Però Rinaldo, anche se non richiesto, trovò il tempo per rendermi i denari che gli avevo prestato, anche se, con il senno del poi, sarebbe stato meglio lo avesse fatto a Lucca.
Io ed i miei marò ci distribuimmo su due camion appositamente fatti venire e risalimmo i reparti che ormai avevano oltrepassato Altare. Solo quando l'ultimo soldato fu alle nostre spalle, fummo scaricati in mezzo alla strada; ci mettemmo in ordine sparso e da quel momento fino ad Alessandria fummo la “punta di sicurezza” di quella colonna.
Il mio compito, mi fu spiegato, a parte quello specifico di prevenire imboscate, era all’occorrenza, di andare a parlamentare con quelle formazioni partigiane che avessero mostrato una certa velleità con azioni di disturbo per convincerle ad evitare scontri armati che in quel momento sarebbero stati inutili e dannosi sia per noi che per loro.
Un esempio per tutti. Ad una scaramuccia, erano partite alcune raffiche di mitra davanti a noi ed io con due marò mi incamminai in quella direzione con la bandiera bianca ben in vista. Come si interpose una certa distanza tra noi e il reparto che avevo lasciato sul posto, fummo circondati da un gruppo di armati che alla mia richiesta di parlare con il loro capo, come prima cosa disarmarono i due marò, poi tentarono di togliermi la pistola, ma al mio netto rifiuto non insistettero. Ci bendarono gli occhi e dopo circa venti minuti di cammino, una volta che ci furono tolte le bende dagli occhi, ci apparve un vasto prato con sul fondo un boschetto; prima del bosco c’era una capanna con intorno diversi uomini, senz’altro partigiani.
Mi diressi in quella direzione e una volta giunto, non mi fu difficile inquadrare quello che ritenni fosse il loro capo.
Senza tanti preamboli spiegai quale era la situazione. Non avevamo alcuna intenzione di molestare ne loro ne altri. Il nostro scopo era di proseguire per Alessandria e vedere se era possibile arginare l'avanzata degli anglo americani con una linea di difesa sul Po. Aggiunsi pure che se attaccati noi li avremmo annientati. Eravamo una forza integra, ben armata, anche con armi pesanti e in condizione di poter fare fronte a qualsiasi evenienza; a loro la scelta. Se non fossimo rientrati entro un certo tempo, sarebbe stato aperto il fuoco con i cannoni e mortai.
Non ci fu bisogno di aggiungere altro, resero le armi ai due marò, fummo nuovamente bendati e riportati al punto di partenza.
Credo che un certo fatto avvenuto mentre mi stavo avvicinando al loro capo, in qualche modo abbia agevolato il mio compito. Avevo visto seduto su un masso un ragazzo che stava armeggiando nel tentativo di rendere efficiente una beretta 7,65 che si era inceppata.
Mi avvicinai e senza proferire parola gli presi dalle mani quella pistola riconsegnandola dopo pochi secondi, perfettamente efficiente.
Non lo giurerei, ma ebbi la sensazione che quel gesto, servì in qualche modo a rompere il ghiaccio tra me e il loro capo che aveva visto tutto, o almeno a rendere quella trattativa più informale e alla buona.
Ne facemmo di strada in quei giorni, tutta a piedi. Si dormiva per terra poche ore e poi via ancora chilometri, trattative e fucilate, quando proprio non c'era altra scelta.
Fu così che giungemmo in vista di Alessandria. Non entrammo in città, la oltrepassammo e improvvisamente dopo poco ad una curva sbucarono dei camion carichi di armati con bandiere rosse al vento. Come furono ad un centinaio di metri da noi, si fermarono sbarrarondoci la strada. Scesero urlando e brandendo con fare minaccioso i loro mitra; uno di loro che doveva essere il capo aveva ben in vista legata alla canna della sua arma una bandiera bianca che agitava molto vistosamente. Erano eccitati lo capii benissimo e solo quando furono a due passi da noi si fermarono. Ci dissero che ormai la guerra era finita e dovevamo consegnare loro le armi. Come risposta ordinai ai marò di schierarsi su tutto il fronte della strada e nei campi attigui.
Si venne a creare una situazione che se da una parte o dall’altra uno qualsiasi avesse perso la calma o fosse stato preso dal panico o se, anche accidentalmente fosse partito un solo colpo, sarebbe stata una carneficina. Basti pensare che le rispettive armi erano puntate sul petto o sulla pancia dei contendenti che si fronteggiavano.
Nel frangente, aiutato anche da quello che ritenni fosse il loro capo, non senza fatica, riuscimmo a calmate un poco le acque. Dopo ci fu una grossa discussione naturalmente a base di minacce ed improperi, ma io non mollai; fui irremovibile e ribadii che mai avrei consegnato le armi senza un ben preciso ordine dei miei superiori. Non ebbi titubanza alcuna e credo proprio che anche loro se ne rendessero conto perché alla fine rinunciarono.
Tornarono sui camion che nel frattempo avevano invertito la direzione di marcia e si allontanarono di gran carriera.
Riuniti i miei uomini e dopo averli disposti in modo da prevenire eventuali imboscate, ordinai di proseguire la marcia.
Non era trascorsa una mezz’ora che sopraggiunse un auto che come ci ebbe superato, si fermò. Vidi seduto nel sedile posteriore un ufficiale, mi pare un maggiore, ma non lo conoscevo.
Chiese chi comandava e una volta che mi presentai disse: «Torni in dietro». Non mi guardò in faccia, aveva la testa abbassata e così rimase. (12)
Capii che veramente tutto era finito e qualsiasi altra parola avesse aggiunto, sarebbe stata perfettamente inutile.
Non mi restò che obbedire e così in una frazione di secondo da punta di sicurezza mi ritrovai alla retroguardia. Ritornammo sui nostri passi e forse un chilometro dopo, ci unimmo a chi fino a quel momento ci aveva seguito e tutti assieme restammo sul posto in attesa di disposizioni.
Si sperava che papà Farina stesse trattando per i suoi marò una resa onorevole e più umana possibile, ma purtroppo non fu così, non certo per sua colpa.
Intanto ci fu distribuita una certa cifra, stipendi arretrati mai percepiti con l’aggiunta di alcune migliaia di lire, che successivamente, in gran parte, andarono a rimpinguare le tasche dei partigiani.
Tra noi intanto si parlava e si vagliava tutte le ipotesi possibili lasciandoci anche andare alle più strane congetture, non ultima quella di non arrenderci, continuare a combattere andando a nostra volta sui monti. Perché no? In fin dei conti eravamo ben armati, conoscevano la zona alla perfezione, il morale nonostante tutto era ancora alto e avremmo potuto dare ancora del filo da torcere a chicchessia (13).
Sopraggiunse la notte e con essa il sonno. Dormimmo sul posto come il solito all’addiaccio e al mattino quando avevamo ripreso a discutere sul da farsi, ci pervenne l’ordine di entrare in Alessandria. Era il primo Maggio 1945.
Seguimmo un certo percorso che senz’altro era stato precedentemente concordato marciavamo inquadrati, cantando i nostri inni e sempre armati. Era più una parata che una resa incondizionata di perdenti.
Potrà sembrare strano e retorico questo nostro comportamento: non sapevamo quale sorte ci sarebbe toccata, ci avevano detto che una volta presi, gli ufficiali sarebbero stati fucilati e uguale sorte sarebbe toccata anche ad una parte dei marò, eppure a dispetto di tutto e di tutti il nostro atteggiamento era da vincitori, non da vinti (14).
Voglio pensare che tutto questo succedeva perché eravamo integri dentro e avevamo la consapevolezza che essere dalla parte dei perdenti, non voleva necessariamente dire che avevamo torto.
Mi domandavo e soprattutto interrogavo il mio io fino a che punto avevo agito per il meglio, fino a che punto la mia scelta e quella dei miei compagni era stata giusta; ancor oggi a distanza di cinquanta anni capita di pormi questa domanda, ma la risposta é sempre la stessa.
Senz’altro avremo agito seguendo certi stimoli, forse anche certe influenze, ma alla base di tutto, oltre che essere sorretti da una grande fede, c’era in noi la ferma convinzione che solo continuando a combattere fino in fondo a fianco del nostro alleato, avremmo salvato l’onore.
Bella parola ma che oggi non ha più senso, direi ridicola solo a sentirla pronunciare; potrebbe essere tranquillamente cancellata dal vocabolario della lingua italiana che ben pochi se ne accorgerebbero, ma fino a che esisterà e se ne potrà leggere il significato, noi restiamo dalla parte giusta.
Una volta ho sentito dire dal nostro generale: «Continueremo a combattere ad di là di ogni ideologia e risultato per l’onore».
«Viva la Germania, viva l'Italia che cadono sul campo
dell’onore» così si espresse prima della resa il generale Hildebrandt agli arditi della S. Marco nel comunicare la notizia della decapitazione da parte dei russi di suo figlio sottotenente mutilato ed invalido e la perdita di tutti i suoi, corpo e beni. (15)
Benedetto Croce aveva scritto; «Ci sono momenti nei quali vittoria e sconfitta diventano, innanzi all’onore nazionale e alla dignità di uomini, cose secondarie...... ma perfino una sconfitta aspramente contesa é una vittoria altrettanto morale, quanto effettiva....» .
Le aveva scritte oltre venticinque anni prima ma rispecchiavano esattamente il nostro pensiero di allora e di ora. I partigiani e i politici hanno sempre detto di aver vinto la guerra alleandosi con gli ex nemici, vittoria facile ottenuta con il tradimento e sempre Benedetto Croce aveva pure scritto:«Una vittoria facile è una sconfitta morale e reale...»
Allora non potevo certo cullarmi su verità espresse da simile personaggio perché non le conoscevo, ma sapevo esattamente quello che la coscienza mi dettava: fare il mio dovere fino in fondo.
In quei giorni della ritirata ero venuto a sapere che il mio amico Ciro era stato ferito e fatto prigioniero; eravamo stati assieme praticamente sempre, solo negli ultimo mesi da Zinola dove comandava un “bunker” era stato trasferito nei guastatori. A quanto mi fu detto pare si fosse ferito proprio in quei giorni nel minare un ponte.
Molto tempo dopo venni a conoscenza della verità, fino in fondo; da ferito era stato fatto prigioniero e fucilato dai partigiani perché non volle, a dispetto di quanto gli si chiedeva, rinnegare i suoi ideali.(16)
Quando le sue due sorelle mi vennero a trovare a Lucca per sapere che fine aveva fatto, detti loro tutte le indicazioni delle quali ero a conoscenza, so che rintracciarono il luogo del delitto e che dal parroco del paese ebbero la conferma di quanto avevo loro raccontato. Credo che una volta riesumato il cadavere, trasferissero le spoglie al Verano a Roma. Consegnai loro pure l’unica foto che avevo e che ci ritraeva assieme; era stata scattata quel famoso giorno che, così mi pare di ricordare, tenentini di prima nomina avevamo indossato la divisa della S. Marco.
Questo é un episodio che ho voluto ricordare perché mi toccò più da vicino, ma quanti ce ne sono ugualmente tristi, ugualmente eroici.
Quante migliaia di eccidi mai saputi, mai raccontati, volutamente ignorati.
Questi ed altri pensieri mi passavano per la testa ed intanto superato la periferia ci stavamo addentrando nel centro di Alessandria.
Intanto gruppetti di partigiani avevano cominciato ad insinuarsi nelle nostre fila e cercavano in tutti i modi di portarci via le armi. Noi sapevamo benissimo di doverle consegnarle, ma non certo in quel modo. La mia pistola una “stajer” calibro otto lungo che poteva sparare anche a mitraglia era molto richiesta; ad un partigiano particolarmente insistente pur di levarmelo di torno proposi il cambio con la sua “beretta” cosa che lo fece felice. Certo non sapeva che le pallottole calibro otto lungo erano introvabili e quelle poche che avevo di scorta, mi guardai bene di consegnarle.(17)
Ormai eravamo in centro e marciavamo tra due ali di folla.
Arrivammo ad una grande piazza stracolma di gente; furono disposti vari automezzi e su quelli ci fu ordinato di depositare le armi, lo facemmo, non senza in precedenza averle rese, per quanto possibile inservibili. Facemmo tutto con grande ordine e dignità, prima gli ufficiali dai più alti in grado e poi tutti gli altri.
Dopo successe il finimondo. Ci fu un tentativo da parte della popolazione di portare via quelle armi appena depositate e molti ci riuscirono perché addirittura vidi gente trascinare mitragliatrici, prendere pistole, mitra e tutto quello che potevano acciuffare. Poco prima avevo visto il tenente che era venuto a trovarmi alla fortezza di Savona e che mi aveva messo al corrente dell’evolversi della situazione, in piedi su un auto scoperta, cereo in volto e molto teso ma sicuro di se, lanciare a piene mani i denari che prendeva da un grosso baule, alla folla che assiepava quella piazza. (18)
In quel trambusto alcuni dei nostri si dettero alla fuga, forse sperando di farcela approfittando della confusione che si era creata, o magari perché non ebbero i nervi sufficientemente saldi lasciandosi prendere dal panico. Comunque sia, chi in quel frangente si trovò isolato, fu travolto da quella marea umana e non fu più rivisto. Si udivano i primi spari e caddero i primi (degli ultimi) morti.
Disarmati come eravamo rimasti, non so come ce la facemmo ad arrivare alle casermette di Alessandria.
Una volta dentro ci misero in fila indiana e cominciarono le perquisizioni; mi resi subito conto come procedevano i partigiani e pensai cosa fare per tentare di salvare i denari che erano tanti sommando quelli resi da Rinaldo e gli altri che mi erano stati dati il giorno prima.
Davanti a noi venivano sistemate delle coperte sulle quali dovevamo mettere tutto quanto avevamo in dosso; poi passavano i partigiani, prendevano tutto quanto interessava loro e procedevano ad un ulteriore controllo sulla persona. I denari, nemmeno a dirlo, erano i primi a sparire oltre qualsiasi altro oggetto ritenuto di un certo valore. Si accanivano su tutto persino sulle foto dei nostri cari, ci sputavano sopra e poi le stracciavano. Nemmeno le mostrine e i gladi romani furono risparmiati.
Presi il portafoglio, tolsi parte dei denari che avevo e riuscii senza essere visto a nasconderli sotto la coperta che avevo davanti ai piedi, la metà circa, lasciando l’altra metà nel portafoglio e nelle tasche dei pantaloni.
Tutto andò come pensavo; mi perquisirono, mi tolsero l’orologio e dal portafoglio che avevo messo sopra la coperta presero tutti i denari, mi vuotarono le tasche e presero anche gli altri. Le foto che avevo le strapparono con il solito rituale al quale nessuno sfuggiva e la stessa sorte toccò a qualsiasi altro oggetto anche senza valore, ma che sapevano che poteva dispiacere disfarcene. In compenso salvai metà dei denari.
Dato che si era sparsa la voce che cominciavano a fucilare gli ufficiali a partire dai più alti di grado, i miei marò di prepotenza mi scucirono i gradi di sottotenente proprio a tempo perché avevano cominciato ad appartare gli ufficiali, ma per buona sorte, il sopraggiungere degli americani alle casermette, impedì una carneficina.
Tra i prigionieri c'erano anche delle ausiliarie con una delle quali ebbi una fugace quanto insperata avventura notturna. Non ricordo quanto tempo rimanemmo alle casermette ma non credo più di due o tre giorni, poi all’improvviso come quasi sempre capitava, venimmo a sapere che l’indomani saremmo stati trasferiti altrove e addirittura si parlava di un campo di concentramento in Africa settentrionale. Impiegammo parte della notte a sistemarci nuovamente sulle divise le mostrine utilizzando le bandiere rosse dei partigiani e attaccandole alla giacca con del fil di ferro.
Al mattino, scortati dagli americani e a piedi ci incamminammo verso la stazione ferroviaria e durante quel tragitto incuranti dei fucili dei partigiani che sempre ci tenevano sotto tiro, marciammo cantando i nostri inni.
Ci fecero salire su vagoni bestiame di quelli scoperti che lentamente si mossero verso Genova. In ogni stazione piccola o grande che fosse, la gente, senz’altro preavvisata del nostro passaggio, assiepata ai lati, era ad attenderci. Evavamo alla berlina mentre il treno lentamente procedeva tra due muraglie umane. A volte il convoglio si fermava ed i più scalmanati tentavano addirittura di trascinarci a terra. Gli americani di scorta facevano del loro meglio non esitando a volte a puntare loro le armi a scopo intimidatorio, ma non sempre ottenevano lo scopo desiderato.
Si può immaginare in che stato d’animo ci trovavamo e non c’é da meravigliarsi se qualche marò, approfittando di alcune gallerie che non erano illuminate, tentò la fuga. Io avevo raccomandato ai miei ragazzi di non farlo, perché ero convinto fosse la via più facile per essere ammazzati. Dopo ne avemmo la conferma perché venimmo a conoscenza che chiunque era stato preso e fosse stato anche minimamente sospettato di essere repubblichino, senza tanti complimenti era stato eliminato.
Arrivammo a Genova e ci portarono al campo sportivo credo di Marassi, ma non ci fermammo per molto, forse un giorno e poi caricati su camion transitando e sull’Aurelia, ci portarono verso sud.
Durante questi trasferimenti la sorveglianza era ridotta al minimo e chi avesse voluto non avrebbe trovato grosse difficoltà a fuggire, per di più che i camion non avevano tendoni, erano completamente aperti, ma avevamo imparato la lezione perché in quei momenti eravamo più al sicuro restando prigionieri degli Americani che tra l’altro, almeno in buona parte, non ci maltrattarono. Le cose cambiarono dopo, ma da parte dei militari di colore.
Facemmo tutta le riviera di levante, il Bracco e dopo La Spezia precisamente a Sarzana, ci fu una piccola sosta.
Come ci fermammo, nemmeno a dirlo, si formarono capannelli di persone e di armati che trovavano un gusto matto ad insultarci e cercando in tutti i modi di provocarci e buttarci giù dai camion.
Io mi ero alzato in piedi per sgranchirmi un poco a causa della scomoda posizione cui eravamo costretti a stare perché non c’erano sedili, ma proprio nel momento sbagliato. Infatti il camion ripartì facendo un sobbalzo, io persi l’equilibrio e per poco non caddi tra le loro braccia; trovai un qualche appiglio appena in tempo ma uno di loro, visto che ero in difficoltà, tentò di trascinarmi a terra. La mia reazione fu immediata anche se inconsulta, ma avevo tanta rabbia in corpo e la scaricai su di lui spuntandogli in faccia. Non avevo altro modo per manifestargli il mio disprezzo e non andai per il sottile.
Lo presi in pieno volto, vidi che alzava il fucile e prendeva la mira: aspettai il colpo ma per fortuna non sparò.
Non avrei dovuto farlo perché, stipati come eravamo, se quel partigiano avesse veramente sparato, poteva colpire chiunque, non necessariamente chi lo aveva provocato. Proseguimmo sempre lungo l’Aurelia e come si giunse a Viareggio all’altezza del cavalcavia, ci fu un’altra breve sosta.
Ormai era diventata una prassi e anche qui appena fermi, gruppetti di persone e di armati circondarono i camion. In mezzo a quella gente credetti di riconoscere lo zio Mario; era sceso di bicicletta e per vedere meglio si era avvicinato a piedi; guardava con una certa intensità come se cercasse qualcuno e io sapevo chi cercava. Il primo impulso che ebbi fu un gran desiderio di farmi notare perché era oltre un anno che i miei genitori non avevano mie notizie o almeno così credevo. Ma questa volta fui saggio e mi nascosi. Quale reazione avrebbe avuta nel vedermi, che interpetrazione avrebbe dato tutta quella gente al suo inevitabile approccio con me; poi, diciamolo pure, mi sentivo umiliato e ritenevo avvilente farmi vedere ammassato in quel camion come carne da macello, sporco, con una faccia che senz'altro rispecchiava la fame accumulata dopo tre giorni di digiuno e con la barba di una settimana. Insomma il mio aspetto doveva essere ben poco rassicurante.
Per fortuna ripartimmo quasi subito e ci fermammo solo quando giungemmo alla nostra destinazione, il campo di concentramento di Coltano. (19)
Finalmente ci fu dato del cibo (non mangiavamo dalla sera precedente la partenza da Alessandria) che però ci lasciò più affamati di prima. Senz'altro ci avranno dato le calorie sufficienti per un pasto, ma il nostro stomaco era troppo vuoto e avrebbe avuto bisogno di ben altro. Quella sensazione di fame non mi abbandonò mai e fu la mia compagna per tutto il periodo che rimasi in quel campo di concentramento.
Fummo alloggiati in baracche di legno una vicina all'altra; avemmo delle brandine e diciamo che internamente al nostro recinto, godevamo di una certa libertà di movimento.
Un poco alla volta ci adattammo a questo non far niente. Ritrovammo vecchi amici, ne facemmo di nuovi e bene o male anche se lentamente, le giornate passavano portandosi dietro i tanti nostri pensieri e la speranza di un veloce rientro alle nostre case.
Capitò un paio di volte che qualche prigioniero tentasse la fuga. Uno fu scoperto mentre fuggiva, fu ammazzato dai militari neri e lasciato in bella mostra un’intera giornata, come lezione per scoraggiare eventuali altri tentativi.
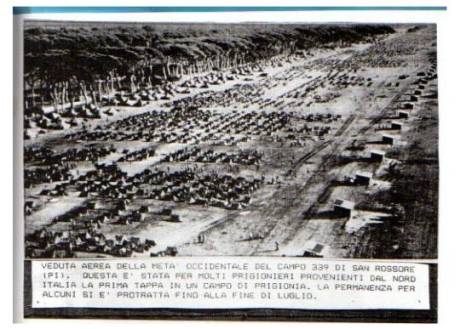
Veduta aerea della metà occidentale del Campo 339 di San Rossore (PI)
Questa è stata per molti prigionieri provenienti dal Nord Italia la prima
Tappa in un campo di prigionia. La permanenza per alcuni si è protratta
fino alla fine di Luglio.
Il nostro campo era completamente circondato da filo spinato messo a “organetto” a più strati, oltre il quale ad una certa distanza l’una dall'altra erano poste delle torrette di legno abbastanza alte sulle quali stavano di guardia i soldati americani.
Durante la notte da queste torrette partivano dei fasci di luce che illuminavano a giorno il filo spinato e tutta la zona circostante. Perciò anche la fuga era molto difficile; ad ogni modo per quanto mi riguardava questa idea non mi era nemmeno passata per la mente perché tutto sommato, ritenevo al momento più conveniente stare tranquillo e aspettare di essere mandato a casa. Il tempo lavorava per noi: più ne passava e più le acque si sarebbero calmate, così ragionavo e trasmettevo questo mio pensiero ai magnifici marò che sino a quel momento mai avevano avuto il sia pur minimo tentennamento e sconforto.
Avevo con me i denari salvati dalla perquisizione di Alessandria e così qualche volta mi permettevo il lusso di acquistare dai neri, che venivano ai bordi del reticolato, delle tavolette di cioccolato ma che in realtà, una volta tolta la stagnola, risultava essere castagnaccio. E’ chiaro che la prima volta ci rimasi piuttosto male perché il loro prezzo era molto alto, ma poi ogni tanto fingevo di ignorare la cosa e mi permettevo ugualmente quel lusso; masticavo più a lungo possibile e così facendo, avevo l'impressione di avere meno fame.
Anche se le giornate erano lunghe a trascorrere ed il sole che si alzava molto presto e mai si decideva a calare, mi consolavo pensando che tutto sommato, dopo quello che avevamo passato, un poco di tranquillità poteva anche essere gradita. cercavo di convincermene, ma con scarsi risultati.
Un bel giorno si sparse la voce che presto avrebbero avuto inizio gli interrogatori a tutti i prigionieri per gli accertamenti del caso. Si sarebbero documentati da quale zona si proveniva, se c’erano eventuali pendenze o denunce a carico e chi risultava pulito, sarebbe stato liberato. (2O)
Questa notizia anziché rallegrare mi allarmò e mi mise l’angoscia a tal punto da prendere in seria considerazione l’eventualità di una fuga. Non avevo fatto niente di cui vergognarmi ma pensavo che se avessero chiesto di me nella zona dove ero stato, come minimo mi avrebbero impacchettato e mandato a Savona. Quali garanzie di imparzialità avrei potuto avere anche ammesso mi avessero concesso un processo? Quanta gente era stata ammazzata per molto meno. Allora mio dissi che visto e considerato fino a quel momento la pelle me l’ero salvata, se dovevo rischiare preferivo puntare sulla mia buona stella che fino ad allora mi aveva protetto, piuttosto che rischiare un processo sommario e certamente non equo. Non volevo compromettere tutto all'ultimo e così decisi di tentare la fuga. Ero in Toscana, vicino a casa, potevo dire di conoscere abbastanza bene la zona e una volta riuscito ad evadere dal campo, il più era fatto. Chi proveniva dal nord era guardato con più sospetto per ovvie ragioni, ma non era il mio caso.
L'infermeria era posta in una zona sempre vicino al campo ma completamente indipendente e correva voce che fosse il posto più adatto per chi avesse voluto tentare una fuga.
Mi concentrai al massimo per cercare un pretesto qualsiasi onde poter essere ricoverato e mi aiutò un piccolo malanno che avevo contratto in precedenze e che si era riacutizzato. Marcai visita e fui ricoverato.
Ebbi la sorpresa di trovarci due fratelli gemelli e che avevo conosciuto molto prima quando ero ancora nella Guardia Nazionale Repubblicana. Furono gli unici ad essere messi al corrente delle mie intenzioni e a loro volta mi confidarono che aspettavano solo il momento opportuno e questo momento era arrivato: avremmo tentato assieme.
Effettivamente le possibilità di riuscire erano molto superiori a qualsiasi altro posto; i gabinetti si trovavano isolati rispetto alle altre baracche ed erano messi quasi a ridosso dei reticolati. La sera quando venivano accesi i riflettori, creavano ombra sopra di essi su un tratto di qualche metro. Inoltre a differenza di dove ero in precedenza, che una volta superato il reticolato prima di arrivare al vicino bosco c'era da percorrere un tratto di zona allo scoperto di una diecina di metri, in quel punto invece con un balzo uno si trovava al riparo nascosto dal folto del bosco.
Sia di giorno che di notte a turno e in varie riprese, nei momenti in cui la sorveglianza era più ridotta, ci demmo da fare per allargare il più possibile dalla nostra parte il reticolato in modo da rendere il passaggio, almeno all'inizio, più agibile possibile, ottenendo un certo risultato.
Non ci fu difficile trovare alcuni indumenti civili dagli stessi prigionieri del campo, perché diversi di loro quando erano stato presi avevano già abbandonato la divisa, nel vano tentativo di farla franca e ritornarsene a casa.
Inutile dire che il momento più delicato della fuga era nel superare quel reticolato perché di notte c’era una sentinella che andava in continuazione da una torretta all’altra camminando tra il filo spinato e l’inizio del bosco. La nostra posizione era circa a metà strada tra due torrette e pertanto bisognava sfruttare al massimo il tempo e agire dal momento che ci passava davanti fino a che non raggiungeva l’altra torretta da dove faceva dietro front e ritornava verso di noi.
Avevamo cronometrato tante e tante volte e sapevamo di avere a disposizione quindici secondi.
Ecco perché era importante che non ci fosse alcun intoppo nel superare il reticolato che doveva essere fatto nel tempo massimo di dieci secondi.
C’era pure l’altro soldato che stava sopra la torretta, ma quello non ci preoccupava perché quasi mai di notte si faceva vedere in piedi a controllare. Senz’altro era una consuetudine che chi faceva la guardia in quel posto, se ne stava sdraiato a dormire.
Ricordo che in quelle due o tre sere che precedettero la fuga, quante volte con la mente ho percorso quel piccolo tratto che ci divideva dal bosco.
Con gli occhi chiusi vedevo il mio corpo che strisciando in terra passava sotto il reticolato contorcendosi come una serpe per poter entrare con minor danno possibile nei vari passaggi.
Concordammo che io sarei stato il primo ad uscire ed i due gemelli mi avrebbero seguito a distanza di qualche minuto sempre che ce l’avessi fatta. Ci saremmo ritrovati ben dentro nel bosco dove li avrei aspettati, per poi proseguire assieme.
Avevo tutto programmato, anche quando una volta fossi entrato nel bosco. Sapevo che di fronte a noi, ad ovest c'era il mare e che l'Aurelia ad est lo costeggiava. Se andavo verso il mare poi mi dirigevo a destra di 90 gradi e ancora a destra sempre di 9O gradi, non potevo mancare l'Aurelia.
Una volta vi fossi giunto sarei andato a Lucca dai miei parenti scartando a priori l’idea di tornare al mio paese perché tutti mi conoscevano e bastava una spiata per essere preso e rispedito in campo di concentramento.
Naturalmente non sapevo che nel frattempo i miei genitori si erano trasferiti a Lucca perché la fabbrica era stata bombardata, ed anche perché mio padre aveva avuto grosse noie dai partigiani del luogo; tutto questo lo seppi dopo, una volta giunto a destinazione.
Passare attraverso quel reticolato per me fu un affare di qualche secondo; ormai conoscevo a memoria tutti i punti accessibili, e lo feci strisciando e tenendo gli occhi chiusi e come avevo fatto tante volte con la mente, seguendo i movimenti del mio stesso corpo.
Anche se mi sgraffiai in più parti, ci vollero pochi secondi per trovarmi dall'altra parte e sempre strisciando raggiunsi il bosco. Solo allora mi alzai in piedi e stando ben attento a non fare rumore, mi allontanai correndo. Con la coda dell’occhio avevo dato una sbirciata alla sentinella che mi era passata davanti proveniente dalla mia destra e la vidi di spalle e ancora non si era voltata.
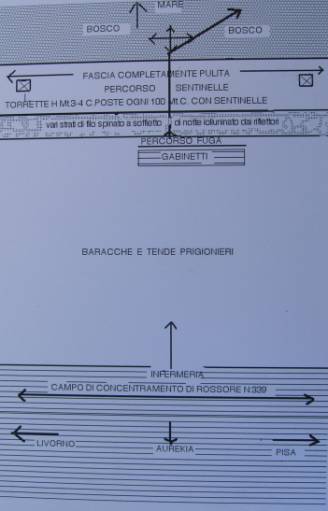
Il percorso di fuga
Corsi per un bel tratto con quanto fiato avevo in gola per porre più distanza possibile tra me ed il campo sempre a diritto come d’accordo con i gemelli verso il mare e solo quando avvertii certo affanno, mi fermai per aspettarli. Il silenzio che regnava tutto attorno non lasciava dubbio alcuno che la mia fuga non era stata scoperta. Già pensavo che da un momento all'altro sarebbero sopraggiunti gli altri due, quando udii degli spari provenienti dal campo. Mi resi conto che erano stati scoperti e che attenderli sarebbe stata pura follia; comunque volli attendere ancora un poco, due minuti dissi a me stesso e poi proseguii da solo.
In seguito venni a sapere (almeno così mi fu riferito) che mentre tentavano la fuga erano stati scoperti, ripresi ed uccisi dalle guardie di colore; non ne fui meravigliato perché era capitato anche in precedenza che se uno fuggendo veniva scoperto e si fermava all'alt, veniva ugualmente eliminato. (21)
Nel bosco non avevo alcun punto di riferimento e per orientarmi seguivo il ragionamento che mi ero prefisso, andare a destra e poi ancora a destra, ma era un ragionamento molto semplicistico. Non avevo pensato ai vari ostacoli che avrei potuto incontrare e che mi avrebbero obbligato a fare larghi giri; ad un certo momento non ebbi più la certezza di essere nella direzione giusta.
A mie spese capivo quanto fosse difficile orientarsi in un bosco di notte.
Mi trovai in uno spiazzo pieno di buche e una volta che lo ebbi attraversato, inciampai addirittura in un paletto che sorreggeva un cartello sul quale a malapena riuscii a decifrare una scritta “mines”.
Avevo attraversato un campo minato magari ripulito solo alcuni giorni prima e fortuna che chi aveva eseguito quel lavoro era stato molto scrupoloso.
Poco dopo incontrai un terrapieno al di là del quale scorsi delle baracche molto poco illuminate e udii pure delle voci. Era un piccolo accampamento che forse fungeva da dormitorio per i militari che si avvicendavano alla guardia del nostro campo.
Fu un continuo girovagare e cominciavo ad avere seri dubbi di trovare il bando della matassa che mi permettesse di venirne fuori, quando, ed era quasi l'alba, mi ritrovai su una strada in terra battuta, sulla quale erano ben visibili tracce di gomme d'auto. Più che altro era un sentiero abbastanza ampio che doveva servire a collegare i vari accampamenti disseminati nel bosco. Ormai ero certo che seguendolo sarei arrivato all’Aurelia e così mi incamminai stando sul lato sinistro, proprio al bordo estremo, perché il buio della notte si dissipava a vista d’occhio e volevo essere pronto a nascondermi nel caso di brutti incontri.
Dopo una curva vidi una luce che proveniva dall'interno di una baracca attraverso una porta aperta. Quella luce illuminava un pontile di legno che univa le due sponde di un fossato.
La baracca era al di là del ponte e nel suo retro intravidi parcheggiata una jeap.
Se volevo andare avanti dovevo decidermi, o passare dal retro guadando il fossato che vidi abbastanza ampio e profondo, oppure attraversare il pontile con tutti i rischi del caso. Decisi per quest'ultima soluzione che in quel momento ritenni fosse la più ovvia.
Per non fare rumore mi tolsi gli scarponi, l'unica cosa che ancora mi era rimasta di militare e tenendoli in mano, avanzai con molta cautela.
Sembrava che ancora una volta la sorte mi fosse stata favorevole, il pontile ormai era stato superato, quando una voce mi bloccò; non capii le parole ma il classico rumore della pallottola che viene messa in canna non mi lasciò dubbi.
Sotto la minaccia del semiautomatico fui spinto nell'interno ritrovandomi in un ambiente piuttosto squallido con un paio di letti di legno a castello e sui quali erano distesi dei militari per fortuna tutti bianchi.
Il soldato che era di guardia e che mi aveva bloccato, una volta accertato che non fossi armato, svegliò uno dei suoi colleghi; parlottarono tra loro in inglese poi quello che senz'altro era un interpetre, in un buon italiano mi chiese: «come mai ti trovi da queste parti?». Devo confessare che il quel momento la più grossa preoccupazione che avevo, erano gli scarponi che ancora tenevo in mano nascosti dietro la schiena. Mi sentivo ridicolo e mentre cominciavo a dare le spiegazioni richieste per giustificare la mia presenza in quel posto, cercando di usare la massima naturalezza, misi le scarpe nella loro sede naturale. Dissi tante belle cose e sopratutto tante “balle” che, lo capii benissimo, non bevve affatto pur lasciandomi proseguire. Come ebbi finito a sua volta mi dice: «non sei per caso scappato dal campo di concentramento?». Con la faccia più meravigliata di questo mondo replicai: «perché da questa parti c’è un campo di concentramento?», «Si» mi rispose, «e molto vicino». Pensare che erano ore che giravo e mi trovavo ancora a due passi dal luogo della mia fuga.
Continuammo a parlare su questo tono per un poco ed io allora tentai quella che ritenni la mia ultima carta e gli dissi: «Dato che credo di capire che i miei argomenti sono poco credibili e la mia presenza in questo luogo quanto meno strana, prendete la jeap e accompagnatemi a Pisa a casa di mio zio generale Guerriero Guerrieri» Mi ero ricordato di aver sentito dire un giorno da mio padre che suo cugino Guerriero da Firenze era stato trasferito a Pisa, questo naturalmente prima della mia partenza.
Non so cosa si dissero l’interpetre e l’altro soldato perché confabularono tra loro due abbastanza a lungo sempre in inglese, poi il primo senza proferire parola e rivolto a me, fece un gesto di commiato. Non me lo feci ripetere due volte.
Sono certo che quel soldato o interpetre che fosse, sapeva benissimo da dove provenivo, ma chissà quale fu la leva che fece scattare quel suo gesto. Anch'io mi ero trovato in certe situazioni non ultimo a Savona e per quanto mi riguardava il mio io si era rifiutato di accettare in quei momenti che una mia decisione e solo quella potesse cambiare in peggio la sorte di un individuo quando ormai i giochi erano fatti.
Al campo la mia fuga non era stata scoperta, il soldato che era di guardia non sapeva cosa ci eravamo detti e così spettava a lui, solo a lui la decisione. (22)
Arrivai come previsto all'Aurelia e voltai a sinistra verso Pisa.
Era ancora molto presto ma avevo le ali ai piedi. Marciavo a spron battuto ma stavo anche molto attento tenedomi il più possibile di lato alla strada e quando potevo farlo, camminavo addirittura fuori strada. Non mi preoccupavano affatto i chilometri da percorrere a piedi e me ne guardavo bene di chiedere un passaggio ai rari automezzi che transitavano.
Non potevo permettermi leggerezze e distrazioni alcuna perché la mia buona stella non poteva proprio fare di più di quello che aveva fatto.
All'altezza di Pisa abbandonai l’Aurelia, imboccai la via vecchia pisana e finalmente, dopo qualche ora, raggiunsi le mura di Lucca.
Andai diretto a casa della zia Argene sorella del babbo, con la quale avevo maggior confidenza perché veniva spesso al Borgo. Non sto a dire la sua gioia e anche la sua meraviglia nel vedermi; da lei seppi che pure i miei genitori si trovavano in città e una volta avvisati, non tardarono a venire.
Fu stabilito rimanessi dove mi trovavo e successivamente, magari dopo qualche giorno, avremmo deciso per il meglio.
La casa che i miei genitori avevano acquistato, una volta trasferiti a Lucca, era un bel blocco su tre piani conosciuto come palazzo Volta. Aveva al primo piano un bell'appartamento, al piano terra c'erano dei magazzini che poi furono adibiti a laboratorio ed un secondo piano a soffitta, ma abitabile.
Quando arrivai io il piano nobile era già stato rimesso a posto e a lavorare c'era rimasto solo un pittore che stava finendo di affrescare le cornici sopra le porte del corridoio. Fu così che gli unici spiccioli che mi erano rimasti, servirono, per mio espresso desiderio, a pagare quest'ultimo lavoro e con quel gesto intesi pagare il prestito che mio padre avrebbe dovuto rimborsare.
Lo trovai molto malandato e quasi tutte le notti veniva ad assisterlo un infermiere. Imparai anch'io a fare le iniezioni e in caso di necessità gli somministravo della Morfina.
Si erano riacutizzate le sue ferite di guerra (tre di cui due mortali) e stava scontando la vita in Africa degli ultimi anni, ma soprattutto le angherie subite dai partigiani che addirittura lo volevano fucilare, ma anche le paure, le ruberie alle quali aveva assistito impotente e non ultimo una accusa che a quei tempi non era difficile ricevere di “arricchimento” con il passato regime. Ridicolo quando si pensa che era stato costretto ad andare in Africa per cercare di rimettere in sesto una baracca che stava affondando, a differenza di prima dell'avvento del fascismo che era un vero signore. Ad ogni modo il suo passato di fascista non gli dava ragione.
Però gli dette ragione il suo passato di uomo integerrimo che sempre aveva dato senza nulla chiedere e, sia pure dopo un certo tempo, fu scagionato da ogni addebito.
Io stavo nascosto in casa, uscivo raramente e quasi esclusivamente di sera; cercavo di non dare nell’occhio ma tutto questo non impedì che cominciassero a farsi vivi i carabinieri. Lo scopo era sempre lo stesso, cercavano un certo Guerrieri che era stato nelle Repubblica Sociale e non trovandomi mai, anche se può sembrare incredibile, cominciarono seriamente a pensare che non fosse il caso di portare via mio padre.
Le visite e relative insinuazioni si fecero sempre più insistenti e ossessive, da convincermi di prendere la decisione che, per porre fine a questo suo nuovo calvario, l'unico modo era di presentarmi alle autorità e ritornare al campo di concentramento. Già stavo per partire, addirittura mio cugino Aimone mi aveva portato alcuni pacchetti di sigarette, quando fortunatamente fu chiarito l'equivoco. Alla questura di Lucca era arrivata una comunicazione da Savona credo un cablogramma che diceva testualmente «Ricercasi tenente Guerrieri accusato di collaborazionismo e crimini». Era chiaro che non poteva essere mio padre, sia perché era sempre rimasto a sud della linea Gotica e non a Savona, sia perché non era tenente ma “maggiore” del ruolo d’onore.
Questa comunicazione non fece che confermare quanto erano fondati i miei timori e quanto saggia fosse stata la decisione di tentare la fuga dal campo di concentramento.
Naturalmente era chiaro che la mia situazione si era ulteriormente aggravata, ma in quel momento la cosa più importante era chiarire la completa estraneità di mio padre.
Non mi restò che continuare a tenermi nascosto ancora per qualche tempo meditando anche, me ne fosse capitata l’opportunità, di andarmene all’estero. comunque ero abbastanza tranquillo perché, anche se i carabinieri periodicamente venivano a casa a cercarmi, io lo sapevo sempre in anticipo e avevo tempo e modo per eclissarmi.
Intanto a Savona era iniziata la fase istruttoria del processo nel quale avrei dovuto essere giudicato assieme ad altri “per collaborazionismo e crimini”, ma i “bollori” se non del tutto, almeno in parte si erano calmati. Si stava rientrando nella legalità e si cominciava a fare una certa distinzione tra azioni belliche e azioni criminali e fu così, almeno per quanto ne venni a sapere io, che nella fase istruttoria e in contumacia, fui completamente scagionato e assolto da ogni addebito.
Cominciai a frequentare l'università a Pisa e contemporaneamente a dare una mano a mio padre che aveva iniziato ad assumere del personale per riprendere l'attività.
Basta. Non vado oltre perché non fa parte di quanto mi sono prefisso. La mia storia di “volontario” nella “Repubblica Sociale Italiana” finisce qui.
Almeno sino ad oggi ho continuato ad essere coerente con i miei principi e con il passare degli anni ho avuto sempre ferma la convinzione che questa decisione fu giusta e doverosa. Per fortuna non fui il solo, ma uno delle migliaia e decine migliaia di giovani, senza ombra di dubbio, la parte migliore del paese.
Per ultimo, dato che su tutto c’è sempre un perché, ritengo giusto spiegare quale é stata la molla che mi ha spinto a scrivere questo breve diario. Molto semplice, a distanza di cinquanta anni, nel “solito cassetto” ho ritrovato degli appunti che risalivano a quel periodo ed è stato lo spunto che mi ha indotto ad iniziare. Successivamente alla voglia di continuare non é stato estraneo un pizzico di nostalgia per quei tempi “duri” ma veramente e intensamente vissuti. (23)
Lucca Gennaio 1993 (24)
NOTE
1)Ho equivocato nel nome con altro trabaccolo. Con il Flavio Gioia effetivamente al Navale di Venezia avevamo fatto varie Uscite in mare, ma negli anni 1940-1941.
(1a)
Nel libro “4.OOO studenti alla guerra” di Emilio Cavaterra a pag. 143 si fa
accenno alla formazione di una scuola allievi ufficiali a Lucca.
(2)
Nello stesso libro a pagina 144 si parla della scuola allievi ufficiali alle casermette
di Rivoli.
(3)
Idem nel capitolo VII a pagina 161 nell’elenco degli allievi ufficiali figura
Guerrieri Ulrico.
(4)
Oltre che il nome ho aggiunto il cognome perché mi é stato espressamente
richiesto dall’interessato. Solo a questa condizione potrà ripetersi con altri
amici, altrimenti userò solo il nome di battesimo.
Immediatamente dopo mi é stata fatta la
medesima richiesta da altri amici e così doverosamente li ho accontentati
aggiungendo il loro cognome prima di stampare. Per l’esattezza devo precisare
che é avvenuto successivamente anche se sono menzionati prima.
(5)
Idem a pagina 147-148 si fa accenno all'invio in val di Lanzo di reparti di
allievi ufficiali di Rivoli.
(6)
Idem nella graduatoria dei promossi a s. Tenente di complemento della Guardia
Nazionale Repubblicana a pagina 349 figura Guerrieri Ulrico.
(7)
Nel libro “S.Marco S. Marco storia di una divisione” a cura di Pieramadeo
Baldrati, a proposito di nuove divise, tra i vari comandi ci fu un susseguirsi
di comunicati per l’interpetrazione da dare al trasferimento di alcuni
ufficiali di prima nomina della G.N.R. alla S. Marco, se dovevano o meno
mantenere le divise e mostrine del reparto di provenienza. I più(tra gli altri
il generale Graziani, e Valerio Borghese) ritenevano che se era un
trasferimento da un reparto all'altro, questo lo doveva essere a tutti gli
effetti, divisa inclusa. Secondo altri gli ufficiali della G.N.R. trasferiti
nella S.Marco, avrebbero dovuto tenere la divisa di provenienza. (II° vol.
pagine 1218, 1234-1235-1236-1252-1271,
1272) Anche questo fu uno dei
motivi per cui noi due, (io e Ciro) pur cambiando divisa come da ordini
ricevuti e giustamente unificandoci a tutta la divisione, come simbolo di
provenienza, continuammo ad indossare la camicia nera e per quanto ricordi, mai
ci fu contestato da alcuno.
(8) Idem nel terzo volume alla voce appendice
C. “Ordine di battaglia analitico e
nominativo della divisione” pagina 1491, nell'elenco che segue, a pagina 1494 sotto la voce "altri
organi extraorganici” alle dirette
dipendenze del comando di divisione comando difesa Savona, figura il s.
tenente Guerrieri Ulrico. (addetto)
(9)
Idem nel terzo volume a pagina 21O2 si fa menzione a quanti furono massacrati
proprio per aver voluto continuare ad indossare la camicia nera.
(1O)
Idem nel secondo volume in più di una
occasione il generale Farina rimbrotta il “tribunale militare di guerra” della
divisione, in quanto a suo dire poco incisivo e troppo lento nell’allestire processi e provvedere a quello che
era ritenuto il suo unico scopo di esistere: “togliere i bubboni” dalla
divisione.
(1I)
Idem dal terzo volume a pagina
212O.
(12)
Idem a pagina 13O2 del secondo volume tra l'altro di parla dell'incarico dato
al maggiore Maiella di andare ai vari reparti e comunicare loro della
cessazione delle ostilità e di entrare in Cittadella.
(13)
Idem a pagina 131O del II° volume documento 358 nell'ultimo rapporto ufficiali
del 3O Aprile, tra le varie possibilità si accenna anche a quella di andare noi
sui monti e continuare a combattere.
(14)
Idem a pagina 131O nel documento 358,
sempre nel II° volume, si parla anche che in caso di resa alle bande
partigiane, la vita era stata garantita solo ai marò ma non agli ufficiali ed
sottufficiali.
(15)
Idem riportato uno stralcio.
(16)
Idem nel terzo volume a pagina 1927 il sottotenente Marianini Ciro risulta
nell’elenco dei caduti.
(17)
Idem a pagina 13O9 nel secondo volume documento 357, si dice chiaramente che per
gli italiani la resa è senza condizioni e che i reparti devono entrare in
Alessandria disarmati. Ma almeno per il nostro reparto non fu così.
(18)
Idem a pag. 13O5 nel secondo volume documento
355/1 scritto a mano dal generale Farina, si fa accenno della fine che
avrebbero fatto i fondi della divisione ottanta milioni. Senz’altro sarà stata
una piccola parte di quell’importo, ma tengo a precisare che l’episodio da me
ricordato é vero in ogni suo particolare e che ancor oggi l’ho davanti agli
occhi esattamente come é stato descritto.
(19)
Io, fino a che non sono ritornato sul posto e precisamente in occasione
dell’uscita del libro “Coltano” (un campo di concentramento dimenticato), ho
sempre creduto di essere stato prigioniero nel campo di Coltano quando invece
ero stato in quello di S. Rossore, (denominato N. 339). Solo poco dopo la mia fuga i prigionieri del campo di S.
Rossore furono trasferiti in quello di Coltano, distante pochi chilometri.
(2O)
In realtà, ma questo lo seppi dopo, avrebbero immatricolato e trasferito tutti
i prigionieri in un altro campo a “Coltano” distante pochi chilometri
(denominato N. 334). Io per fortuna,
almeno quello lo potei evitare.
(21)
Questo diario l’ho terminato di scrivere nel Gennaio del 1993 e solo dopo due
anni sono usciti due libri sul campo di concentramento di Coltano e nel quali
si fa menzione di questa fuga. Leggendoli, ho potuto ritrovare il nome dei due
Gemelli che non ricordavo, Mario e Luciano Costalli. Strano come ancor oggi a
distanza di tanti anni ricordi perfettamente i loro volti, mentre il loro nome
mi si era completamente cancellato dalla memoria. Comunque purtroppo le cose
per loro andarono esattamente come mi erano state raccontate tanti anni prima.
In questi due libri non si parla minimamente che a fuggire con i fratelli
Costalli c’era una terza persona. Questo é normale perché di me nessuno ne
sapeva niente ed io la prima volta che ne ho fatto menzione é stato in questo
diario che hanno avuto e letto (sempre due anni prima dell'uscita dei due
libri) solo tre amici (Amerigo, Enrico,
Teresio e i miei due fratelli).
D’altra parte, come ho già raccontato, quando decisi di fuggire e
riuscii a trasferirmi in infermeria, non avevo conoscenze a parte i fratelli
Costalli. Nessuno era al corrente delle nostre intenzioni perché non ne
parlammo con chicchessia e anche nella ricerca che facemmo per qualche straccio
di indumento civile, non demmo spiegazione alcuna. Inoltre ed é la cosa più
importante, al momento della fuga non ero stato ancora “immatricolato” e così
praticamente una volta fuggito era come se non ci fossi mai stato e una volta
morti i Costalli, l’unico che poteva chiarire ero io.
I due libri sono: Coltano (un campo di
concentramento dimenticato) di Pietro Ciabattini edizioni Murzia a pag.
44-81-154-158-168 e “Mezzo secolo in trincea” (i quattromila studente
della Repubblica Sociale Italiana dalla guerra alla pace) curato da Emilio
Cavaterra edizione Nistri-Lischi a pagina 62. In quest'ultimo libro c’è un
piccolo errore che inizialmente scrivendo questo diario avevo fatto pure io,
ossia che il fatto (sempre a pag. 62) avvenne non nel campo di concentramento
di Coltano, ma in quello di S. Rossore.
(22)
Negli anni che seguirono molto spesso ho ripensato a questo episodio a dire
poco singolare, che se fosse successo ad altri e poi mi fosse stato raccontato,
credo proprio che avrei stentato a crederci. La cosa che ho sempre ritenuta più
credibile é che questi americani erano già a conoscenza della fuga dal campo di
concentramento e dell’uccisione dei due gemelli Costalli e avranno pensato che
riconducendomi al campo, quasi certamente avrei fatto la loro stessa fine. Era
chiaro che queste morti erano veri e propri omicidi e forse, per mia fortuna,
non se la saranno sentita di addossarsi un simile peso sulla coscienza per il
resto dei loro giorni. Non ho trovato proprio altro motivo cui pensare.
(23)
Uno dei pochi amici che hanno letto questo diario diciamo alla prima stesura,
mi ha fatto un piccolo rimprovero perché a suo giudizio avrei dovuto
approfondire ulteriormente i vari avvenimenti descritti.
Non era nelle mie intenzioni fare
l’apologia di quel periodo, casomai spetterà ad altri, e tanto meno di me
stesso. Con questo scritto intendo attraverso i miei ricordi, solo raccontare
di noi tutti nel modo più semplice e veritiero. Parlare di fatti ed esperienze
che abbiamo vissuto, ognuno a suo modo, ma sempre con lo stesso denominatore
comune, con umiltà e grande fede.
Insistendo su certe situazioni, penso che,
anche senza volerlo, avrei potuto essere mal compreso e potevano essere
interpetrate non nel verso giusto.
Se in tutti noi ci fu un atto di coraggio,
fu solo quello di aver voluto vivere in prima persona quei “giorni che contano”
e che ritengo, nel tempo, conteranno sempre di più perché, pur nella
consapevolezza della sconfitta ormai certa, furono vissuti fino all’ultimo
giorno di guerra con onore.
Ci prendemmo carico (per tutti gli
Italiani) di restare fedeli ad una sola parola e dimostrare al mondo, ma
soprattutto ai posteri, che così facendo, era stato possibile trasformare “la
sconfitta in una vittoria”.
(24)
Questo diario l’ho riletto e rivisitato, anche per quei particolari dei quali
ne sono venuto a conoscenza, dopo la prima stesura del Gennaio 1993. Per questo
motivo può essere menzionato qualche particolare in realtà accaduto
successivamente, tra il 1993 ed il 1996.
come pure alcune inesattezze delle quali
ne sono venuto a conoscenza successivamente, comunque sempre precisandole su
queste note.
(25)
Dal primo volume" S.Marco S.Marco"storia di una divisione a pagina
383,4 Marzo 1944 ottava rigae seguito, si fa menzionedell'accaduto ede anche se
non riportato nel modo esatto, non non lascia alcun dubbio che non si tratti
dello stesso episodio:"verso le 12 di ieri in zona Quiliano due partigiani
armati fermavano e tentavano di disarmare un gradiato del & fanteria. Il
militare reagiva uccidendolo.
(26)
Ritengo, nello scrivere, di aver fatto un po' di confusione tra quello che
accadde e quello che raccontavano i marò alle mie dipendenze che in precedenza
erano già stati alla fortezza. Mi è stato fatto notare e per questo, nel
dubbio, preferisco chiarire:Con certezza fosso affermare che in alcune
occasioni caccia bombardieri isolati, scesero a bassa quota e noi facemmo uso delle mitragliere.
U.G.
Altri scritti di ULRICO GUERRIERI, oltre alle presenti memorie, si
trovano nel sito www.guerrieriulrico.it