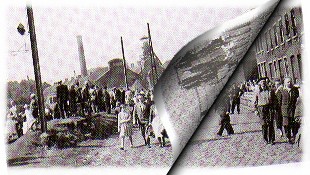|
Uno dice, o scrive:
Marcinelle e subito tutti pensano a quel pedofilo belga veramente
posseduto dal demonio. E invece per i giornalisti della mia generazione,
pei vecchi italiani emigrati in Belgio e rimasti laggiù (in pulite
casette modeste o in piccoli cimiteri) oppure tornati in Italia col
gruzzolo e la silicosi, e per tanti, molti cristiani ancora, italiani e
non, uomini insomma, Marcinelle vuol dire miniera. Vuol dire carbone.
Vuol dire fatica e morte vuol dire; un punto fermo nella storia della
nostra emigrazione, un lungo grido disperato nella storia della (ineludibile?)
sottomissione dell'uomo alla mina. Saint-Charles del Charbonages du Bois-du-Cazier è il nome esatto della miniera di Marcinelle. Il giorno 8 di agosto dell'anno 1956 morirono a Marcinelle 262 minatori: 136 italiani, 96 belgi, 14 polacchi, 5 greci, 5 tedeschi, 3 ungheresi, 2 russi, un inglese. I superstiti furono sei. |