 |
|||||||
 |
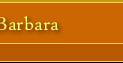 |
||||||
 |
|||||||
 |
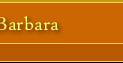 |
||||||
|
|
Alla
ricerca del consolidamento del potere in tutta la Toscana il Duca Cosimo I
dei Medici perseguì per tutto il suo lungo dominio una politica
promozionale fatta di grandi opere pubbliche, tra le quali l'edilizia
militare, ovviamente, godé di un'assoluta priorità. In quel periodo
vennero realizzate o rafforzate molte delle numerose fortezze che
ancor'oggi presidiano i territori di quello che fu il Granducato di
Toscana. Protagonisti di così grandi imprese furono, tra gli altri,
Antonio e Giuliano
da Sangallo, Giovanbattista Bellucci e Bernardo Buontalenti.
Quest'ultimi due furono tra gli architetti più qualificati in questo
settore e, in tempi e con soluzioni diverse, gli artefici dell'intervento
rinascimentale sul vecchio fortilizio pistoiese. Una tradizione popolare,
accolta dalla storiografia locale, vuole che in epoca medioevale la
fortezza, realizzata dai fiorentini nella prima metà del XIV secolo
quando la città stava ricostruendo le sue mura, avesse il nome di S.
Barnaba per essere vicina ad una cappella dedicata a questo Santo. Fu
intitolata a Santa Barbara soltanto in tempi successivi. Durante il
periodo rinascimentale il fortilizio subì un primo ampliamento la cui
direzione dei lavori fu affidata al Bellucci, al tempo impegnato nel
recupero dell'intero sistema difensivo della città. All'origine
dell'intervento bellucciano era il progetto dell'architetto Nanni Unghero
che aveva previsto una struttura, a pianta quadrilatera con bastioni ai
quattro angoli, priva di ogni decorazione e con un profondo fossato
tutt'attorno. Successivamente Bernardo Buontalenti inglobò questo nucleo
in un nuovo baluardo collegato alle mura urbane conferendo in tal modo
alla fortezza quell'imponente aspetto che tutt'oggi conserva. In tutta la
sua storia la fortezza ha subito un solo assedio alla metà del XVII
secolo, quando le truppe pontificie attaccarono Pistoia ma furono respinte
dai suoi potenti bastioni. Alla fine del Settecento il Granduca Pietro
Leopoldo nell'ambito della sua vasta opera riformatrice decise il disarmo
della fortezza. Perduto in quell'occasione il suo ruolo di baluardo posto
a difesa della città, il fortilizio ha comunque mantenuto una funzione
militare, prima come caserma, poi come carcere e distretto. |
|
«…I Fiorentini feciono
fare in Pistoia uno castello in su le mura di porta San Pietro, alle spese
del Comune di Pistoia, e facean alle spese loro, e ressono la città
grande tempo in buono stato e in gran pace e se non fosse lo castello che
vi feciono fare e ‘l modo che teneano a signoreggiare la città, li
Pistolesi non sarebbero stati tanto in pace che l’uno non avesse
cacciato l’altro per le sette e divisioni loro…».
In questo modo nelle Historie Pistoresi si racconta delle origini
della fortezza di San Barnaba. Nel 1334 il Comune di Pistoia acquistò i
terreni e le case da abbattere poste nell’area del Borgo di Santa Maria
nuova fra la porta di San Pietro e la via del Nemoreto, per costruire il
nuovo fortilizio. La fortezza di San Barnaba fu costruita in breve tempo.
Aveva forma trapezoidale e racchiudeva una piccola area. La cortina
perimetrale aveva un’elevazione di 8,50 m dall’antico piano di
calpestio. Se consideriamo pure l’altezza del parapetto e dei merli
possiamo ipotizzare un’altezza complessiva di circa 10 m. Lo spessore
dei muri perimetrali è di 108 cm, essi sono costituiti da ciottoli di
fiume murati con calce aerea, giallastra, di bassa consistenza e con
grande quantità di inerti di ghiaia di fiume di piccola pezzatura. Lungo
il perimetro un fossato alimentato dal rifiuto della gora di Gora
proteggeva la struttura difensiva. |
|
|
|
Di questa prima fortezza
abbiamo avuto conoscenze vaghe e incerte per molto tempo. Si è ritenuto
che fosse intitolata a santa Barbara da sempre e i rari accenni a san
Barnaba sono stati liquidati frettolosamente. Eppure la testimonianza del
Fioravanti era inequivocabile nel raccontare che «…in questi tempi
passasse per la città di Pistoia san Barnaba Apostolo, e ancora spargesse
nella medesima i semi della eterna verità; lo che ci fa pensare quale, e
quanto fosse il conforto nei nuovi Cristiani; ed è comune opinione,
autorizzata da tradizione assai volgata, che la casa ove egli dimorò
fosse ridotta a forma di Cappella, o Chiesetta, la quale al di lui nome
dedicata, desse la denominazione al Castello, o Fortezza, che i Fiorentini
l’anno 1331 edificarono contigua col nome di San Barnaba posta tra
levante, e mezzo giorno vicina alle mura sopra il terreno della Porta di
San Pietro in cura a Santa Maria Nuova…». A conferma del
racconto del Fioravanti vi sono le ripetute testimonianze d’archivio
relative alla nomina di castellani per il «…castro dicto Barnaba
sita in civitas pistorii…». La cappella o chiesetta di San Barnaba
oggi non è riconoscibile, si può solo ipotizzare che fosse uno dei
locali all’interno del fortilizio oggi adibito ad altro uso.
Analogamente per molto tempo si è creduto che la prima fortezza fosse
stata distrutta dai Pistoiesi nel 1343, in occasione della cacciata del
Duca d’Atene da Firenze. È ancora la narrazione del Fioravanti ad
avvalorare la tesi della distruzione, infatti la fortezza «…fu poi
da’ Pistojesi fazionari fino [dai] fondamenti spianata…». Ma
anche il Salvi, qualche decennio prima del Fioravanti aveva scritto che i
Pistoiesi «…ottenuto il detto castello, subito lo disfecero, anzi
fino da’ fondamenti lo spianarono…». La ricognizione della
struttura muraria inglobata nell’attuale fortezza smentisce il racconto
dei due eruditi che, probabilmente, intendevano solo accentuare
l’aspetto campanilistico a discapito della narrazione storica. Peraltro,
i documenti d’archivio testimoniano della nomina dei Castellani della
fortezza fra il 1338 e il 1370, essi avevano il compito di provvedere a
tutte le necessità e agli approvvigionamenti. In questo modo diviene più
evidente l’inesattezza del racconto del Fioravanti e del Salvi,
mentre è confermato quanto si osserva nella struttura muraria. |
|
La costruzione della terza
cinta muraria fu avviata probabilmente poco dopo l’acquisto di casamenti
e terreni da spianare per far posto alla fortezza nel quartiere di Santa
Maria Nuova. La nuove mura racchiusero un’area doppia di quella della
seconda cinta includendo sia i borghi che si erano sviluppati lungo gli
accessi principali alla città, sia i monasteri degli ordini mendicanti
che erano sorti negli ultimi due secoli. Oltre all’edificazione delle
mura fu pure deviato per l’ultima volta il percorso del torrente Brana.
I lavori ebbero varie fasi: una prima, molto rapida, alla fine della quale
le mura dovevano essere state, sia pure sommariamente, completate, come
sembrano suggerire alcuni documenti d’archivio a proposito della
custodia diurna e notturna delle porte della città; mentre per lungo
tempo proseguirono i lavori di ristrutturazione e modificazione, in
particolare nei tratti prossimi agli angoli. Abbiamo notizia di interventi
ancora nel 1375 e possiamo ipotizzare che essi si riferissero alle
trasformazioni eseguite per saldare le mura della città alla fortezza di
San Barnaba. Questa terza cerchia muraria fu realizzata con ciottoli di
fiume e calce aerea, la sezione delle mura è di poco superiore al metro
e, nello spessore, è ricavato, in sommità, il camminamento di ronda con
lo spalto munito di merli che furono demoliti, nel 1544, nel corso dei
lavori per la seconda fortezza diretti dal Sanmarino. La cortina muraria
si congiunse con il fortilizio in prossimità e a ridosso delle due torri
laterali. Sono ancora visibili le tracce sia sulla torre di nord-est, sia
su quella di sud-ovest dove, peraltro, sono evidenti i segni di un
tamponamento eseguito nel Quattrocento quando il fortilizio fu staccato
dalle mura. La saldatura ebbe come conseguenza la necessità di passare
attraverso la fortezza per poter entrare o uscire dalla città per cui,
poco dopo, si provvide ad aprire una nuova porta, a fianco della fortezza,
che si apre su Sant’Agostino. Di essa abbiamo testimonianza dal
passaggio di 80 soldati inviati da Firenze a Pistoia nel 1371. Sul
finire del Trecento quindi Pistoia ebbe il nuovo perimetro saldato alla
fortezza con le rispettive porte principali e le postierle. Il perimetro
della cinta muraria andava così a definire lo spazio urbano che, salvo le
aggiunte del Cinquecento, sarebbe rimasto pressoché intatto fino agli
inizi del Novecento. |
|